NOTE DEL TRASCRITTORE:
—Corretti gli ovvii errori di stampa e punteggiatura.
—Le note a piè di pagina, che nell’opera originale erano raccolte alla fine di ogni capitolo (lezione) sono state trasferite dal Trascrittore all fine del libro.
—Sono presenti in questa opera una quantità di dizioni multiple, in specie per le traslitterazioni dall’Ebraico; considerata anche la singolarità dell’ortografia utilizzata dall’Autore e nell’impossibilità di stabilire univocamente la corretta dizione, tali forme multiple sono state conservate.
—Gli accenti, l’ortografia e la sintassi utilizzate dall’Autore sono alquanto ricercate e rispondenti alla forma erudita della lingua italiana in uso all’epoca della stesura dell’opera. Tale forma prevede anche una variabilità nelle forme che sono state in massima parte conservate laddove non siano state considerate palesi errori tipografici.
—L’indice non è presente nell’opera originale; ne è stato prodotto ed aggiunto uno a cura del Trascrittore.
—L’immagine di copertina è stata prodotta dal Trascrittore usando l’immagine del frontespizio dell’opera originale. L’immagine è posta in pubblico dominio.

Proprietà letteraria.
STORIA
DEGLI ESSENI
LEZIONI
DI
ELIA BENAMOZEGH
RABBINO-PREDICATORE
E PROFESSORE DI TEOLOGIA NEL COLLEGIO RABBINICO DI LIVORNO.
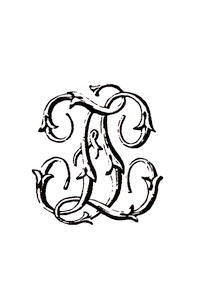
FIRENZE.
FELICE LE MONNIER.
1865.
Tipografia dei Successori Le Monnier.
PREFAZIONE.
Le Lezioni che ora si pubblicano, risalgono all’epoca per me tuttavia di dolce rimembranza, in cui mi era dato esporre alcune parti della Storia della Teologia ebraica ad una eletta schiera di giovani livornesi, i quali, con perseveranza non comune in questa nostra città dedita ai traffici, seguirono le mie conferenze per circa tre anni.
Queste cose stimava opportuno premettere, a spiegare la forma non troppo consueta di questa Storia, ed a giustificarla eziandio. Perciocchè non mancherà taluno, e forse non senza fondamento, il quale osservi che più acconcia sarebbe stata la forma semplicemente espositiva. Ma oltrechè per satisfare a questo bisogno sariami stato d’uopo rifare quasi interamente il mio lavoro, parevami ancora che ciò non sariasi potuto operare senza compromettere in qualche modo le sue sorti. Chè il subietto presente sia per sè grave, e forse arido per i lettori comuni, non vi ha, credo, chi nieghi. L’erudizione storica, e teologica in ispecie, è cibo di pochi; e per farlo accetto ai più, sarà forse senza niuna utilità uno stile men disadorno, più drammatico e vivace quale s’addice a Lezioni? I fatti e le idee che altronde riescirebbero ai schifiltosi indigesti, non divengono pascolo più gradito, ove ai condimenti si mescano della imaginazione e del sentimento? Non solo, e il dico a costo di parer puerile, gli Esseni studiando con amore e con fede, perciocchè in essi intravvedeva i predecessori della buona nostra Teologia, io sentiva nella nobile indagine impegnate la Ragione e la Critica, ma la imaginazione altresì e il sentimento, e spontanea dal labbro sgorgavami la parola viva e affettuosa. Mai parvemi così vera ed[v] acconcia la sentenza platonica, non essere il bello che lo splendore e la veste del vero.
A che però, diranno altri, venir fuori con questi vecchiumi? Appena trovano venia presso i comuni lettori le politiche o letterarie lucubrazioni:—qual sorte mai dovrà toccare agli opliti della scienza, alle scritture gravemente armate, alle dotte e severe indagini della Storia e della Teologia?—La Dio mercè però, questo linguaggio diventa di giorno in giorno più raro. A dispetto di chi vorrebbe confinare la mente umana nello studio e nell’amore delle quisquiglie letterarie e degli arcadici vezzi, come i tiranni invitano il popolo a seppellire le più generose potenze nelle tazze soporifere di Bacco, di Momo e di Venere, l’uomo anela a cose più alte. Gli argomenti che, or si può dire pochi lustri, erano il patrimonio di pochi, diventano ogni giorno più, quasi comune proprietà. Le menti s’iniziano alle più alte e scabrose indagini. Libri che altra fiata sariano giaciuti in eterno polverosi negli scaffali delle Biblioteche, girano adesso per le mani di tutti: avidamente si leggono, in ogni lingua si traducono: ed ove per mole e scienza soverchie disdicano ai comuni intelletti, epitomi se ne fanno e compendi. La scienza si fa piccina per trasfondere la vita nel popolo, come Elia si contrae sul corpo morto del figlio della vedova, a comunicargli la vita.
La storia presente non solo prende a considerare serio argomento, ma è parte nobilissima e tema di gran momento nella questione religiosa che ora preoccupa e divide gli animi nel mondo intero. La Storia degli Esseni è fonte ricchissima di documenti atti a spiegare l’origine del Cristianesimo; e qualunque concetto di questo si formi, niuno vi ha che si attenti di negare per la Storia di questa religione, la importanza dello studio dello essenico Istituto. Perciò tu vedi tutti i libri che prendono a trattare di quelle origini, assegnare posto segnalatissimo all’esame dell’Essenato. Parevami dunque non fare, anche per questo verso, inutile opera, mandando fuori questi miei pensieri intorno una Scuola tanto studiata[vi] e tanto degna di studio; e sopratutto non venire meno alle leggi di opportunità. Un altro resultato, o ch’io m’inganno, mi sarà lecito sperare da questo mio lavoro.—Nelle ebraiche scritture da me finora pubblicate, vuoi in forma polemica come le repliche contro l’antico Leone da Modena e l’illustre amico professor Luzzatto, vuoi nelle mie Note al Pentateuco, vuoi infine nel mio Essai sur l’origine des Dogmes et de la Morale du Christianisme premiato dall’Alliance israélite di Parigi, pienamente soscrissi e, quanto seppi e potei, crebbi forza alla sentenza intorno a cui convengono non che gli scrittori ortodossi, ma i critici eziandio più indipendenti, come Munk, Frank e Jost ed altri moltissimi, che, cioè la Teosofia cabbalistica, che coltivò il nostro gran Pico Mirandolano, ebbe per antichi rappresentanti gli Esseni e lo Essenato. Questa Storia è destinata a porgere nuovo tributo a questo gran vero, mercè un perpetuo confronto che si va facendo fra le une e gli altri.
E non meno parevami adempiere all’officio di buon italiano. Che se ogni individuo ed ogni ceto debbono contribuire, per ciò che lor spetta, a maggiore onoranza e gloria della Patria comune, perchè questo dovere non incomberà egualmente agli Israeliti e alla scienza israelitica? L’Italia ha il diritto di avere una Scienza ebraica filologica, storica, teologica, erudita, quale da gran tempo posseggono altre Nazioni sorelle; e in special modo la Germania. Ma a chi spetta principalmente arricchire di questa gemma la sua corona, se non agli Israeliti per cui l’Italia tanto fece e fa tuttavia? E chi tra gli Israeliti più debitore di questo giusto tributo se non il Rabbinato? Il quale in tanto lume di pubblicità, in tanto nobile pugnare di dottrine e sistemi, in tanto strenuo combattere a trionfo del vero, deve a sè, all’Italia, al mondo, alle sorti avvenire del genere umano, di alzare la voce a proclamazione e difesa del suo Credo.
Nell’adempire però, nei limiti delle mie scarse forze, a questo dovere, un pericolo sopratutto mi toccava cansare, quello cioè di venir meno al rispetto delle altrui[vii] opinioni e di religioni dalla mia diverse. L’ho io sempre felicemente evitato? Certo che costante mio intendimento fu di fuggirlo, e certo del pari che per le continue e delicate occasioni che ad ogni tratto mi si paravano dinanzi, ardua impresa era il superarlo continuamente. Se mai talvolta la parola o il pensiero suonano, più che non s’addice, liberi e severi, spero non mi si vorrà apporre a colpa quando si rifletta che tra la tolleranza fraterna da una parte, e la libertà dello speculare e la veridica parola dall’altra, angusto e difficile è il calle, e rado è che tu non pieghi talvolta o a un linguaggio alquanto severo, o a qualche dissimulazione del vero. Fra i due mali, qual’è il lettore illuminato che non preferisca il primo? La vera reciproca tolleranza è quella che sa amare e stimare gli altri, pur serbando intatto il culto delle proprie dottrine. Anzi, vero amor fraterno non si dà quando alto non proclamisi ciò che vero si crede. Il primo diritto dei nostri simili, è quello di udire da noi la verità.
Dopo le cose esposte, non mi rimane che a dire intorno i motivi di questa pubblicazione. Non è sete di onoranza, che scarsa mi riprometto, sì pel picciol merito dell’opera, come pel poco conto in cui questi studii si tengono generalmente; non è amor di guadagno, che non si trova per queste vie; non è vanità letteraria, che più agevolmente e più sicuramente si può satisfare con più amene produzioni; non è nemmeno quello che tanti autori protestano, la pressa dei loro amici che non gli dan tregua se non ne veggono le opere su per le stampe. È lo stesso motivo che m’indusse a sobbarcarmi spontaneo al ministero religioso, che mi fe’ e fa lavorare intorno a subbietti difficili, ingrati, spinosi; senza altro rimerito che il buon testimonio della coscienza: l’amore del sapere e della verità.
Livorno, Maggio 1865.
Elia Benamozegh.
INDICE
| Pag. | |
| Prefazione | iv |
| Lezione Prima | 1 |
| Lezione Seconda | 10 |
| Lezione Terza | 19 |
| Lezione Quarta | 34 |
| Lezione Quinta | 45 |
| Lezione Sesta | 66 |
| Lezione Settima | 75 |
| Lezione Ottava | 101 |
| Lezione Nona | 119 |
| Lezione Decima | 137 |
| Lezione Decimaprima | 152 |
| Lezione Decimaseconda | 185 |
| Lezione Decimaterza | 203 |
| Lezione Decimaquarta | 236 |
| Lezione Decimaquinta | 247 |
| Lezione Decimasesta | 261 |
| Lezione Decimasettima | 271 |
| Lezione Decimottava | 284 |
| Lezione Decimanona | 292 |
| Lezione Ventesima | 300 |
| Lezione Ventesimaprima | 311 |
| Lezione Ventesimaseconda | 323 |
| Lezione Ventesimaterza | 335 |
| Lezione Ventesimaquarta | 346 |
| Lezione Ventesimaquinta | 357 |
| Lezione Ventesimasesta | 368 |
| Lezione Ventesimasettima | 378 |
| Lezione Ventesimottava | 388 |
| Lezione Ventesimanona | 399 |
| Lezione Trentesima | 409 |
| Lezione Trentesimaprima | 419 |
| Lezione Trentesimaseconda | 430 |
| Lezione Trentesimaterza | 437 |
| Lezione Trentesimaquarta | 446 |
| Lezione Trentresimaquinta | 457 |
| Lezione Trentesimasesta | 468 |
| Lezione Trentesimasettima | 478 |
| Lezione Trentesimottava | 483 |
| Lezione Trentesimanona | 495 |
| Lezione Quarantesima | 502 |
| Lezione Quarantesimaprima | 512 |
LEZIONE PRIMA.
Io debbo, diletti giovani, nell’esordire, revocare alla vostra mente quei giorni al mio cuore carissimi, in cui per la prima volta erami conceduto, la parola mia indirizzarvi. Voi il rammentate. Non appena i primi passi muovevamo pel lungo e difficil sentiero, che il bisogno faceasi sentire imperiosissimo, di una logica e razionale divisione del nostro assunto. Simile alle colonne miliarie, che all’animoso viandante additano il cammino percorso, e nuova lena gl’infondono e nuova speme; noi pure, o signori, il cammino nostro in tre grandi stadj, in tre grandi epoche, in tre grandi divisioni partimmo.
Nulla per ora delle ultime due calendoci, diremo solo della prima epoca, del suo principio, del suo termine.
Quale era, o signori, la prima epoca della storia della ebraica teologia?—Era quella che dalla Mosaica rivelazione partendo, si stende per tutto quello immenso intervallo, che da quel fatto memorando trascorre, sino alla cessazione della nostra vita politica, sino, che dico, o signori? sino al suggello dei Profeti e delle tradizioni, sino alla compilazione del Talmud. In questa epoca, o signori, noi risalimmo sin dove alcuna traccia per noi si scorgesse di movimento religioso, di dogmatica vicissitudine; sin dove un sistema ci apparisse che un compiuto avesse e particolare sembiante, di Dottrina e[2] di pratica. In quei remotissimi tempi, una setta ci fermava, ed era quella dei Samaritani.
Noi togliemmo ad esame tutto ciò che ad essa appartiene, e comecchè parecchie cose fossero da noi e per brevità, e per incompleta notizia pretermesse, non è sì, o signori, che una cognizione voi non ne abbiate acquisita generale e sommaria. Mestieri è ora muovere il piede in cerca di nuovi liti e nuove genti, mestieri è, discendendo per la serie dei secoli, quella setta, quella scuola tôrre a subbietto di studio che prima si presenti, dopo i discorsi Samaritani. Voi ricordate, o signori, di questa setta il nascimento. Ella sortì i natali in quella epoca al popol nostro esiziale, quando la sua nazionalità venne per la prima volta vulnerata, quando la via si apriva dell’esilio, quando le dieci tribù schiudevano quel cammino di dolori e di spine, che le rimanenti due tribù non avriano tardato a calcare.
Le ricerche nostre, o signori, debbono dunque oggimai da quell’epoca in poi esercitarsi. Dobbiamo i tempi a quelli posteriori interrogare, e le voci studiosamente raccogliere che ci porge la istoria. Quali furono le vicende della ebraica religione nei secoli a quello successivi? La risposta, o signori, troppo più tarderà ad udirsi, che alla vostra impazienza non si convenga. Invano il chiederete all’esistenza incerta e languente del primo tempio; invano alla cattività babilonese, invano ai primi periodi del tempio secondo. Egli è, o signori, nei tempi di mezzo della nuova Restaurazione, egli è durante le lotte fraterne degli Asmonei, che la nuova scuola, la nuova setta apparisce con Giuseppe, sul teatro della istoria. Egli è allora soltanto che la presenza ci è dato costatare d’una forma nuova in seno alla ebraica religione.
Non vorrei però, o signori, che le parole mie fossero[3] da taluno fraintese. Quando io parlo di questo protratto silenzio, quando noto una sì grande lacuna nella storia religiosa del popol nostro, quando dico che solo collo storico Giuseppe la esistenza ci si appalesa di nuova scuola; dire non intendo, o signori, che per tutto questo lungo intervallo, le sètte da Giuseppe rammentate esistito non abbiano; che quella specialmente che offrirà tra non molto al mio dire subbietto, non spinga alte e profonde le sue radici in una ben altrimenti remota antichità; che più vetusta esistenza non conti di quella che la istorica menzione parrebbe assegnarle. No, o signori, questo nè dico io nè penso. Che anzi le successive nostre conferenze vi chiariranno abbastanza, come, a senso mio, certe scuole, certi istituti a cui i documenti non porgono che una età posteriore, spingano oltre le loro barbe negli strati, per così dire, più profondi del suolo ebraico; che altro la cronologia dei documenti, altro quella sia veramente della storica esistenza; che, benchè per nomi, per forme, per sembianze diversi, i moderni agli antichi istituti si riappicchino mercè l’unico genio, l’unica mente e, come oggi si dice, l’unico spirito. Ma questo, o signori, sarà piuttosto corollario ultimo e postulato supremo dei nostri studj, anzichè premessa da noi gratuitamente anteposta al nostro discorso; sarà frutto anzichè radice; sarà comignolo anzichè base e fondamento al nostro edifizio. Per ora, o signori, l’ordine delle nostre trattazioni sarà quello ch’emerge dall’esame eziandio più superficiale dei monumenti esistenti, sarà quello che scaturisce dall’ordine, dalla successiva menzione delle sètte. Per ora, o signori, quella stimeremo più antica che anzi le altre figura nelle istorie dei tempi. Per ora quel nascimento soltanto le supporremo che la età ci concede, della istorica menzione. Criterio falso, arbitrario, siccome vedete, e che tanto vale a parer mio[4] quanto il fissare che uom volesse d’un’individuo i natali in quell’ora, in quella epoca, che le forze sue attuava sul teatro del mondo.—Ma noi, o signori, mentre ogni altro sussidio ci vien meno, di questa data ci staremo contenti. Quale è la setta che, nell’ordine di storica menzione, dopo quella immediatamente figura che non ha guari insieme studiammo? Per ritrovarla, mestieri è non solo valicare, siccome dissi, molti secoli e regni, ed imperi diversi vederci prima scomparire dinanzi; ma penetrare eziandio è mestieri nella santa città di Solima, e penetrarvi come vi dissi mentre la guerra è bandita tra i due contendenti e rivali Asmonei. Che spettacolo, o signori, non ci offre allora la santa città! Direste una grande, una immensa officina in cui le arti tutte si adopran solerti di guerra e di pace. Vedreste le divisioni politiche armare l’animo, il braccio dei cittadini. Vedreste il fratello contro il fratello, e talvolta, oh sciagura! il fratello ligio a strana signoria, contro il fratello della patria libertà difensore. Vedreste alle politiche, le religiose dissenzioni innestarsi, e quelle a dismisura esacerbare; per quella legge che fa più vive ed accanite le lotte di religione, quanto più il subbietto intimamente ci appartiene, e nulla più intimo di ciò che ha seggio nel più segreto dell’animo; d’onde, o signori, la ferocia unica anzichè rara delle guerre di religione. Vedreste tutte le forze morali, religiose, intellettive, nazionali, civili, del popol nostro in uno stato di aperta tenzone, di febbrile e prodigiosa esaltazione. Vedreste un disordine, un antagonismo, un’anarchia; vedreste un caos da cui il Fiat divino dovrà forse a suo tempo suscitare un nuovo mondo, e tutti gli elementi più generosi fervere in uno stato di soluzione, nell’aspettativa di quel disegno, di quella forma, che tutte dovrà forse comporle e armonizzare in bell’ordine.—In mezzo, o signori, a Gerusalemme in[5] travaglio, in mezzo al romore delle armi, al disputar dei Dottori, al piatire dei rivali, al ruggito delle fazioni, inoltratevi, se vi dà l’animo, per le vie mal sicure di Gerusalemme, impegnatevi per le sue vie, e se il pugnale non paventate dei sicarj,[1] i più cospicui luoghi visitate della città e dei suburbj. Qui è la setta dei Sadducei, e queste le sue aule. Nuovi giardini d’Epicuro, primi furono tra noi a preludere a coloro che l’anima col corpo morta fanno.—Non son questi che noi cerchiamo. Ecco, o signori, i centri, le accademie ove rivive la sementa santa, del Farisato, eccone le porte, ecco a traverso le grate le immagini austere, le fronti sublimi dei Dottori e dei Scribi.—Inchiniamo e passiamo.
Ma ecco, o signori, nella parte più queta, nella regione più silente della città rumorosa, pacifico presentarsi e maestoso abituro. Qui un alternarsi di silenzio e di canto. Qui l’ordine, qui la regola, qui la misura presiedere ad ogni atto, e tutta la interna e la esterior vita informare. Qui le tempeste muggono alle porte incatenate; qui si frangono impossenti i marosi delle civili discordie; qui l’animo si leva a quelle alture in cui le nubi, come accade sulla cima dei monti, ti si addensano ai piedi anzichè sulla testa, e quasi partecipe della gloria di Dio, l’uomo assunto a tanta altitudine cavalca le nubi e calpesta le folgori. Qui si maturano i grandi pensieri, qui si elaborano le grandi dottrine, che esciranno salve ed illese dal gran naufragio.—Che casa è questa, o signori, che gente è cotesta che l’abita? È cielo questo, è questa anticipazione di Paradiso? Sono angioli cotesti, sono mortali?—.... Sono gli Esseni.—Esseni! nome nuovo, inaudito forse per alcuni di voi.—Nome che l’Ebreo non dovrebbe mai obbliare, come a delitto imputeriasi al Greco Platone disconoscere e l’Accademia; come all’Italo, Pitagora [6]e gli Stoici; come ad ogni popolo la più grande gloria, e il prisco vanto intellettuale de’ suoi proavi.
Gli Esseni!—Venerando nome per tutti quelli appo i quali sono in onore Sapere e Virtù. Nome carissimo per noi figli, per noi eredi di loro fama. Nome, lasciatemi aggiungere, nome santo per chi in essi vede, come io già veggo, come voi spero tra non poco vedrete, negli antichi, nei venerandi Esseni il fiore, il Patriziato, il Grado supremo nella Gerarchia Farisaica;—Il Farisato rivolto alla speculazione del sommo vero e alla pratica del sommo bene; la falange, come la Macedone, degli Immortali[2] che tra le fila si reclutava della comune farisaica milizia.—Io so, o miei giovani, che sì dicendo, io proclamo cosa che il mondo non era usato sin qui ad udire; so che, come ogni idea nuova, avrà pregiudizj, errori e rispettabili convinzioni da combattere. Io so, o signori, che grave debito io mi assumo di somministrare a questa mia teoria, carte e diplomi in regola per viaggiare pacificamente per il mondo. Per ora mi contento di un salvo condotto. La identità dell’Essenato col Farisato negli ultimi e supremi suoi stadj, sarà, spero, frutto di una continua dimostrazione nel corso di questa istoria; anzi, la storia stessa ne sarà la più concludente dimostrazione. Epperò, appunto, egli è questo tema siffatto, a cui troppo disconviene tempo e spazio ristretto. Il suo tempo, è tutto quello che noi spenderemo intorno gli Esseni. Il suo spazio, tanto si allargherà, quanto lungi andranno di questa storia i confini.—Per ora, il nostro passo dee procedere regolato e metodico. Noi abbiamo pronunziato un nome bello, un nome onorando, e, se mel permettete, dirò ancora onorante. Ma che vuol dire questo bel nome? Che significa la gran parola di Esseni?—Il suo significato logico, dottrinale, storico, provvidenziale, non ha che una sola possibile definizione.—La[7] storia stessa della bella scuola, così da or innanzi la chiameremo. Il significato però che adesso cerchiamo è quello più ristretto del vocabolo stesso; il significato gramaticale, filologico della parola, il valore suo puramente etimologico. Questa è la definizione che noi andiamo cercando. Ma questa, qualunque essa sia, non è tale che non debba necessariamente colla prima connettersi; che anzi, l’armonia tra le due definizioni, è tale criterio, che la verità dee porre in sodo dei nostri resultamenti. Noi cerchiamo la definizione del vocabolo, ma questa, per essere vera, dee armonizzare colla definizione della setta, che è l’istoria. Una definizione gramaticale che non fosse la natia espressione, e quasi lo invoglio naturale della definizione logica, un nome che non esprimesse lo Essere, sarebbe improprio, sarebbe supposto, sarebbe falso.—Il nome è il Corpo, l’esteriorità dell’Idea, come il Corpo è l’esteriorità dello Spirito.—Ecco il criterio che noi dobbiamo a guida proporci nelle ricerche che saremo per fare sul nome di Esseni, nella cerna che fare dovremo degli infiniti supposti, delle origini multiformi a quel nome assegnate.
Egli è perciò, o signori, che prima meta ci proporremo nelle nostre ricerche il nome di Esseni. Stabilita di questo nome la definizione, discorreremo delle origini dell’Essenato; cercheremo di stabilire una data almeno approssimativa del suo nascimento, di additare le fasi più cospicue della sua esistenza, di seguirne le vestigia più o meno sensibili pel corso dei secoli. Determinata degli Esseni la origine e la Istoria, parleremo delle loro istituzioni e di tutto quello che queste concerne, delle leggi loro costitutive, della loro organizzazione, del loro genio, delle lor costumanze, insomma, o signori, della loro vita sociale.—Dopo la vita sociale, altra vita non meno della prima preziosa, sarà subbietto delle indagini nostre;[8] voglio dire, o signori, la loro vita intellettuale; le loro credenze, i loro dogmi, i loro principj. Qui è, o signori, ove meno pienamente potremo appagare la nostra sete di cognizioni; qui è ove una grande lacuna romperà in gran parte il filo coerente della nostra esposizione; qui è dove chiaro apparirà negli effetti quel sistema prediletto agli Esseni di sottrarre agli sguardi curiosi parte almeno delle dottrine più riservate. Qui è ove noi, giunti alla soglia del tempio, dovremo se non indietreggiare sconfortati, certo non più che pochi e timorosi passi avanzare nel recinto del Santo, e solo, a così dire, di sbieco gettare di tratto in tratto qualche sguardo furtivo per entro alla cortina, che la piena ed intera fruizione ci contende degli inviolati misteri. Esaurito, o signori, il Dogma, narrata quanto meglio si può la vita intellettuale degli Esseni, quella prenderemo a descrivere che pratica o, come dire vogliate, rituale si appella, ove i riti, la forma del loro culto, il numero, l’indole delle loro osservanze tutte, l’esercizio pratico delle loro credenze, tutti in bell’ordine ci si offriranno dinanzi schierati. Noi avremo allora tutta intera ricostituita la personalità degli Esseni.—Esistenza, Pensiero, Azione, tre sommi indivisibili elementi di ogni Ente morale, che nella Origine, nel Dogma e nel Culto, ogni volta si convertono che di Setta o religioso Sodalizio è discorso.
Per ora, o signori, del nome degli Esseni.—Una falange di dotti si contenderà la gloria di averne l’appellazione decifrata. Voi ascoltateli con quella riverenza che si deve all’ingegno, e col rispetto che esigono le loro fatiche spese a restaurare una gloria che a voi, giovani israeliti, più che ad ogni altro appartiene. A noi, il falso dal vero discernere, a noi raccorre gli elementi del vero disseminati talvolta per entro i falsi sistemi; a noi il rintracciare in tanta distanza, in tanto pugnare di ostili[9] pareri, il primitivo e genuino senso del vocabolo Esseni.—E dove a noi il cielo arrida propizio, potrò dir di me stesso, come per Laura il Petrarca:
Forse avverrà che il bel nome gentile
Consacrerò con questa stanca penna.
LEZIONE SECONDA.
Vi promisi, o signori, che subbietto della presente conferenza saria stato la origine, il significato di questo nome di Esseni, di quel nome col quale venne la scuola presente invariabilmente contraddistinta. Aggiunsi, o signori, che molte sono, che sono discordi le congetture che di questo nome furono in tutti i tempi proposte. Io vengo ad adempire la mia promessa, vengo a schierarvi in bell’ordine innanzi le moltissime congetture che nella presente disquisizione il primato contendonsi.—Uomini celebri ci hanno trasmesso delle loro meditazioni il portato; nomi cari e venerati alla scienza non esitarono disputare lungamente intorno l’origine di questo vocabolo. Saremo noi rispetto ad essi più avari di attenzione, di quello ch’essi il furono verso di noi di lucubrazioni e di veglie? Io dico, o signori, per voi che nol saremo.—Levino, dunque, la voce e ci dicano dei loro studi il portato. Ci dica per primo il Salmasio in qual guisa egli giunse a credere il nome di Esseni da quello derivato di una città e regione che questo nome portava di Essa. Ci dica poi il Basnage su qual fondamento egli la opinione del Salmasio negava, affermando a dirittura, nulla traccia averci l’antica geografia tramandato della esistenza della supposta regione. Ci dica, infine, la buona critica tra il Salmasio che afferma e il[11] Basnage che dinega, chi meglio al vero si sia apposto. Cel dica, o signori, la Rabbinica Enciclopedia, e in particolare il Talmud. Cel dica, in secondo luogo, il deposto degli antichi geografi e l’autorità dei viaggiatori. Cel dica e la paziente disamina dei Filologi, e la scienza talmudica (e nello invitarvi a bere con me a questo fonte, nel potere ad autorità invocare il libro che tanti e tanti ebbero ed hanno in dispetto, difendere io non mi so da un innocente sentimento di orgoglio, che il rigoroso ascetismo del Passavanti non temeva qualificare di santa superbia): cel dica il Talmud in quei tanti e concludentissimi passi da me con grande studio raccolti, ove, ad onta dell’asserzione del Basnage, la esistenza di una regione così chiamata vien posta in splendidissima luce. Cel dica il trattato di Sanhedrin, ove di due Dottori si narra che, a determinare le Neomenie e le feste, convenivano insieme a moltissimi altri, in una spezie di concilio che una città vedeva allor celebrare, la quale il nome reca veramente di עסיא Asia: cel dica ivi stesso, ove di un altro Dottore si narra R. Meir, il quale in altra congiuntura si recava nella stessa אסיא Asia all’effetto medesimo. Cel dica nel trattato di Mesiha, ove invitando un Dottore alla fuga, onde all’obbligo sottrarsi di ministrare a certi offici edilizj, Tuo padre, così gli dicono, rifugiossi in Asia, e tu cerca riparo in Laodicea. Che più, o signori? Cel dicano quei passi ove, volendo far comprendere ai contemporanei a quali popoli, a quali terre corrispondono i popoli, le terre nel Genesi rammemorati, ci offre il più curioso ed interessante spettacolo dei primi degli iniziali conati che la scienza etnografica andava facendo per organo dei Dottori, e nuovo lustro e nuovi raggi aggiunge se è possibile alla loro corona. Il Talmud babilonico—il gerosolimitano, il Comento perpetuo che si chiama Medrasce, opera pur essa Palestinese, la Parafrasi[12] di Gerusalemme, tutti, o signori, i primi albori ci offrono della Etnografia nascente, cresciuta, come sapete, ai nostri tempi gigante; e tutti della presenza attestano della contesa עסיא Asia. L’attesta il Babilonico in Batra, laddove ingegnandosi tradurre con nomi nuovi l’antico Cheni, Chenizi, Cadmoni, da Dio ad Abramo promessi nella sua discendenza, ci offre nel secondo di questi nomi il desiderato Asia. L’attesta il Talmud di Gerosolima, laddove a Cheni sostituisce Asia,—a Chenizi Apamea,—e Damasco al Cadmoni. L’attesta il Medras alla sezione 44, ove si riproducono i nomi stessi se non l’ordine istesso del Gerosolimitano. L’attesta infine il Parafrasta di Gerusalemme, ove il nome istesso ci porge di Asia, in ciò solo però dagli altri discorde, che lo equivalente egli ne fa dello antico Aschenaz. Innanzi, o signori, a questo bello e generoso adoprarsi dei Dottori a far convergere al luminoso centro delle Scritture tutti i rai dello scibile, due pensieri l’animo mio tutto intero si assorbivano. Io dissi da principio: È egli possibile, dopo tanti e solenni esempj, più a lungo il divorzio protrarre tra la scienza e la fede; e protrarlo (lo che è a dismisura più enorme) sull’autorità fondandosi e sull’esempio degli stessi dottori? Ripiegando poi l’animo mio verso il subbietto in discorso, io dissi a me stesso: Volle il Salmasio il nome Esseni da quello di Essa originare.—Lo negò il Basnage, e solo il Talmud parve al primo dei due consentire. Dovrà ella la questione rimanere in pendente? Dovremo noi la sola autorità del Talmud opporre al Basnage, a costo di udirci intimare solenne declinatoria? Immaginate voi, o miei giovani, l’ansia che assalisce il viatore quando, dopo mille disinganni, qualche caro pronostico gli ripromette la terra vicina? Or bene, tale io mi feci nella ricerca di una rovina, di una memoria, anzi di un vocabolo solo. Questo nome, o signori,[13] finalmente spuntò. Non solo Tolomeo asserisce essere stato il nome di Asia particolarissimo alla Frigia, ma l’autorità eziandio mi soccorse ben tosto di nomi, di autorità ben altrimenti sonori, che non è in oggi l’esautorato Tolomeo. Egli fu il celebre orientalista Klaproth, che mi mise il primo sulla buona via. Egli, nella Cronaca caucasiana da esso pubblicata, mostra lo stabilimento in quelle regioni sino da epoche remotissime di un popolo detto Osi, o meglio Asi, come piuttosto crede il suddetto Klaproth. Non basta. Il Dubois era più esplicito; egli, nel suo Voyage autour du Caucase, questo formalmente ci fa sapere, cioè che il nome di Asia ha esistito in epoca remotissima, qual denominazione locale particolarissima della parte settentrionale della catena caucasiana.[3] Perchè tanto studio a rivendicare la esistenza di tale sconosciuta regione? Forse, o signori, perchè io soscriva interamente alla origine dal Salmasio immaginata? Il processo del mio dire vi mostrerà che così non è veramente. E perchè? Perchè niuno, che io mi sappia, antico, originario legame il nascimento della Setta congiunge colle province dell’Asia minore. Ora, o signori, chi non lo sa? egli è proprio delle sètte quel nome assumere che più aperto n’esprima il genio, e il principio nativo, in quella guisa istessa che ognuno di noi quel nome porta con sè chè recò in sul nascere. E tanto esser dee avvenuto per quel degli Esseni. E poi, o signori, quante altre e potentissime ragioni non avversano la ipotesi del Salmasio! L’avversa il costume che ebbero, sto per dire generale, tutte quante le Sette, di tôrre a preferenza quel nome o che il fondatore ricordasse, o che più alla mente pingesse l’indole, il carattere, il genio ideale, anzichè il luogo, la patria, il paese ove prima ebbe i natali. Così voi dite, o signori, Platonismo, Epicureismo tra i pagani, e voi leggete tra le cristiane eresie i nomi[14] di Ario e Nestorio, le dottrine del Triteismo e del Monoteismo, e tra le filosofiche scuole voi usate rammemorare l’Idealismo, il Sensualismo, il Panteismo.[4] L’avversano, o signori, tutte quelle buone e salde ragioni che ci consigliano, come in seguito vedrete, a preferire diversa sentenza; e finalmente, l’avversa la più seria, la meno oppugnabile difficoltà che si potria contro un sistema suscitare. E sapete qual’è?—La prova del contrario. Invero, che dicono, le più antiche memorie della setta? Ove per la prima volta lo storico con gli Esseni s’imbatte, ove li trova, ove ne nota la prima presenza, i primi atti, la prima dimora? Altro che Frigia o Bitinia o altra qualsivoglia gentilesca contrada! E’ sarebbe come chi cercasse fuor di Roma il Campidoglio, l’Acropoli fuori di Atene, e il cuore umano fuori del centro vivificatore ove ha stanza ed imperio. La patria naturale, dirò anzi, necessaria dell’Essenato, è Palestina; e Palestina registra veramente la istoria qual primo teatro della loro storica apparizione. A Palestina aderirono costantemente gli Esseni, in quella guisa istessa che la più nobile parte di noi al frale aderisce per conservarlo in vita sin dove il militar le fu prescritto. Egli n’era l’anima, il genio personificato, condensato, ristretto; quindi tanto più espressivo: genio nazionale e religioso, ma religioso e ieratico sovra tutto, per i tempi volgenti a politico sfacelo, e pel predominio da lungo tempo avverantesi negli ordini ebraici dello spirito sulla materia, del generale sul particolare, dell’eterno sul temporaneo, del Cielo sopra la terra. Egli è quindi nel giro della patria Palestinese che l’origine e il significato dobbiamo cercare del nome di Esseni.
Ma per entro agli stessi confini di Terra santa, non è così unanime il sentire, che tutti in una origine si quietino gli indagatori delle Esseniche antichità, nei confini[15] di Palestina. Tra le quali, una mi piace per questa sera considerare, che non piccola fama nè piccolo stuolo di seguaci si trasse dietro nel consorzio degli eruditi. Chi il merito vanti del primato non so, ma egli è un fatto però che non pochi furono di coloro a cui tra gli Esseni e i Baitusei, altra religiosa setta di Palestina, parve vedere una perfetta identità. L’udì forse per la prima volta l’Italia, e dalla bocca l’udì di un Ebreo, di un Rabbino, di un Italiano. Egli era il nostro concittadino Azaria De Rossi, o, com’egli si diceva ebraicamente, Min aadomim, che nel secolo decimosesto seppe coltivare con tal successo la storia e l’erudizione Greca e Romana, che la fama ne corse e dura tuttavia onorata nel mondo erudito. Or bene, o signori, Azaria De Rossi fu quello che propose la identificazione perfetta dei Baitusei del Talmud coll’istituto degli Esseni. Non basta; egli ne vide il nome nel nome dei Baitusei. Questo nome di Baitusei, si scrive in ebraico Baitusim, o Betusim, secondo altra lezione. Or bene, l’occasione era troppo bella per un ingegnoso etimologista, e il De Rossi non era uomo da lasciarla fuggire. Egli scrisse in due parti il vocabolo Baitusim; divise Bet da Usim. Di Bet egli fece Casa, Istituto, Sodalizio, Società; di Usim fece il nome proprio, l’appellativo istesso di Esseni. Ecco che cosa fece il De Rossi, schiudendo in questa via la strada a quelli che in processo di tempo la percorsero intiera. Vi entrò per primo il Fuller, che alla sentenza soscrisse del nostro Rabbino. Vi entrò quasi ai nostri tempi il Gfroëre, dotto tedesco, nella celebrata sua istoria, Critica del cristianesimo primitivo, a pagine 347; e tanto reputò la congettura avverata, che precipuo argomento ne trasse a provare tra le due sètte perfetta, intera omogeneità di carattere. Convien dire però, o signori, che tale non sembrasse a parecchi altri, nè di minore rilievo, che delle origini Esseniche[16] presero a trattare. Io non dirò di altri che il precessero; ma se ultimo fu, certo non meno formale si pronunziò contro l’asserta origine Baitusea, l’illustre Franck, che onora in Parigi il nome e la dottrina Israelitica. Egli, il Franck, nella terza parte dell’opera sua la Kabbale, ou Philosophie religieuse des Hébreux, formalmente la respinge. Io credo che in questa, come in altre cose moltissime, abbia colto nel segno.—No, o signori, fintanto che luce non sarà tenebre, nè il giorno in notte converso, Baitusei ed Esseni non saranno giammai una cosa sola, un istituto, un sodalizio. Riflettete all’opinione costante universa prevalente negli antichi e nei moderni tempi della esistenza di un individuo, di un eresiarca famoso per nome Baitos, fondatore o vogliam dire caposetta della fazione Baitusea;[5] esistenza, o signori, che, come vedete, la possibilità perfino ci toglie di scindere, di notomizzare l’indiviso e personale distintivo dell’eresiarca Baitos.[6] Riflettete, infine, che i Baitusei non sono tali sconosciuti e incompresi settarj, che sia lecito alla ventura fantasticare sul conto loro; che note non ci sieno le lor dottrine, note le divergenze dal centro ortodosso, noti i caratteri, note le costitutive e naturali fattezze,[7] e troppo ristretto quindi e troppo angusto il vallo riservato ad arbitrarii connubii.
LEZIONE TERZA.
Vi dissi, o signori, come il Fuller aveva dapprincipio sottoscritto alla opinione del nostro De Rossi, e come esso prestò omaggio alla etimologia Baitusea. Ma che? ben presto s’avvide su quanto fragile fondamento posasse la preaccennata opinione. Narrò ai dotti impazienti come il vocabolo Esseni significasse uomini ritirati, ascosi, e poco mancò non dicesse solitarj e romiti. Non è difficile ch’egli dedotto avesse il nome Esseni dal vocabolo Asam, che in ebraico significa ripostiglio; o, meglio, che dalla radice ne ripetesse l’origine, che l’idea esprime veramente di tesaurizzare e nascondere, siccome Isaia (XXIII) aveva detto, di questo vocabolo giovandosi, lo ieazer veló iehasen. La nuova etimologia del Fuller riunisce ella, o signori, tutte le desiderate condizioni di credibilità? Rispond’ella a tutte le esigenze grammaticali, critiche, storiche e dottrinali? Quanto alla prima, io vo’ dire alla convenienza grammaticale, sarebbe ingiustizia il dirne male. Ben altre etimologie, e ben altrimenti arbitrarie, furono propalate qual prezioso e pellegrino trovato. Ma potranno dirsi egualmente contenti la critica, la istoria, e il genio e l’indole generale delle sètte? La critica potria invero, ponendoci un poco di buona volontà, chiamarsi contenta; potrebbe ricordarsi la critica come i Talmudisti dicessero[20] appellativo glorioso quello di hobesé bet amedras, che suona gli studiosi reclusi; come uno tra essi celebratissimo recasse il nome di Hanen il recluso, Hanen anehba; come di parecchi si narri nel Talmud di Gerusalemme, avere eglino menato della vita gran parte, nel fondo di una grotta, tamir bimhartà: e infine potrebbe con cert’aria di trionfo notarsi come i diletti di Dio, i suoi servi, i suoi fedeli, siano detti a dirittura nei Salmi, i reclusi di Dio, i nascosi di Dio. (Salmo 83.)
Ma che per ciò, o signori? Io ripeterò ciò che parmi aver detto altre volte. Questi curiosi ravvicinamenti, questi tratti di luce, queste inaspettate e brillanti conferme, possono, in progresso di tempo, avere sovrapposto sul fondo primitivo un nuovo senso che nè al vocabolo ripugnava nè al costume degli Esseni. Ma può esserne stato, o signori, cotesta la naturale e propria e primitiva intelligenza? Io non lo credo; e per addurre due potentissime ragioni, ella è, in primo luogo, la considerazione per me capitale che gli Esseni così facendo, dissentito avrebbero dall’andazzo comune di ogni setta, la quale quel nome a preferenza si appone che il genio intimo e la natura sua propria e il carattere prominente stia a significare, anzichè un uso o una qualunque consuetudine, per quanto grande e peculiare si voglia imaginare. Ella è, in secondo luogo, la formale e contradittoria deposizione della istoria, la quale, siccome a suo tempo vedremo, non solo della vita reclusa, del genio cenobitico non fa costume proprio inseparabile dagli Esseni, ma gli Esseni stessi ci addita talvolta negli affari e nelle transazioni mischiati della umana società, e bella e grande parte sostenere sì nelle politiche, come nelle religiose faccende.—Il fatto, o signori, la reclusione, la vita cenobitica, cade qual integral requisito dell’Essenato; e con esso cade la etimologia del Fuller sur esso fondata.[21] Altra ne escogitò lo Scaligero, e fu quella di Santi. Che ciò significhi il nome di Esseni, non oserei sostenere, comecchè io vada persuasissimo che tra i nomi che recarono gli Esseni, fu quello di Santi; come, da un lato, ne fanno fede le numerose menzioni che sotto questo nome appunto ne fa il Talmud, segnatamente là ove si parla della Santa Società, Keilla caddiscia di biruslem; e come, dall’altro, non meno concludenti ne soccorrano all’uopo i tanti passi degli Evangeli, in cui i primitivi cristiani, usciti senza meno dagli essenici chiostri, s’intitolano Santi; e Santi è tra i nomi che gli storici attestano avere i cristiani nei primi tempi recato, molto prima che cristiani si dicessero in Antiochia.
Strana cosa avvenne poi ad un antico padre della Chiesa cristiana, a S. Epifanio. Non è già che la cognizione della vera e sana etimologia gli facesse difetto, che anzi egli la conoscea benissimo, egli la propose, la insegnò; ma non quotando nel possedimento del vero, cercò il nuovo ed incappò nell’errore. Stava a cuore ad Epifanio, siccome stette di poi ad altri moltissimi della sua religione, di noverare il nobilissimo Istituto tra quelli che la chiesa generò nei primi secoli; di cristianizzare, per così dire, lo Essenato, di svellere la gloriosissima pianta dal Monte Sion per innestarlo al tronco cosmopolita del cristianesimo, e questa cara e bella gemma strappare alla corona di Giuda. Però non rifinirono antichi e nuovi dottori cristiani di cercare alle loro pretensioni argomento; cercarlo nei fatti, cercarlo nelle dottrine, e di queste vedremo; cercarlo poi nell’etimologia, e di questa adesso vediamo. Il primo a dar il segno della propaganda retrospettiva, fu, come dissi, Epifanio. Egli nel nome Esseni trovò Iesse genitore di Davide; anzi, in grazia di esso, il nome di Esseni in quello mutò più alle sue viste affaciente di Iesseni. Gli parve poco. Gli parvero troppo[22] remoti, troppo indiretti i rapporti coll’oggetto che preso si aveva di mira. Egli osò; e di un balzo superò ogni distanza, e di un balzo strinse, confuse, identificò l’Essenato o il Cristianesimo; e quello, come questo, derivò dal nome di Gesù, e gli Esseni disse da Gesù appellati, siccome quelli che alle dottrine sue preso avevano ad ubbidire. Dante, o miei giovani, disse in alcun luogo della Commedia, negarsi talvolta dagli uomini ossequio a quel ver che ha faccia di menzogna; nè la mente errò, così dicendo, del divino Poeta. Dante, avria potuto dire con egual verità, che spesso quest’ossequio si concede, si prostituisce a quella menzogna che ha faccia di verità. Ma quella di sant’Epifanio ha ella almeno, o signori, di verità la sembianza? Io dico che ella reca distinto il suggello dell’errore, dell’arbitrario. Chi mi sa dire, invero, quale delle due sue interpretazioni riesca più a udir tollerabile? È ella forse la prima, è ella quella che da Iesse padre di Davide l’appellazione ripete degli Esseni? Ma qual rapporto, di grazia, fra l’antico Betlemmita, e il grande e il dotto istituto degli Esseni? È ella la seconda che da Gesù, il nome conia di Esseno, di Essenato? Ma vuol dunque egli, sant’Epifanio, la baia dei fatti nostri? Che un padre della chiesa, che un Epifanio non voglia soscrivere alla sentenza di parecchi tra i moderni che Gesù vogliono anzi educato, ispirato nella società degli Esseni, questo di leggieri si comprende; ma quello che non si comprende, questo si è, o signori, cioè come ignorasse Epifanio, che mentre gli Esseni mangiavano, bevevano e panni vestivano, il modello d’onde tolsero, al dire di lui, a foggiare il nome loro, il preteso denominatore della setta, giaceva tuttavia latente in grembo al futuro; ch’è quanto dire che Gesù Cristo non esisteva: e non occorre aggiungere che, salvo quei rarissimi casi in cui tutto collima ad attestare la verità di[23] un supposto, non è concesso a chicchessia, fosse pure un santo, detrarre o aggiungere una jota, siccome egli fa, veramente nel nome che si vuol decifrare. Or, chi ha egli abilitato Epifanio a cangiare il nome di Esseni in quel di Iesseni? Ecco, o signori, le cause, le gravissime cause che ci interdicono lo assentire alle arbitrarie interpretazioni di Epifanio.
Vi fu, o signori, chi accettando la lezione di questo Padre, e chiamando lo antico sodalizio Iesseni piuttosto che Esseni, una interpretazione v’innesta che ha, se non altro, l’apparenza di plausibile. Volle il Nilo che Esseni si dicessero nel significato di Dotti e di Savi. D’onde una siffatta etimologia? Egli vide la Sapienza denominata nelle sacre scritture col nome implicito di Ies; dico, o signori, implicito, perchè la forma e lo involucro esteriore suona piuttosto Tuscia, comunque universa predomini la opinione, inchiudervisi qual radice il vocabolo significantissimo di Ies. Che vuol dire Ies, o signori?—Ies è il vocabolo che esprime l’Idea più astratta, l’Idea, sto per dire, più ideale—l’Idea massima—l’Essere—l’Essere metafisico, incondizionato, indeterminato, e come direbbe il Rosmini, l’Ente Possibile.—Ma Ies esprime eziandio, voi già l’udiste, l’Idea di Scienza, di Dottrina, di Pensiero per eccellenza; attalchè, per una ammirabile e notevolissima sinonimia, acchiude nel proprio senso il duplice significato di Essere e di Pensiero. Voi non potreste misurare la immensa importanza di questo bellissimo trovato filologico senza molte indispensabili precognizioni filosofiche; che dico? senza alle più alte cime poggiare della odierna filosofia Alemanna, senz’almeno toccare del rinnovatore delle filosofiche discipline, di Cartesio, che poneva a base del suo sistema il famoso Cogito, ergo sum: Penso, dunque esisto;—senza risalire almeno a Platone che, nel decimo delle leggi, domandava[24] che cosa è l’Essere Primo? e rispondeva l’Essere Primo, è l’Idea—è il Pensiero;—senza accennare almeno ai Dottori, i quali videro nel Ies promesso ai giusti in Paradiso, leanhil oabai ies, l’Essere Perfetto e il Perfetto Pensiero, cioè la Visione.[8]
È egli questo lavoro, o signori, che intraprendere si possa e compire tra due parentesi? Il vostro buon senso ha già risposto per me. Io voglio soltanto che impariate da questo esempio, quale sterminata latitudine abbracciano le lettere ebraiche; come in fondo ad un oscuro vocabolo ti si apra non di rado agli sguardi atterriti tale profondo e smisurato abisso, da darti, al solo vederlo, il capo-giro; come gli spregiatori di queste frasche pretese, sieno tanto savi quanto il villano che d’uno sguardo non degna la minutissima polve stellare che si chiama Nebulosa, alcune poche palate anteponendole invece del suo caro concime. Fatto è, o signori, che Ies adombra l’Idea di una scienza sublime, di una scienza nella sua perfezione immanente; e chi solo ne dubitasse potria vedere i più rigidi ed esclusivi gramatici, il Kimhi tra gli altri, nei suoi Radicali.
Si apponeva egli, o signori, il nostro Erudito nel derivare da questo vocabolo, l’origine di quel di Esseni? Senza dubbio, che qualche giusta e calzante analogia milita in favor suo. Il favorisce, o signori, l’Ebraico Jesciscim, al plurale Vecchi, o come altrimenti si voglia, Anziani, nei quali, dicono i Proverbi, posta ha seggio la Sapienza: bisciscim hohma. Il favorisce lo esempio dei Pitagorici, coi quali non pochi nè lievi riscontri ci offrirà il nostro Essenato, che il nome i primi coniarono ed assunsero eglino stessi per tempissimo, di filosofi, ossia cultori ed amanti della sapienza: e quando ogni altra analogia venisse meno, quella sorgerebbe viva e parlante di tutto il Dottorato Ebraico, che la caratteristica[25] distinse mai sempre di Hahamim, savi. Dirò anzi di più, che per questa come per alcuna fra le altre etimologie da noi rigettate, noi rechiamo sentenza che i nomi che vi si volle trovare, se non esprimono il senso di Esseni, pure tornano in acconcio al grande Istituto, e per, alcuni almeno, probabilmente il contraddistinsero. Di questo novero è il nome di Savi, di Dotti; diciamolo a dirittura, di Gnostici. Noi che crediamo gli Esseni antenati dei Cabbalisti, la cui scienza essi chiamarono Gnosi o Scienza per eccellenza, come chiamarono la propria e il Cristianesimo e le prime Eresie; noi che ricordiamo nel Talmud cento parlantissimi casi in cui il nome di hohma o Gnosi è usato manifestamente nel senso di Dottrina Acroamatica, non potremmo negare la convenienza di questo nome all’istituto degli Esseni. Ma è egli questo che il nome loro significa? Chi non lo vede? Ies, Iascisc, Tuscià, nel senso pure più favorevole alla imaginata derivazione, sono vocaboli che appartengono principalmente al linguaggio sublime, allo stile, per così dire, nobile, poetico, aulico, aristocratico della Scrittura. È ella questa la officina ove i nomi si coniano per l’ordinario, che scuole e sètte contraddistinguono? La Storia vi risponde al contrario. Parole vive, parole usate, correnti sulle labbra del popolo; parole pregne di senso, multiformi, multilatere e in sommo grado comprensive; ecco, o signori, il materiale donde si foggiano i nomi, le qualificazioni delle sètte. E tale non è la proposta derivazione.—Ella è troppa dotta, troppo classica, troppo studiata, per esser vera. È anche, dirò di più, troppo biblica, troppo scritturale, per tornare in acconcio nella epoca Rabbinica per eccellenza, nella quale sotto questo nome ti apparisce a prima volta lo Essenato;—per consuonare con quella lingua dai Dottori parlata, che se non è il dialetto Ebraico-rabbinico[26] dei tempi posteriori, è certo immensamente distante dal biblico purismo; con quella lingua insomma che mirabilmente tramezza
Fra lo stil de’ moderni e ’l sermon prisco.
Ancora, o signori, ulteriore esame ci attende, e noi abbiamo finito.
Egli è un curiosissimo passo che la mia stella propizia mi parava dinanzi nel volgere e rivolgere a questo uopo le carte; un passo, io dico, sugli Esseni rilevantissimo, nella più dotta descrizione che della Grecia vetusta ci abbia tramandata l’antichità, in un autore greco egli stesso, in Pausania. Egli, nella descrizione dell’Arcadia, discorrendo del celebre Tempio di Diana Imnia nella regione degli Orcomeni, alcune cose va esponendo di cui disconoscere non si potrebbe la importanza. Narra Pausania, come stabilito fosse dalla legge che la sacerdotessa e il sacerdote, non solo circa il commercio carnale, ma in tutte le altre cose ancora dovessero serbare la castità per tutto il tempo di vita loro; che nè il bagnarsi, nè vivere secondo gli altri, nè entrare nemmeno nella casa di un privato fosse loro consentito. Giunto a questo punto, Pausania esce fuori con queste parole che io vi raccomando, che riproduco testualmente, ed alle quali vi prego attendere tutti in orecchi.—Io so, dice Pausania, che queste cose (ch’è quanto dire il celibato, la solitudine e la vita in tutto singolare di sopra rammentate) osservano presso gli Efesi, per un anno non per tutta la vita coloro i quali sono Estiatori di Diana Efesina, e che dai cittadini, Esseni, sono chiamati Tanto è. Pausania ha pronunziata la gran parola! La parola di Esseni! e l’ha profferita a proposito non già di Solima e delle sue sètte, ma di Efeso, ma del culto di Diana, ma del prisco Politeismo.
Ove siam noi, o signori, e che cosa significa questo stranissimo incontro? Siamo in Efeso? Siamo in Palestina? È Diana che qui si adora, è l’Eterno che qui si cole? Sono Ebrei cotesti, sono Pagani? Voi siete già, o miei giovani, non è egli vero, alquanto sorpresi. Or bene, permettete che vi dica che tutto non avete udito. Avete udito, è vero, i sacerdoti di Diana Efesina qualificati Esseni; intenderete adesso, cosa più strana, intenderete un Dio, un Dio del Paganesimo, il più grande degli Dei dell’Olimpo, l’Ottimo, il massimo Giove, Esseno egli stesso esser chiamato. Chi gli diede questo nome inatteso? Chi operò questo strano connubio? Egli è il poeta Callimaco, a cui gli antichi e i moderni tempi concessero fama di dottissimo nelle greche antichità. Egli è Callimaco che così si esprime nell’Inno a Giove che reca il suo nome. Callimaco, che insieme a Pausania ci attesta la presenza in seno al paganesimo di un istituto, dirò di più, di uno stato di straordinaria perfezione che dai popoli, dai poeti, Esseni ed Essenato eran chiamati. Che vuol dir ciò, o signori, e quale è dello Essenismo la chiave? La chiave, o signori, è pronta. L’Edipo si è trovato. Egli è lo Scoliaste, ch’è quanto dire l’autore delle Scolie o commenti alle Poesie di Callimaco. Egli lesse come noi il Giove Esseno di Callimaco; ad esso, come a noi, sembrava strano, incompreso l’epiteto; ma egli meglio di noi nelle greche lettere erudito, potè coglier più davvicino nel segno.—Narra lo Scoliaste, come il vocabolo Esseno—notate, o signori, singolarità,—fosse vocabolo vecchio, usitato in Efeso; e di che lingua credereste? Forse della lingua greca? della lingua popolare? Signori no, dice lo Scoliaste, della lingua Religiosa. E che significa in questa lingua, di grazia, il nome Esseno?—Significa, ripiglia il nostro chiosatore, significa Re delle Api, e in questo senso fu conosciuto, fu[28] usato nei prischi tempi. Però non guari andava, continua lo Scoliaste, che il senso assunse di Re, di Monarca in generale, e Monarchi e Re furon detti Esseni. Ma una nuova trasformazione il vocabolo Esseni attendeva, e non è la meno importante. Venne tempo in cui per dir Re, Sacerdote, Principe dei sacrifizj, Preside nei sacri agapi o nei religiosi conviti, Esseno generalmente solea dirsi. Esseno, quando l’officio si voleva indicare che in Atene eserceva il Re Arconte; Esseno, quando quello che in Roma sosteneva il Rex Sacrificulus.
Questi sono i fatti, o signori, e dei fatti interprete fedelissimo finora mi sono reso. Èmmi dato perciò muovere un passo più oltre? potrò io scoprire quali relazioni possono avere stabilito questa comunanza di nome, e in parte questa comunanza d’idee, tra l’Essenato Palestinese e il sacerdozio dell’Asia Minore? Io confesso che non mi sento da tanto, nè tanto mi consentono le notizie di cui io dispongo, nè le forze nè il tempo nè la già stancata pazienza vostra. Il fatto, o signori, è grande e vistoso, e tale da provocare gli ingegni più felici, e da meritare le indagini più accurate. Noi lo lasceremo per altra volta intentato: forse non ci sarà disdetto rivolgerci sopra altra fiata la mente. Per ora mi basta chiamare la vostra attenzione sopra questi tre punti, secondo me, capitali. Il primo riguarda il luogo. Quale è il luogo ove udiste risuonare il nome di Esseni? È, voi lo sapete, l’Asia Minore; quell’Asia, cioè, ove vedemmo sin dalla prima lezione sorgere una città per nome Asia, da cui fu creduto per alcuni derivato il nome di Esseni; ove traevano, come avete veduto, i più eletti campioni del nostro Dottorato a celebrarvi la fissazione e la proclamazione delle feste, e la intercalazione del nuovo mese. Questo è, o signori, il primo punto. L’altro fatto di non minore rilievo, è il vocabolo ebraico[29] Hassen, il quale non solo, come l’Efesiano Esseno, suona in genere forte, illustre, magnifico; non solo è posto al fianco di Nezer, Corona, e vi officia qual sinonimo, secondo il genio del parallelismo ebraico, chi lo leolam hasen veim nezér ec. ec.; ma, ciò che pone il colmo alla nostra ammirazione, è il vedere nei salmi Dio, Dio nostro, il Dio vero chiamato Dio Hassin, in quella guisa che facendosi organo del pensiero ieratico dei sacerdoti di Diana, chiamava Callimaco il greco Giove, Giove Esseno; parola non greca, non popolare, ma vocabolo vecchio, ma vocabolo della lingua religiosa, siccome udiste dalla bocca di Callimaco stesso.[9] E questo è il secondo punto. Venga il terzo adesso, e chiuda di queste riflessioni la serie.
Il terzo è quell’accordo mirabile di cui misurare non potete sin d’ora la estensione, ma che vedrete tra non molto evidente tra parecchi dei costumi agli Esseni di Efeso da Pausania assegnati, e quelli di cui la Storia favella degli Esseni Palestinesi. Il Celibato—La Solitudine, e sopratutto l’officio, il genio religioso che rappresentano, sono altrettanti legami che l’una all’altra stringono le due lontane e sconosciute istituzioni. Quale è la conseguenza che da tali fatti scaturisce spontanea? Io dissi come troppo soffriamo inopia di ulteriori notizie per decidere autorevolmente delle origini recondite, per assegnare di queste curiose coincidenze la prima cagione. Noi da questa doverosa riserva non ci partiremo. Hanno sempre, hanno tutti a questo proposito seguita una sì facil a un tempo e sì difficil virtù? Mi duole dirvi che non fu sempre seguita. Sedotti da queste parventi e preziose analogie, si attentarono alcuni autori a sentenziare a dirittura la medesimezza, che dico, o signori? la filiazione e derivazione immediata della società degli Esseni palestinesi dalla corporazione sacerdotale degli[30] Esseni di Efeso; e ciò che vi parrà senza dubbio enorme, non temettero di asserire l’origine e il carattere intimamente pagani del grande, del bello istituto degli Esseni. Siamo noi condannati a sottoscrivere ciecamente ai costoro novellamenti? Siamo noi così al verde di prove, di argomenti, che dobbiamo accettare l’origine pagana che agli Esseni si vuole assegnare? Fortunatamente, nol siamo; e che nol siamo veramente, non è da ora che il potete vedere; non è da ora che noi dobbiamo affrontare la grande questione della origine. Se ne ho fatto menzione da ora, sapete, o signori, perchè? Perchè questa strana, questa folle pretensione, non d’altro prendeva, a così dire, le mosse, che dal fatto di una concordanza etimologica, da una pretesa identità di vocabolo. Vedete che cosa vuol dire una falsa etimologia. Eccone, gli effetti. E quali effetti! La più grande mentita alla istoria; la più solenne contradizione ai principii più ricevuti; la più grande eresia storica che sia mai uscita da labbro mortale. Aveva io ragione di crollare, anzi tutto coll’etimologia, le basi degli avversi sistemi? Aveva io ragione di attaccarmi corpo a corpo alle parole, e bandire, per così dire, una guerra gramaticale? Guerra che ha forse avuto presso di voi l’aria di puerile, di sofistica, di pedantesca; ma che pure è suggerita imperiosamente dall’assunto, e che noi con queste parole abbiam condotto a buon fine.
Prima però di chiudere questa discussione sul valore del nome Esseni, non possiamo tacere di un dotto Israelita vivente, distinto non meno per l’insigne officio che egli onora, che per la scienza e l’erudizione sua vastissima. Egli è questo l’illustre signor S. J. Rapoport, Rabbino maggiore di Praga. Egli, nel suo gran Lessico Rabbinico, Ereh Millim, e di cui solo una brevissima parte mandò già alla luce, tocca del significato del nome[31] Esseni ove ragiona del vocabolo Iso, che s’incontra di frequente nel Talmud; ch’egli fa derivare dal greco ισος Amico, Confidente, e da cui, egli dice, si trae a buon diritto uno dei due soli significati plausibili del nome dell’antica società degli Esseni.[10] Egli ci promette di meglio svolgere il suo concetto al vocabolo Haber. A noi torna sommamente gradevole il poter annoverare il dottissimo uomo tra quei che vorrebbero vedere nei Haberim del Talmud gli Esseni medesimi, siccome pare volere accennare l’illustre israelita, e se male non ci apponiamo, egli è questo un nuovo omaggio a quella identità essenico-farisaica che sarà obbietto di perpetua dimostrazione nel presente lavoro. Quanto al nome di Iso, amico, confidente, d’onde il nome di Esseni sarebbe derivato, non parmi trovato così felice come pare al dotto autore. Scarsa e dubbiosa consonanza col nome di Esseni o Essei concordemente usato dagli antichi; improbabilità che per designare un particolare sodalizio, quel termine si sia adottato che vale a significarne ognuno qualsiasi; le allusioni che sotto il nome di Assé o Asia vedremo fare dal Talmud alla società degli Esseni, locchè prova come nella mente dei contemporanei meglio da Asia medico, che da qualunque altro il nome suo derivasse; sono queste, o signori, considerazioni, e tutte gravissime, se non erro, che ci tolgono di potere sottoscrivere alla sentenza del signor Rapoport. Non pertanto, ella è quella che noi abbracceremmo volentieri, se altra non fosse che meglio ci paresse riunire le condizioni della verosimiglianza, e s’ella non è la vera, ella è certo la migliore di quante abbiamo udito sino qui profferire.
Che ci resta ora, o miei giovani? Saziare gli occhi nel dolce aspetto di verità. Trovare, additarvi che cosa intesero gli Esseni dandosi questo bel nome che la virtù e la sapienza loro han renduto immortale.
LEZIONE QUARTA.
Io vengo, o signori, a mantenere la mia promessa. Il nome di Esseni deporrà questa sera ogni velo che ne contende la vista, e tutto ci apparirà quale prima immaginaronlo gli antichissimi Esseni. Che cosa significa questo nome? Esseni (diciamolo una volta, ed all’asserzione seguano immediatamente le prove) Esseni fu detto da Assia, o Asse, che nella lingua Aramea, nella lingua talmudica, nella lingua da Babilonia a Gerusalemme importata e quivi a favella promossa pressochè generale, significava Medico, Risanatore, o come dire vogliamo in greco idioma, Terapeuta. Voi fate, o miei giovani, le meraviglie ed avete ragione. Io non mi sono ancora abbastanza spiegato per avere il diritto d’essere a prima fronte creduto da voi; la mia ipotesi non ha fatto ancora le sue prove, non vi ha presentato i suoi certificati in buona regola per concederle incontrastato della mente vostra l’accesso. Il vostro pensiero europeo, occidentale, positivo, analitico, non può farsi issofatto un’idea degli arditi, dei bruschi passaggi, delle repentine conversioni dal senso proprio a quello improprio di una parola; e tanto meno potrebbe al primo sguardo afferrare tutta la serie infinita di applicazioni, di accessorj, di ramificazioni, in cui l’Idea madre si traduce di mano in mano; in cui, quasi in un ampio ed opaco[35] mantello, si va sempre più nascondendo all’occhio dei riguardanti. Leviamo un lembo di questo velo,—mostriamo un raggio di quell’evidenza di cui brilla, a senso mio, la presente interpretazione. Io dissi esser ella eminentemente consentanea alle idee, alle forme dei sommi, antichi predicatori dell’Ebraismo. Ma che cosa è l’Ebraismo? L’Ebraismo non solo è una Religione, non solo una Civiltà, non solamente una politica, una legislazione, una letteratura; ma, tollerate che io lo dica, ed ho prove nelle mani, è anche una Terapeutica, un’arte, una scienza salutare. Lo è dei corpi,—lo è degli spiriti. Lo è dei corpi in doppio modo, in doppio senso, per doppio scopo. Pel primo, ella non fa che antivenire coi suoi celesti preservativi i mali onde i popoli vanno afflitti; ella promette per bocca di quanto ha di più adorabile, che tutte le piaghe, le infermità dell’Egitto sarebbero senza possa sopra i suoi fidi seguaci; che Dio, ne sarebbe il grande archiatro, il gran medico, il gran Terapeuta.[11] Ella annunzia, qual conseguenza del culto di Dio, il pane e l’acqua salutiferi, la remozione d’ogni malore, non orbamento, non sterilità, e sopratutto una vita longeva; ella, infine, tutto il suo culto adombra sotto una frase che l’idea ci offre viva, spiccata, di una salutar disciplina; anzi, che significa a dirittura Terapeutica nel nome, o signori, di Terafim, la quale comecchè rivolta fosse ad uso idolatrico, pure in principio alla fede vera appartenne, e il magistero degli oracoli divini e tutto l’insieme del culto valse a designare;—in quella guisa che Kesem, e forse per avventura anche Nahas, prima di essere espressioni colpevoli e termini idolatrici, furono vocaboli innocentissimi di religione;—in quella guisa che l’idolatria stessa non è che abuso e adulterazione ed apoteosi parziale di un principe ortodosso. Ella annunzia per bocca di Salomone, che le sue[36] dottrine, il suo culto, sarebbero il palladio della salute corporea, e l’antidoto più efficace contro di ogni maniera infermità,[12] ed in questo senso, o signori, ella è interna, occulta, indiretta operatrice di sanità. Chi volesse di questo pronunziato sindacare il valore, chi volesse, al lume eziandio naturale, indagare di questi influssi le cause, troverebbe occasione di belle e amabili speculazioni. Montesquieu, e prima e dopo di esso moltissimi come lui, comecchè non così di reciso, videro nel clima, e poi nelle Istituzioni, la causa delle grandi e delle infinite varietà etnografiche fra popolo e popolo. Curiosissimo, poi, sarebbe studiare delle varie Religioni gli svariatissimi influssi sul corpo dell’uomo, e quella predicare sovrana tutrice dell’umano benessere, che più al segno si avvicina. Dico cotesto per persuadervi come le vantate pretensioni che udiste poc’anzi, non siano aerei edifizi che non poggino sovra basi reali e ferme.
Certo, o signori, questa Igiene per così dire trascendentale, estolle il capo sino al più sublime dei cieli, e certe segrete armonie suppone tra il corpo e lo spirito, le quali la scienza non sospetta nemmeno: ma se il capo si erge al cielo, i piedi posano in terra; se i suoi principj sono sovraumani e sovrasensibili, i suoi effetti, le sue leggi di second’ordine, il suo teatro, la sua applicazione sono sensibili, sono palpabili, nè la scienza li revoca in dubbio. Ma qui non si ferma il carattere per così dire terapico di nostra fede. Ella non è soltanto come vedeste un’Igiene, non solamente contra i morbi assicura e guarentisce, ma i morbi combatte sopravvenuti, ma la salute restituisce perduta, ma ella è una vera e propria Terapeutica che lo scopo suo prosegue con due ordini di mezzi.—Sono i primi mezzi naturali, scoperti, naturali medicamenti che il genio enciclopedico universale delle antiche Religioni restrinse ed accolse in grembo ai[37] tempj, fece banditori primi i Sacerdoti, ed a cui il carattere sacro appose, al primo apparire, di religioso e divino trovato. Sono i secondi quei mezzi cui l’arte umana verrebbe meno; sono quella dittatura instantanea che l’uomo ispirato assume, Dio consenziente, sopra il Creato; sono la taumaturgia propriamente detta; sono le guarigioni prodigiose del Vecchio Testamento; è Elìa, è Eliseo nell’atto di riaccendere la fiaccola che è per spegnersi nel povero infante. Chi furono, di questa doppia Terapìa, umana e divina, gli organi, i professori? Furono i Sacerdoti ed i Profeti.—I Sacerdoti, che più dimessamente procedono, e l’arte principalmente considerano e praticano dal lato umano; i Profeti a cui spetta per eccellenza la medicina straordinaria taumaturgica, che, nuovi Prometei, rapiscono di tratto in tratto il foco celeste per riallumare la lampada della vita. Vedete però, o miei giovani! sacerdozio e profetismo conscj ambedue delle prerogative, non vogliono rivali, non tollerano che altri l’impero divida che esercitan sui corpi. Non fu accademia così ostile alla importazione di nuove teorie, alla consecrazione di nuovi farmachi, che più nol fossero Sacerdoti e Profeti contro la medicina non officiale, non sacra, non religiosa. I Re d’Israele sono presi a biasimare perchè, piuttosto che consultare il Signore, gissero a interrogare la scienza spuria dei medicastri (Croniche II, Cap. XVI, 12), e, se crediamo ai nostri dottori, Ezechia Re santo avrebbe soppresso un intero trattato di Medicina che sotto il gran nome si ammantava di Re Salomone; ed allo stesso Ezechia affetto di scabbia, non sdegna il grande Isaia di prescrivere egli stesso quell’impiastro di fichi che ridonargli doveva la sanità. Ma Profeti e Sacerdoti cessarono.—Cessò forse la Medicina religiosa, nel doppio suo genio naturale e divino? si estinse forse con essi, o trasmigrava nei successori[38] dei Profeti, dei Sacerdoti? Così è, ai Profeti, al sacerdozio tenne dietro il Dottorato, e il Dottorato raccolse di ambedue il retaggio nella doppia Medicina naturale e miracolosa che insegnava ed esercitava congiuntamente. Naturale nelle infinite vestigia che di essa reca il Talmud, e tutta l’enciclopedia rabbinica dei primi secoli; arte se volete meglio che scienza, cieco empirismo anzi che principj e metodiche deduzioni, ma pure, o signori, tutti di medicina gli officj e tutte le parti; prodigiosa però in quelle guarigioni portentose taumaturgiche che sono, a così dire, uno strascico dell’Èra profetica, e che l’impero rivelano non del tutto dismesso dell’uomo perfetto sovra le forze create, che la Genesi augurava sin da principio (Genesi I, 28).[13] Ora, questa duplice Terapia, quest’uso simultaneo di mezzi così dispari, di semplici e di scongiuri, di virtù naturali e di angeliche potestà, questa terrena e celeste farmacopea, ella è, sappiatelo a dirittura, ella è il più vistoso, il più manifesto distintivo della scuola che togliemmo a studiare. Non è da ora, o miei giovani, che a noi è dato il vederlo; ma verrà tempo, e non è lontano, in cui queste cose ci saranno manifeste. Vedrete gli Esseni a questa duplice Terapia dar opera solerte; li vedrete studiar sulla natura, sulle virtù dei semplici e sulla composizione dei farmachi; li vedrete studiosi sui libri della recondita Medicina dagli avi loro trasmessa; li vedrete in una parola Esseni in tutta la forza della parola, che è quanto dire Medici—Medici, risanatori per eccellenza.
Questo è il primo senso in cui si dissero gli Esseni medicatori e Terapeuti. Ma non vi fu un altro, che il primo immensamente sopravanza in altezza, in nobiltà? Sì, vi fu; e tanto il primo trascende per ogni verso, quanto l’animo il corpo trascende, quanto la sanità,[39] la purità e la interna armonia dello spirito, quelle vincono di gran lunga che il frale riguardano. Gli Esseni non furono soltanto i Medici del corpo, ma Medici si dissero pure dell’animo umano. Era egli cotesto nuovo officio, nuovo vocabolo nella lingua religiosa dell’Ebraismo? Dite piuttosto che era antichissimo; che la Bibbia rigurgita di simili esempi; che lo spirito non meno che il corpo fu sempre dall’Ebraismo considerato siccome un ente che a tutte le vicissitudini soggiace, buone e triste, della vita; che ha la sua salute, le sue infermità, le sue crisi, le sue cadute, le sue ristorazioni, e quindi una vera e propria scienza mediatrice. Ma dite piuttosto che univoci attestano di queste idee predominanti i Profeti; che lo attesta Davide quando chiedendo la remissione delle colpe, e la rigenerazione dell’animo suo, chiede farmaco e guarigione, Guarisci l’anima mia, chè a te peccai;[14] che il Perdono è da Isaia dichiarato qual suprema sanatoria;[15] che lo stesso Isaia parlando nel nome di Dio, ci presenta il peccatore amnistiato qual malato medicato e guarito[16], che lo attesta, infine, Geremia e quasi al sommo reca la forza dell’argomento, quando il Profeta istruttore chiama col nome istesso di Rofé, Medico; e farmaco dice per avventura e teriaca preziosa la dottrina di lui.[17] Sono elleno men di questi frequenti, meno di queste eloquenti le prove che dai Rabbini si traggono? Hanno eglino con manco predilezione usate in questo senso traslato, in questo senso metaforico l’idea, il vocabolo di Medicina e i suoi derivati? Sarebbe ignorare assolutamente dei Dottori la fraseologia, il disconoscere di questa Idea, di questi traslati, gli esempj parlanti. Volete sapere che cosa sono le religiose dottrine per i nostri Rabbini? Sono potentissimi cardiaci pei cuori infermi; sono collirj pegli occhi oftalmici, e antidoto, in breve, efficacissimo[40] contro ogni malore. Ho io bisogno di avvertirvi che così magnificando delle religiose dottrine i privilegi a tutt’altro intendevano che ad una vera e propria virtù curativa? Voi già comprendete, o signori, a che cosa si allude. Si allude sotto il corpo allo spirito, si mira a traverso le infermità corporali, a quelle infermità che affliggono la parte migliore di noi medesimi: all’occhio della mente ottenebrato, al cuore fatto recesso d’ogni vizio. Che più, o signori? Se un dottore trova agli ignoranti della legge difesa nel dì della Resurrezione, egli chiama questo trovato Medicina, e trovai per loro guarigione nella legge:—se il pregio si vuol accennare trascendente di uno studio disinteressato, Farmaco si dice cotesto di vita Eterna, Sam haim; come tossico mortale si dice il suo contrario, ch’è quanto dire ministero religioso sostenuto per argento, Sam ammavet. Che volete di più? Non solo è il linguaggio tal quale ve lo descrivo, non solo idee siffatte di Terapia ricorrono ad ogni tratto, e più che non dissi ne riboccano gli antichi rabbinici monumenti; ma ciò che infinitamente si lascia dietro ogni prova, ciò che è lo specchio vivo e parlante dell’Essenato salutare e medicativo, è l’attitudine esteriore—sono le forme curiosissime, sono gli atteggiamenti espressivi, parabolici, figurativi, che prendeva talvolta il dottorato insegnante. Avete udito d’Isaia che seminudo percorre le vie di Gerusalemme, ed in sè raffigura gli Ebrei da esso vaticinati, che fuggono dalla spada babilonese? Avete mai letto di Ezechiele che, in realtà o in visione, si giace or da un fianco or da un altro, e i cibi ingolla che l’umor satirico divertirono per lungo tempo del filosofo di Ferney? Or bene—non dissimili da queste immagini parlanti ci offre talvolta il dottorato mimiche rappresentazioni, e la medicina n’è il subbietto. Vedete questo rivendugliolo che, andando attorno[41] per i villaggi che coronano Sippori, non rifinisce di gridare a squarciagola e quasi con piglio ciarlatenesco—chi vuol della vita lo elisire, venga e compri? Man bae lemizban sam haim. Chi è costui e quale è il mirabilissimo specifico che proferisce? È un farmacista, dice semplicemente il Medrasce, e nulla dell’esser suo aggiunge di più. Ma il farmaco che cosa è? Il farmaco ve lo darei in mille a indovinare. Pure se punto vi cale saperlo, salite qui.—Il pseudo farmacista è già nelle stanze entrato di un dottore il quale affacciatosi al noto grido, gli fece cenno dalla finestra, salisse pur su, che un confratello avria trovato con cui alternare i saluti e le soavi parole. Che cos’è, o gentil farmacista il Farmaco che tu ci vendi? Alla quale domanda ratto trasse fuora un salterio che sottopose agli occhi del dottore, dove questi detti si leggono significanti—chi è l’uomo che ami la vita, che giorni chiegga per esser felice? La lingua sua guardi dal male, le labbra dalla menzogna, ec. (Vaicra Rabba, sez. XVI.) Ecco il farmaco vantato. E pure, qual vero e proprio farmaco lo bandiva per terra e castello. E pure, a quel grido gran calca fattaglisi intorno di incettatori, la innocente frode per avventura disvelava, e testo prendeva di là ed occasione a moralizzare le turbe, in quella guisa che il fondatore del Cristianesimo ci dipingono gli Evangeli andando attorno per le campagne e le moltitudini accorrenti concionando di tratto in tratto dalla sommità di un poggio.[18] Vi pare che sia abbastanza decisivo cotesto esempio? E pure una circostanza vi manca sapere, ed è la più concludente. E quale è, o signori? É il nome vero, il vero ufficio e il vero carattere dello pseudo farmacista. Già voi sospettate che qualche cosa di più nobile sotto i panni si asconda del cerretano: già i fatti presenti parlano troppo in favor mio; ma la provvidenza ci serbava ancor più.—Per[42] una di quelle singolari coincidenze che nei libri rabbinici si dànno in mille volte, ciò che implicito rimase nel Medrasce, trovammo esplicito nel Talmud; ciò che col nome fittizio, supposto, quivi si designa di Rohel, col vero e genuino nome si accenna nel Talmud. In una parola, nel fatto stesso, ma più brevemente dal Talmud raccontato, il Rohel non è più Rohel, il cerretano non è più cerretano, ma è un vero e proprio dottore, un vero e proprio Fariseo, nomato Alessandro.
Aveva io ragione quando diceva, il concetto che suggerì l’appellazione di Esseni, profonde, vaste gettare le radici nei Profeti e nei Rabbini, nella Bibbia e nella tradizione? Io credo, e non è troppo presumere, che queste prove da sè basterebbero. E pure non sono le sole; vi sono analogie, vi sono concetti, vi sono appellazioni non dissimili nell’istesso paganesimo. Che dire della Biblioteca Egiziana? Domandatene ad Orapollo e poi a Bossuet, che la narrazione ne riferiva. Essi attestano concordi, come le Biblioteche si chiamassero in Egitto con nome che in quella lingua suonava medicina dell’anima. Domandatene Diodoro Siciliano. Egli parlando del sepolcro di Osimandia, vi dirà che tra gli appartamenti di quel palazzo era una sacra Biblioteca alla quale queste parole soprastavano incise: Medicina dell’anima. E per ultimo, le buone ragioni si guadagnarono i buoni autori;—la buona causa trovò buoni avvocati che la difendessero. S. Epifanio, che conobbe il vero, e amore del nuovo trasse fuori del cammin dritto; il sig. Munk, che nella Palestina alla interpretazione nostra fa ossequio; il Salvador, che esplicitamente vi assente nella grandiosa sua opera J. C. et sa doctrine, ed altri molti che sarebbe lungo annoverare; tutti intesero egualmente nel vocabolo di Esseni quel concetto di sublime, di superlativa Terapeutica, che noi v’intendemmo;[43] tutti vi prestarono ferma e ragionevol credenza: a guisa del ver primo che l’uom crede. Ella è, infine, una deposizione il cui valore non sarebbe possibile dissimularsi. Non è da ora che non possiamo insistere sulla identità originaria degli Esseni coi Cabalisti. Sull’autorità di scrittori gravissimi, ci permettiamo aggiungere quanto verrà più a lungo trattato nel corso di questa istoria, ponendone i titoli in una luce che non si potrebbe più sfolgorante. Intanto non è fra gli ultimi indizii che a questa identità ci conducono, il fatto per più d’un verso eloquentissimo, che nel Zoar il nome di Assia vien conferito a un dottore Cabbalista; e ciò che è più, nel senso che qui si accenna, di medico spirituale, di Risanatore delle anime. E tanto si legge in quell’opera a proposito di R. Samlai (Zohar, vol. III, 75, 2.)
LEZIONE QUINTA.
L’origine degli Esseni doveva essere, voi lo sapete, subbietto delle nostre ricerche, quando il nome fosse stato da noi rintracciato che il nostro istituto contraddistinse. Questo nome, o Signori, la derivazione di questo nome fu da noi recata a quella evidenza che si poteva maggiore. Qual’è ora il compito nostro? Io già vel diceva. Ella è la origine, la origine storica dell’Essenato, l’epoca della sua formazione, le cause che precedettero al suo nascimento, il luogo d’onde prima trasse i natali. Era la prima disquisizione, più ch’altro, gramaticale. È la presente, ricerca storica, e ricerca gravissima.
Noi abbiamo di fronte, non amici da abbracciare, ma nemici da combattere. Noi avremo il paradosso, il pregiudizio, la mala fede da superare, pria di poter penetrare nei vestiboli di verità. Quali sono questi pregiudizj? Eglino sono così svariati di forme, come sono eguali in bruttura. Egli è, in primo luogo, il pregiudizio Pagano; che è quanto dire l’origine pagana gratificata allo istituto più ebraico che abbia mai esistito. Chi lo avrebbe pensato? Chi avrebbe detto che di origine pagana dovesse supporsi lo Essenato? E pure nulla di più vero, di più dimostrato. Egli è il Buhl, il celebre storico della Filosofia, che ne fa fede. Grazie al cielo, non è il Buhl che noi dobbiamo combattere. Non è egli l’autore di paradosso siffatto; ma egli lo ha registrato,[46] gli ha dato luogo nella sua istoria; e se la memoria non erra, non l’ha, come pure avrebbe dovuto, sotto il peso schiacciato della sua autorità. Quale è la causa di tale aberrazione? Su quai fondamenti, su quai pretesti riposa la pagana derivazione? Io credo che non sia difficile indovinarlo. Voi vedrete quando del culto ragioneremo, e delle adorazioni degli Esseni, come fuggito non abbiano costoro ai morsi della più svergognata calunnia. Voi li vedrete, sopra basi inconsistenti accusati, processati e per peccato condannati d’Idolatria; li vedrete posti al bando del Giudaismo, e le note contender loro e le prerogative di Monoteisti e di Ebrei. Li vedrete, in una parola, accusati di prestare idolatrico omaggio al Sole nascente. Noi vedremo allora di che sappia l’accusa inconsiderata; noi rivendicheremo la bontà, la purità della loro credenza. Ma che cosa si esigeva di più per porre gli intemerati Esseni in mala voce, per additarli al mondo quali idolatri, e la fama accreditare tra i contemporanei, tra i posteri, di una origine viziosa, di una origine pagana? Voi vedete le basi vacillanti dell’accusa. Avrò io mestieri di spendere parole soverchie a giustificarli? Dovrò io ricordare le atroci calunnie onde furon bersaglio le israelitiche credenze, siccome allora vi accennai, che del culto Samaritano tenevamo parola? Dovrò dirvi dell’adorazione del firmamento che non pochi tra i Poeti Latini favoleggiarono dei nostri proavi; del teschio che, al dire di essi, nel recesso si adorava del Tempio di Dio, del famoso Asino che il gran Tacito non dubitava di erigere a sommo obbietto del nostro culto?
Or, che miracolo se gli Esseni pur essi del grande onore parteciparono di subire le accuse pagane, e se nell’accusa furono involti pur essi del popolo nostro, essi che del popol nostro la più eletta parte formavano e la più santa?
Ma un altro, credo, e non lieve pretesto, potè l’adito schiudere alla imputazione mostruosa; voglio dire, o miei giovani, di un passo di Flavio concernente gli Esseni, che tratto a peggior sentenza ch’egli non dice, commentato dall’ignoranza e dalla malizia, potè per un istante autorizzare la insensata imputazione. E quale è il passo di Flavio? Egli è quello ove, parlando della essenica scuola, e precisamente nel lib. XII delle Antichità, quella definisce come una setta di Giudei Pitagorici. Il nome di Pitagorici non fu invano pronunziato. Egli avrà sedotte le menti superficiali, egli avrà fatto vedere ciò che Giuseppe non vi ha posto giammai, ch’è quanto dire l’origine pagana. E pure, quant’era facile comprendere Giuseppe senza costituirlo reo di tanta enormità! Che voleva dire Giuseppe? Egli voleva far comprendere ai suoi lettori, ch’è quanto dire al mondo pagano, ai Romani, ai Greci, a tutti quelli che degli Ebrei nulla sapevano che non fosse dalla passione travisato, che cosa fosse quel bellissimo istituto di cui egli, il grande istorico, si professava il ferventissimo ammiratore. Egli lo dice un Istituto Pitagorico foggiato all’ebraica. Egli lo dice un Pitagorismo israelitico, un Pitagorismo ortodosso, siccome Filone fu detto Platone filonizzante, siccome Porfirio chiamò lo stesso Platone un Moisè atticizzante.
Aveva egli ragione così giudicandolo, è ella esatta la sentenza di Flavio? Noi in seguito lo vedremo. Ma quanto non dobbiamo noi l’ignoranza ammirare, ammirare la mala fede di chi le parole di Giuseppe innocentissime torse a così rea sentenza?
Noi non saremo i detrattori degli Esseni. Non saremo nemmeno i loro adulatori. Non diremo neppure come da taluno fu detto, che Pitagora essendosi recato, come ognun sa, in Oriente, colà cogli Esseni s’incontrasse, che ne adottasse i principj, che l’Italico sodalizio erigesse[48] poi sul modello di quel di Solima. Questo fu detto, e caldamente propugnato dai Frati Carmelitani, i quali vedendo nell’Essenato l’origine del loro ordine, vollero fare altresì di Pitagora un copista dei loro supposti antenati, e Carmelitano pur esso coi tria vota substantialia: obbedienza, povertà e castità.[19] Novelle son queste da muovere a riso, nè più seria meritano veramente nè più lunga disamina.
Potremo dire lo stesso di altra origine che l’ingegno moderno pegli Esseni fantasticava? Io credo che più profonda cotesta si esiga e più protratta disquisizione. Il nome, il tempo, la fama dell’autore vogliono che noi alcune parole ci spendiamo d’intorno. Qual’è il nome? Il nome non potrebbe essere nè più famoso nè più interessante, e (aggiungo volentieri) nè più specchiato nè più caro al popol nostro. Egli è il Salvador, che primo tra gli Israeliti francesi dei tempi nostri, salì sulla breccia, e tutto il fuoco sostenne il primo delle falangi avversarie. Il tempo fu quello dei grandi religiosi dibattimenti della Francia moderna. L’opera è quella che più fama destò di sè in Europa, e soprattutto in Allemagna, ove precorse, ove augurò la terribilissima scrittura dello Strauss.
Or bene, nella Vita di Gesù e la sua Dottrina, il nostro Salvador dal proprio têma? condotto, scende a parlar degli Esseni. Egli chiede a sè stesso degli Esseni l’origine; e qual ne segue risposta? Certo non tale quale per noi si vorrebbe. Egli chiede del tempo, ed il tempo egli lo vede, durante la invasione Siriaca, quando i successori di Alessandro osteggiarono aspramente il popolo nostro, e sotto Antioco in ispecie. «Son origine la plus probable, dice il Salvador, remonte à l’époque de l’invasion des Syriens.» Quali le cause che allora lo istituto creavano? Non sono cause propriamente, dice il Salvador, ma piuttosto fortuito concorso di circostanze.[49] «È una turba, sono sue parole, è una turba di famiglie che rovinate dalla guerra, desolate dalla continua violazione dei luoghi sacri, e degli atti alla credenza loro oltraggiosi, ai quali venivano costretti; vanno in cerca di un asilo nelle regioni alpestri della Giudea.» Quale è l’origine del loro culto? Eccolo qual ei ce lo narra. «È l’impossibilità di compiere in quelle solitudini, riti e sacrifizj, o, come dire si voglia, il culto esterno, ella è cosifatta impossibilità che l’animo rivolse ad un’altra specie di culto, ad un culto più interno, alla continua elevazione dello spirito, mercè la pratica della giustizia e gli offici di carità.»—D’onde poi, secondo il Salvador, quella singolare comunanza di beni, che fu peculiare distintivo dell’Essenato? Quali le cause che la produssero? Furono, ad udirlo, «l’incertezza della vita, minacciata mai sempre dalla spada nemica, fu la necessità di provvedere di sostentare tanti vecchi, tante donne, tanti fanciulli.»—Ecco le cause, conclude trionfalmente il Salvador, che ispirarono loro la comunanza dei beni, che la stabilirono allora e poi in seno agli Esseni, e ch’egli dice nel suo idioma «ne tarda pas à devenir une règle principale de leur institut.»—Noi abbiamo parlato del Salvador, come d’uomo si conviene della sua tempra, del suo ingegno. Noi gli abbiamo tributato elogi non ipocriti, non servili e non avari. Ma noi abbiamo perciò stesso la libertà pienamente acquistata di sindacare la bontà, la ragionevolezza delle sue dottrine. Mi duole il dirlo, il Salvador ha soggiaciuto al genio predominante del suo paese, del suo tempo, e più assai al genio dei suoi vicini Tedeschi. Egli sente, come essi, alto profondo orrore di tutto quello che per poco trascende le età più moderne della istoria; egli è uno di quelli che i tempi, gli uomini, gli istituti più antichi modernizzarono; egli è uno dei grandi atleti che stringendo[50] a così dire tra poderose ritorte le statue, i monumenti, che sorsero all’aurora dei secoli, si sforzano e sudano e si affaticano a tirarli a tempi a noi più vicini; egli è uno di quelli che fanno vedovi i primi secoli dei fatti più illustri, degli uomini più venerandi; che fanno, nell’ordine della cronologia, ciò che le moderne nazioni civili fanno in ordine allo spazio, togliendo obelischi, sfingi, sarcofagi e d’ogni maniera anticaglie, a quei paesi ove l’arte li generava, e decoro illustre ne fanno di musei, di biblioteche, di capitali. Egli è di quelli che fanno il vuoto nelle origini, e gli uomini e i fatti condensano, accalcano in angustissimo spazio di tempo, con quanta sapienza e ragione, non so.
Fuori dei tempi antichi, ogni romanzo è buono a costoro. Anzi, la storia sol perchè è antica, è romanzo, e il romanzo solo perchè è moderno, è la istoria.—Io ho detto romanzo, e lo mantengo. La teoria del Salvador, con sua buona pace, non è che romanzo. E se vi aggrada come me osservarlo, vedetelo immantinente. Io potrei appuntare per primo il Salvador, non di plagio, chè la di lui probità letteraria me lo contende, ma di aver disdetto, voglio credere involontariamente, l’onor del trovato a chi si appartiene. Potrebbe dire una critica meticulosa, che male non avrebbe fatto il Salvador a narrarci chi fu il primo a porre innanzi la ipotesi menzionata; a dirci, che fu il Drusio colui che primo gliene offriva l’idea; che fu esso che andando in cerca, siccome noi dell’origine degli Esseni, insegnava come questa si dovesse riporre ai tempi d’Ircano Asmoneo, quando la parte perseguitata si ricovrò nei deserti, e colà di buon’ora s’assuefece ad un tenore di vita durissimo, nel quale dipoi perseverò volentieri. Il sistema del Drusio non è quello, ben io m’avveggo, del nostro Salvador, il quale differisce siccome udite in ordine al tempo, e risale ad un’epoca[51] non di poco anteriore a quella dal Drusio seguita. Ma finalmente, che cosa non hanno di comune i due sistemi, ove si eccettui la differenza notata? Io ardisco dire che hanno tutto in comune, e che bene avrebbe fatto il Salvador a dividere con chi di ragione la responsabilità del sistema. Egli però nol fece, nè io insisterò di soverchio. È egli almeno probabile, è egli almeno accettabile il sistema dal Salvador propugnato? Io gli chieggo del culto essenico la origine, ed egli l’impossibilità mi addita dei sacrifizj e del culto esteriore; al quale ei dice, un culto più elevato si sostituì in ispirito e verità.—Di buona fede è egli questo raziocinare per filo e per segno? Che cosa suppone il ragionamento Salvadoriano? Suppone, se io non erro, che nè sacrifizj nè culto esteriore appo gli Esseni esistesse. Che se così non fosse, che cosa suonerebbe questa sognata sostituzione? Io dico dunque che lo suppone.—Ma che dice la Istoria, alla quale ogni reverenza si dee ed ogni ossequio? Conferma ella la ipotesi del Salvador, ed una setta negli Esseni ci raffigura quale egli ce la dipinge, destituita di culto esteriore e di sacrifizio? Nulla affatto. La storia parla alto, parla solenne contro la teoria irriflessiva del Salvador, ed un amore ed uno studio ci offre presso gli Esseni del culto esterno, da disgradarne ogni più raffinata e squisita pietà. Ma che volete? Il Salvador pecca per troppa bontà. Egli ama gli Esseni, egli li stima, nè confine egli pone alle lodi che al bello Istituto profonde nel suo libro: epperò gli dà troppo del suo, epperò di quelle vesti li abbiglia che più talentano al suo genio filosofico, al suo gusto, al suo favorito sistema. Epperò li va profumando con quegli unguenti razionalistici che ponno farli accogliere, festeggiare nei dotti consessi. Rimane però a sapersi se del presente generoso gli Esseni si chiameranno contenti.—Io proseguo e chieggo al Salvador:[52] d’onde, secondo voi, la comunità degli averi? Che cosa risponde il Salvador?—Dalla incertezza della vita, dalla necessità di provvedere a tanti vecchi, a tante donne, a tanti fanciulli.—Eppure il mondo non l’aveva finora capita così. Si credeva finora che nulla vi fosse di più egoista della necessità, nè di più avaro della miseria. Si credeva finora che l’abnegazione, la generosità, e soprattutto il rinunciamento assoluto di ogni bene, non albergassero precisamente colà, ove la fame manda i suoi orribili latrati, e dove la prepotente mano del bisogno, stringe i cuori ad ogni senso di pietà, e non occorre dire d’abnegazione. Benedetti razionalisti! Quanti miracoli non sanno fare! Eglino ti cavano un effetto dal suo opposto con quella disinvoltura con cui Mosè trasse dalla rupe le acque. Ma eglino, i razionalisti, ci hanno insegnato a dubitar dei miracoli, e questo basti perchè i loro miracoli eziandio da noi si rifiutino.
Ma su.—Io voglio menar buone al Salvador tutte le anzidette repugnanze. Voglio dire che il culto esterno tra gli Esseni non vi fosse, e che dalla brutta fame sia uscito fuora il più sublime prodigio di carità. Ma il nodo gordiano non è qui. Sapete invece dov’è? È nel passaggio da questo stato temporario, provvisorio, forzato, ad uno stato durevole, ad uno stato definitivo, ad uno stato volontario. Mi spiegherò ancor più. Bisogna che ci dica il Salvador in qual guisa, per quale sconosciuta ragione, una condizione così miserevole, così eccezionale, così a malincuore subìta dai poveri emigrati, si tramutò, ad un colpo di magica verga, in un’associazione regolare, stabile, religiosa, dotta e venerabile, come fu quella che veggiam negli Esseni. Se questo il Salvador non ci narra, se egli non ci svela il transito miracoloso, sapete che cosa io crederò? Io crederò che non appena rimossi gli ostacoli, non appena gli impedimenti sgombrati, non[53] appena restituita la pace e la libertà, non appena le vie si dischiusero del ritorno ai poveri fuoriusciti, che ognuno riedendo pacificamente a casa sua, avrà ripreso il godimento degli antichi diritti; e l’esercizio delle prische faccende. Ecco che cosa credo, ecco quello che suggerisce il più comunale buon senso. Per trasformare un’orda di fuorusciti in un istituto ammirando quale fu l’Essenato, ci vuol altro che parole! Ci vuol ragioni! E che cosa ci dà in compenso il Salvador? In qual guisa si districa egli dagli intricatissimi lacci?—Ecco, come: Quello stato, egli dice, era provvisorio, era precario, ve lo confesso. Udite pellegrinità di trovato. Ma, egli aggiunge in sua favella: «Mais ne tarda pas a devenir une des règles principales de leur institut.» Volete più? Se più esigete, sareste davvero indiscreti. Quel ne tarda pas, ch’è l’anima del concetto, è fatto proprio per contentare anco gli ingegni più schizzinosi. Egli è proprio un miracolo; ma un miracolo di coreografia, non dialettico procedimento. Questo si chiama in Parigi glisser sur les questions. Ma io dico piuttosto, che fa scivolare, che fa sdrucciolare gli inesperti, e che il minor pericolo che può incoglierci, sia quello di nulla imparare.
Noi abbiamo, se ben mi appongo, abbastanza crollato il sistema del Salvador. Or bene, lo credereste? Egli è ancor più fragile di quel che credete, e quando pure potesse avere le superiori sembianze del colosso di Nabucco, certo che i piedi, che le basi di creta non mancheriano. Tali le prove, tali i fatti sono che vi addurrò, che il sistema del Salvador riporrete certo tra gli onorati defunti. Non lo credete?—Ebbene, o miei giovani, togliete in mano il libro del Salvador, e la citazione osservate alla quale tutto egli affida il peso del suo sistema, e ditemi che ve ne pare. Non dovrebbe essere, non è egli vero, una colonna, una piramide, un atlante? Oibò, è[54] canna, e fragil canna. Qual’è la citazione del Salvador? Egli è un passo del libro dei Maccabei, ove si narrano i primi effetti della irruzione Siriaca in Palestina. Come suona quel passo? Dice per l’appunto così: «E si ridussero gli sbandati Israeliti ad abitar nelle caverne ed in ogni luogo ove potessero un asilo trovare...... Allora parecchi tra quelli che cercavano giustizia, trassero al deserto onde abitarvi.»—Qui finisce la citazione Salvadoriana, che dal 1º e dal 2º Capitolo fu tratta del primo libro dei Maccabei. Ma noi non sbaglieremo dicendo che il Salvador così facendo, si affidò più a quanto di proprio avrebbe supplito il lettore, a quanto avrebbe la immaginazione suggerito in compimento, che a quanto sta veramente registrato nei Maccabei. Diffatti, a questo punto arrivati della istoria, allo spettacolo di tanta gente che fermano stanza nel deserto, dopo le parole in ispecie del Salvador, che cosa vi suggerisce la fantasia? La fantasia s’impadronisce di questo dato, di questa emigrazione dalla storia narrata, e vestendola secondo il suo stile di colori fittizj, ed allargandola ed ampliandola, e preoccupando il campo dell’avvenire, e parlando ove la storia si tace, già dimostra in questo pugno di fuorusciti il germe della grande istituzione; già ve li addita stanziati definitivamente in quelle solitudini; già li stringe in religiosa consorteria; già dal semplice soggiorno alla convivenza trapassa, quindi dalla convivenza alla scelta di una vita comune, da questa all’organamento sociale, al culto, alle dottrine; e così di grado in grado salendo, ed elemento ad elemento soprapponendo, fa sorgere quasi per incanto il grande, il bello istituto degli Esseni. Io non so se mi vorreste più generoso; ma io tutto ammetterei, quanto può di fantastico offrirci, di gratuito, questa ipotesi, quando almeno la base istorica, quell’esilissimo storico addentellato, che pur or ricordammo, rimanesse[55] saldo, inconcusso, rimanesse in piedi. Che sarebbe però, dilettissimi, se pur esso svanisse; che sarebbe se il gigantesco edifizio tutto vedessimo sull’arena fondato; che sarebbe se tutte le nostre immaginarie scoperte andassero miseramente in frantumi, come le fantastiche supputazioni di colui che sopra pochi miseri vetrami la fortuna sua fondava?—Certo che bene avremmo di maraviglia argomento, come un ingegno svegliato, probo, erudito come il Salvador, si lasciasse tanto aggirare dall’orror dall’antico, tanto dagli spiriti razionalistici, sino a disconoscere la inanità del sistema proposto. Quale è di questo sistema la base; quel quid senza di che sarebbe a zero ridotto; quel polline, quell’embrione d’onde si vuol tutto l’Essenato prodotto? Egli è senza meno, e voi lo sapete, quel nucleo d’Israeliti i quali dalla Macedone spada incalzati si ridussero raminghi per lo deserto. Or bene. Mi spiace per voi, mi spiace per il Salvador, mi spiace per quei poveri Israeliti. Il preteso embrione non giunge alla prima fase di gestazione. Il polline muore sullo stelo per effetto di una brinata. Senza figura, quel pugno d’Israeliti su cui si fondava così alto e immenso edifizio, non scorsero pochi giorni che raggiunti, circuiti, assaliti, ed infine distrutti dai Macedoni persecutori, spariscono miseramente dalla superficie della terra. Dove son iti i germi dell’Essenato, dove sono i primi rudimenti, dove i portentosi sviluppi? Se ne desiate novelle, chiedete piuttosto ai generali Siriaci, che vi mostreranno in risposta la spada tinta di sangue. Chiedetene, se ne volete più mite responso, alla storia stessa dei Maccabei, allo stesso 2º Capitolo citato dal Salvador, ai versi stessi che quasi immediatamente conseguitano a quelli dal Salvador indicati; e queste parole vi leggerete, che pur esser dovrebbero suggel ch’ogni uomo sganni:
«Coloro dunque (cioè i soldati Siriaci) gli assalirono[56] con battaglia in giorno di sabato, sì che morirono, essi e le loro mogli, e i lor figliuoli e i lor bestiami, fino a mille anime umane.»
Avete inteso?—Non uno rimase vivo; non uno da cui potesse sorger per miracolo l’Istituto degli Esseni; non uno di coloro che furono, secondo il Salvador, semenzajo del grande Istituto. L’esito, la catastrofe sarebbe veramente comica, sarebbe ridicola, se tetra e lagrimevole troppo non fosse.
Giunti a questo punto, in presenza a questa terribile e sanguinosa confutazione, che cosa più dovremo aggiungere? Certo che noi potremmo dire al Salvador, che pria della origine supposta, pria che di questa emigrazione si narri nel libro dei Maccabei, già di una valorosissima consorteria ivi stesso è menzione, che si noma dei Hassidim, e che tutti i segni reca manifestissimi dell’Essenato, onde cerchiamo l’origine. Ma innanzi alle ricordate deposizioni dell’istoria, ogni argomento vien meno. Egli è per questo che noi abbiamo il fine raggiunto della nostra via? Debbo dirvi che no. L’argomento che ci siamo proposti vuole che ancora altre origini consideriamo, altre opinioni. Non è invano che si prende grave argomento a trattare. Dirò a voi come Dante ai suoi lettori:
Conviene ancor seder un poco a mensa,
Perocchè il cibo rigido ch’ho preso,
Richiede ancora ajuto a sua dispensa.
LEZIONE SESTA.
Qual’è l’origine, la origine storica degli Esseni? Ecco l’oggetto delle nostre passate, delle nostre presenti ricerche. Noi movevamo, nella lezione passata, in traccia di questa origine; noi vedevamo il Salvador riporla nella invasione dei Siriaci, nelle emigrazioni specialmente che questa invasione cagionava tra gli Ebrei di Palestina. Noi domandavamo a noi stessi quanto si apponesse il Salvador così sentenziando, e la risposta fu tale, se ben ricordo, che male potrebbe il sistema del Salvador riaversi.—Mestieri è oggi proseguire nel divisato cammino; mestieri è pure, quelle qualunque opinioni che a spiegare l’origine degli Esseni furon proposte, chiamare egualmente a sindacato. Qual’è il sistema che noi dobbiamo oggi esaminare? Egli è un sistema che se l’ingegno, la fama, il sapere, fossero sempre infallibile criterio di verità, solo vero e legittimo sistema dovrebbe cotesto da ora bandirsi. Noi abbiamo dinanzi uomini cari a noi e onorandi per la fede comune, per servigj segnalatissimi ai buoni studj prestati; abbiamo tra i nostri l’illustre autore della Kabbale, il Frank; l’autore chiarissimo della Palestina, il Munk; e infine abbiamo tale che torreggia gigante fra tutti quanti gli si appropinquino, abbiamo un uomo che vale per mille, un uomo, (tollerate la riabilitazione di una frase) un uomo che si chiama Legione, abbiamo Vincenzo Gioberti.
Il Munk, il Frank, il Gioberti, ecco i grandi, i terribili avversarj che dobbiamo questa sera combattere. E che cosa, di grazia, dicono i tre chiarissimi uomini dalla origine degli Esseni? Tutti egualmente in una sentenza convengono, tutti in una origine consentono l’origine Greca, l’origine Alessandrina, l’origine Egiziana. Che cosa s’intende dire per questa origine da me con triplice nome designata? S’intende dire che gli Esseni o, per dir meglio, l’Essenato, ch’è quanto dire l’Istituzione, le Dottrine, il Genio degli Esseni, siano tutti provenuti da quella filosofia, da quella scuola, che parte greca, parte orientale, avea posto da lungo tempo suo seggio nella Metropoli dell’Egitto, nella erede di Atene, in Alessandria. Ecco che cosa vuol dire origine Alessandrina. E dove professano i tre insigni uomini rammemorati la opinione ch’io dico? La professa il Munk nella bell’opera che sulla Palestina dettava (a p. 519), laddove, dopo aver con succinte indicazioni degli Esseni trattato, conclude dicendo, molto andare la loro Istituzione debitrice agli istituti; alle scuole dei filosofi egiziani. Lo confermava poi in una nota alla pagina istessa ove a buon diritto redarguendo la teoria del Frank, ci dipinge gli Esseni quasi mediatori e sensali tra le dottrine in Egitto imperanti, e la ebraica ortodossia di Palestina. Noi avremo in avvenire occasione di noverare il Munk tra i più valenti propugnatori di non poche capitalissime verità riguardanti gli Esseni. Noi avremo luogo di tributargli largo, sincerissimo ossequio per essere stato animoso banditore di tre principj che crediamo nella Storia degli Esseni rilevantissimi, per aver apertamente insegnata la filiazione e quasi la identità degli Esseni col Farisato, per aver sanzionata l’antichità, la contemporaneità della teologia Cabbalistica, e sopratutto per avere tra questa teologia e la scuola degli Esseni dimostrate[60] quelle intime, profondissime attinenze che sono, secondo me, uno dei pregj più esimj della scrittura del Munk. L’occhio della mente sua, sempre veggente,[20] travide queste attinenze, le notò, le insegnò; e i germi da esso deposti nella opera sua, debbono quando che sia larga messe fruttare di preziosissime conclusioni. Noi non saremo tra gli ultimi a secondarne il dettato, a riconoscerlo, a salutarlo qual possente alleato. Per ora, come dicemmo, nella questione presente della origine, èmmi forza trattarlo quale avversario. Io dissi che non è il solo, ma poderosi atleti accompagnarlo. Uno di essi è il Frank. E dove soscrisse il Frank alla origine in discorso? Nell’opera già ricordata della Kabbale. Egli, nella terza parte del suo libro, in quella cioè da esso alla comparazione dedicata tra la dottrina dei Cabbalisti ed i sistemi affini contemporanei, sembra inchinare assolutamente alla origine Alessandrina. Parlando degli Esseni e dei Terapeuti, egli dice apertissimo: l’une et l’autre (che è quanto dire Esseni e Terapeuti) l’une et l’autre étaient nées en Egypte. L’una e l’altra, sortito avere i natali in Egitto. Io vi dico forse cosa che vi stupirà. Voi udite quanto esplicito si pronunzj il Frank in favore della tesi avversaria, quanto deliberato consenta all’origine Egiziana. Eppure (stranissima anomalia!) egli sarà il Frank istesso, egli sarà lo stesso libro della Kabbale, e la stessa parte sarà del suo libro, e senza forse la pagine istessa, che i più forti, i più saldi argomenti ci forniranno ad infermare, a distruggere la teoria prediletta, la origine fantasticata. Io credo che gli argomenti perchè tratti dall’avversario nulla scapiteranno, se non invece immensamente più ratti e più infallibili ci meneranno allo scopo. Ma chi è il terzo, che sovra gli altri come aquila vola? Io dissi che è V. Gioberti.—E dove toccava il Gioberti della istituzione degli Esseni? Egli ne parlò[61] nella Filosofia della Rivelazione; in una di quelle opere che la morte non concessegli di pubblicare, e che i postumi anatemi non valsero che a render più cara, più ricercata. In quest’opera della Filosofia della Rivelazione (a p. 181 dell’opera stessa), laddove prende colla sua usata grandiosità a trattare della pretesa missione unificatrice del Cristianesimo, e quindi (quali rappresentanze di due opposte idee) della presenza in Palestina della dualità Ebraica e Gentilesca, che dovevasi pel futuro Cristianesimo unificarsi, così il grande intelletto si esprimeva: «Presso i Giudei a’ tempi di G. C. vi eran due scuole. L’Alessandrina, filosofica, acroamatica, sottile; la Palestina, tradizionale, positiva. La prima esprimeva il genio Indopelasgico e Greco; l’altra, il genio Semitico.»
Voi l’udite, Gioberti sta risolutamente per la origine Alessandrina; imperocchè di null’altro egli può aver inteso colla sua scuola acroamatica e sottile, rappresentante il genio Greco o Indopelasgico, tranne della scuola della Consorteria degli Esseni.
Noi avremo, dunque, a lottare non solo coi due preclari scrittori il Frank ed il Munk, ma ancora contro la mente più vigorosa che generato abbia l’Italia moderna. Fortunatamente però non è così. Noi possiamo a buon diritto declinare Gioberti quale avversario, noi possiamo rimuoverlo rispettosamente dallo steccato, noi possiamo risparmiarci il pericolo, e non è lieve, di tenzonare con atleta siffatto. E perchè? Per una ragione semplicemente, e che voi di leggieri comprenderete. Perchè Gioberti non è responsabile della verità dell’asserto; perchè egli, a guisa di tutti quelli che versando sopra una particolar disciplina, si giovano delle ricerche e dei trovati altrui, qualora di altre discipline si tratti, tolse agli uomini, agli scrittori speciali; tolse, per esempio, al Munk, tolse al Frank; come ad altri di simil fatta tolse per avventura[62] il supposto sul quale la teorica sua fondava della unificazione Cristiana; ch’è quanto dire, toglieva da essi la origine Greca Alessandrina dell’Essenato, senza porsi per questo mallevadore della verità del supposto, come fatto non si sarebbe mallevadore se tolto avesse, verbigrazia, al Champollion la notizia dei Monumenti Egiziani, o dai Fisici imparato avesse cosa che fosse dipoi chiarita fisicamente inesatta. Sapete sopra chi gravita intera la responsabilità dell’asserto? Sovra coloro che tolsero a subbietto delle loro ricerche, disquisizione siffatta; sovra di quelli che ne trattarono exprofesso. Sopra gli scrittori Israeliti in ispecie, siccome quelli che più eruditi si suppongono nelle proprie antichità; ed ai quali più facilmente che ad altri si presta credenza, i quali dovrebbero, se non isbaglio, penetrarsi più che non fanno di questa verità; cioè, che gli occhi, che le menti dei dotti sono più che ad altri, ad essi rivolti, siccome ad organi ed interpreti fedelissimi e naturali di tutto lo scibile israelitico, e che grave però loro incombe il dovere di procedere circospetti non poco nelle loro sentenze. Non sono eglino i rappresentanti legittimi, e quasi non dissi gli oratori d’Israele nel consesso dei dotti? Tali almeno sono dall’universale estimati.—Che cosa dicono il Frank ed il Munk? Dicono che il nostro Essenato deve all’Egitto, alle idee dell’Egitto, il suo nascimento. Porganci dunque le fedi di nascita, che le vediamo; porganci, cioè, quelle prove che a così credere li inducevano, e se ne vegga il valore.
E prima, difendere non mi so da un pensiero che vulnera, a parer mio nella parte più sensibile la opinione in discorso. E qual’è? È il superfluo, è il vano, è l’inutile di tale opinione. Voglio dire che questa ipotesi che combattiamo, ove pure si prescinda dal suo intrinseco[63] valore, manca senza meno del primo e indispensabile requisito di ogni asserto, la sua necessità. È egli necessario per ispiegare l’origine degli Esseni, fare siccome fanno costoro un’escursione in Egitto? Fermamente io credo che non lo è.—E chi è quello che me lo insegna?—Strana cosa, ma pure verissima. È il signor Frank istesso, è quello istesso volume ov’egli di volo depose la sua professione di fede riguardo agli Esseni. Ed in qual guisa ce lo insegna il signor Frank? Disputando intorno all’antichità delle dottrine, della scuola dei Cabbalisti. Egli fu quello, e già ve lo dissi, che più risoluto tra i moderni scese nello steccato a propugnarne l’antichità. Egli non si diè posa fintantochè non rimise l’antichità della scienza in quella evidenza intuitiva che era stata pria delle moderne discettazioni. Ciò fece il signor Frank, e saviamente faceva, a parer mio. Perchè non fu conseguente? Perchè avendo in casa più che non era mestieri a rendersi conto della derivazione degli Esseni, andò attorno a cercarne la culla sulle rive del Nilo? Perchè non quetare nella origine propria e casalinga, quando tutti gli elementi ei ne chiudeva in pugno coll’antichità cabbalistica? Perchè torcere gli occhi da quelle strette attinenze alle quali ossequiava sinceramente la buona fede del Munk, nè il signor Frank istesso osava negare? Ecco la prima lagnanza che contro l’origine Alessandrina mi è dato rivolgere. Si comprende in una parola, in una frase; cioè, non è necessaria.
Non basta questo. Un argomento vi ha che, a senso del signor Frank, dimostra l’autonomia delle dottrine cabbaliste, cioè la loro origine indigena, nazionale, Palestinese; e questo argomento è la lingua.
La lingua, egli dice, di quella dottrina, è l’ebraica, e l’ebraica aramea, ch’è quanto dire, la lingua allora usitata in Palestina. Qual’era, per contro, la lingua dei filosofi Alessandrini? Era il greco idioma, il greco[64] esclusivamente. Non è questa, dice il Frank, prova dell’autonomia Cabbalistica? Io non voglio discutere l’argomento del signor Frank, ma lo prendo per quel che vale, e così argomento. O la lingua prova, o nulla dice. Se prova, perchè non vale egualmente rispetto agli Esseni, dei quali non si è mai detto nè si poteva dir veramente che altra lingua usassero in Palestina, che non fosse l’ebraica, o quella qualunque allor usitata?—O non prova; ed allora, perchè concedergli di prova le sembianze e gli effetti?—Pare impossibile! Vi sono nel libro prelodato del signor Frank, nella scrittura della Kabbale, e in quella parte istessa, e quasi a contatto della malaugurata origine Alessandrina, tali inattese, tali decisive confessioni, e tale offrono manifesta repugnanza colla origine istessa, che davvero non si comprende come uno scrittore illustre, qual’è il filosofo francese, non l’abbia avvertita.
Vedete, in fatti, il signor Frank precludersi colle sue mani la via a spiegare non solo, ma nemmeno a comprendere la sognata origine Alessandrina. Vedete egli stesso elevare una barriera materiale, insormontabile, che il passaggio persino contende, onde prendere nello Egitto lo Essenato. Vedete egli stesso porci le armi alla mano, con queste parole: «Dallo istante (egli dice, e traduco a verbo), dall’istante in cui la scuola Neoplatonica prese a fiorire nella nuova capitale dell’Egitto, sino alla metà del secolo IV dell’E. V.; epoca nella quale la Giudea vide morire le sue ultime scuole, i suoi ultimi Patriarchi, le ultime faville della sua vita intellettuale e religiosa; quali rapporti troviamo tra i due paesi, tra le due civilizzazioni da essi paesi rappresentate? Ove, durante questo tratto di tempo, la filosofia pagana fosse penetrata nella Terra Santa, e’ bisognerebbe naturalmente supporre la intromissione degli Ebrei di Alessandria.[65] Ma gli Ebrei di Alessandria sì scarsi rapporti aveano coi loro fratelli di Palestina, che assolutamente ignoravano le istituzioni Rabbiniche, le quali tra gli ultimi occuparono luogo così cospicuo, e che trovavansi già radicate tra essi oltre due secoli innanzi l’E. V.»—E quali prove reca in mezzo il sig. Frank ad avvalorare l’asserto?
Prove reca, bisogna pur dire, che desiderar non potrebbonsi più luminose. Egli reca la intera Enciclopedia ebraica alessandrina, ove assoluta campeggia la ignoranza delle cose e degli uomini Palestinesi. Reca, tra gli apocrifi, il libro della Sapienza, di origine, di autore Alessandrino. Reca l’ultimo libro dei Maccabei, foggiato come pare indubitato sulle rive del Nilo, ed il silenzio ci addita e la ignoranza assoluta di tutto quello che Palestina riguarda. Ignoranza dei più grandi uomini, che alta e sonora levarono fama di sè; ignoranza di Simone il Giusto, dei più celebri tra i Tannaiti; delle grandi scuole di Hillel e Sciammai; e sovra tutto, ei dice, ignoranza di costumi, d’idee, di tradizioni. Ma il Frank non è uomo da darci dimostrazioni incompiute. Egli prova, e si può dire con egual nerbo, con egual verità, la ignoranza reciproca nella quale gli Ebrei di Palestina vivevano di tuttociò che in Egitto avveniva, di tuttociò che concerneva i loro fratelli di Alessandria. Lo prova la oscura, l’alterata cognizione che i dottori possedevano della traduzione dei Settanta; lo prova il silenzio strano, incomprensibile, nella Misnà e nel Talmud dei nomi più insigni, delle grandi, delle somme illustrazioni israelitiche dell’Egitto; silenzio di Filone, silenzio di Aristobulo, e silenzio infine di tutte le opere anzidette, concette e partorite all’ombra delle scuole Egiziane. Lo credereste? Egli è in mezzo a quest’osanna perpetuo, alla impossibile comunicazione tra Palestina ed Egitto, egli è in[66] mezzo a questo concorso imponente, maestoso di prove, contro l’origine Alessandrina, egli è qui, qui per l’appunto che l’origine Alessandrina degli Esseni si pone dal signor Frank siccome quel vero, che mestieri non ha di esser provato.
Voi lo udiste; voi vedeste con quanta urgenza di prove l’illustre autore innalzi tra Palestina ed Egitto tale una muraglia, rispetto alla quale, quella famosissima della Cina ti pare un trastullo. Che credereste ora che faccia il sig. Frank? Egli crede citare la massima delle prove, e cade invece, se così è lecito pensare di un tant’uomo, nel massimo degli equivoci. Egli cita in prova della non avvenuta comunicazione tra Palestina ed Egitto, il silenzio dei Rabbini intorno gli Esseni, intorno i Terapeuti. Perchè, egli chiede, perchè questo silenzio? Perchè gli Esseni, ei dice, origine avevano egiziana, e nulla che fosse egiziano dai Rabbini si conosceva.—Sogniamo o siamo desti?—È egli il sig. Frank che tale profferiva sentenza? E pure, dovuto avrebbe ad una piccola circostanza avvertire, che tutta avrebbe mandata a soqquadro la sua argomentazione; ch’è quanto dire, avria dovuto avvertire, che se la ragione può valere pei Terapeuti dimoranti in Egitto, non lo può in nessun modo pegli Esseni in Palestina stanziati; pegli Esseni che viveano tra le stesse mura e sotto gli occhi stessi dei dottori, i quali se non ne fecer menzione, a tutt’altra cagione bisogna imputarlo, che non a quella della pretesa origine egiziana. La quale origine egiziana tuttochè fosse vera addimostrata, nulla avrebbe impedito che dai dottori gli Esseni si conoscessero, e di essi a dilungo favellassero, siccome quelli che comune con essi avevano e patria e soggiorno e convivenza. Che se non lo fecero, non ci dite, di grazia, perchè traevano dall’Egitto la origine; chè così dicendo, offendete, non ch’altro, il più comunale[67] buon senso.—Ma che dico il buon senso? Dovrei dire la vostra istessa teoria, il vostro sistema istesso d’isolamento, di separazione dell’Egitto. E come no? Voi dite gli Esseni Egiziani. E bene sta. Ma dove abitavano cotesti Esseni? Abitavano pure in Palestina; dunque di Egitto trasmigrati si erano in Palestina, o almeno le idee loro dall’Egitto passate erano in Palestina, perchè uomini od idee, nel caso nostro, è tutt’uno. Ma se passarono, se dall’Egitto trasferironsi in Palestina: che segno è? È segno che questi rapporti da voi negati, esistevano veramente. È segno che le dottrine cabbalistiche possono avere quelle stesse vie percorso, che lo Essenato percorse. È segno che tutto l’apparecchio dialettico da voi posto a sostegno della autonomia, della originalità cabbalistica, ruina ad un tratto. È segno che coteste due cose da voi sostenute, non possono insieme capire. È segno che bisogna scegliere, che bisogna ottare.—Volete gli Esseni derivati d’Egitto? Ed allora non negate tralle due regioni i rapporti. O meglio vi talenta ricusare tra Palestina ed Egitto ogni legame, ed allora rinunziate alla origine alessandrina dello Essenato. Volere e l’uno e l’altro, è al di sopra di ogni creata possanza: stare, per così dire, sulle due sponde a cavallo, è opera più che umana; conciossiachè del solo colosso di Rodi, si narri poggiare ad un tempo i suoi piedi sulle due opposte rive. Ma il colosso di Rodi è favola meglio che storia. E bene, o miei giovani, se ne accorse quel perspicace intelletto del Munk, il quale nella sua Palestina (a p. 519) tali parole dettava sul conto del Frank, le quali comecchè di gentilezza condite, non lasciano per questo di contenere l’avvertenza che noi al signor Frank dirigiamo. «Sembra, dice, in verità avere il signor Frank indebitamente negletto l’officio che gli Esseni ponno aver sostenuto, quali mediatori e sensali, tra l’Egitto e Palestina.»
Questa si chiama conseguenza, e noi volentieri la ossequiamo, quale diretta e legittima illazione del principio da ambidue consentito, cioè della origine alessandrina dell’Essenato. Noi possiamo però separarci dalla costoro sentenza, senza per questo incorrere nella taccia di contraddizione. Noi neghiamo col signor Frank la comunicazione tra Palestina ed Egitto; ma neghiamo altresì ciò ch’egli non fa veramente, cioè la origine alessandrina dello Essenico istituto.[21]
Io vi dissi che gli argomenti dal signor Frank invocati a sostegno della autonomia cabbalistica, militavano con non minor urgenza in favore dell’autonomia degli Esseni. Giudicatene voi stessi.—Ignoravano, egli dice, i dottori di Palestina, i loro confratelli di Egitto. In qual guisa le scuole pagane avriano conosciuto? Non è egli, io aggiungo, cotesto validissimo argomento in favor eziandio della originalità degli Esseni? Ma più. La lingua greca, dice il signor Frank, era in onore: sì, ma appo gli Israeliti di Palestina non era però familiare. Vedete, egli aggiunge, vedete Flavio che pure nella scienza pagana ci sembra tra i coetanei il più erudito. E pure, chi il crederebbe? è Flavio stesso che ne depone, è la sua confessione, sono le sue parole: Mestieri egli ebbe di chi nella greca favella lo erudisse, quando prese a dettare le sue istorie.—Mestieri ebbe di porsi al fianco tale, che nella lingua dei Greci quelle nozioni possedesse, di cui egli era digiuno. Mestieri fu che le istorie sue al costui sindacato sottoponesse.—Non basta. Flavio non recita sol di sè stesso la confessione, ma la ignoranza egli autentica altresì di tutti i suoi contemporanei, i quali al dire di lui poco in generale delle lingue curandosi, poco eziandio coltivavano lo idioma dei Greci; e se l’idioma, dice il Frank, era così trascurato, come potevano meglio conoscere le dottrine in esso[69] idioma vergate? Bene, a parer mio, argomenta il signor Frank, e non meno bene noi stessi argomentiamo.
Io torno e domando. Avvi nulla in questo raziocinio che a capello non si acconci alla istituzione degli Esseni? Avvi nulla che più manifesto resulti della loro autonomia?—Ma più oltre spinge il signor Frank la intrapresa argomentazione, e più oltre con esso noi pure procederemo. Che cosa dice il signor Frank? Poniamo, egli dice, che la lingua si conoscesse. Poniamo che queste materiali difficoltà che noi vedemmo frapporsi alla comunicazione dei due paesi, non esistessero; mettiamo anzi, che liberamente le idee alessandrine in Palestina circolassero, e quelle di Palestina nello Egitto avessero accesso. Sarebbe per questo più probabile l’adozione delle dottrine dei Greci tra gli Ebrei, tra i dottori di Palestina? Lo nega il signor Frank per ciò che le dottrine cabbalistiche concerne, ed ha ragione. Chiama il Frank a rassegna, e concludenti ed infiniti sorgono alla sua voce, fatti, assiomi, decreti, anatemi, che tutti attestano concordi l’errore, la repugnanza in cui si avevano tra i dottori antichissimi le dottrine dei Greci. Egli chiarisce assurda, impossibile la pretesa consecrazione di teorie forestiere; egli restituisce alla teologia cabbalistica i suoi titoli, la sua ingenuità, la sua cittadinanza.
Io credo che niente più grecizzante sia il nostro Essenato, il quale, come vi accennai sino dall’esordire, tra le più distinte file si reclutava del nostro dottorato; che n’era, a così dire, il substratum, la quintessenza, il patriziato, e quindi doveva tutte parteciparne le viste, tutte le repugnanze. Finalmente, vi ha un argomento al quale come ad ultima ratio ricorre il signor Frank; nè male veramente si appone, sendo questo, e per esso e per noi, decisivo. Egli è l’argomento cronologico. Prova il Frank che R. Iohanan Ben Zaccai, grande Patriarca della misteriosa[70] Mercabà, molto tempo innanzi fioriva che una scuola si schiudesse in Alessandria, che un solo filosofo vi facesse udire delle sue dottrine la voce. E non solo R. Iohanan Ben Zaccai, ma un dottore ad esso posteriore, R. Gamliel, quella scuola alessandrina precedette di tempo, conciossiachè da lunga pezza egli fosse già morto quando i primi albori spuntavano di filosofia nella città di Alessandria. Or bene (cosa meravigliosa e pur vera!), non si avvide il signor Frank, che questa stessa cronologica repugnanza si oppone a dirittura a qualunque preteso rapporto tra l’Essenato e gli Alessandrini; che questa anteriorità ch’egli a buon diritto conferisce ai dottori sulle scuole di Alessandria, di gran lunga maggiore, vantano meritamente gli Esseni, siccome quelli che, a confessione del medesimo signor Frank, erano, come attesta Giuseppe, generalmente conosciuti non solo ai tempi superiormente indicati di R. Gamliel e di R. Iohanan, ma in tempi assai più per antichità ragguardevoli, ch’è quanto dire ai tempi di Gionata Maccabeo, quando 150 anni dovevano ancora passare pria che di Cristiani si parlasse, pria che le scuole alessandrine risuonassero di quelle dottrine, che si vogliono generatori, balj del grande Essenato. E questo è argomento che davvero vi sembrerà categorico. Nè ciò basta.
Quando più saremo innoltrati nelle presenti esposizioni, molte cose vedremo che a confermare varranno la impossibile derivazione straniera del grande istituto degli Esseni. Vedremo la loro forte e rigida organizzazione, i gelosi insegnamenti, le lunghe prove, le incomunicabili dottrine, la perpetuità, la immutabilità dei dettati e tutto; insomma, vedremo quello che costituisce una forte, un’autonoma personalità, ove il genio spicca della originalità anzichè della imitazione, del profondo e concentrato sentire anzichè della espansione, della interiorità anzichè[71] della esteriorità. In una parola, noi vedremo come non solo tutti gli argomenti dal signor Frank accampati, ma ben altri ancora rendano sommamente improbabile quella greca paternità, che pel Munk, pel Frank e per V. Gioberti si volle agli Esseni assegnare. Adesso venga pure avanti nella prossima conferenza l’origine cristiana, che non la temiamo. Faccia pure l’estremo di sua possa, chè rimarrà ancor essa sconfitta. Tutti i campioni che ella potrà mettere in campo, non salverannola dall’ultimo eccidio. Dirò come David nell’atto di affrontare Golia: «Ed io pure il Leone, ed io l’Orso percossi a morte.»—Quando si è avuto l’onore di convincere d’inesattezza gli autori questa sera rammemorati, si può a buon diritto sperare di venire a capo di altri eziandio. E sin da ora ai difensori della origine Cristiana potrò dire con Dante:
Ch’a più alto lion trassi lo vello.
LEZIONE SETTIMA
Movendo in cerca della origine storica, della derivazione degli Esseni, due furono finora i sistemi che abbiamo discusso. Quali questi sistemi si fossero, voi certo lo ricordate. Fu quello in primo del Salvador, che questa origine pone durante la invasione dei Siriaci sul suolo Ebraico. Fu quello in ultimo che sotto gli auspizj ci si offriva del Frank e del Munk, i quali la origine veggono entrambi dell’Essenico istituto nelle scuole, nelle idee, che la greca civiltà trapiantato si ebbe sulla terra di Egitto. Qual fu il giudizio che emerse dal duplice esame? Io non so se sbaglio, ma parmi avere abbastanza dimostrata la improbabilità di ambedue i sistemi.—Avvi ancora un terzo da esaminare; e quello si è che agli Esseni, all’Essenato un’origine attribuisce, un carattere assolutamente cristiano. Potremmo noi senza citarlo in giudizio procedere risolutamente alla dimostrazione di quella origine che crediamo più vera? Io credo che nol possiamo. Nol possiamo, perchè troppo si disdice ad accorto strategico, lasciarsi fiero e numeroso nemico dopo le spalle. Nol possiamo, per le smodate pretensioni che accampa, per la fama, per l’autorità dei suoi campioni; ed infine, permettete che io aggiunga, per il legittimo e dolce desio di un trionfo. Io ricordo però come il Profeta ammoniva, non prima doversi celebrare[76] vittoria, che l’arma non si discinga debellatrice. Mestieri è dunque combattere, e combattere virilmente. Il campo conoscete, conoscete del litigio la causa; solo vi manca di conoscere gli avversarj, e dopo gli avversarj, le armi, gli argomenti proposti, e infine i poderosi argomenti della difesa.—Quali sono gli avversarj? Si può dire arditamente che nè maggiori potrebbero essere nè più cospicui. Qui è per primo Eusebio, il quale nel secondo libro delle Istorie Ecclesiastiche non dubita di affermare, non altro aver voluto Filone ritrarre, laddove degli Esseni prese a discorrere, che la Chiesa Cristiana allora nascente. Eusebio che aggiunge (e di che sappia l’asserzione vedremo fra poco) che il nome di Terapeuta vale a dire il nome in Egitto equivalente a quel di Esseni, anzi la greca traduzione del vocabolo Esseni, fosse comune appellativo dei primi Cristiani, anzi che questo nome di Cristiani assumessero.—Qui Epifanio che dice risolutamente, aver Filone nei Terapeuti dipinto il modello e i prischi tentativi del monacato cristiano; qui S. Girolamo che, per andare per le corte, converte di motuproprio al Cristianesimo il nostro Filone, che storico degli Esseni, Egiziani ed Essena egli stesso, fu quello le cui memorie togliamo anch’oggi qual guida, almeno principalmente nella cognizione dell’antico Essenato; qui il pseudo Dionigi Areopagita, che seguendo ciecamente l’andazzo dei suoi, giunge sino a chiamare un monaco a cui scrive, col bel nome di Terapeuta; qui Sozomeno, storico dei primi secoli dell’E. V., che alla sentenza medesima aderisce, solo per correttivo aggiungendo aver forse gli Esseni qualche vestigio conservato di riti giudaici; qui un cardinale, il Baronio, che a dimostrare la verità dell’antico Cristianesimo dei Terapeuti, così argomenta. Egli avverte il silenzio che degli Esseni si conserva assoluto per tutto il corso degli Evangelj, ed a[77] questo silenzio non trova il Baronio che altre cause si possa assegnare, tranne coteste due. È la prima, dice il Baronio, la identità degli Esseni colla chiesa Cristiana. È la seconda la posteriore loro apparizione alla predicazione evangelica. Ma la seconda, aggiunge il Baronio, si oppone alla storia, che la esistenza degli Esseni ricorda sin da’ tempi anteriori: dunque, sola è vera la prima, solo il Cristianesimo degli Esseni basta a spiegare il silenzio evangelico. Voi udiste l’argomentare del Baronio; udrete tra poco, come dice l’Alighieri, l’argomentar che gli farò avverso. Per ora seguitiamo la nostra rassegna. Io debbo un solo ancora ricordarvi degli avversarj, e questi è il P. Montfaucon. Chi era il Montfaucon? Egli appartenne al dottissimo ordine fratesco, alla regola di quel grande che fondò Cassino, e fu Benedetto. Il Benedettino Montfaucon, che visse nel secolo erudito del 700, lasciossi così appieno infatuare dal preteso Cristianesimo dei Terapeuti, che a provarne ad esuberanza la verità, si accinse, siccome credo per primo, alla traduzione di quelle opere di Filone ove dei pretesi Cristiani, dei Terapeuti, è parola.
Ecco gli avversarj. Quali sono i loro argomenti? Parte ve ne dissi, e questi più particolarmente appartengono agli autori rammemorati. Parte adesso ne udirete, e sono quelli che più di frequente si veggono dagli avversarj imbranditi.—Quali sono questi argomenti? Sono tutti, si può dire, fondati sopra qualche supposta analogia fra i costumi, le leggi, la società, il genio dei primi Cristiani, e quelle dipinture che degli Esseni ci lasciava Filone. Ella è ora la gerarchia che s’invoca dei Terapeuti, ove tutti i diversi ordini sembra a costoro vedervi della Chiesa nascente; ora le guarigioni dagli uni e dagli altri miracolosamente operate, i beni ai poveri distribuiti, l’erario e gli averi comuni, l’amore delle chiose, dei commenti allegorici, il predominio del[78] senso mistico sul letterale; eglino sono i digiuni, le macerazioni; ed infine, egli è il celibato. Ecco gli argomenti nemici; ed ecco i nostri. Egli è, in primo luogo, la contraddizione in cui cadde Eusebio, quegli stesso che primo vedemmo accreditare tra i Cristiani la voce del Cristianesimo Terapeutico. Or bene, tanto fu possente la verità, che lo stesso Eusebio non potè in qualche luogo dell’opera sua contrastargli l’ossequio. Voleva Eusebio provare come tra gli stessi Ebrei, nella stessa chiesa primitiva, allignasse lo spirito, la tendenza al ritiro, alla vita solitaria, alla contemplazione. Or che credete che faccia Eusebio? Egli cita gli Esseni; gli Esseni che, a senso suo, attestano l’antichità del genio cenobitico in Israel; gli Esseni che, per provare l’assunto, devonsi supporre Israeliti eglino stessi; gli Esseni, infine, che lo stesso Eusebio dovrà tra non molto dichiarare Cristiani. Si può dare contraddizione maggiore di questa? Eusebio però non si contenta di asserire, egli pretende inoltre provarne il Cristianesimo. Quali sono le prove? I Cristiani, egli dice, ebber nome Terapeuti, anzichè quello assumessero definitivo di Cristiani. È egli vero, costante, il fatto da Eusebio allegato? Parecchi antichi ne mostrarono la falsità. Lo mostrò, tra gli altri, il Basnage provando sino all’evidenza, come il nome Cristiani venisse dalla Chiesa adottato anzichè il menomo sentore avessero i nuovi credenti della esistenza nemmeno del nome Terapeuti; ch’è quanto dire che i cristiani tal nome ricevessero nella città di Antiochia, prima che altrove fosse predicato il Vangelo, pria che Marco Apostolo fondasse la Chiesa Egiziana, della quale si volle trovare i primi elementi nella scuola, nell’istituto dei Terapeuti. Che se il nome di Terapeuta lo vediamo tra i Cristiani usitato, siccome veramente il vedemmo, a denotarsi scambievolmente, che prova ciò? Prova soltanto che la parentela,[79] che la consanguineità Terapeutica fu antico vanto, vanto preteso della Chiesa Cristiana; prova soltanto che imbevuti siccome erano della origine Terapeutica, si gratificavano scambievolmente di sì bel nome per una illusione che io chiamerei volentieri illusione retrospettiva; prova soltanto che il credersi dai Terapeuti originato, era un onore che avidamente si agognava. E poi, chi meglio di voi conosce il senso lato, vasto, capacissimo del nome Terapeuta, del nome di Essena? Voi sapete che cosa significa; significa Medico, Risanatore, e Risanatore dell’anima, delle passioni; ch’è quanto dire un concetto vi presenta che ogni religione, ogni setta, ogni scuola, per poco che abbia amore di sè, per poco che alto voglia infondere in altri il senso della sua eccellenza, si approprierà volentieri, siccome quello che meglio adempie all’officio nobilissimo per quel vocabolo additato. Che maraviglia, dunque, che il Cristianesimo se l’appropriasse e che il togliesse, senza per questo accennare precisamente ad una origine, ad una filiazione qualunque? Vi ha ora l’argomento del Baronio, che dobbiamo giudicare con processo sommario. Che cosa diceva il gran cardinale? Egli argomentava il Cristianesimo degli Esseni dal silenzio degli Evangelj. Diceva il Baronio: due sono le sole cause plausibili di questo silenzio: o gli Esseni sono Cristiani, o ai tempi evangelici non esistevano.—Ma l’ultimo dei supposti è falso, perchè gli Esseni esistevano veramente, dunque è dimostrato che gli Esseni sono Cristiani.—Dante, quando nell’VIII canto del Paradiso volle parlare di Sigieri, che insegnato aveva logica in Parigi, disse di lui che nel vico degli Strami
Sillogizzò invidïosi veri.
Io non so in qual vico abbia sillogizzato il Baronio. Certo che i suoi non sono invidiosi veri; piuttosto invidiosi[80] falsi. Io potrei, a combattere il Baronio, valermi degli argomenti del Basnage; ma non me ne valgo per la ragione semplicissima, che credo un solo il vero, il massimo degli argomenti, e questo non lessi scritto in alcun luogo. Non dirò con Basnage al Baronio: badate che la rete del vostro dilemma, non abbia in alcun punto a smagliarsi; badate che la setta degli Esseni non era numerosa, e quindi può essere passata inavvertita; che il ritiro in cui vivevano li sottraeva al rumore, alla pubblicità, e quindi agli affari ed alla conversazione degli uomini. Ciò non dirò perchè credo questi argomenti insussistenti; perchè credo che le sètte, le scuole, non si contino ma si pesino, che non valgano per quantità ma per qualità; perchè credo che il ritiro negli Esseni non fosse così assoluto quanto si vuol far credere; perchè credo che il ritiro, la solitudine, serva talvolta a farti più rimarcare, e come oggi si dice, a farti brillare per la tua assenza; e perchè, finalmente, il non imbarazzarsi nelle faccende altrui, non è sempre infallibile preservativo onde tu non sia molestato, accadendo infinite volte che per quanto tu ami cansare piati o litigj, pure tanto frastuono e baccano ti fanno d’intorno, che sei costretto finalmente a metter fuor dell’uscio la testa per chiedere di grazia che cosa si voglia del fatto tuo. E per questo non vo’ che il Baronio abbia facil vittoria dei miei obbietti. Piuttosto vorrei sapere in qual guisa non siasi degnato nemmeno considerare una terza alternativa, la quale rispettando la storia e spiegando il silenzio degli Evangelj, non costringa per questo a cristianizzare il grande istituto. E qual è l’alternativa in discorso? È la possibile, la pensabile identità dell’istituto Essenico con uno di quelli che il Vangelo rammenta, e che vissero cogli Esseni ad un tempo, coi Sadducei, cogli Scribi, cogli Erodiani, coi Farisei, con una insomma di quelle sètte di cui è[81] menzione negli Evangelj. Io credo, e voi già da un pezzo il presentite, come il più bello e più grande resultato delle nostre conferenze, la dimostrazione perpetua di queste mie lezioni, sarà il ritorno dell’Essenato in grembo a quella scuola più vasta che ha nome dai Farisei; e questa identità, la ragione, la storia, l’eloquenza dei fatti ci faranno debito di consentire. Ma se per noi è dovere di ammetterla, pel Baronio era dovere il discuterla. Perchè non la discusse? Perchè propose dilemma che non è dilemma? È inutile il cercarlo. Il perchè voi già lo sapete, perchè voi già ripeteste con me le parole di Dante.—Il Baronio, come Sigieri, ma in senso molto diverso Sillogizzò invidiosi veri.[22]
E non solo il Baronio, ma moltissimi altri vedeste sotto quel vessillo raunati. Quali sono le loro prove? Io ve l’esposi di già ad una ad una, e ad una ad una verranno qui invocate in giudizio. Si parlò di gerarchia, si vide tra quella dei Terapeuti e quella dei Cristiani analogia di nomi, di officj, di organismo. Che vuol dire ciò? Vuol dire, dicono gli avversarj, che i Terapeuti sono Cristiani: vuol dire, aggiungo io, che questi tolsero a imitare i Terapeuti, in quella guisa che tutte le idee e istituzioni, e il sacerdozio e i riti e tutto, tolsero ad imitare dell’Ebraismo; vuol dire almeno che Terapeuti e Cristiani, sendo da un corpo solo concetti e partoriti, offrono tra loro quelle affinità di sembianze che sono proprie dei fratelli, dei consanguinei. Ma non è sola la gerarchia: si citano le guarigioni miracolose, si dice che proprie furono dell’una setta e dell’altra, dei Cristiani e dei Terapeuti; e da questa comunanza la identità si conclude dell’uno e dell’altro. Parvi che rettamente concludasi? Io credo fermamente che a questa stregua, che a questa misura, poco meno di mezzo mondo diverrebbe Cristiano; che il diverrebbero i Dottori, i Farisei grandi[82] taumaturgi, come ognuno conosce; che il diverrebbero i sacerdoti pagani, che di simili guarigioni andavan superbi; che lo diverrebbe Vespasiano, di cui si narra la portentosa restituzione della vista ad un cieco mercè la saliva; che il diverrebbe Apollonio Tianeo, che circa quel torno empieva il mondo dei suoi miracoli. Ma più ci dicono: vi è di più; vi è la repartizione dei proprj beni ai poverelli, vi è l’erario comune o, in termini moderni, il comunismo, quale si praticava dalla Chiesa Cristiana. Ci chieggono; vi par cotesto argomento che basti? Sì, io rispondo, se la povertà volontaria fosse nata col Cristianesimo, e pria e fuori di esso non se ne vedessero gli esempj. Sì, se il monacato Buddistico, se i Bonzi, se i Fachiri non lo praticassero in Oriente. Sì, se tutto lo stato ebraico non fosse stato una spezie di pacifico comunismo, il cui alto proprietario o signore supremo era Dio. Sì, se i dottori non ce ne offrissero l’esempio proprio siccome quello che nei Cristiani si ammira; e se, finalmente, il Cristianesimo non potesse aver tolto anche quest’idea in prestanza all’antico Essenato. Che diremo poi dell’amore, delle allegorie, della esegesi mistica che si cita per quarto? Sarà egli più stringente argomento dei suoi confratelli? L’esegesi mistica! Ma l’esegesi mistica era il vezzo, era l’andazzo, era il gusto comune dei tempi d’allora. Lo era presso i pagani, quando si accostavano a spiegare i capolavori dei loro poeti; lo era presso i dottori, e le traccie ne durano immense, ne durano sensibilissime nei grandi monumenti che ci trasmisero, dove ad ogni piè sospinto ti si accalcano in folla le allegorie, le parabole, i miti, le tropologie, infine tutto quello che la veste esteriore costituisce delle dottrine riservate, e come dice Gioberti, della scienza acroamatica dell’Ebraismo. Dovremo noi soffermarci ai digiuni, alle macerazioni, che si dicono comuni? Noi questo solo diremo,[83] che se digiuni e macerazioni dovessero essere assunti a criterio d’identità, l’origine degli Esseni non dovrebbe a lungo cercarsi, perchè bella e pronta noi l’avremmo tra i dottori trovata, ove in un ramo soltanto, notate bene, in un ramo soltanto della loro scuola, tali si vedono prodigiosi e prodigati digiuni, da disgradarne le più raffinate macerazioni della Tebaide. Sarà egli più felice argomento il celibato, che qual distintivo comune a provarne s’invoca l’identità? Il celibato, per ciò che riguarda gli Esseni, non può essere inteso assolutamente ma parzialissimamente; quindi non prova. Quanto ai Terapeuti, che sono gli Esseni Egiziani, il fatto corre alquanto diverso; epperò il raziocinio offre alquanto più del verosimile. Ma quanto a veder bene non è fallace! Non tanto perchè i Terapeuti non praticassero il celibato, chè veramente il praticavano, ma sopratutto (curiosissimo a dirsi!) perchè i Cristiani allora nol praticavano, perchè tempi eran quelli ancor distanti dal fervor religioso che spinse gli uomini nei chiostri, nei cenobj, nei romitaggi; perchè Paolo allora bandiva, dovere il vescovo vivere senza colpa colla donna sua; insomma, perchè il celibato cristiano non era ancor nato.
Gli argomenti a favore sono caduti: adesso cominciano gli argomenti contrarj: la guerra difensiva è terminata, adesso si vuol prendere energicamente la offensiva. Quali sono di oppugnazione le armi? Sono parecchi pensieri, e tutti serj, e tutti stringenti. Ella è, in primo luogo, le tendenza di ogni parte, di ogni setta osteggiante ad appropriarsi quanto vi ha di bello e di buono nella setta, nella parte rivale. Dante è guelfo per i guelfi; è ghibellino pei ghibellini. Maimonide è cabbalista pei cabbalisti, è antimistico pei loro nemici. Aristotile, Platone ed altri ancora, se fossero stati conosciuti, sarebbero stati dai nostri dabben proavi, giudaizzati e colle debite forme[84] circoncisi. Seneca fu battezzato da S. Paolo, o da chi per esso, e tanto eco ebbe di sua conversione la fama, che la tesi fu trattata di recentissimo innanzi l’illustre Accademia Parigina in un libro che vide poi per le stampe la luce; nè di questo dirò più sillaba, avendone io a dilungo parlato, in una lettera che or sono alcuni anni, pubblicava l’Educatore. Nè agli Esseni incolse dissimile ventura. Parevano così santi, così dotti, così esemplari, che non si potè più a lungo tollerare il loro Ebraismo. E così un bel giorno furono presi e fatti Cristiani; come Cristiano fu fatto Giuseppe, come Cristiano fu fatto Filone, e come Gamliel e come Akiba furono debitamente cristianizzati e in terra santa seppelliti nella chiesa di S. Francesco di Pisa.
Ma di queste fole più non si parli. Diciamo piuttosto di argomenti più serj. E serissimo, a parer mio, è quello che si trae da Giuseppe e Filone[23] Io già ve lo dissi, Giuseppe e Filone furono i due scrittori che tolsero con qualche diffusione a narrare della scuola, delle dottrine degli Esseni; e l’ultimo in spezial modo, che due interi libri dettava a descriverne lo istituto, oltre quelle diffuse nozioni che qua e colà sparse si trovano per avventura nelle opere rimanenti. Or bene, Giuseppe e Filone non sono soltanto gli storici, gli espositori, i descrittori del grande istituto, ma ne sono eziandio, e in grado eminente, i panegiristi, gli encomiatori, i lodatori. Non cessano e Giuseppe e Filone di laudarne la virtù, di celebrarne le dottrine, di encomiarne il costume; e tanto profuse e tanto magnifiche riescono di costoro le lodi, che grave ingenerarono sospetto nell’animo ai posteri, non forse più che verità consentisse, di gioconde e gaie tinte spargessero il quadro ad attirare la stima, l’ammirazione, l’ossequio del mondo gentile. Dite di grazia. Potevano e Giuseppe e Filone con tanta pompa favellare di un istituto[85] Cristiano, d’un Istituto che cattedre ed altari elevasse contro la pristina fede; il potevano essi che nacquero e vissero e morirono nella più pura ortodossia?[24] Il poteva Giuseppe, che non rifinisce di laudare la scuola farisaica, ch’è quanto dire la scuola che più apertamente si osteggiava dal Cristianesimo; il poteva Filone, che la vita consacrò e gli studj e le fatiche alla esaltazione del nome, della fede ebraica, e che la età senile non trattenne dalla famosa ambasceria a Cajo Caligola, dove alta e solenne levò la voce in difesa dei patrj riti e della patria salute? Che se Filone e Giuseppe, Ebrei pronunciati, non potevano tante lodi prodigare se non ad Ebrei; se gli Esseni, ebrei essendo, non lasciavano di possedere parecchie doti, qualità, costumi, istituzioni che il Cristianesimo si appropriò, come desumere da queste simiglianze la identità? Come non avriano potuto essi che queste cose possedevano di proprio in antico, come non avriano potuto continuare a ritenerle senza farsi Cristiani? Certo che il potevano e certo ancora che i generosi encomj dei due grandi Israeliti fanno fede pienissima contro ogni supposta apostasìa. Però Filone di lodarli non si contenta. Due libri ei scrisse, come vi ho detto, di cui il primo consacrò agli Esseni, l’altro dedicò ai Terapeuti. Il primo suona: Ogni onest’uomo è libero, il secondo si chiama, De vita contemplativa. Or bene, il prima è prova come a senso di Filone, Ebrei fossero gli Esseni, poichè di costoro favellando, il nome apertamente e la qualificazione gli assegna di Ebrei. Si può dire altrettanto dei Terapeuti che prese a têma della seconda opera sua? Certo che sarebbe meno esplicita la deposizione Filoniana, se non sapessimo che la vita contemplativa forma come una parte seconda del primo libro rammentato; più, se nel passare dagli Esseni ai Terapeuti, se nel prendere di quest’ultimi a favellare, una frase ei non usasse ove i[86] legami, la parentela delle due sètte apparisce manifestissima; se, infine, concorde non sorgesse oggimai una voce ad ammettere tra Terapeuti ed Esseni, non solo alcun tratto di somiglianza, ma salvo qualche varietà d’indirizzo, una sostanziale e perfetta identità; se di questo universale ossequio facendosi interprete, non ci ammonisse il Jules Simon, nella Istoria della scuola di Alessandria, così dicendo: Il est plus que vraisemblable que les Thérapeutes sont des Esséniens voués à la contemplation; e ciò che più monta, se queste parole precedute non fossero da un coscienzioso esame sul preteso cristianesimo dei Terapeuti. Che se Ebrei sono gli Esseni a confessione di Filone, se i Terapeuti altro non sono che Esseni contemplativi, chi non vede come le insegne di Ebrei più ai Terapeuti non disconvengano, che non agli Esseni?
È egli Filone il solo a proclamare degli Esseni lo ebraismo? Per ventura, non è il solo. Una voce vi ha, s’è possibile, più autorevole, che l’attesta. E qual è? La voce della cronologia. Attendete, e con qualche diligenza mi seguite, chè si tratta di cifre. Quando nacque Filone? Nacque, e ne abbiamo certezza, l’anno 724 dalla fondazione di Roma. Quando scrisse le opere in discorso, quando parlò, quando l’elogio compose dei Terapeuti? Egli dice che era, allor giovanissimo. Giovanissimo, accennerebbe ai 20 a 30, ma pure diamogli, se così volete, anni 40, i quali addizionali ai 723 dalla fondazione di Roma, costituirebbero la somma di 763. In che anno della romana fondazione nacque Gesù? Nacque il 753, ch’è quanto dire non più di anni dieci pria che Filone a scriver si accingesse le opere sue; non più che dieci anni prima del grande e sublime ritratto che ci porge Filone dell’Essenato Egiziano, coi suoi romitorj, colle sue leggi, colle sue tradizioni, col suo culto purissimo, e, ciò che[87] più urge al fatto nostro, colle sue istorie, coi suoi libri antichi, colla venerata memoria dei suoi predecessori.
È egli possibile, dopo prove siffatte, parlare di Terapeuti Cristiani? Però vedete astuzia! Noi citammo Filone e i suoi encomj; encomj incomprensibili in bocca ad un Ebreo, ove i Terapeuti supporre si vogliano cristianeggianti. Or bene, che credereste che facciano gli avversarj! Con un colpo di mano ci rapiscon Filone. Audacia direte enorme, se altra fu mai. Ma pure la è così. Se Filone credeste finora Ebreo, disingannatevi. Egli è Cristiano, e davvero Cristiano, testimone S. Pietro che in Roma vedutolo, lo convertì. Ma la buona gente non guarda tanto per la sottile, nè spinge più che tanto le sue indagini. Non cerca, per esempio, se il preteso Cristiano ci abbia di cristianesimo alcuna traccia tramandato nelle opere sue; che strana cosa ed incredibile veramente sarebbe questa, se tutto lo zelo ed il fervor del neofita una sola parola posta non gli avessero in bocca, non dico di elogio, di venerazione, di fede, ma nemmeno di semplice ricordanza, di semplice citazione. Non veggon cotestoro che invano tutto questo si chiederebbe alle opere Filoniane, che per quanto si stendono, non menzione vi ha di G. C., non di Pietro il conversare preteso, non dei Vangeli, non dei dogmi cristiani; ove dogma cristiano non vogliam dire la teoria del Verbo, comune non solo alle religioni orientali, ma propria altresì di Platone suo donno e maestro; non infine di quel dogma menzione, sul quale tutto s’appunta l’edificio cristiano, voglio dire l’Incarnazione o, come Gioberti il chiama, il dogma teandrico. Che se occhi non han costoro per vedere, non hanno nemmeno orecchi per udire; per udire, per esempio, Giuseppe quando, sopravvissuto a Filone, di Filone parla con la riverenza ch’ei sentiva per un tant’uomo; quando lo dice insigne nella sua nazione, quando leva a cielo l’attaccamento[88] di Filone alla fede, alla patria, a tutto Israele. Avria così di Filone favellato Giuseppe, se Filone conchiuso avesse la vita nella apostasia, nella fede cristiana? Certo che non avrebbe; e certo egualmente che le lodi di Filone sul labbro a Giuseppe, come quelle degli Esseni in bocca a Filone, come tutti gli altri accennati argomenti, sono una catena ben connessa, ben stretta, ben coerente, che c’interdicono, degli Esseni parlando, i limiti varcare e i confini dell’Ebraismo. Io potrei valermi del dritto di rappresaglia; potrei sotto ai vessilli riparare del Salvador e sancire quella derivazione che egli propone delle idee cristiane dall’Essenato; potrei dire con esso: son organisation et ses mœurs occupent un rang très élevé parmi les causes qui pendant la jeunesse de Jésus imprimèrent la première impulsion à sa pensée; potrei far eco ad Adolfo Esquirol, il quale non dubitò sentenziare: «Les Evangélistes se rattachent par leur Maître à la secte des Esséniens.»[25] Potrei tutte queste cose togliere a dimostrare; e comecchè tornerebbe agevole con corredo non esiguo di prove sussidiarle, ciononostante mi rimarrò, che dette influenze esteriormente esercitate dall’Essenato, qui non è luogo a trattare. Ci basti che inviolati ne sieno i sacri recinti, ci basti che pura ed intemerata e legittima ne sia la origine, ci basti che del più puro sangue sia egli concetto del corpo ebraico.
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
LEZIONE OTTAVA.
Grande ricerca, o signori, imprendevamo, ed è questa la origine degli Esseni. Noi esautorammo le false, le spurie derivazioni che pregiudizi multiformi ci volevano imporre, noi respingemmo là dove il sole tace di verità l’origine pagana, e dopo questa l’origine alessandrina, e per ultimo vedemmo di che sapesse la cristiana paternità. Mestieri è ora rivolgere a migliore indirizzo le nostre forze, mestieri è pure ch’a correr miglior acque alzi le vele omai la navicella del mio ingegno. Però se il còmpito nostro riesce tuttavia grave e scabroso, quanto però non ci si presenta e più piana e più secura la via! Noi conosciamo gli scogli e li eviteremo; noi sappiamo come circoscritta, e per ciò stesso più sicura sia al presente l’opera nostra, noi sappiamo come esclusi, eliminati per sempre il Paganesimo, la filosofia, e il cristianesimo quai padri presunti del grande Essenato, non ci resti che una fede a cui chiederlo, un popolo ove cercarlo, una filosofia a cui riferirlo, e questa è la filosofia, la fede, il popolo Ebraico. Ma se sappiamo che il campo ove nacque fu l’Ebraismo, ci resta a conoscere il dove, il quando, il come e quel germe particolare e quel particolare terreno conoscere ove il gloriosissimo albero allignava; ch’è quanto[102] dire la origine propria, la origine propriamente detta del grande istituto degli Esseni. Però due cose si distinguono in ogni corporazione, in ogni istituto, e quindi duplice è il modo con cui considerare se ne può la origine. Dissi due cose, e ve lo provo. È la prima la parte per così dire ideale, rudimentale, gli elementi che costituiscono ogni corpo sociale, le pietre a così dire distaccate del grande edifizio, le molecole primitive di cui è composto, i materiali di cui fu fatta la fabbrica.—L’altro aspetto, è la fabbrica in sè stessa, e il tempo, la data, l’origine, della sua esistenza complessiva indivisa, definitiva; l’origine, starei per dire, della combinazione dei diversi elementi costitutivi in un tutto ordinato, organico, positivo, esteriore. Quindi due origini quando degli Esseni si parla: origine degli elementi delle parti loro costitutive, e questa è l’origine prima:—Origine poi della personificazione della incarnazione di questi elementi in un ente sociale, e questa è l’origine seconda. Io chiamerò la prima origine dell’Essenismo o Essenato in quanto accenna ai caratteri ed alla genealogia storica dei principj; io chiamerò la seconda origine degli Esseni in quanto meglio allude agli uomini in cui l’Essenato divenne persona, e alla genealogia storica dei suoi professori. Facciamoci dalla prima di queste origini, dall’origine dell’Essenato ossia dei caratteri, delle idee, del genio delle istituzioni degli Esseni. Io credo che voi non disconoscerete la importanza di questa ricerca. Quando pure avverso fato ci contendesse il rintracciare la seconda di queste origini, cioè l’incominciamento storico, individuo, complessivo della setta, ei sarebbe acquisizione preziosissima la storia, la origine degli elementi di cui si compose. Ma il fato ci arriderà benigno meglio che non estimate; e lo studio che siamo per fare al presente, verrà compito, integrato da quello che faremo[103] di poi; e l’origine delle idee vedrà immediatamente seguirsi l’origine della loro personificazione in un sodalizio. Io chiedo adunque all’Ebraica antichità gli elementi dell’Essenato, e che cosa mi risponde l’Ebraica antichità? Ella mi risponde, offrendomi una istituzione in cui, siaci lecito il dirlo, gran parte si dipinge dei caratteri e dell’Essenato, ed ove tranne l’associazione, l’organizzazione sociale, e tranne il celibato, la fisonomia splendidamente rifulge di precursori, di preparatori del grande Istituto. Qual’è questa istituzione? Ella è l’istituzione del Nazirato. Non so se voi quanto sia mestieri conosciate che cosa è Nazirato: fatto è che nè conosciuto nè apprezzato egli è a parer mio quanto pure si dovrebbe. Nazirato era quello stato di religiosa separazione in cui volontariamente si poneva ognuno che più particolarmente si volesse a Dio dedicato. Si dedicava, o miei giovani, al Signore con tre specie di voti che i precipui obblighi costituivano dei Nazirei. S’interdiceva in primo luogo non solo il vino ma l’aceto, ma l’uva istessa, e stando alla parola Scehar ogni bevanda eziandio inebriante. S’interdiceva in secondo di rader un sol capello della chioma, la quale doveva al termine del suo voto recidersi tutta ed al fuoco bruciarla del sacrifizio che il Nazireo offeriva; s’interdiceva per ultimo di venir menomamente a contatto con un cadavere, nè qualunque altro genere contrarre di impurità che da quel derivasse. Di questi tre voti, di questi tre obblighi, due vediamo comuni agli Esseni; comune cioè la interdizione del vino, siccome a suo luogo vedremo, comecchè da talun contestata; comune l’orrore da ogni corporea impurità, come più estesamente sarà da noi dimostrato; e se comune non vediamo egualmente la intangibilità della chioma, egli è perchè la perpetua consacrazione, il vincolo non temporaneo degli Esseni la rendeva impossibile, e soprattutto perchè[104] la legge dei Nazirei formalmente ne assolveva coloro che la intera vita sacravano, siccome meglio dalle cose sarà chiarito, che in appresso diremo. Voi comprendete già come questi strettissimi obblighi, uno stato costituissero pegli Esseni di particolare santità; ma quanto più questi voti non acquisteranno valore se li vedrete dovunque applicati ove una maggiore si esiga o più esquisita perfezione religiosa! Se li vedeste per esempio iterati e tra i doveri annoverati dei sacerdoti; se esplicita invocassi l’inibizione che ai sacerdoti interdice l’uso degli inebrianti ogni qual volta l’alterno servigio li chiamava attorno il santuario: se vi mostrassi Nadab e Abiù, i due infelici figliuoli di Aaron, divorati da un fuoco miracoloso solo per aver, secondo la tradizione, libato del vino al loro ingresso nel tempio; se vi citassi infine la legge che vuole i giudici pro tribunali, sedenti sobri per tutto quel giorno di liquore ebriante; se vi dicessi con Ezechiele che i sacerdoti non debbano radersi assolutamente la testa, ma sì tanto della chioma rispettare che bella mostra faccian di sè nel pubblico servigio; se tale vi citassi una frase in Geremia ove la capigliatura, la lunga chioma è detta serto, è detta corona; se passando poi al tema delle impurità, vi mostrassi i Nazirei equiparati nelle rigide osservanze non solo al volgo dei sacerdoti, ma al grande, al sommo pontefice egli stesso il quale solo esso in questo ai Nazirei somigliante, doveva non solo da ogni impurità tenersi lontano, ma nemmeno gli estremi offici rendere ai prossimi parenti, al padre, alla madre, al fratello, alla sorella, pei quali invece al sacerdote volgare era conceduto immondarsi.[26] Che più? Se vi mostrassi a certi effetti, in certi casi e secondo certe opinioni, il Nazireo allo stesso pontefice sommo in santità sovrastare, quando cioè pontefice e Nazireo imbattutisi per caso in cadavere derelitto[105] era imposto al sommo pontefice rispettare la santità del Nazareo e la propria dignità obliare per rendere gli ultimi doveri a quel corpo infelice. Certo, che dopo avere tutte le anzidette cose udito a ricordare, certo esclamerete che ben grande doveva essere nella mente del divino leggidatore, del Nazireo il concetto. Che sarà poi se i termini intenderete con cui sul conto suo si esprime? E quai termini! La corona di Dio è sul capo suo, vi dice aperto il sacro testo.[27] Non basta: Per quanto dura il suo Nazirato sacro è desso al Signore. Termini che nè diversi, nè più pomposi suonano pel sacerdozio, termini chè chiaramente la parentela, l’affinità ti rivelano, che volle Iddio stabilita tra il Nazirato e il sacerdozio, tra il Nazirato sacerdozio incoato, virtuale, temporario, e il sacerdozio Nazirato attuale e perpetuo. Voi udiste parlare di corona sacra a proposito del Nazareo, e di sacra corona intenderete parlare a proposito del sommo pontefice. Voi udiste il Nazareno qualificato sacro al signore, e sacro al signore recava in lettere d’oro sul frontale inciso il sommo pontefice. I sacerdoti sono ministri dei sacrifizi, e ministri esclusivi, chi non lo sa? Ma pure se vi fu uomo che tutte le ordinarie regole conculcando dei sacrifizii, si sia eretto a pubblico, a solenne immolatore, e se eretto si sia comecchè nè sacerdote nè in luogo celebrante al culto di Dio dedicato; se uomo cotale vi fu, ei fu un Samuele, ei fu un semplice levita, ei fu un Nazareno; e se in progresso di tempo, e se dei redivivi Nazareni, e se infine degli Esseni fu detto siccome da Giuseppe apparisce, che fuori del tempio sacrificavano, chi sa che lo esempio di Samuele ad accreditare non sia valso una opinione siffatta! Fatto è che il carattere sacro, religioso e quasi ieratico non fu mai ai Nazarei disdetto: non lo fu nemmeno ai tempi malaugurati della invasione siriaca. Quando, secondo un preziosissimo[106] testo dei Maccabei, nel primo di questi libri al capitolo 3º, ritiratisi gli Ebrei fuori di Solima seco recano dalla santa città a Maspa, ove s’adunano e si accampano, tutto chè di più sacro e prezioso avessero nel tempio di Dio; quando siccome si esprime il testo istesso dei Maccabei, bandito un generale digiuno e postisi dei sacchi attorno e della cenere in sul capo, spiegano i libri della legge, arrecano le vesti sacerdotali, le primizie e le decurie e fanno venire innanzi i Nazirei, quando non sapendo in qual luogo più sicuro riparare tanto tesoro, esclamano, dice il testo, con gran voce dicendo: Che faremo a costoro e dove li meneremo? Conciossiachè il tuo santuario sia calpestato e profanato, e i tuoi sacerdoti sieno in cordoglio e in afflizione.
Io credo che non pochi insegnamenti abbiamo fin qui acquistato; abbiamo veduto tra gli antichi Nazirei e gli Esseni parecchi correre luminosissime attinenze, e tra ambedue altresì, e il sacerdozio costituito in Israele; abbiamo in tanta antichità rinvenuti parecchi degli elementi onde si formò di poi il nostro Essenato. Ma qui non finisce la vena feconda del Nazirato vetusto, qui non hanno fine i mirabili riscontri tra esso e’ moderni Nazirei che si chiamano Esseni. Solo che meglio vi piaccia la natura indagarne, solo che le frasi dei nostri Profeti, laddove dei Nazirei tolgono a ragionare, non vadano, come avviene, perdute nel torrente di una irreflessa e precipitosa lettura. Un passo principalmente vi ha di cui non si potrebbe ragionevolmente inforsare la importanza. Egli è il Profeta Amos quando rinfaccia ai coetanei suoi la ingratitudine onde ripagavano le insigni beneficenze di Dio, quando ricorda loro il portentoso riscatto, le spirituali divise con cui rivestilli, quando in ispecie ricorda i doni profetici, le fatidiche ispirazioni; quando esclama[107] in nome d’Iddio, E pure io fui quello che i figli vostri costituiva profeti e i giovani vostri costitutiva Nazareni. Non è forse così, o Popolo d’Israel, dice il Signore? Ma voi che faceste? Voi propinaste ai Nazareni il vino conteso, ed ai profeti intimaste dicendo: Non profetate. O io m’inganno, o nuova sembianza è cotesta che assumono i Nazareni. Non solo gente sacra e quasi sacerdotale, siccome vedemmo, ma gente, si può dire arditamente altresì, gente profetica. Chi conosce il genio della lingua Ebraica, la replicazione del concetto, nelle due metà del versetto, le predilette sinonimie, il parallelismo frequentissimo, non porrà menomamente in dubbio che nella mente di Amos, Profeti e Nazireni, il vino dai Nazareni libato, e la esautorazione del Profetismo non si unificassero a dirittura in un solo concetto. Per chi è autonomo nei giudizi questo è d’avanzo. Per chi ama invece poggiare sulle autorità ne avremmo a citare di soverchio. Potremmo dire del Parafrasta Caldeo che con significantissima sostituzione pone invece della parola Nazireni il vocabolo Arameo Malfin che suona insegnatori; potremmo invocare il venerabile Rasci che tale ci offre definizione di cotesti del profeta, che più acconcia, più precisa, più completa non si potrebbe dare degli Esseni medesimi; quando dice cioè ch’erano i Nazirei separati dalle comuni costumanze, e tutti dediti alla legge di Dio. Potremmo dal labro pendere di Abenesra ove col consueto laconismo, ma altamente espressivo pel caso nostro, Nazirei dice che consacrai a riprendervi, a santificarvi. Potrei chiamare a testimonio l’Abrabanel che dice il Nazireato esser preparazione allo spirito santo, che aggiunge essergli stato il vino propinato onde lo spirito divino non scendesse sopra di essi, nè quindi potessero vaticinare.[28] Or che cosa sarà s’io vi dicessi che gli Esseni andavano celebri per i loro vaticini[108] e che non poche delle loro predizioni ci sono da Giuseppe riferite, siccome a suo luogo vedremo? Certo che vedreste allora nell’antico Nazirato, nelle doti profetiche di cui va insignito un elemento nuovo dell’Essenato moderno, una pietra nuova del grande edifizio, un preludio alle Esseniche predizioni: e che sarà poi se vi farò toccare con mano nuovi riscontri nelle circostanze più particolari della vita, nell’abito per esempio, nel regime tra l’Essenato e i Nazirei; il sacerdozio antico e il Profetismo? Certo non negherete che sarà un passo di più verso la mèta a cui aneliamo, il ritrovamento delle parti integrali, degli elementi del grande Istituto. Or bene, volete sapere degli Esseni l’abbigliamento? Mirate ai Profeti ed ai Nazirei; due luoghi vi sono aurei tutti e due, luminosi tutti e due per chi ha gli occhi per vedere, dove il costume esteriore ci vien dipinto, ma di volo con un sol tratto, di Profeti e di Nazirei. Costume uniforme dei Profeti, colà abbiamo, laddove predicando Amos il discredito in cui saria caduta l’ispirazione, tanto vil cosa aggiunge sarà reputata, che niuno vorrà simulare nemmeno il portamento esteriore di un Profeta, che niuno più addosserà un mantello peloso.—Chi ha orecchi ascolti: un mantello peloso, ecco dei Profeti la divisa, il destintivo. Che se non contenti di aver trovato, se così è lecito dire, dei Profeti il figurino, ne voleste uno proprio di carne e sangue in cotal foggia vestito, potrei io esitare un istante, potrei io non vedere sorgere immantinente ai miei sguardi il severo, l’ispido Elia, l’uomo come il descrive il sacro storico, l’uomo peloso, l’uomo dalla cintura pelosa, Elia il Jesbita; Elia il solo superstite tra i Profeti di Dio, Elia che al sol vederlo in questo arnese caratteristico esclamano tutti? Elia attisbi u?[29] Ebbene mirate nell’autobiografia di Flavio Giuseppe ciò che del costume va esprimendo dei più rigidi tra gli Esseni, e mi saprete[109] dire se troppo disforme da quello procedesse tra i profeti usitato. Ma i men rigidi, i più urbani tra gli Esseni come vestivano essi? Ah! egli è qui ove ritornano in campo non solo i sacerdoti come gli Esseni bianco vestiti, ma ciò ch’è più, ritornano in campo gli stessi Nazirei e un nuovo e parlante rapporto ci offrono colla società degli Esseni. È tal cosa la Scrittura, o miei giovani, che se uomo non tende l’orecchio del continuo a spiarne non ch’altro le più fuggevoli espressioni, gran parte sperpera, miseramente perduta, delle sue ricchezze. È un mondo che si rivela per cenni ed enigmi, è la figlia del Re, secondo la magnifica parabola Zoaristica, che solo rivela la faccia sua bellissima, dopo avere con ripetuti cenni ed ammicchi l’attenzione e l’ansia provocate del suo amadore.[30] Testimone l’esempio che abbiam tralle mani. Chi avrebbe detto che la Bibbia contenesse perfino l’antico costume dei Nazirei? Eppure nulla di più esatto, la Bibbia lo contiene, in una locuzione, in una idea incidentale, ma pure lo contiene. Povero Geremia! Ei lamenta perdute tante cose e carissime! Ma non dimentica, credete per questo, cose di men rilievo, per esempio i bellissimi Nazireni e le loro vesti. Dove n’andaste, sclama nel dolor suo, Dove, o Nazareni dalle candidissime stole più della neve bianche, bianche meglio del latte? (Treni cap. IV, v. 7.) Perocchè glossa il venerando Rasci i Nazirei e i Farisei (notate questo contatto e ponetelo in serbo per altro tempo) i Nazirei e i Farisei mostravansi al di fuori tersi e puri colle bianchissime loro vesti, alla neve somiglianti, siccome alla neve si assimigliano le vesti dell’antico dei giorni, e siccome infine è costume dei Ilasidini; ed anche quest’ultima frase ponete in serbo, giovani miei. Ed ecco il costume degli Esseni, il costume dei più miti tra essi somministratoci dall’antico Nazirato, dal Nazirato consenziente anco in[110] questo col sacerdozio ministrante nel tempio di Dio.[31] Ma io dissi che negli antichi profeti un vestigio ritrovato avremmo della tavola degli Esseni, del regime degli Esseni. Dissi ben poco; doveva dire e la dietetica e la dimora e la scelta del luogo. Vi è un passo nel secondo dei Re ove la scuola dei profeti, i figli dei profeti come allor si dicevano, banchettando a cielo aperto ci permettono di osservare di che cosa si formassero le consuete imbandigioni. Io veggo primi rammentati i legumi; e legumi pure erano il cibo favorito nell’essenico refettorio, veggo radiche ed erbe qua e colà dai Profeti stessi raccolte su per i campi; ed erbe e radiche alternavansi talvolta negli essenici prandi. Che più? La scuola profetica abita non solo sotto il medesimo tetto, tralle stesse pareti, ma soggiorna eziandio lungi dall’abitato presso le rive del Giordano; e non sarebbe temerità s’io dicessi che non del tutto andò errato Gerolamo quando nelle frasi del testo intravide eziandio la costruzione di separate cellette.
Aveva io ragione di sperare larga suppellettile di elementi, di preludi, di presentimenti Essenici nella storia dei Nazireni, in quella del sacerdozio, in quella dei profeti che tanta parte offron pur essi della fisonomia dei Nazireni? Ma vi ha un’obbiezione che voi potreste fare e ch’io perciò appunto amo di prevenire. Potreste dire: il Nazirato era voto e vincolo; ma voto e vincolo a tempo, ch’è quanto dire era assai diverso dall’Essenato che una consacrazione importava la quale continuar doveva quanto la vita lontana. E benissimo vi apporreste se tra Nazirato ed Essenato non corresse a senso mio divario alcuno; se io dicessi le stesse forme, le stesse leggi essersi per tanto corso di secoli dall’uno all’altro tramandate senza alterazione alcuna. Ma ciò nè dissi nè poteva io dire in verità. Sebbene che dico? È egli poi vero che il voto[111] dei Nazireni fosse sempre temporaneo come voi dite? Certo che così pensò e scrisse un uomo dottissimo il Munk nella Palestina. Ma con sua buona pace sia detto: il Munk s’ingannò a partito. Non solo la tradizione attesta il contrario, non solo esempi vi sono luminosissimi di Nazirato perpetuo, e basti citare i nomi famosi di Sansone, di Samuele, e nei tempi Rabbinici di Elena la pia Regina degli Adiabeni;[32] ma sopratutto il testo stesso su cui pare il Munk affidarsi, se non dice aperto di un Nazirato a vita, non parla nemmeno di tempo, non prescrive termine, nè limitazione prefigge. Si dirà ancora che non vi fu Nazerato perpetuo? Io credo che la sua esistenza non possa revocarsi in dubbio, e quindi un nuovo elemento, un nuovo apparecchio emmi lecito intravedervi della grande e dotta congregazione degli Esseni.
Io non lascerò, o miei giovani, l’argomento dei Nazireni, anzi che non vi abbia fatto toccar con mano come oltre le regole, le leggi, le istituzioni, il nome stesso di Nazireno sinonimizzi mirabilmente con tutti quelli che in ogni tempo recarono gli Esseni, con tutta la ricca suppellettile di nomi con cui a senso mio furono contradistinti. Primo tra questi, e già in parte ve lo accennai altra volta, si è quello di Fariseo; nome che nella sua vastissima comprensione anco l’Istituto abbracciava degli Esseni siccome quello che dei Farisei era culmine ed apogeo. Or che vuol dire Fariseo? Vuol dire separato. E come direste separato nella lingua biblica, nella lingua della scrittura? Direste precisamente Nazir; col qual nome avrebbe qualificato Mosè i Farisei se al tempo suo fossero esistiti, in quella guisa che Farisei avrebbero potuto qualificare i dottori i Nazireni?[33] Vi pare assai? Udite ancora. Io vi dissi altra volta e ve lo proverò in seguito, come speciale designazione degli Esseni fosse ai tempi Rabbinici il nome di Hasidim. Volete ora vedere i Hasidim trasformarsi[112] in Nazireni? Certo che la metamorfosi vi parrà avventata. Pure nulla di più preciso se aprite il Talmud al primo di Nedarim. Dove leggerete questa confessione preziosissima; che i primitivi Hasidim solevano di frequente votarsi a Dio in Nazireni.[34] Volete più? Certo che voi discretissimi non esigereste di più: ma pure proviamoci: proviamoci a recare il sinonimo di Nazir con Essena a quella evidenza che si può desiderare maggiore. Voi vedrete tra non molto come il Talmud, come i monumenti Rabbinici più antichi tracciano, siccome fu creduto finora sul conto degli Esseni, come questo silenzio formasse sempre argomento di legittima sorpresa per chiunque si facesse ad osservarlo, e come questo preteso silenzio, fosse creduto, fosse ammesso non solo dai dotti, dagli eruditi di ogni maniera, ma eziandio dai succedituri Rabbini, dai dottori che sursero e scrissero dopo il Talmud i quali quando ebbero contezza, strano a dirsi! per mezzo dei moderni scrittori della esistenza di un antica setta fra loro per nome Esseni, quando di essa ebbero come di peregrina e inaudita scuola a favellare, che nome credereste che gli apponessero? il nome di Nazireni! Tanto pareva loro confacersi agli Esseni l’antico nome di Nazireo, tanto al genio rispondere il genio, la vita, le leggi alle leggi e alla vita.
Un grande insegnamento emerge, se io non sbaglio, dalle cose dette sin quì, ed è questo: che senza ammettere una generazione diretta od omogenea, grande però, massima parte di tutti gli elementi che la vita composero e la esistenza dell’Essenato si trovano contenuti e come in germe rinchiusi in seno al Nazirato ed al Profetismo. Purità, sobrietà, dottrina, ispirazione, vita solitaria e cenobitica, costume, dietetica e persino il nome loro caratteristico. Si può dire per questo che tutte abbiamo le parti costitutive dell’Essenato? Io non oso dir tanto:[113] vi ha un elemento nella organizzazione degli Esseni di cui traccia non solo nei Nazireni non si discopre, ma che pure ardua, se non impossibile impresa, sembra trovarne vestigia nella ebraica antichità; che dico? Che pare a dirittura contraddire alle leggi, ai costumi, allo spirito generale dell’Ebraismo. E questo è il Celibato. Il celibato fu egli dagli Esseni praticato? Ove sia stato praticato, ha egli radici, ha egli origine nel genio, nella storia, nel passato dell’Ebraismo? Io mi affretto a dirvi per ciò che concerne la prima dimanda, come il celibato fosse istituzione sì degli Esseni; non tale però che da tutti fosse egualmente praticata. Quando delle leggi loro favelleremo e del loro Istituto, vedremo come gravi restrizioni debbano accompagnare la divulgata sentenza che a tutti gli Esseni indistintamente attribuisce il celibato. Pure si praticò; e se non tutti come il più perfetto consideravanlo degli stati, certo che appo taluni era in grande onore. D’onde quest’onore? D’onde questa dissonanza dalla voce dei secoli che proclamava invece tra gl’Israeliti maledetto, infame il celibato? Ardisco dire che l’ebraica antichità non è sorda assolutamente al nostro dimando. Io vi so dire che certi fatti vi sono e certe frasi i quali attestano manifestissimo che se pel comune degli uomini, per le condizioni più comuni della vita sociale, lo stato coniugale è lo stato più onesto, più meritorio, più religioso, pure si dànno certi stati così sublimi, certi uomini così trascendenti, certi momenti così augusti, in cui la virtù della continenza, temporaria e passeggiera talvolta, si stende però altre fiate ad un epoca così vasta, e talvolta abbraccia così una vita intera, che male il nome si potrà contrastargli ed il carattere di Celibato. Quali sono questi fatti e questi precetti? Un occhio penetrante li scuopre a prima giunta nel gran campo delle scritture; una mente alquanto erudita li ritrova nel[114] grande emporio delle Tradizioni. Ecco i Dottori cui amore stringe della vita speculativa, della vita ipermistica dispensati formalmente dal matrimonio: ma di questo non dirò di vantaggio, perciocchè non appartiene a rigore all’epoca delle origini. Ecco un colloquio interessantissimo tra il sacerdote di Nobbe e David che chiede cibo per sè e pei suoi. Ecco il sacerdote obbiettare come i sacri pani non potessersi offerire a coloro che da contatto donnesco non si fossero astenuti. Ecco David replicare essersi tutti da tre giorni serbati continentissimi. Ecco Giobbe che pria di bandire i Riti e il sacrifizio domestico, impone ai figli, apparecchiarvisi con rigorosa castità. Che più? Ecco il gran fatto, il fatto più culminante nella storia dell’Ebraismo, ecco la promulgazione della legge ed ecco ciò che impone Moisè? Egli comanda si separi ognuno dalla donna sua e tre giorni di severissima continenza li predispongano al condegno accoglimento della parola di Dio. Volete più? Vi ha una tradizione preziosissima certo non coniata in grazia dell’Essenato, ma che pure torna mirabilmente in acconcio pel caso nostro, e la tradizione riguarda Moisè. Si volle, si disse, che da quel punto in cui Dio fece suonare quelle parole sacramentali «Ed ora qui rimanti con me;» il gran profeta avesse letto nel volere divino l’obbligo di sequestrarsi da ogni carnalità e di vivere oggimai la vita dei Celesti, e le sole voluttà omai pregustare che il novello stato gli offriva nel consorzio di Dio.[35] Che volete? Fosse consiglio della solitudine, fosse desio di scuotere a dirittura ogni polve terrena, fosse vaghezza di una perfezione superlativa, fosse persuasione di esquisita misticità, gli Esseni nostri, allo stato aspirarono eccezionale dei grandi uomini e dei grandi momenti nella vita dell’Ebraismo; aspirarono a fare una regola, una legge dell’anormale e dell’eccezione, agognarono ad ottenere del continuo quella[115] istantanea elevazione in cui si tennero i santi antichissimi in breve ora del viver loro; e invece di libare un sorso della vita beata, vollero votare interamente la tazza. L’erezione dello stato eccezionale in regola inflessibile, del transitorio nell’immanente costituì tra gli Esseni il Celibato.[36] Questi sono i germi, questa l’origine che ci offre la Bibbia. Quando parleremo della istituzione in se stessa, avremo un altro termine fecondissimo di raffronto, i Dottori e le Tradizioni; e il Celibato diverrà allora se occorre anco più comprensibile. Per ora noi abbiamo fornita parte non indifferente di nostra via, abbiamo notati, registrati nell’antichità Ebraica gli elementi dell’Essenato. Abbiamo descritta la embriogenia del grande Istituto. Otto giorni ancora e gli elementi disgregati, inorganici, impersonali diverranno un ente vivo, storico, parlante, organico, personale; in cui tutti o quasi tutti s’incarneranno i discorsi elementi. Noi possiamo dire oggi: questi sono gli elementi dell’Essenato. Noi potremo dire allora: questi sono degli Esseni i progenitori, gli antenati. Noi diciamo oggi, ecco le pietre, ecco i materiali: noi diremo allora, ecco la fabbrica, ecco il palagio, o almeno: ecco le fondamenta.
LEZIONE NONA.
Se prepotente io non sentissi il bisogno di giungere più ratto che ci è dato a la mèta prefissa, la tela che noi andremo questa sera svolgendo troppo maggiore argomento ci offrirebbe che quello di una sola conferenza. Le cose che ho a dirvi sono molte, sono gravi, sono di grande momento, sono la ricostruzione storica dell’Essenato per tutti i tempi favolosi, incerti, storici della sua esistenza, sono la storia della sua incarnazione durante i lunghi secoli che precederono l’Essenato propriamente detto, egli è infine l’albero genealogico del grande istituto. Io stringerò il molto in brevissimi termini, io vincerò il desiderio che pur provo vivissimo di farvi assaporare di ogni parte il valore di farvi misurare sol collo sguardo gli amplissimi orizzonti che ad ogni tratto ci si schiuderanno dinanzi, nè a questo bisogno meglio che desiderio, verrei men di certo se io non contassi sulla vostra penetrazione, sul vostro acume. Supplite voi al manco del mio dire; intendete meglio che io non possa spiegami. Fecondate colla mente ingegnosa i dati che vi vado porgendo, indovinate quello che per brevità io taccio, andate più lungi colla mente di quel che a me sia conceduto lo andare colle parole; e sopratutto stringete tutte in un fascio le cose che sono per[120] dirvi: sia la vostra mente un filo, anzi sia poderosissima catena che tutte unifichi le cose che sono per dire; alla seconda vi ricordate la prima, alla terza prima e seconda; nè giunga del mio dire la conclusione, senza che le precedenti cose vi stiano tutte dinanzi all’occhio della mente schierate, così io sarò breve senza pericolo, e voi istruiti sarete senza disagio.
Voi lo ricordate. Abbiamo trovato nelle passate conferenze gli elementi dell’Essenato, adesso ci è d’uopo trovare l’Essenato medesimo. Abbiamo veduto i suoi principii, adesso ci è mestieri vedere i suoi antenati; veduto abbiamo la storia delle sue idee, ci conviene adesso la storia studiare dei suoi precursori. Dove cercarla? Non vi dirò le laboriose investigazioni che emmi costata la costatazione di questa origine, la sua ordinazione, la sua confermazione. Voi stasera, o miei giovani, coglietene il frutto, ed il saperlo sarà il mio premio. Dove cercarla? Cercarla io dico colà ove l’origine si cerca di quanto vi ha di più nobile e venerando in Israele, dove si cerca l’origine della Reale Dinastia Davidica cioè nell’innesto di un ramo pagano sul ceppo ebraico,[37] nella Moabita Rut che fu madre del Regno siccome leggiadramente chiamaronla i Dottori; dove si cerca l’origine di alcuno tra i Profeti stessi, siccome Obadia che di pagano che era si fece ebreo secondo i Dottori, dove si cerca l’origine dei più illustri tra i Dottori i quali pressochè tutti sortirono a confessione di loro stessi i natali da progenitori pagani: tra i quali si potrebbe citare per tutti il gran Proselita Onchelos, il più popolare tra tutti i Dottori. Cercarla infine tra i Pagani al Giudaismo conversi, cercarla nella nobil famiglia dei Proseliti. Perchè così abbia disposto il Signore, perchè non sia gentil pianta nell’ebraico giardino che un ramo non rechi innestato dell’agreste e selvatico Gentilesimo; troppo vorrebbesi lunga e protratta[121] disamina perchè ci sia qui lecito il tentarla. Io domando solamente se l’Essenato deve al Proselitismo la sua origine, se in questo solo senso avvera l’opinione di coloro che gli Esseni dichiararon Pagani. Quale è tra i Proseliti che ricorda la Storia, il santo seme, onde poi allignò il rigogliosissimo albero? Io non so se ben m’apponga, ma io credo che il nome non vi riesca ignoto. Avete mai, o miei giovani, udito parlare di Jetro, di Jetrò il sacerdote di Madiani, il suocero di Mosè, il suo consigliere, lo approvato dal Signore, il primogenito tra i conversi, e secondo un antico Rabbino spagnuolo David di Leon, l’iniziatore di Mosè alla vita religiosa, alla propedeutica religiosa; tanto che se Mosè dir si può il padre di nostra fede, Jetrò se ne può dire l’avo? Io dissi primogenito tra i conversi e n’ho ben d’onde. Ho per me la tradizione che lo attesta, ho per me la formula quasi della sua abjura laddove all’udire il portentoso egresso di Egitto esclama ammirato: Ora sì riconosco che grande è l’Eterno al di sopra degli altri Dei. Ho per me l’atto istesso con cui al culto s’inizia nuovamente abbracciato, quando a Dio appropinqua olocausti ed ostie pacifiche, quando alla sacra mensa banchettan festanti assieme al Neofita, Mosè, Aronne e gli anziani tutti d’Israele; ho per me l’onore unico da nessun altro partecipato, tranne Jetro, di essere istitutore della Ebraica Magistratura, Dio consenziente non solo, ma encomiante; ho per me le parole mirabilissime di Mosè ove si confessa, quasi non dissi al grande suocero inferiore, quando cioè istantemente lo supplica di procedere seco lui per lo deserto, quando Jetro rifiuta dicendo: No, che solo al paese mio tornerommi e alla mia patria; quando senza lasciarsi ributtare al primo rifiuto torna Mosè e prega e scongiura, quando il titolo onorandissimo prodigagli il gran Profeta di suo duce, di suo conduttore e, secondo la forza[122] dell’ebraico vocabolo, di occhio suo. Ho per me i dottori quando dicono che ridottosi al suo paese non quietò il gran Proselita sino a tanto che non ebbe il culto degli idoli estirpato dalla sua famiglia; e questo è Jetro, e questa è la sua conversione. Ma della sua famiglia altresì io parlai e della di lei conversione. Dove ne sono le prove? Parlai dei dottori e delle lor tradizioni, ma io doveva dire la scrittura, la Bibbia in quei fatti momentosissimi ove si fa parola della discendenza del gran Proselita, ove ti apparisce la sua figliolanza costituita veramente in società distinta, sì, ma pure dimorante in seno agli Ebrei, ove per gran fortuna possiamo passo a passo seguire le vicissitudini tutte dei Jetroiti, ove al tempo istesso che vi leggiamo la loro storia, una esatta dipintura ci si porge altresì della successiva, della lenta formazione di un dotto di un Religioso Istituto in quella famiglia. Io oso dire che non è senza una particolare provvidenza che la Bibbia ci ha serbato memoria di questo fatto, che di tratto in tratto ha deviato dal suo prescritto cammino per toccare delle fasi in vari tempi percorse dai discendenti di Jetro. Quali sono queste fasi? In qual guisa vi si può come in ispecchio mirare la secolare concezione dell’Essenico Istituto? Ecco il come ed ecco i fatti.
Ecco il libro dei Giudici che non appena pochi passi ha mutati nella sua narrazione, non appena alle conquiste ha esordito dopo Giosuè operate, esce fuora con queste parole: Ora i figli di Cheni suocero di Mosè trassero dalla città dei Palmizi coi figli di Giuda al deserto di Giuda che è posto a mezzodì di Arad, e andò e pose stanza appresso al popolo.—Che parole son queste e che significano? Se io non erro, non troppo vi saranno riuscite per ora accessibili. Però tranquillizzatevi; questa difficoltà non è in voi, è piuttosto nel testo istesso, è la mancanza[123] di antecedenti che spianino la via alla sua intelligenza, è l’isolamento in cui il verso stesso si trova in seno al contesto, è quel piombare che ti fa subitaneo in sulla testa senza troppo sapere d’onde provenga, è quell’apparire istantaneo a guisa di lampo che pare scaturir di seno alle tenebre, per ricadere nelle tenebre, è quell’oscurità innanzi a cui resta perplesso, esitabondo ognuno comecchè erudito proceda nel sacro Idioma; nè se dovessi tutte le cause narrare di questa oscurità non saprei veramente venirne a capo. Però l’oscurità sentiamo, e la sentiamo gravissima; proviamo a diradarla. Si parla qui dei Cheniti, dei figli di Cheni. Chi sono i Cheniti? Sono certo Cheniti quei popoli di cui Dio accenna ad Abramo nella solenne promessa. Ma Cheniti sono, si chiamano pure i discendenti di Jetro, vuoi che Jetro appartenesse all’antico popolo dei Cheniti, siccome vuole il Munck, vuoi come meglio a parer mio opinarono il Gesenius, il Bohlen, il Tahu, come ad essi la tradizione consente, che Cheniti si dicessero da Jetro, appellato esso pure Cheni, vuoi finalmente che Cheni si dicessero da Chen nido, pel nido che facevano per campi e per selve siccome comprese il Zoar. Fatto è che i discendenti di Jetro si dicono Cheniti e che sotto il nome stesso ci si riveleranno in appresso i loro successori. Ma che cosa è la Città dei Palmizi? Città dei Palmizi è Gerico; Gerico chiamata negli ultimi versi del Pentateuco col nome istesso usato dai Giudici; Gerico situata poco lungi dalle sponde del lago Asfaltide. Ma in qual guisa li Jetroiti veggiamo stanziati in Gerico? Come dalla città lontanissima di Madian loro patria nell’Arabia Petrea, le orme seguirono di Israel sino nel cuore di Terra Santa? Nessuno lo spiega, e nessuno il narra, tranne la Tradizione. Ma quanto bene la Tradizione! Per la tradizione Jetro dopo i primi rifiuti, cesse finalmente alle istanze del divino[124] Mosè. Jetro, i suoi figli, la sua famiglia ricovrarono all’ombra del popolo Ebreo, battagliarono nelle sue battaglie, trionfarono nei suoi trionfi e le piagge dilette vider pur essi della Cananea conquistata. Ma quale gli attendeva laggiù guiderdone? In qual guisa si sdebitarono gl’Israeliti della promessa Mosaica che Jetro voleva a compartecipe dei beni, delle terre acquisite? Coi suburbi, colle campagne di Gerico, dice la Tradizione; le quali terre dovuto avrebbero li Jetroiti serbare in custodia sino a tanto che fosse il Tempio edificato, e la metropoli destinata, la quale, proprietà nazionale dovendo essere meglio che tribunizia, mestieri pure era porgere alla Tribù spodestata una adeguata indennità, e questa doveva essere il territorio di Gerico, la stanza antica dei Jetroiti. Ma questi, voi lo vedeste, partiti da Gerico traggono altrove. Dove vanno? Vanno, dice il testo, nei deserti di Giuda che sono a mezzodì di Arad, e in mezzo al popolo fermano stanza. Che luoghi sono cotesti? Voi vedeste poc’anzi come Gerico fosse posta sulle rive o a quel presso, del lago Asfaltide. Or bene; il deserto di Giuda, Arad istesso, la nuova dimora dei Jetroiti, non piega sulla carta dalla linea contrassegnata, e l’epoca stessa gloriosissima di Debora troveralli abitare sui luoghi medesimi. Che monta ciò, potreste dire? Nol direste però se tutto aveste già ascoltato; nol direste se io vi mostrassi come gli Esseni di cui adesso cerchiamo l’origine, quegli stessi luoghi abitassero in tempi tanto più posteriori, che gli antichi Jetroiti occuparono in tempi così antichi; nol direste se vi ripetessi le parole di Plinio nel Cap. 17 del libro 5, laddove degli Esseni parlando, li qualifica Gens socia Palmarum, gente dei Dattolari amica, nè più celebre di Gerico e della riva del Giordano s’ebbe giammai in fatto a Palmizi; nol direste se vi mostrassi in Plinio stesso al luogo istesso, come la città ove ai suoi[125] tempi abitavano gli Esseni fosse Engaddi, Engaddi posta essa pure sull’Asfaltide sulla linea stessa di Gerico e Arad, come vi mostra la carta, Engaddi famosa pur essa pei suoi Palmizj d’onde il nome derivolle più antico di Kazazon Tamar; nol direste finalmente se udiste Plinio istesso additarvi qual residenza altresì degli Esseni moderni Masada, città anch’essa meridionale di Palestina, anch’essa posta in riva all’Asfaltide, come di leggeri potete osservare nella Geografia del Dufour. Attalchè Gerico, Masada, Engaddi, Arad formano sulla carta una linea continuata che rasenta il Mar Morto, muove dall’ovest in direzione del Sud, e dove negli antichi e moderni tempi ebbero stanza gli Esseni ed i loro proavi Jetroiti. Ed a che fare traggono i Cheniti ad Arad? Ad abitare, dice il Testo, in mezzo agli Ebrei, a convertirsi, dice il Gersonide, definitivamente all’Ebraismo. E presso chi particolarmente riparano gli emigrati? presso Jahbez, dice la Tradizione, presso Jahbez, conferma la Bibbia nel 1º delle Cronache, come fra poco vedrete. Chi era Jahbez? Era Dottore, era Scriba, era Profeta, chè tutti e tre i caratteri solevano a quei tempi andare congiunti,[38] ed alla Tribù dotta, massima, reina, apparteneva di Giuda; in cui doveva secondo l’antica benedizione perpetuarsi lo scettro, e l’oracolo promulgarsi della legge di Dio, a cui il titolo di maestra leggidatrice si concedeva nel libro dei Salmi; Jehuda mehokeki in cui rifulse mai sempre il primato sulle sorelle Tribù. Che se tale era pure l’origine, qual’è il Ritratto che di lui medesimo ci fa la Scrittura? Io oso dire che il libro delle cronache tali usa gravi, significantissime espressioni sul conto suo, che in tutto il corso dell’opera stessa, non se ne veggono per alcuno altro le simiglianti. E bene le avvertirono i nostri Dottori i quali osservarono e giustamente; come da Adamo da cui esordiscono le cronache sino a Jahbez, niuno si trovi che[126] abbia fatto così nobilmente favellare di sè. E come favellano intorno a Jahbez i libri summentovati? Essi dicono E fu Jahbez sopra i suoi fratelli onorandissimo. Non basta. Il testo biblico reca manifeste le tracce di un gran voto da Jahbez pronunziato, voto che rimane per sventura incompreso poichè la promessa fatta al Signore restò implicita, restò sottintesa, ma che tutti i caratteri porge, come diceva, visibilissimi di un gran voto. Jahbez, dice il Testo, invocò il Dio d’Israel e così disse: Se tu mi benedirai, o Signore, se amplierai i miei confini, se la mano tua sarà in mio aiuto, se mi camperai dal male, onde non abbia a dolorare..... Ebbene che cosa aggiunge, che cosa promette Jahbez ove Dio lo ascolti? Vano il cercarlo! Il Testo lo tace, gli Interpreti non sanno dirci se non che voto vi fu, ma rimane ignorato; e lo stesso Rasci non seppe dettare che le frasi seguenti ed egli votò quel che votò, ch’è quanto dire come più non c’è dato sapere. Sebbene questo sappiamo; che Dio ne adempì pienamente le voglie, e quindi se voto vi fu, siccome par dimostrato, se la preghiera fu accetta, il voto fu anch’esso adempiuto. Ma perchè traggono i Cheniti a fianco a Jahbez? I Giudici tacciono; ma la tradizione e le cronache lo dicono esplicito. Che dice la Tradizione? A imparare la legge, a fondare una scuola. Che aggiungono le cronache? Parole aggiungono che tutto il valore hanno di una grande conferma, di una grande rivelazione; un tratto di luce, vivo, acceso, che balena e sparisce; una stella che brilla un istante e quindi la ricuopre la nube, un suono che rompe per un istante la monotonia di un canto uniforme, parole ed idee che non siamo usati incontrare in mezzo le viete ed aride genealogie delle cronache e che rivelano la presenza dell’elemento scientifico intellettuale teologico, nell’epoche più remote della nostra esistenza.[127] E quali parole poi perciò che riguarda i Cheneti e la origine degli Esseni!
Prende il Cronista a narrare le genealogie di Giuda, a ricostituire il passato d’ogni famiglia, a riconnetterla cogli antichi anelli di cui si parla nel Pentateuco. A un certo punto della genealogia ascendente, esce fuora con queste parole: Ora famiglie di Scribi di Dottori abitavano presso Jahbez le quali dicevansi, le quali sono i Cheniti che discendono dal fondatore dei Recabiti. Gran parole, o signori, e quante cose non s’imparano dalle parole citate! Vedete le famiglie di Scribi Solferim da Sefer libro in quella guisa che Letterato si disse un tempo ognuno che legger sapesse; Soferim che i Lessici interpretano coloro che espongono e spiegan la legge, qui lege describenda et esplicanda vacat, Soferim che lo stesso Kimhi al luogo istesso delle cronache non può a meno di comentare che scribi erano e Dottori della legge. Vedete i nomi stessi delle famiglie discorse, tutti significanti e parlanti secondo il valore che traggono dal sacro idioma. Vedete Tirhatim da tarha porta sinonimo in Ebraico, siccome è noto, di Aula, di Corte, di Magistrato e che noi Europei usiamo ancora quando diciamo la Porta Ottomanna, e quindi vedrete nei Soferim la gente Aulica, magistrale e Patrizia. Vedete la Mehiltà di Rabbi Ismael libro più antico del Talmud e forse più venerando, ove della parola tirhatim come delle altre che seguono tali si offrono graziosissime etimologie che più in acconcio non potrebbero tornare ai predecessori degli Esseni; anzi che dico? che a niun altro possono attagliarsi se non a costoro. Tirhatim dice la Mehiltà da tarha porta, conciossiachè abitassero alle porte di Gerusalemme. Meraviglioso a dirsi! Sappiamo da Giuseppe che una porta eravi ai tempi suoi in Gerusalemme che si chiamava la porta[128] degli Esseni. Che più? Tirhatim dice la Mehiltà da strepito, suono, preghiera, perchè le preghiere loro eran accette. Giuseppe vi citerò e Filone dai quali sappiamo come in altissimo pregio fossero tenute le costoro intercessioni. Volete piuttosto, continua la Mehiltà, che significhi i Chiomati non Rasi ed allora vi ricorderò ciò che, non è molto, io vi diceva intorno al costume dei Nazareni Jesco più antico, e dei Cheniti ed un tempo e degli Esseni medesimi. Ma ecco gli altri nomi, ed ecco non meno belle ed appropriate derivazioni secondo la Mehilta: ecco Scimhatim da Sciamah ascoltare, ubbidire, e quindi gli ubbidienti, i sommessi, come a dilungo discorrono gli storici intorno agli Esseni, reverenti sovra ogni altro, all’autorità dei maggiori e dei capi, siccome a suo luogo vedremo. Ecco Suhatim e con bello e significante corteo di preziosi sensi che a nessun altro, ardisco dire, possono tornare confacenti se non agli Esseni. Suhatim che deriva, dice la Mehilta, da Saha conciossiachè da ogni unzione si astenessero; e mirabile veramente! la storia tutta attesta concorde essere stato l’orror degli unguenti costume peculiarissimo del nostro Istituto, come anche questo a suo luogo vedremo. Ecco lo stesso Suhatim derivare da Capanna Succa perchè vita menavano, dice la Mehilta, solitaria e romita; ed a chi meglio potria l’indicazione tornare a capello se non agli Esseni?
Questi sono i nomi delle famiglie. Voi li udiste: Tirhatim, Simhatim, Succatim. Ma quale n’è il nome di stirpe, il nome generico? Il testo lo dice, nè tollera dubbiezza: sono essi i Cheniti, i Cheniti che, come veduto abbiamo nel libro dei Giudici, sono i discendenti di Jetro, e più specialmente, aggiunge il testo, sono tutte da quel derivati che la grande famiglia fondò dei Recabiti, Abbahim me-hamà abi bet rehab. Quando più oltre avrem proceduto, vedremo chi sono i Recabiti; li vedremo[129] famosi solitari ai tempi di Geremia, li vedremo in una società costituiti che tutte reca in rudimento le future sembianze della società degli Esseni, in quella guisa che nel fanciullo stanno ascose in potenza le fattezze, le membra dell’uomo adulto. Per ora le cose dette ci bastino; e più oltre proseguiamo nel corso dei secoli a trovarne i vestigi. Li vedemmo ai tempi dei primi Giudici. Ma Giudici a Giudici si succedono; ed una donna, donna di genio, una donna profeta sorge in Israel. Voi la nomaste, ella è Devora. Dove sono li Jetroiti? La storia ne parla, e ad una nuova emigrazione accenna, operata dal centro della Palestina meridionale alle regioni del Nord. Voi conoscete la storia di Devora, i suoi giudizi, le sue battaglie, i suoi trionfi. Ma non so se ricordate egualmente Jaele, Jaele l’ucciditrice di Sisara, Jaele che volle essere infame per tradita ospitalità, pure di salvare la patria diletta, Jaele che fu benedetta in quel canto famoso ch’irruppe dal petto della gran donna vittoriosa Taelmoghe, come udiste di Heber il Chenita che insieme ai fratelli viveva allora in Israel. E dove sono i fratelli, la famiglia, la società? in questo verso sono che la narrazione precede delle battaglie di Devora, dei suoi trionfi. Come suona il verso? Ora Eber il Chenita separato si era dai Cheniti fratelli, dai figli di Obab suocero di Mosè e tese aveva le sue tende nella pianura di Sananim ch’è presso Chedese, ch’è quanto dire all’estremità boreale di Palestina, nel Territorio di Zebulun e di Neftali e presso quel Chedes istesso che fu patria al capitano Barac. Voi l’udiste, i tempi dai primi Giudici trascorsi non estinsero la nobilissima stirpe. Vivono i Cheniti, vivono in Israel, nella loro fede, nella loro alleanza, in loro ausilio; e vivono, ciò ch’è degno di nota, sotto le tende e vivono nelle campagne.[39] Vedremo più tardi i loro ultimi successori ai tempi di Geremia viversene pur essi per[130] valli e per monti, e nella quiete riparare pur essi di pacifiche tende.
Ma il gran fiume della Istoria Giudaica ripiglia il suo corso, e noi pure con esso. Dopo Devora e Giudici, e guerre, e pace, e servitù, e riscatti, si succedono incessanti. Ecco Elì, ecco Samuele, ecco l’antica ebraica repubblica in monarchia trasformata, ed ecco Saul il monarca novello, ed ecco infine la guerra di Amalek. Tempi ed eventi sono trascorsi in gran numero. Sarebbe mai per avventura de’ Jetroiti smarrita la traccia? Tranquillatevi, essi vivono, e vivono quali i loro antichi predecessori vedeste poc’anzi. Dove sono? Sono qui, sono nel centro tuttavia da’ proavi abitato, sono a mezzogiorno di Palestina, a mezzogiorno di quell’istesso Arad di cui fu menzione nel libro dei Giudici, sono come allora sulle rive del mar Morto, e come allora precisamente sono anche adesso limitrofi, finitimi a Amalek. Ma la guerra santa contro Amalek è bandita; al nuovo re n’è commessa l’impresa: ed egli già scende a fare strenua prova di sè contro ai nemici di Dio. Che farà Saul? Rivolgerà egli contro i Cheniti le armi? Forzerà il passaggio? La quiete dei loro abituri conturberà col romore di guerra? No! pieno di rispetto pei figli di Jetro non forza il passaggio che sarìa? violenza; non lo chiede nemmeno poichè di guerra non vuole offrirgli nemmeno l’aspetto, la mostra; non li invoca in suo aiuto, non li spinge alle armi conciossiachè egli sappia troppo alieno officio essere a quei solitari i ludi di Marte: ma che fa Saul? Fa ciò che qualunque capitano avria fatto con religiosi, con sacerdoti, con solitari. L’invita a sgombrare. E disse Saul ai Cheniti: su via partitevi da Amalek onde con esso non siate involti, conciossiachè tu abbia usato carità con tutti i figli di Israele, quando trassero fuori della terra d’Egitto: e si partirono i Cheniti d’infra Amalek.
Ma che? E Saul e Cheniti e Amalek rapiti sulle ali del tempo, più non si lascian vedere ai nostri sguardi: quella generazione è passata, e tempi sorgon ed uomini e fatti nuovissimi. Ecco David, ecco Salomone, ecco il reame d’Israel scisso in due parti, ecco i re di Giuda e i re d’Israello. Ecco Elia profeta, ecco Acabbo, ecco Jehu, che dal profeta Eliseo riceve missione cruenta, missione di lavare nel sangue l’onta della famiglia di Acabbo. Ecco Jehu accingersi all’opera di sangue, ecco il trono di Ahab rovesciato e Jezabele che dall’alto di un balcone Salve! dice, o Jehu! Omicida del suo Signore; ecco Jehu che dopo avere il trono purificato si prepara a purificare gli altari, che verso Samaria s’incammina per farvi la immane ecatombe dei 400 falsi profeti trucidati nel tempio, nella festa di Baal. Gran cose, gran fatti, grandi vicende, ma dove sono li Jetroiti? Eccoli nel personaggio più cospicuo dei suoi tempi, in quello che farà mutare sembiante a tutti i Cheniti, che li stringerà finalmente in un sodalizio, che sarà, se non il Fondatore, il Restauratore di quell’Istituto, che lor darà leggi, e regole, e divieti che saranno di poi rigorosamente osservati. Chi è costui? Egli è Jonadab figlio di Rehab che in un memorabile incontro strinse amicizia e patto fraterno col rammentato Jehu. Muoveva questi a Samaria, e nella mente volgeva, come vi dissi, terribili progetti contro i profeti di Baal. Muoveva superbo dei riportati trionfi, della dinastia rovesciata, del regno conquiso. Chi è questo che gli si fa incontro? Egli è Jonadab Ben Rehab, Jonadab a cui Jehu siccome a maggiore fa riverenza il primo, da cui chiede l’amicizia, la stima, l’ausilio, da cui riceve lieta testimonianza d’affetto e con cui infine trattolo in sul carro si avvia insieme alla capitale del regno.
Quante cose da osservarsi! Il primo salutare di Jehu[132] che non isdegna, comunque altero per i recenti successi, inchinare l’umil privato Jonadab ben Rehab; protestargli devozione ed affetto, ed affetto eguale da Jonadab supplicare; la risposta amorosa sì, ma laconica dignitosa oltremodo di Jonadab ben Rehab; il volerlo al fianco suo compagno, auspice dell’opera che imprende; ed infine una forse meno interessante analogia, ma pur curiosissima tra il fatto presente e quello tanto più antico di Melchisedech ed Abramo, Jehu è l’Abramo moderno come Jonadab vi rappresenta Melchisedech: Abramo e Jehu riedono trionfanti, e Jonadab e Melchisedech, gli uomini di Dio, i devoti all’Altissimo, ne ricevono gli ossequi; e Jonadab infine e Melchisedech, per completare il raffronto, sono ambedue di sangue, di origine pagana.
Ma che più tardiamo? Il tempo volge di nuovo le sue ruote veloci. Qual mutamento! Quanto vuoto, quanta emigrazione, quante rovine! Il regno d’Israele è caduto, le dieci tribù vanno schiave in esilio e solo come capanna in vigna, come giaciglio in campo di cocomeri[40] resta ultimo baluardo di libertà la figliuola di Sionne. Dove sono li Jetroiti? Il nome qui, confessiamo il vero, non si trova; ma si trova qualcosa più, si trova il ritratto, si trovano i caratteri. Chi n’è il pittore, chi li descrive? Maestro e sommo pittore delle memorie antiche e dei fatti avvenire, il profeta Isaia. Egli è un passo dell’ultima parte del suo libro di cui non seppi giammai rendermi conto abbastanza, e che solo principiai a comprendere quando il pensiero rivolsi a’ Jetroiti, ai Recabiti che tra poco ci descrive Geremia, in una parola, agli antenati dei nostri Esseni. Si apre il capitolo 55 con una profezia consolante pei profughi di Babilonia. Osservate giustizia, grida Isaia, operate equità; conciossiachè è prossima la mia salute e la giustizia mia a comparire. Beato [133]l’uomo che farà questo, che a quel che dico si atterrà, che si guarderà da profanare i sabati, che la mano sua tratterrà dal fare ogni male. Ecco però il punto oscuro, anzi a parer mio il centro luminosissimo. Continua Isaia: Non dica il figlio dello straniero che al signore si è unito: separato mi ha il Signore dal popolo suo; non dica l’Eunuco: ecco io sono albero che non fa frutto: perciocchè così dice il Signore agli Eunuchi che osserveranno i miei sabati, che ameranno ciò che io amo, che si atterranno al mio patto; io darò loro nella casa mia e tralle mie mura seggio e fama migliore di figli e di figlie; fama eterna darò loro, che non avrà fine.
Ecco il testo d’Isaia ed eccone il senso. Per chi parla il Profeta? A chi allude? Chi è lo straniero unitosi al Signore che rassicura? Che sono questi eunuchi sconosciuti, inauditi in tutta la Bibbia? Che cosa sono questi sabati, in cui particolarmente si ripone degli eunuchi la speme? Qual’è la casa, quali le mura di Dio ove agli stessi eunuchi seggio si ripromette e fama imperitura? E che cosa è la fama istessa e le generose promesse, e la perpetua durazione della gloria del nome di questi eunuchi? Io chiesi tutto questo agli interpreti, ai glossatori antichi e moderni, e che cosa risposermi glossatori ed interpreti? Nulla che non sia comune, vago, generalissimo; nulla che solva condegnamente e pienamente i gravissimi problemi accennati; nulla che dia moto, vita e senso alle parole del gran profeta, nulla che non riveli in tutti un grande imbarazzo. Niuno pensò ai Cheniti, niuno pensò ai Recabiti che Geremia ci ritrarrà, da lungo tempo stretti organizzati in società; niuno s’avvide che qui il profeta evidentemente favella di proseliti ab antico vissuti in Israel, di proseliti tratti seco loro in esilio, involti nella stessa sventura, ed a cui il bisogno[134] si sente di far suonare alta e solenne la parola della speranza; niuno disse: Ma gli eunuchi sono gente ignota in Israel: non di essi menzione in tutti i libri ispirati: non possibile nemmeno la loro esistenza in Israel, di fronte al solenne inviolabile disposto della legge di Dio, che interdice assolutamente ogni evirazione; niuno concluse: Mestieri è dunque intendere di un Eunucato volontario di un voto di continenza; niun ricordò come il nome di eunuco usasse una religione insigne a denotare il celibato dei sacerdoti, niuno avvertì come Policrate vescovo di Efeso nella sua Epistola a papa Vittore, il chiamasse recisamente eunuco e uomo pieno di Spirito Santo; e per ultima negligenza niun pose mente al titolo che volontari assumevansi i Farisei di eunuchi comecchè nè evirati fossero nè il celibato guardassero così rigorosamente siccome gli Esseni,[41] ma solo per il costume come dissi continentissimo; niuno attentamente badò all’espressioni del profeta, ove eunuco e proselita sono posti non solo a contatto ma considerati i medesimi nei timori, nelle promesse, nelle speranze; e tranne i predecessori degli Esseni, io non so veramente dove eunucato e proselitismo siansi insieme trovati; non videro come qui si vuol dire che il rimanersi senza prole non minacci la loro esistenza, conciossiachè questa si fondasse non già sulla procreazione materiale ma sulla perpetua aggregazione di nuovi fratelli, dei discepoli, dei seguaci, dei figli nello spirito e nella fede; non notarono poi come il vaticinio sia mirabilissimamente commentato dalla storia, e Isaia giustificato da Plinio. Da Plinio che in quel famoso passo del 5º libro, dove, come udiste, degli Esseni discorre, queste parole lasciò scritte memorandissime. Essi, dice Plinio, (gli Esseni) non vengon mai manco, perchè tutto giorno si riducono a viver presso di loro quelli che tirati sono ai loro costumi; e così (gran parole!),[135] e così per migliaia di anni (che diranno Munk, il Franck, il Salvador che li fan giovanissimi?), e così per migliaia d’anni, cosa incredibile a dirsi (è Plinio che si stupisce), questa nazione è eterna dove non nasce persona.[42] Isaia Profeta! sono profezie le tue o sono storie? E tu Plinio, è la storia che tu ci narri o il vaticinio che ripeti del grande Isaia? Tanto, e Profezia e Storia, e Plinio ed Isaia, procedono mirabilmente concordi.
Io vorrei stasera spingere più oltre le nostre ricerche, e il preziosissimo frammento studiare con voi di Geremia profeta. Egli è un gran cap. il cap. 35 di Geremia per la quistione che ci preoccupa! ed agio vuole e sviluppo maggiore meglio che ora nol consentan le forze. Io farò punto: ma prima di accommiatarvi, un’altra volta ancora vo’ ripetervi le parole di Plinio. Ricordatevi, o miei giovani, dell’aureo detto. E così per migliaia di anni, cosa incredibile a dirsi! questa nazione è eterna dove non nasce persona.
LEZIONE DECIMA.
Muovendo dai tempi più antichi della Istoria del popolo nostro, noi chiedemmo ad ogni secolo, ad ogni grande epoca, degli Esseni contezza. La storia ebraica, la scrittura, i profeti, ci risposero in guisa che non avremmo forse sperato in quistione che le vicende proprie nazionali degli avi nostri non toglie di mira. L’ultimo ad erudirci nell’ultima nostra conferenza, l’ultimo a mostrarci degli Esseni o meglio dei loro precursori il passaggio, si fu Isaia. Isaia vide più regi succedersi sul trono di Giuda, e l’ultimo che la voce udì del sommo ispirato, anzi, che ne riportò, come non è molto vi accennai, guarigione completa, si fu Ezechia. Ma come tetri e procellosi procedono i tempi dopo Ezechia! Dopo di esso Manasse, dopo di Manasse Amon e dopo Amon un re pio, un re che le tradizioni riprese del suo bisavo, il re Iosciau, Iosciau è sul trono, e alla restaurazione si adopra, si affatica del culto di Dio. Ma chi regna nella pubblica piazza, chi conciona le moltitudini, chi fulmina i vizi e la idolatria imperante, chi fa suonare alta, paurosa minaccia di guerra, chi predice servitù e quindi riscatto; in una parola, chi profetizza? Il profeta è Geremia e i suoi discorsi, i suoi scongiuri, i suoi anatemi, i suoi vaticini sono in quel libro raccolti[138] che s’intitola da Geremia. Ma un capitolo in questo libro vi ha che dissi altamente interessare la origine degli Esseni, e questo è il capitolo 35. Là, gli antenati degli Esseni ti appariscono davvero costituiti regolarmente in società, con una regola particolare di vita, con memorie, con tradizioni, e quel che più monta, con voti, voti solenni, inviolabili, imprescendibili che egualmente avvincono ogni suo membro. Là tu vedi i Cheniti sinora da noi contemplati, meglio come nomade e separata tribù che qual religiosa società, tutte di società e religione assumere qualità e sembianze. E chi lo dice? Lo dice Geremia; anzi egli è Dio stesso che quasi in mostra offre i gran Recabiti ai contemporanei ed ai posteri. Va’, dice il Signore a Geremia, (udite che tutto in nostra favella trasferisco il capitolo rammentato perchè tutto da capo a fondo rigurgita di preziose indicazioni): Va’ alla casa dei Recabiti e parla ad essi, e menali alla casa del Signore in una delle stanze laterali, e porgi loro a bere del vino. E presi Jazania figlio di Geremia figlio di Abazinia e i suoi fratelli e tutti i suoi figli, e tutta la famiglia dei Recabiti e menali alla casa del Signore; nella stanza del figlio di Amon figlio di Igdeliau, l’uomo di Dio, ch’è presso le aule dei principi, ch’è sopra alla stanza di Maseiau, figlio di Sciallum il tesoriere. E posi innanzi ai figli della casa dei Recabiti ampolle piene di vino e tazze; e dissi loro: bevete del vino. E’ risposero: non beremo del vino, perciocchè Ionadab figlio di Rehab il padre nostro c’impose dicendo: non bevete vino voi ed i vostri figli in eterno. E case non fabbricate, nè grani seminate, nè vigne piantate, nè possedete alcun che, ma in tende abiterete tutti i vostri giorni affinchè viviate molti dì sulla faccia della terra ove siete pellegrini. Ed ascoltammo la voce di Ionadab figlio di Rehab padre nostro, in tutto quello che ci comandò,[139] di non bere vino tutti i nostri giorni, noi, le nostre donne, i nostri figli e le nostre figlie; e di non fabbricare case, per abitarvi nè vigna, nè campo, nè sementa alcuna possedere. Voi udiste parlar di donne e di figlie, voi udiste ancora nelle passate lezioni di donne Nazaree. Troppo, direte pertanto, siam lungi dal celibato degli Esseni. Eppure le donne non furono al tutto escluse dal nostro istituto. Nol furono nello stato di matrimonio per moltissimi degli Esseni siccome ne ammonisce Giuseppe, i quali il matrimonio anzi praticavano e pregiavano assaissimo. Nol furono poi per gli stessi celibi contemplativi; i quali schiudevano di frequente le porte loro alle donne affiliate che chiamavano, come dice Filone, col nome di Terapeutidi (Pridaux 5. 92.) Ed abitammo, continuano i Recabiti, entro alle tende, ed ascoltammo e facemmo quello che comandò Ionadab nostro padre. E fu quando salì Nebuhadrezar re di Babel contro la terra, e dicemmo: andiamo, entriamo in Gerosolima per causa dell’esercito dei Casdei, e dell’esercito di Aram; ed abitammo in Gerusalemme. E questa risposta per l’appunto voleva il profeta. Egli si volge allora al popolo che udito aveva sino all’ultimo i Recabiti, e dall’esempio loro trae argomento ad acerbe rampogne. Vedessero, ei dice, i fedelissimi uomini come i comandamenti serbati avessero di un mortale, di Ionadab Ben Rehab; vergognassersi di avere eglino le volontà di Dio derelitte, le parole del padre immortale tenute a vile, ed altre simili querele che si omettono per brevità. Solo vi piaccia udire la conclusione; quando cioè Geremia, finito che ha di favellare al popolo, si rivolge di nuovo ai Recabiti e così dice: Ed alla casa dei Recabiti, disse Geremia, così parlò il Signore degli eserciti Dio d’Israele. Poichè ascoltato avete il comando di Ionadab vostro padre ed osservaste i suoi[140] precetti, ecco così dice il Signore degli eserciti Dio d’Israele: non mancherà uomo a Ionadab Ben Rehab che ministri innanzi a me per tutti i tempi. Qui termina il capitolo 35 e qui finisce ancora tutto quello che intorno ai Recabiti ci offre il libro di Geremia. Io volli testualmente riprodurre l’intero capitolo, sì perchè pare a me nella nostra indagine rilevantissimo; sì perchè possiate adesso con più vantaggio seguirmi mentre andrò a parte a parte sponendovene i singolari documenti, e le preziose notizie sprigionando che in seno racchiude. E quante e di qual peso notizie! Lo è persino il nome che recano, il nome di Recabiti il quale attesta, se non m’inganno, come la loro esistenza sociale rimonti ad epoca ben più antica di Ionadab che fu sol discendente di quel Recab da cui s’intitolarono i Recabiti, che diede probabilmente una forma che molto si avvicinava a quella che assunser di poi, e che finalmente, siccome chiaro apparisce dal 1º delle Cronache, visse in epoca che non ardisco determinare, ma che pure di molto precesse e Ionadab e i Recabiti di Geremia. Voi l’udiste: per comandamento di Dio alle loro stanze questo si conduce, e intimato loro la commissione che ricevuto aveva, tutti dal primo all’ultimo li conduce a offrire di sè grandioso spettacolo negli atrii di Dio. Che bel momento fu questo! che scena! che solennità imponente! in cui fu visto il tenero, il patetico Geremia, messosi alla testa della nobilissima schiera, apporre come a dire il divino suggello alla loro istituzione; ed essi offerire a modello di fedeltà, di obbedienza, di costanza al popolo riunito: costanza vera, perpetuazione quasi incredibile in mezzo ad una società più vasta qual era l’Ebraica, che da ogni parte li circondava. Poichè, sappiatelo una volta, i Recabiti di Geremia sono i discendenti di quei Cheniti che vedeste ai tempi di Devora, i pronipoti di quei medesimi che ai[141] tempi dei primi giudici lasciarono i palmizi di Gerico; e per dir tutto in una parola, sono la vera e legittima figliolanza di Jetro, il grande, il vetusto proselita. Ma quanto diversi però dai loro proavi! e quanto più ai figli loro, agli Esseni, somiglianti che non ai padri! Qui vedete l’astinenza dal vino che data da Jonadab; il quale secondo la legge del Nazirato che vi feci conoscere, ne trasmise, come pare, di mano in mano gli obblighi nella sua discendenza; siccome dato era veramente a ogni padre di così praticare; siccome fece Anna per lo infante Samuele; siccome i genitori, auspice l’angiolo, fecer pel famoso Sansone; e siccome infine, ne convengono autori gravissimi, tra gli altri il Pastoret il quale a dirittura asseriva: i Nazirei senza dubbio diedero l’idea dei Recabiti. Ma qui oltre al Nazirato altre cose vedete e di non manco rilievo. Qui la vita solitaria e campestre che menavano costantemente i Recabiti, anzichè le cause da loro stessi accennate, le invasioni nemiche non fossero venute a strapparli alla loro solitudine per riparare ai tempi di Geremia entro le mura di Gerusalemme; qui il voto di povertà, o per dir meglio il voto di nulla possedere in proprio, ma tutto avere in comune fra loro, che chiaro in quella frase breve ma esplicita, velò hiè lahem ti apparisce; qui l’impronta di virtù, di santità, che loro appone il profeta per bocca di Dio, e la sanzione che loro reca in premio dal Cielo, del loro istituto, di loro vita, tali frasi usando sul conto loro che altro senso tollerar non potrebbero, siccome avvertiva il De Jurieu, se non quello di apertissima commendazione; qui un carattere che fu particolare agli Esseni e per cui furono ad una voce celebrati da Giuseppe, da Filone e da quanti degli Esseni presero a trattare, io vo’ dire la riverenza ai maggiori, il culto che professavano verso i loro antenati, del quale veggiamo il primo esempio e forse il primo tipo[142] in quella venerazione onde son laudati, per Ionadab, figlio di Rehab, pei suoi dettati, per le sue leggi; e quando partitamente discorreremo delle qualità delle virtù degli Esseni noi vedremo Giuseppe e Filone tenere un linguaggio che per poco differisce da quello di Geremia, l’uno e l’altro levando a cielo, come diceva, il loro rispetto ai maggiori: e qui infine la promessa di Dio. E qual promessa! La quale sarebbe andata fallita, se poco stante dai tempi in discorso quella società allora così illustre non avesse di sè lasciato vestigio alcuno, se riprodotta non si fosse sotto il nome di Hasidim, se quindi l’altro non avesse assunto di Esseni e Terapeuti, e se infine la scuola, la società degli Esseni non si fosse perpetuata in tutti i secoli, e se al presente non durasse tuttavia, se la esistenza augurata da Geremia non si verificasse sempre, dopo mille trasformazioni nella esistenza dei Farisei. Io dissi esistenza, ma questa è la parte men grande del vaticinio, doveva dire anco il modo, anco lo stato che Geremia gli promette. Qual’è il modo, qual’è lo stato? Voi l’udiste. Che parole! che officio, che grandezza! Io ardisco dire che se l’idioma ebraico non lascia di essere ebraico, se un concorso innumerevole imponente di esempi non dice il falso, se le analogie più parlanti non c’inducono in errore, se v’è criterio in una lingua per discernere acconciamente il preciso significato di una frase, io oso dire che male non mi apposi nel traslatarlo quando parlai di offici, di ministerio, di sacerdozio, giacchè tutte queste tre cose, ma queste tre cose soltanto, accenna la locuzione in discorso. E se vaghezza vi prendesse di fare con me escursione pei campi della scrittura, oh quanti non avreste a raccorne luminosissimi esempi! Volete sacerdozio? E qui avete per la tribù di Levi, pel suo officio sacro sacerdotale la frase stessa, le stesse parole, siccome[143] pei Recabiti leggete: Laamod lifnè adonai lesciaredò ec. O meglio vi talenta l’idea di intercessori? Ed allora ve l’offrirà Ezechiele quando dice: se pure Mosé e Samuele intercedessero appo me non più accetterei questo popolo, come appunto pei Recabiti leggete: im iaamod Moscè usmuel lefanai; ec.; o vi piace meglio un’altra volta udire del sacerdozio? E ve l’offriranno i Giudici quando parlando del pontefice, di Pinehas: E Pinehas, dicono, figlio di Elazar omed baiamim aem come per l’appunto dei Recabiti si legge omed lefanai. Volete profezia, volete udire come qualifica la scrittura l’officio del profeta? ve lo dirà Elia nel celebre suo giuro quando esce fuora inaspettato dicendo: Viva il Signore innanzi a cui ministrai; non vi sarà per questi anni nè rugiada nè pioggia che io nol voglia; in quella guisa che udiste per Recabiti.[43] E la profezia si è adempiuta alla lettera. Sacerdozio, profetismo, tutto fu riposto, fu concentrato nei successori e poi nei continuatori dei Recabiti, prima nei Hasidim, primo nome che assunsero dopo quello di Recabiti, quindi negli Esseni, parte eletta, parte dotta e santa e ieratica del Farisato, quindi negli eredi degli Esseni, nei professori delle loro dottrine, nella scuola speculativa ascetica superlativa dei Farisei, nei Ben Iohai, nel Rabbeno Aj Gaon, nel Nacmanide, nel Cordovero, nel Loria ed in quanti altri le orme calcarono di quei Santi, di quei Dottori.
Ma noi siam lungi ancora da questi modernissimi tempi; ed a quelli convienci restituire che a Geremia seguitarono. Geremia visse non poco dopo la distruzione del primo Tempio; però la riedificazione del Tempio non vide. Da Geremia alla prima apparizione degli Esseni sotto tal nome, poniamo che ci corra un dugent’anni, quali sono gli anelli che questi due estremi congiungono della catena? Quali gl’intermedi che possan dare alla storia[144] che costruimmo, quella continuità che, diciamo il vero, non le mancò sino all’istante presente? Egli è doloroso ma pur necessario il confessarlo: è questa l’epoca che più povera resulta di documenti per la storia degli Esseni: è quasi una lacuna nel loro passato, tanto più deplorabile quanto i cenni che immediatamente avrebbero preceduto la loro apparizione nell’Essenato, avrieno mirabilmente giovato a cogliere il punto di passaggio dall’antica alla forma novella; e porto avrebbero ultima e solenne conferma a tutte le cose precedentemente discorse. Però è necessario fare tre specie di avvertenze che immensamente diminuiranno la vostra sorpresa; e se non colmeranno interamente il vuoto, almeno lo spiegheranno e tutto ciò gli torranno che può avere di ostile, di negativo alla tesi da noi sostenuta, alla genealogia degli Esseni. La prima è che mentre sino ad ora avevamo documenti contemporanei, adesso mancano assolutamente, nè la Bibbia nè la Tradizione contengono alcun volume che a quell’epoca appartenga, attalchè non so vedere veramente in qual guisa degli Esseni o dei loro predecessori si poteva fare menzione. Nulla dunque di più naturale, di più necessario della mancanza di questa menzione. La seconda avvertenza si è, che per quanto io abbia detto assolutamente che di questi tempi non esiste memoria, pure non si vuol intendere la mia sentenza in guisa che qualche lembo non si sollevi, che un barlume non ti apparisca dell’Essenato nell’epoca in discorso. Io chiamo un barlume il fatto di Daniel che per 23 lunghissimi anni stando a Rasci, di pane eletto non si ciba, non mangia carne, non beve vino, nè usa nessun unguento dal quale rifuggivano, come udiste, gli Esseni. E questo faceva Daniele per carità della patria infelice, e per chiedere fine alle sue desolazioni, in guisa che in questo senso soltanto può essere vera l’ipotesi del Salvador[145] che le patrie desolazioni abbiano dato l’origine all’Essenato. Un barlume poi io credo che abbiamo nei Paralipomeni. I Paralipomeni sono opera di Esra posteriore a Daniele, ed è probabile sentenza quella in cui oggi conviensi, e di cui è qualche cenno nel Talmud, che dopo Esra i più antichi della magna congregazione recato abbiano a compimento il libro delle cronache. Or bene, in guisa si esprimono le cronache intorno ai Recabiti, che pare veramente come a quei tempi tuttavia sussistessero. Vuol far capir l’autore quali fossero le tre famiglie Tirhatim, Simahtim, Succatim che presero stanza presso Iahbez, e lo vuol far capire con allusione più moderna. Che dice per questo? Dice che sono identici ai Chinnim: ma i Chenim stessi possono essere ignorati, quindi necessità di riferirli a nome anche più moderno, a nome contemporaneo. E qual è questo nome? È quello di Recabiti. Abbaim mehamat abi bet Rehab.
Però queste cose andavamo tra noi meditando pria che ci si partisse dinanzi nell’atto stesso di dettare la presente lezione, una breve ma significante indicazione rabbinica, poi un frammento preziosissimo di un autore il cui nome non suonerà io spero sconosciuto ai vostri orecchi. Qual’è in primo luogo l’indicazione? Ella è quella contenuta nella sezione 98 del Berescit Rabba, opera anteriore al Talmud, e dove chiaro apparisce che tra i primi Tanaiti eranvi alcuni che, come si credeva generalmente, discendevano da Jonadab Ben Rehab.—Dunque io dico: i Recabiti non cessarono di esistere anco in tempi posteriori agli Esseni, e nulla pertanto si oppone che questi da quelli sieno derivati. Ma v’è di più: voi ricordate come io avessi luogo parlandovi dei Samaritani di rammentarvi Beniamino di Tudela, i suoi viaggi, il gran conto che si fa generalmente dai dotti delle sue relazioni. Or bene, egli è un passo nel Pellegrinaggi di Beniamino[146] dove prende a narrare di ciò che vide, di ciò che osservò nel Iemen, nell’Arabia Felice. Lo credereste? Egli parla dei Recabiti, egli li vide, egli ne osservò, ed egli ne narra altresì i costumi. Le sue parole sono troppo preziose perchè io non ve le citi. Di là movemmo ei dice verso la Terra del Iemen a settentrione, e dopo un viaggio di 21 giorno pei deserti, pervenuto essendo in quella regione, vi trovai i Giudei che si chiamano Recabiti e in Ieman hanno imperio. Aron il Nasi vi risiede ed è grande città. Narra poi Beniamino i loro commerci, le loro scorrerie, e quindi aggiunge: E danno poi la decima di tutto quanto posseggono ai Dottori della legge che stanno del continuo nei pubblici studi, ai poveri d’Israele ed ai loro Farisei che fanno lutto per Sionne e Gerusalemme, che non mangiano carne, non beono vino, e vestono logori abiti; ed abitano in spelonche, e tutti i giorni digiunano, tranne i Sabati e le Feste. Ecco le parole e l’attestato di Beniamino. Quando viveva il famoso spagnuolo? Certo nel mille o a quel torno; che è quanto dire in tempi infinitamente posteriori a Geremia ed alla società degli Esseni; in tempi che provano come lungi dall’essersi precedentemente estinta la famiglia e l’istituto dei Recabiti, perdurasse invece non solo dopo il profeta che li descrisse, non solo in epoca immediatamente anteriore e contemporanea ai nostri Esseni, ma per secoli eziandio parecchi dopo di essi; cioè prova in una parola come la filiazione da noi voluta degli Esseni dai Recabiti riceva quella conferma che noi credevamo invano desiderare, ma che pure la Provvidenza ci porse, quando meno l’attendevamo.[44]
La terza ed ultima avvertenza è quest’una. È lo stato in cui lasciammo i Recabiti ai tempi di Geremia, stato se altri fu mai rigoglioso, florido, vivacissimo; stato che a tutt’altro accenna che a deperimento e rovina; stato[147] che ove pure ad una declinazione accennasse, questa declinazione si sarebbe naturalmente protratta tant’oltre da ricongiungere l’estinguentesi Recabismo col nuovo, col nascente Essenato. E queste sono le tre avvertenze che vi promisi.
Giunto a questo punto, e quasi meco stesso meravigliato del gran compito che ho fornito, che altro mi resta a fare per condurre a fine l’impresa? Null’altro a parer mio che citar le autorità che militano a favor mio, che per diretto o per indiretto fanno risalire l’Essenato agli antichi Cheniti, ai discendenti di Jetro. Primo tra le autorità io annovera Plinio; Plinio nella Storia Naturale in quelle parole ove agli Esseni attribuisce un’esistenza di secoli, Plinio che in tal guisa alla origine apre le porte da me sostenuta sinora. Io pongo poi per secondo il Serrario il quale, è giusto il convenirne, diede il primo il segno di questo sistema e forse con buoni argomenti il convalidava comecchè condannato io fossi a rifare il lavoro, non potendo dell’opere sue giovarmi, che non posseggo. Io pongo infine per ultimo un inatteso alleato, la Mehilta. Voi udiste finora da me, voi avrete certo udito da ognuno e gli autori tutti vi avrebbero a gara ripetuto, come i libri Rabbinici tacciano assolutamente dell’Essenato, e grave problema riuscisse a risolvere ognora, questo silenzio. Or bene voi potete dire adesso ad ognuno che vi dimandasse, che questa menzione esiste veramente, che gli Esseni non sono ignorati dai nostri Dottori; non basta; potete dire che il cielo ci riserbava due scoperte ad un tempo, che gli Esseni presso i nostri Dottori non solo eran conosciuti; ma, lo che più monta pel fatto nostro, erano come legittimi e diretti successori considerati degli antichi Recabiti. Potete dire che queste cose si trovano certo per vie non troppo comuni e battute, ma non per questo men belle e men importanti;[148] potete dire che se ai grandi intelletti è dato scoprire nei cieli immensi un astro novello, al mio umilissimo quest’onore solo fu conceduto di scuoprire nel cielo Ebraico la società degli Esseni. Io dissi la Mehilta. Ma che cosa è la Mehilta? È un opera più antica del Talmud, opera di un Tanna antichissimo, di R. Ismael, opera di cui solo una parte è giunta sino a noi sul libro dell’Esodo. Aprite la Mehilta alla sezione di Jetro e vi troverete, come dice Vico, un luogo d’oro che suona così. Avvenne una volta che uno di coloro che beono acqua avendo fatto nel tempio un sacrifizio si udì una voce dal santissimo che diceva così, colui che accettò i loro sacrifizi nel deserto accetterà anche questo in quest’ora.
E notatelo bene, giovani miei, queste parole non sono isolate; il passo che avete udito non è senza precedenti e conseguenti. Lo precedono immediatamente tutte le indicazioni da voi udite sui Cheniti che abitavano pei deserti, che tolsero poi a dimorare presso Iahbez nel deserto di Giuda, e lo seguono immediatamente le parole di Geremia sui Recabiti, sul loro avvenire. Il fatto che udiste narrato è un fatto ai Dottori contemporaneo, è una allusione agli Esseni allora esistenti, è una identificazione di questi Esseni coi Cheniti, coi Recabiti; è insomma tutto quello di che noi bisogniamo. Questo breve frammento è un prezioso e grande trovato; ma non è il solo. Quando meglio ci addentreremo nella società degli Esseni, uno o due altri ne rinverremo ove non più colla perifrasi testè udita i bevitori di acqua si additano gli Esseni, ma colla vera e propria loro denominazione. Questi pochi e sparsi frammenti sono il più bel gioiello delle nostre conferenze; e se io ne ho potuto adornare le mie lezioni, a voi si deve in gran parte che a queste indagini rivolgeste l’animo mio; e sopratutto a quel padre[149] dei lumi senza di cui niuna cosa che valga si può fare in niuna disciplina, e molto meno nel culto delle lettere sacre, ove prima condizione è il culto e la stima del suo grandissimo obbietto, e nelle quali meglio che in niuna altra cosa si può dire con Petrarca:
Non si fa ben per uom quel che il ciel nega.
LEZIONE DECIMAPRIMA.
Io vengo a proseguire l’opera incominciata. Noi abbiamo degli Esseni studiato già e il nome e quello che più c’interessava, l’origine loro. Noi abbiamo, a parer mio, trovato in mezzo a tante etimologie la vera etimologia, e tralle tante congetturate origini la vera origine. Per svolgere ordinatamente il nostro assunto conviene che io vi riduca a memoria il piano, l’ordine, la seguenza che imponemmo al nostro dire. Io vi promisi sin dalla prima lezione che dopo il nome, dopo l’origine degli Esseni noi avremmo preso ad esame la loro costituzione, le loro leggi, le lor sociali discipline; e le loro costituzioni, leggi e discipline formeranno oggi il soggetto che io prenderò a trattare. Egli è naturale che dopo avere conosciuta per nome la cosa che vogliamo studiare, se ne cerchino le leggi costitutive, le leggi che presiedono, che regolano la sua esistenza. L’Essenato è persona, persona sociale, collettiva, morale, certamente, ma pur persona. Noi sappiamo come si chiama, sappiamo d’onde tratto si abbia il nascimento; che ci resta ora a sapere? Le leggi della sua esistenza, i principii regolatori della sua associazione. Però, vi ha uno studio che deve per sua natura andare innanzi alle cose accennate, ed è lo studio, ed è l’esame del teatro in cui sorse, in cui ebbe[153] stanza il grande Essenato, in cui scelse, in cui fermò la sua residenza. In questa guisa, procedendo noi dalle cose, dalle circostanze più generali a quelle più proprie, più intime, più speciali al grande istituto; andremo sempre più intorno ad esso stringendo il cerchio delle indagini nostre: in questa guisa potremo dire che nulla di quello ci può sfuggire che può per diretto o indiretto riguardare l’Essenica associazione.
Qual è dunque il teatro in cui nacque, in cui crebbe, in cui ebbe vita il grande Istituto? Notate, o miei giovani, che io non chiedo la loro patria. La loro patria è conosciuta, e questa è la Palestina. Chiedo la loro residenza, il loro soggiorno che dal concetto di patria molto come sapete è diverso. Lo chieggo in primo luogo a Filone siccome quello che tanto studio pose nella storia dei suoi cari, dei suoi ammirati Esseni. E che cosa mi risponde Filone? Mi risponde con un passo dell’opera sua, che se non coglie precisamente nel segno, pure non lascia di avere il suo valore e grande valore nella presente quistione. Egli addita gli Esseni ai suoi lettori Pagani, e se riscontrare, ei dice, volete la fedeltà della mia dipintura, mirateli ovunque sono diffusi pel grande, per l’immenso vostro impero; mirateli tra i Greci e tra i barbari, ove vivono dispersi. E così dicendo Filone, voi di leggeri comprenderete come venga a stabilire senza meno la loro universale diffusione non solo nell’Impero Romano ma eziandio al di là dei suoi confini, fra quei popoli che i Romani seguendo l’esempio dei Greci qualificavan col nome di Barbari: (cioè secondo la genuina sua significazione forestieri forse da vocabolo Arameo, siccome io da molti anni congetturai che suona uomo di fuori, gente straniera.) Gran parole son coteste di Filone e che compiono il concetto vero, storico degli Esseni qual ce lo aveva Plinio accennato nella sua storia. Plinio e Filone sono[154] i due Restitutori del vero carattere della società degli Esseni. Plinio dove pone in sodo la loro antichità, dove, come udiste altra volta, gli assegna un’antichità di secoli e secoli, Filone in questo luogo dove sancisce, autentica la loro universalità, Plinio restaura l’Essenato nel tempo gli rende la sua antichità, Filone lo restaura nello spazio, cioè gli rende la sua universalità. Ma in qual guisa cotesta universalità, cotesta diffusione si acconcia al nostro Istituto? come a quelle idee che pure da parecchi storici si avvalora d’isolamento, di concentrazione, di particolarismo? Come a quel concetto sinora predominante che volle gli Esseni limitati, circoscritti ai confini Palestinesi? Come? intendendo pegli Esseni ciò che noi intendiamo, ciò che essi son veramente, ciò che sarà continuamente dimostrato dal corso di questi studi. Intendendo cioè per Esseni la parte più alta, più nobile, più dotta, più spirituale del Farisato pel quale veramente e pel quale soltanto è vera alla lettera la sentenza Filoniana; pei quali, e pei quali soltanto, si poteva dire che sparsi, che diffusi, vivevano tra Barbari e Greci. Il poteva Filone se gli Esseni fossero diversa scuola, diverso Istituto da quel Farisaico? Poteva dire per essi che eran diffusi tra Barbari e Greci; poteva dirlo di fronte al silenzio generale, al silenzio specialmente di Plinio, e di fronte infine all’esempio degli altri settari i quali, vuoi pel numero scarso, vuoi per poca virtù espansiva, se ne vissero sempre ristretti, rannicchiati tra i patrii confini? Ma quanto bene poteva dirlo se gli Esseni non sono altro che il più bel fiore che il patriziato dei Farisei! Quanto appropriate per essi le parole tra i Barbari e Greci! Essi col grand’Illel in Babilonia anzichè in Palestina non emigrasse, e essi in Damasco con Rabbi Iose il Damasceno; essi in Egitto con Filone stesso, coi Terapeuti e coi Dottori Egiziani che figurano nella Misna come Anael l’Egiziano, e con[155] quelli che ivi stesso si narrano pellegrinanti in Egitto; essi in Nisibi in Persia con R. Ieuda ben Betera che è il discendente di quegli Eroici Betera che allo straniero Illel cessero la posseduta dignità di Nasi, solo perchè più d’essi erasi mostrato nelle patrie leggi erudito; essi in Media con Nahum il Medo; essi in Arabia, in Grecia e in Italia con Ribbi Akibà che queste regioni visitò e che lascio ricordate; ed essi nell’Asia minore in Laodicea, in Antiochia, in Assia dove traevano, come altra volta vi dissi, a sedere in concilio, e dove morì il grande Rabbi Meir, come più tardi vedremo; essi nelle Gallie non solo col rammentato Rabbi Akibà che ne ricorda i paesi, i costumi, la lingua, ma anche con Dottori, dalle Gallie denominati demin gallià; ed essi infine in Roma. In Roma non solo colla sinagoga già lungo tempo stabilitavi, non solo coi più celebri nostri Dottori che la visitarono e preziosissime indicazioni ne lasciarono scritte, ma principalmente per due tra essi, per due grandi Farisei che da Roma s’intitolarono e in Roma ebbero stanza durevole e cattedra e maestrato. L’uno è Todos o Teodozio che il Talmud chiama Todos Is Romi, Teodozio il Romano, quel desso di cui si narra nel Talmud di Pesahim, come a ricordare forse il sacrifizio pasquale, istituito avesse tra i fratelli di Roma l’uso di cibarsi d’agnello arrostito nei vespri di Pasqua; quel desso a cui s’intimava, pena la scomunica, di cessare da quell’uso; quel desso che per animare i Fedeli al martirio soleva citar loro l’esempio dei Zefardehim Rane o Coccodrilli, che al cenno di Dio, comecchè irragionevoli fossero, si gettano nei forni ardenti del popolo Egiziano. L’altro poi è Rabbi Mattia ben Haras ch’ebbe seggio e cattedra in Roma e fu per lunghi anni Pastore e Dottore di quella chiesa con tanta celebrità, che quando volle il Talmud offrire l’idea di una cattedra e di un pastore modelli disse fra gli[156] altri: Zedek Zedek tirdof; ahar R. Mattià ben haras leromì.
Se qui, o miei giovani, fosse il luogo, vorrei mostrarvi come il soggiorno di Roma, il suo consorzio, la sua civiltà inspirassero talvolta il linguaggio di R. Mattia, siccome il registra il Talmud; vi mostrerei le nozioni mediche che vi raccolse e che bellamente applicava all’osservanza dei riti, lo specifico contro la idrofobia che egli addita nel fegato del cane idrofobo, la gravità somma ch’ei concedeva alle infiammazioni della trachea onde voleva il sabato per quelle impunemente violato, la indicazione del salasso nelle tracheiti istantanee da eseguirsi anche di sabato; e sopratutto mostrarvi come cogliesse nell’esperienza degli uomini e delle cose romane, nelle repentine cadute e nelle repentine elevazioni dei Cesari, quella sentenza che voi recitate al tornare di ogni primavera e che suona; fatti coda ai leoni e non capo alle volpi; e come infine dallo stesso soggiorno di Roma gli fosse quel detto suggerito troppo necessario a praticarsi nella città delle continue rivoluzioni: Sii il primo a salutare ogni uomo. E dove non recarono le loro idee, la loro presenza i Dottori antichissimi? Persino qui nella nostra Toscana, e come a me fu dato, ch’io mi sappia il primo, notare in Pitiliano quando muovendo inverso Roma ne traversavano le vie d’onde, dice il Medrase, udendo il frastuono, il trambusto lontano della città lasciva, sclamarono: se questa è la grandezza, o Dio! dei riprovati, qual è quella che tu tieni in serbo pei tuoi eletti?[45]
Che se gli Esseni erano universalmente diffusi, se questa diffusione ad altri non può convenire che ai più illustri membri del Farisato, se la identità ne rimane perciò stesso sempre più confermata, vogliam dire per questo che un centro non vi fosse dal quale raggiassero per ogni dove[157] i grandi lumi dell’Essenato, e dove vivessero secondo le norme del loro Istituto? Ciò non si vuol dire, che anzi la storia attesta il contrario, attesta cioè come vedemmo, che patria del nobile sodalizio fosse la patria Palestinese; non basta: attesta ancora che dell’istessa Palestina una parte sola fosse quella ove la società a preferenza abitava, e dove le sue scuole e dove fossero tutti i suoi centri, i suoi romitaggi. E qual’è questa parte? È la parte meridionale, è tutto quel tratto di paese che lasciando al nord Gerusalemme, è circoscritto a levante dal Lago Asfaltide, in ripa al quale, o poco stante, si ergeva anticamente Gerico la città dei palmizi dove abbiamo veduto abitare i Cheniti e dove infine più al sud è notata sulla carta Arad dove prese succesivamente ad abitare la discendenza di Jetro. Colà, dice Plinio nel quarto libro, si vedevano gli Essenici abituri. Non basta: egli accenna per nome alcune città ove a preferenza avevano stanza Masada p. e. Engaddi l’antica, detta pur essa così pei palmizi che vi abbondavano; d’onde poi quella celebre frase con cui Plinio caratterizza gli Esseni, gente dicendoli delle Palme amica. Gens socia Palmarum. Io dissi che in quei dintorni preso avevano eziandio antichissimamente ad abitare i progenitori degli Esseni, i vetusti Cheniti. Doveva dire di più; doveva dire che su quelle rive vissero, fiorirono le più distinte scuole dei profeti, siccome abbiamo dai Re, che su quelle piagge sorgeva prima della conquista di Giosuè, una città che il nome reca caratteristico di Kiriat Sefer la città dei libri, il quale poi in quello fu tramutato di Debir non meno del primo significante, perciocchè suona il seggio della parola, dell’oracolo; siccome egualmente appellavasi il Santo dei santi il seggio dell’oracol di Dio, l’oracolario, appunto perchè di là emanavano i venerati responsi. Gioberti lo notava scrivendo: Fra le città cananee vinte da Giosuè[158] vi è Chiriat Sefer detta poscia Debir; questo nome può farci subodorare un antica cultura. Forse era l’Archivio dello Stato (Protologia 371).[46] Doveva dire che tutta quella regione andò celebre per l’ingegno, pel sapere dei suoi abitanti; che là sorgeva Patria di quella donna che i profeti dicono savia, forse una Terapeutide, la quale col dolce parlare placò il paterno risentimento di Davide, quella stessa città di Tekoa che per l’olio che produce squisito fu creduta perciò stesso dai Dottori educare la più colta e svegliata popolazione. E qual meraviglia se nello stato medesimo una regione si distingueva per ingegno ferace, se Cicerone diceva l’aria di Atene sottile e quindi più degli altri popoli greci gli Ateniesi vivaci e briosi, se diceva l’aria di Tebe pesante, quindi ottusi e rozzi i Tebani? Se Platone ogni giorno ringraziava gli dei per averlo fatto Ateniese e non Tebano, comecchè Tebe ed Atene città fossero, come sapete, ambedue di una stessa provincia?
Che se il mezzogiorno di Palestina fu soggiorno gradito, ordinario della società degli Esseni, del dottissimo Istituto, che l’antica fama d’ingegno accrebbe a quelle regioni, ci sarà egli dato rintracciare come nella Bibbia le antiche, così nei Dottori le moderne vestigia del loro passaggio? Io ardisco dire che lo potremo. Voi udiste come per noi fu altra volta falso addimostrato il parere di coloro che dicono tacersi affatto i Rabbini della società degli Esseni. Voi udirete in avvenire citazioni, se è possibile, anco più concludenti. Quelle però che adesso vi espongo ne sono un preludio, un apparecchio di cui non potreste disconoscere la gravità. Vuoi tu veramente far acquisto di scienza? dice il Talmud: volgiti a mezzogiorno. Che vuol dire volgiti a mezzogiorno? Vuol dire forse tenere la persona nell’orare rivolta da quella parte? Così certo la intesero alcuni, ignari come io[159] credo, del vero senso. Ma quanto meglio i più antichi! Quanto meglio, p. e., l’autore del Aruch Rabbi Natan figlio di Iehiel tesoriere di papa Bonifazio! Quanto meglio, dico, R. Natan non coglieva nel segno quando diceva interpretando il passo Talmudico: Vuoi tu fare di sapere tesoro? Va’ presso i Dottori che hanno stanza a mezzogiorno di Palestina e impara da essi la scienza. Udite ora Simeone il Giusto, Simone che per tanti anni gloriosamente ministrò nel sommo pontificato. Giammai, egli diceva, io volli le labbra accostare al sacrifizio dei Nazirei, tranne una volta quando vidi al tempio presentarsi un Nazireno dal mezzogiorno (e voi sapete quali rapporti stringano, secondo me, gli Esseni al Nazirato) il quale, continua Simone narrando per filo e per segno tutto lo accaduto, mi disse come simile a Narciso, specchiatosi un giorno in una fonte s’innamorasse del suo bel volto; come indi vergognandosi del vano sentire, facesse voto di Nazirato, e come infine venisse adesso a bruciare l’antico oggetto del suo orgoglio, la bellissima chioma, nelle braci ardenti del sacrifizio. Ma poco è questo. Voi udiste poc’anzi l’autore del Lessico Aruh parlare dei Dottori più insigni che vivevano nel Darom, a mezzogiorno di Palestina. Or bene uditene adesso menzione dalle labbra istesse dei Talmudisti; e dove, o miei giovani? Nell’ultimo capitolo di Tamid. Là si narra di un famoso abboccamento intravvenuto tra Alessandro il Macedone e alcuni tra i più illustri dottori in Israel: e come si chiamano questi Dottori? Si chiamano i savi del mezzogiorno. E su che cosa si aggira il loro favellare? Sopra parecchi e gravi argomenti in cui Alessandro la celebrata sapienza loro pone al cimento, e che troppo attestano l’indole, il genio speciale dei gravi studi dell’Essenato. Chiede Alessandro le relative distanze dal Sole alla[160] Terra; chiede quale creato prima, se il Cielo o la Terra; chiede quale dei due abbia preceduto, la luce o le tenebre; e se a tutte le precedenti inchieste ottenne risposta, a quest’ultima però si udì intonare un modestissimo Nescio. Perchè non risposero gli Esseni mentre il testo mosaico sì chiaro favella? E qui permettete una piccola digressione che pure ha la sua importanza. Perchè io ridomando non risposero al testo conforme? Il Talmud tanto posteriore all’avvenimento, ne chiede, ne indaga il perchè, ma mestieri è pur confessarlo, troppo mostra nella risposta l’incertezza, l’imbarazzo nelle idee, troppo nella risposta si scorge la distanza dei luoghi e dei tempi.[47] Perchè veramente non risposero? Il perchè ce lo dirà Aristotile, il maestro di Alessandro, l’interrogante. Ci dirà Aristotile, per parlare col linguaggio del Ritter, que les anciens Théologiens étaient en général persuadés que le meilleur sort du pire, l’ordre du désordre, puisqu’ils faisaient naitre toute chose de la nuit et du chaos. Avete inteso? Dalla notte e dal caos, ch’è quanto dire ch’erigendo in persone reali questi Enti fantastici, ne crearono altrettanti primi principii, altrettante Divinità cosmogoniche, e Notte e Caos adorarono quai numi. Poteva darsi silenzio più opportuno? Potevano essi i Dottori del mezzogiorno, che sono a parer mio gli Esseni, risolvere secondo Mosè la quistione, concedere cioè alle Tenebre il primato di creazione senza concedere perciò stesso il principio d’onde la Teogonia greca prendeva le mosse, senza pericolo, senza conferma d’Idolatria?[48]
Io vorrei, o miei giovani, più a dilungo soffermarmi a studiare con voi altre cose e bellissime che contiene il precitato frammento del Talmud.[49] Mel contende il bisogno di procedere ordinato e spedito alla mèta proposta, mel contendono gli altri non meno gravi, i[161] parlanti attestati che degli Esseni del Sud ci porge il Talmud. E dove? È il primo a pagina 70 di Pesahim, dove si narra di un Ieuda ben Dostai che, sendo venuto a contesa intorno alla convenienza del sacrifizio in giorno di sabato, si separò, dice il Talmud, dal centro Gerosolimitano, ritirossi egli e il figlio suo nella Palestina Meridionale dove assieme ai Farisei ivi stanziati, notate la frase, protestò contro la decisione dei Colleghi e più assai contro Semaja e Abtalion due antichissimi Dottori anteriori di assai all’E. V.; lo che prova quanto antico fosse Ieuda ben Dostai e quanto la raccontata sua separazione. È il secondo a pag. 23 di Zebahim dove e’ s’introducono ad esprimere una opinione circa la materia delle impurità di cui sapete omai i nostri Esseni tanto gelosi.[50] E infine è il terzo se non erro nel Rabba, e non temo di aggiungere il più interessante, il più prezioso di tutti. Io vorrei, o miei Giovani, che sapeste che vuol dire Aggadà, vorrei potervi esporre a parte a parte tutti i dati che mi hanno da lungo tempo persuaso non altro essere in bocca ai Dottori che la veste, la forma popolare, esoterica, parabolica, dirò anche iperbolica delle dottrine loro più riservate, la Mitologia nel cui seno vive rinchiusa la Teologia,[51] vorrei sapeste da ora, come gli Esseni, e specialmente quelli tra essi che si dicevan contemplativi, andassero sopra ogni altro famosi per lo studio, per la cultura, di una gelosa e segreta Teologia come più tardi intenderete. Or bene! Che cosa dice il Medras? Dice non solo come disse il Talmud che al mezzogiorno di Palestina una scuola intera vivesse di Dottori illustri; ma dice di più, dice cioè che loro speciale, loro precipua occupazione era la coltura dell’Agadà, e dice infine che i più eruditi Rabbini non isdegnavano ad essi ricorrere per la interpretazione dei Testi; e in queste parole lo narra: Disse Rabbi Ieosciuah ben Levi: di questo[162] verso richiesi tutti i maestri dell’Agadà che vivono in mezzogiorno, e niuno me ne porse risposta adeguata. Che più? Non è persino il Zoar istesso, che altra non cen fornisca e solenne conferma, il Zoar l’Emporio delle idee Cabbalistiche, il Repositorio delle più recondite tradizioni, il Zoar che in più luoghi appella ad una scuola di Teologi Mistici che abitavano il Sud e che chiama apertamente, i compagni nostri, i soci nostri, che abitano il mezzogiorno. Compagni, soci! Che gran parola! Non vi dice punto alla mente la bella frase? Non vi accenna ad una consorteria, ad un corpo, ad una società, a cui tutti appartenevano egualmente? di cui tutti si dicevano indistintamente i compagni, i soci, i fratelli? Io avrò luogo più tardi di ritornare su questa frase preziosa, e la Misna e il Talmud e il Zoar ne proveranno ad esuberanza, se già non l’hanno provato, il significato che per noi gli è concesso, e che suona sì favorevole come vedete alla identità Essenico-Cabbalistica da noi propugnata.
Noi dicevamo in principio di volerci occupare del luogo, del teatro ove ebbe stanza principale la società degli Esseni. Noi sappiamo già qualche cosa della loro dimora; sappiamo da Filone che per quanto un centro di convergenza avessero, pure i loro raggi si estendevano, voi lo udiste, tra Barbari e Greci; sappiamo da Giuseppe che questo centro era in Palestina e nella parte meridionale di Palestina; sappiamo in ultimo che queste due indicazioni, ve l’ho provato, si attagliano a meraviglia ai Farisei, alla parte speculativa filosofica mistica dei Farisei.[52] Ma se la parte abitavano gli Esseni di mezzogiorno, quale presero ad abitare a preferenza, le città o i campi? qual vita menarono a preferenza, solitaria od urbana? cittadinesca o anacoretica? Solitaria, vi risponde Giuseppe nel secondo delle Guerre Giudaiche, ove dice amare costoro a preferenza la solitudine, i campi ove avevano[163] eziandio domicilio; solitaria, vi risponde Filone (De vita contemplativa) quando dice dei Terapeuti che per la massima parte vivevano fuori di Alessandria presso ad un lago; solitaria, vi dice Plinio quando li pone ad abitare poco lungi dal lago Asfaltide; e solitari pure ragion vuole che fossero i grandi contemplativi; che non a caso scelsero gli Esseni per loro stanza la quiete, la pace, il silenzio dei campi. È là, è nella solitudine, è nel libero e forte ripiegamento dell’animo sovra sè stesso, è nella concentrazione di tutte le nostre morali facoltà, tanto lungi dallo sperperamento cotidiano della vita cittadinesca, è là che l’anima si tempra a forte, a maschio sentire, che lo spirito si eleva nei grandi pensieri, che l’immaginazione spicca libero e naturale il suo volo, ed è là che si educavano, che si dovettero educare gli Esseni contemplativi. Credete che siano ubbie coteste mie, che faccia a guisa dei poeti il panegirico della solitudine, e come i poeti, ponga i piedi sul vano, sull’aereo, sull’imaginario? Io ne voglio a giudice, a testimone l’uomo più competente, la scienza più positiva e per ciò stesso più decisiva; voglio che lo udiate per me da un medico, e da un medico filosofo, e chi è questo? È il Descuret in quell’aureo trattatello della Medicina delle passioni. Sentite come si esprime il Descuret. Lo scrittore, ei dice, può acquistare in società facilità e stile brillante, eleganza e gentilezza di frasi, ma giustezza di vedute, profondità e concatenazione di pensieri, fuoco e vita nel discorso, trovano origine per consueto nel ritiro, nella meditazione. I più grandi scrittori hanno creati i loro immortali capolavori nella pace della solitudine, tanto atta ai concepimenti del genio. Che cosa si contiene in questo squarcio, che io non abbia detto, e che cosa che a capello non si acconci al nostro Istituto? Il quale non solo nel preferire e rive e campi, obbediva al proprio[164] genio, ma sì ancora si conformava fedelmente al genio ebraico, alle tradizioni ebraiche, ed agli esempi ebraici. Io dico cosa che forse parravvi strana, e appunto per questo non la direi, se non avessi argomenti di avanzo, e se tanti non ne avessi da dovere perciò stesso affrettare anco più il mio passo. Dissi il genio ebraico, la fede ebraica, amare i campi; e come no? Abramo prega e sacrifica all’aria aperta sopra un monte; nel silenzio, nella solitudine pianta boschetti, e là sacrifica e là adora il Signore, nel che è imitato di poi dal suo figlio Isacco: Isacco per pregare lascia l’abitato e trae su per i campi orando dice il Testo, orando conferma la tradizione e orando, conferman pure essi i Samaritani per quanto non ligi al certo alle nostre tradizioni. Giacobbe ha visioni, prega, fa voti in una solitudine nelle vicinanze di Luz o Bet El. Agar ha visioni promesse e prodigii nel deserto di Beer Scebah; Mosè pascola, medita per quarant’anni, e poi ha visioni, rivelazioni portentose nelle solitudini dell’Oreb; se Mosè vuol orare al Signore, egli trae fuori dall’abitato e colà alza all’eterno le palme; se ha in Egitto rivelazioni, le ha nei campi lungi dalla città. La legge, la legge di Dio non è data nè in Egitto nè in Palestina, ma nel deserto, per accennare, dicono i Dottori, alla copia che gratuitamente fa di sè ad ognuno; per non far nascere, dicono altri, tralle tribù gelosia, rivalità. Eliseo fonda la sua scuola profetica nelle prossimità del Giordano, e quivi vedeste in altra lezione adunarsi la bella scuola di quel Signore dell’altissimo canto, i Recabiti di Geremia, progenitori a senso nostro degli Esseni, Ezechiele, che fuori di Terra Santa patisce difficoltà a profetare, trae fuori pei campi e profetizza. Che diremo poi se dai Bibblici trascorreremo agli uomini e ai tempi rabbinici? Qui gli esempi si accumulano, si affollano e in guisa tale che appena è tempo di accennarli; qui nel Ieruscialmi (Scebihit[165] 6.) parecchi esempi come di Ieuda Js Cozi, che si ritira in una spelonca e dice addio al mondo per viversene a Dio soltanto;—qui nel 2º di Sciabbat il fatto più cospicuo, il fatto modello, il tipo degli anacoreti, il grande Essena Rabbi Simone ben Iohai che per tredici anni vive solitario in una grotta, ove si fa così perfetto nella legge di Dio, che al rivedere il suocero dopo tanti anni, tutto che estenuato si fosse nella persona, non potè a meno di esclamare: Beato me che malconcio mi rivedi, poichè ricco cotanto esco dal mio romitorio; ed ove infine secondo i Cabbalisti meditò gran parte delle cose contenute nel Zoar. Qui il Zoar istesso, e questo è grave assai, poichè attesta sempre più quella conformità di genio che è base all’identità da me sostenuta, qui il Zoar, ove si può dire senza tema di errore, non è colloquio, non è incontro, non è polemica, non esposizione che non avvenga o all’ombra di un palmizio, o presso i recessi di una spelonca, o in un campo seduti, o sul ciglio di un fiume, o in una rustica abitazione. Non basta; qui il Zoar che non solo vi dice essere tutte queste cose avvenute laddove avvennero, ma che il fatto vi offre altresì preziosissimo di stanza, di soggiorno, di domicilio che in quelle solitudini avevano i soci, i fratelli come tra essi si chiamavano, della società cabbalistica. Egli è questo un fatto, un gran fatto a cui non si potrebbe prestare abbastanza attenzione, nè io dubito che un dotto di buona fede non ne trarrebbe argomento a gravissime reflessioni. Aprite il Zoar, apritelo nel vol. 2º a pagina 13, dove non solo vedrete come i Cabbalisti dimorassero nella pace dei campi, ma le vestigia vi troverete eziandio luminosissime di ben altre sorprendenti analogie che vorrei tutte analizzare, ma che per ora non mi è dato. Troverete consorteria, organizzazione sociale, e sopratutto vi troverete libri acroamatici ove i misteri si contenevano della Religione; i quali libri[166] non si mostravano che di volo e ai meglio provati, appunto come accadeva in seno al nostro Essenato;—apritelo nello stesso volume 2º, a pag. 183. Che cosa vi vedrete? Vedrete Rabbi Simone, Rabbi Eleazar suo figlio, Rabbi Abba, Rabbi Iose che procedono per via. Chi è questo che gli si fa incontro? È un vecchio ed ha per mano un fanciullo: al solo vederlo dice Rabbi Simon a Rabbi Abba: Cose nuove apprenderemo da questo vecchio. Chi sei tu, gli chiede quando è vicino, e d’onde sei? Ebreo io sono, risponde l’altro, e la mia dimora è tra i farisei del deserto ove do opera allo studio della legge. Gioì Rabbi Simone e disse: Sediamo; conciossia che Dio a noi t’abbia inviato, deh! non ti spiaccia farci udire delle parole nuove, ma antiche (Che bell’antitesi novità e antichità ad un tempo!) che piantaste laggiù nel deserto intorno a questo settimo mese. Allora sorge il vecchio e colle parole esordisce di Mosè ove agli Israeliti ricorda l’assistenza divina per lo deserto, e in mezzo alla sua sposizione esce fuori con questa aperta allusione ai suoi, alla setta di cui era parte: E noi egualmente ci separammo dall’abitato per vivere nei deserti onde meditarvi la legge, conciossiachè non si comprendano davvero le parole di dio se non nel deserto; quindi riprende il santo vecchio il divisato argomento, e tante e sì belle cose va dimostrando sui giorni e sui riti pasquali che l’anima elevano ed il pensiero al solo fraintenderle; tanto vanno improntati di una sublime e trascendentale metafisica. Che sarà poi quando udirete il termine con cui il Zoar conchiude la narrazione? Intanto, dice il Zoar, piangeva Rabbi Simone; ed era pianto di gioia: levarono tutti gli occhi e videro cinque di quei Farisei che dietro al vecchio procedevano per raggiungerlo; alzaronsi tutti. Disse Rabbi Simon: Dinne il nome tuo—Rispose lo straniero: Neorai il vecchio, conciossiachè altro[167] più giovane Neorai sia fra noi.—Disse Rabbi Simone ai nuovi venuti: Qual’è il vostro cammino?—Noi seguiamo, risposero, il santo veglio le cui acque noi beviamo del continuo per lo deserto. Allora gli si appressò Rabbi Simone e baciollo,[53] e disse: Luce tu ti appelli, e luce è con te: nè guari andò che accommiatitosi da quei solitari ripresero i tre Dottori il loro cammino. Questi sono i due fatti che volli citarvi appunto perchè sendo registrati nel libro più illustre dei Teosofi nostri o cabbalisti, tolgono sempre più a confermare quella identità che fu ed è mio officio il dimostrarvi fra l’antica scuola dei nostri Teologi e l’Istituto degli Esseni.
Egli è forse per questo che gli altri rabbinici monumenti ci porgano meno significanti gli esempi di questa predilezione dell’amore del ritiro, della quiete dei campi e del sommo suo confacimento agli studi ed agli atti di Religione? Tutt’altro. Vi dissi, non è molto, come esempi non pochi vi fossero d’insigni Dottori in ambedue i Talmud che chiesero al silenzio, al ritiro, l’acquisizione dei misteri e delle religiose dottrine,[54] e solo perchè meglio gli individui riguardavano le istituzioni, gli usi e i generali costumi, ne feci separata e preventiva menzione. Ma quanto più non tornan all’uopo efficaci gli esempi generali, gli usi, le istituzioni, le leggi stesse da questo spirito informate! Le leggi, quando sentenziano che ove tra i coniugi sorgessero contestazioni sulla scelta del domicilio, a quella parte si debbe piuttosto attendere che preferisce alla città i villaggi, conciossiachè, dice il Talmud, il soggiorno delle grandi città torni non poco alla morale periglioso, pei costumi pel solito più molli e più rilassati. Le idee più intime dei nostri Dottori quando ponendo in bocca alla Chiesa Israelitica quelle parole di Salomone: Deh, gli fan dire (Talmud Tract Irrubin) al Signore; deh non giudicarmi come gli abitanti[168] delle grandi città, tra i quali è violenza, lussuria e maldicenza; ma usciamo ai campi, (notate queste parole) ove ti mostrerò i cultori della tua legge che meditano del continuo e tra angustie la tua parola, mattiniamo alle vigne, cioè (continua il Talmud) ai tempj ed agli studi dove vedremo la vite fiorire, cioè la Bibbia coltivarsi: e così via discorrendo. Ma quali parole quelle che attribuisce alle città i vizi discorsi! E quanto bene consuonano con quel che dice Filone a proposito del ritiro e delle solitudini dei Terapeuti; maravigliosa consonanza in verità! Primieramente, dice Filone, abitano in campagna e schivano le città grandi, a cagione del mal costume che in esse regna per ordinario, persuasi che siccome si contrae una malattia col respirare un aria infetta, così i mali esempj degli abitanti fanno impressione indelebile sull’animo nostro. Ma io dissi anche gli usi generalissimi, anche istituzioni permanenti. Potrò io dimostrarlo? Sarei io in grado di provarvi che tanto spinsero oltre l’amore pei campi, da farne il prediletto, il durevole, il venerato soggiorno? Facilmente, solo che io vi rammenti la benedizione di Meen Scebach. Che cosa è questa? Voi lo sapete, perciocchè l’udite la vigilia di ogni sabato. È quella benedizione che dopo la preghiera sommessa pronunzia il Ministro e che non è, a veder bene, che un compendio o sommario della istessa Amida. Che cosa è questa benedizione e perchè istituita? Chiedetene al Talmud, ai Ritualisti, chiedetene ad ognuno, ed ognuno vi dirà quello che andiamo cercando; cioè vi dirà che ai tempi misnici, ai tempi talmudici gli oratorii, gli studi sorgevano tutti in mezzo ai campi, lontano dall’abitato, nella solitudine e nel silenzio; vi diranno che all’orazione vespertina convenivano da ogni parte i fedeli, che parte solerti giungevano a tempo e la preghiera cominciavano[169] e finivano col popolo tutto, parte trattenuti dai negozi o dal cammino protraevano le loro orazioni alquanto più tardi. Perchè non rimanessero soli costoro fuori dell’abitato, che cosa fecero? Istituirono il Meen Scebah che mandando un poco più alla lunga la orazione offriva agio ai ritardanti di terminare prima che il popolo si partisse. Un gran fatto emerge da tutto questo; ed è la presenza delle antiche sinagoghe e dei pubblici studi nella solitudine; ch’è quanto dire un nuovo riscontro col costume presso che generale degli Esseni, dei Terapeuti.
Io non vi dirò adesso ciò che scrisse Beniamino di Tudela nelle sue peregrinazioni. Ebbi luogo di ricordarvelo quando voleva provare la provenienza Recabitica del nostro Istituto, e spero che non l’avrete obliato. Narra Beniamino di aver veduto nel Iemen tra le numerose popolazioni israelitiche di quella regione, uomini, Dottori, Asceti che perseveravano nell’antico costume degli Esseni, nella solitudine e nel ritiro. Non vi dirò nemmeno come i nostri meno antichi moralisti, p. e., il Hobod Allebabod, che fu non ha guari trasferito in italiano, il Rescit hohma di un Cabbalista discepolo del Rabbi Isaac Loria, facciano tutti e due menzione di una scuola di religiosi che predilegeva l’isolamento e la vita anacoretica, l’ultimo in ispecie che fa menzione siccome tale di un Rabbi Abraham apparus che vita menava non disforme da quella più sopra descritta. Queste cose pretermetterò volentieri poichè ho fretta di giungere all’ultima quistione; non ultima però al certo per lo interesse che desta, ed è quest’una. Rimane egli tra noi tuttavia traccia veruna di questi antichissimi costumi e degli Esseni e di una frazione dei Dottori? cioè, v’è nulla che tragga l’Israelita dal romore delle città per levare la sua mente colla vista della natura, col silenzio, colla maestà del creato, a pensieri più celestiali? Io ardisco dire che vi è, vi è almeno nei libri, conciossiachè e belle e nobili[170] istituzioni sien cadute fra noi in disuso, ed un gran brivido mi mettesse un giorno per l’ossa il Lamennais, quando lessi nel suo Romanzo les Amshaspandas et les Darvands quella frase terribile les Hébreux ont perdu le sens de leurs institutions. Dopo avere tante cose perduto, perdere ancora il senso delle proprie istituzioni pareami troppo orribile cosa in verità; e vedendo tanti e tanti inconsci assolutamente di aver perduto il senso delle nostre istituzioni, pensai non forse avvenisse nella perdita del senso morale, come avviene nei sensi del corpo che non sappiamo d’averla perduta. Fatto è che la memoria, che la reliquia esiste; ed esiste in un uso a noi incognito, ma che pure praticato fu dai Talmudisti, e che solo fu in progresso ed è forse in qualche parte ancor praticato dalla scuola Cabbalistica, io vo dire il Ricevimento del sabato. Che cosa è ora? Egli è ora pei più un canto incompreso, egli è per pochissimi lo stare per qualche istante ritto colla persona, l’inclinare un poco a destra, un poco a sinistra, un leggiero dimenare di capo; e tutto è detto. Che cosa era e che cosa dovria essere? Era purificarsi anzi tratto il corpo, era vestirsi di candidissimi pannilini, (vi ricordi il bianco uniforme dei Nazarei, le stole dei sacerdoti, le candide vesti degli Esseni, e tra poco, vedrete anco le bianche insegne degli Esseni moderni, dei Cabbalisti,) e sopratutto egli era uscire all’aperto, rinfrancare lo spirito coi vastissimi orizzonti, colle aure purissime, colla maestà del tramonto, rannodare le antichissime tradizioni patriarcali, salutare il sabato imminente, la sposa mistica che s’avvicina. Così fecero i Talmudisti quando dicevano l’uno all’altro esciamo ad incontrare la sposa. Così il verace continuatore delle loro tradizioni l’Aari, quando per attestato dei suoi discepoli (conciossiachè egli o poco o nulla abbia scritto), vestito di quattro abiti bianchi a guisa dei sacerdoti, traeva fuori per le campagne di Safet, città[171] boreale di Palestina, e alternando i salmi di David e il mistico poetare, riceveva il sabato. Così a tempi più tardi i Dottori di Sionne perseverando nell’uso antico cercavano pei campi la mistica sposa. L’autore del Hemdat iamim, Cabbalista se altri fu mai, gran scrittore, gran moralista, dolorando come divelto dalla cara Sionne non potesse dar opera, come l’usato, all’amabile rito, così si esprime in suon di lamento: e nei giorni del mio esilio quando la sorte mi divelse dalla Eredità del Signore, nei luoghi ove ramingai pellegrino, non fummi per molte cause conceduto di proseguire nell’antico costume; sibbene questo io faceva: traeva fuori al vestibolo della sinagoga ove vasto e libero ti si schiude l’orizzonte, ed atto all’accoglienza della sposa, e colà io leggeva il Ricevimento del sabato. Avete inteso? È l’aria aperta, è il libero orizzonte, è la vista del creato che sta a cuore al pio Dottore; egli a questo spediente si appiglia non potendo far meglio: ma ciò ch’ei fare vorrebbe, ei lo ha detto, ei lo dirà anche meglio nelle parole che seguono: Ed ove ti sia conceduto, ascendi sulla cima di alta montagna, provvedi che il luogo sia puro, e colà recita il Ricevimento del sabato. Quanto diversi i tempi presenti! Le persecuzioni, le reclusioni, le tirannie fecero certo gran male e più male alle anime che ai corpi, perciocchè se la Religione si conservava nei Ghetti, a caro prezzo si conservava; a prezzo di divenire rachitica, atrofica, impotente, ingenerosa, a prezzo di perdere quel fare nobile, grandioso, poetico, sentimentale che le è proprio. I Ghetti caddero, è pur vero; e gli uomini ne uscirono frettolosi, ma vi dimenticarono preziosissima gemma, la Religione. La Religione è sempre in Ghetto; e sempre tra le angustie, tra le tenebre, tra la melma di quei schifosi meati. Meno infelici i soggetti dello Islamismo! i quali le pratiche religiose spiegano impunemente alla luce del sole; i quali possono mostrare davvero che[172] sia, che possa la fede ebraica. Il Fariseo Cabbalista che ascende la montagna per salutare il giorno santo, è cosa grandiosa per chi la intende, per chi non ha perduto il senso delle nostre istituzioni; è più grande di Byron che si affida su barca leggera al mar tempestoso per essere spettatore e forse vittima della natura infuriata, che vuol assaggiare la morte tanto per poterla descrivere; è più grande di Iacopo, la creatura del Foscolo, che cerca per balzi e dirupi emozioni fortissime. E perchè dico più grande? Perchè i poeti cercan nella natura, nelle sue grandi scene, le sorgenti del Bello, mentre i poeti teologi dell’Ebraismo ve lo recano, ve lo diffondono: conciossiachè vi rechino, non vi cerchino le grandi idee ed i grandi effetti; conciossiachè viva nel loro petto Dio creatore della natura, fonte suprema del bello e del sublime; conciossiachè abbiano in petto il tipo increato del Bello al cui raffronto sorgono giudici meglio che spettatori del Bello creato. In una parola, i poeti ricevono il raggio di Dio riflesso dalla natura, i poeti teologi dell’Ebraismo diffondono sulla natura il divin raggio riflesso dall’anima loro.—La natura divinizza i poeti—non è così? ma i poeti teologi dell’Ebraismo divinizzano la natura.
[173]
[174]
[175]
[176]
[177]
[178]
[179]
[180]
[181]
[182]
[183]
[184]
[185]
LEZIONE DECIMASECONDA.
Parecchie cose furonvi conte finora intorno agli Esseni. Oltre il nome, l’origine, di cui a dilungo parlammo, sappiamo dove abitavano—il mezzogiorno di Palestina—sappiamo ancora, lo abbiam veduto nell’ultima lezione, come abitavano, ch’è quanto dire solitari nella quiete dei campi. Se queste cose come le avvenire, maggior tempo richiesero a trattarsi che per avventura non sembra dicevole, lieve è lo scuoprirne la causa. Ella è quel duplice e complessivo lavoro che noi imprendemmo, e quel volere ad ogni passo, ad ogni nuovo elemento della loro esistenza, trovare nuova conferma a quel postulato supremo che vi enunciai dapprincipio, la restituzione dell’Essenato a quella scuola più vasta che s’intitola dai Farisei; e più specialmente a quella frazione che dagli altri si distingueva e per l’austerità della vita e per la sublimità degli studj. Rinunciare a questo scopo nobilissimo sarebbe certo ridurre a più angusti termini il nostro lavoro, ma sarebbe altresì rinunciare a quel benchè modesto resultato che ci è concesso sperare dalle nostre fatiche, a quell’unico titolo che possono queste lezioni vantare alla estimazione dei dotti. Ella è dunque stasera una nuova circostanza di lor vita esteriore che noi dobbiamo apprezzare. È quella predilezione e quell’amore[186] che gli Esseni ebber mai sempre per le piagge, per le rive dei fiumi. Se meno gravi, se meno concordi fossero gli attestati degli antichi autori, io dubiterei non forse il caso meglio che la elezione avesseli per ordinario fatto stanziare sulla ripa dei fiumi. Ma il potremmo pensare, dopo che Plinio e Filone abbiamo ascoltato? Che dice Plinio? Plinio parla specialmente degli Esseni di Palestina, e quanto ei dice al capitolo 5 del libro XVII solo ad essi dobbiam riferire. Ora, se non m’inganno, io ebbi luogo di accennarvi in altra lezione, quanto Plinio ci narri in proposito. Egli asserisce come gli Esseni vivessero tutti quanti in riva al Lago Asfaltide ossia Mar Morto, e solo egli aggiunge tanto se ne discostavano quanto tornava indispensabile a cansare le mefitiche esalazioni di quel lago insalubre. Or che sarà se intenderete Filone lo storico dei Terapeuti dirci altrettanto dei suoi solitari? Certo direte che non è senza grave cagione che così accadeva. Or bene; aprite Filone nella Vita contemplativa, e poichè vi avrà dette come taluni di quei religiosi dimorassero qualche volta nelle città, queste parole nonostante ne intenderete apertissime. Ma i principali, dice Filone, si ritirano quasi tutti in un luogo che hanno fuori di Alessandria vicino al Lago Mereotide sopra un’eminenza, che fa il luogo securo e dove l’aria è salubre. E qui i Terapeuti non potrebbero mostrarsi più che non si mostrino conformi ai loro fratelli palestinesi. Com’essi parte vivono in società e parte in ritiro, com’essi amano le campagne, i luoghi salubri, sopratutto com’essi ancora prediligono le rive. Havvi a quest’uso un perchè? Erano eglino gli Esseni, i Terapeuti nella scelta di questi luoghi guidati da un principio, da una tradizione, da un esempio che glieli additasse? La storia, il culto, la religione, la letteratura ebraica ci rispondono propizi. Non dirò come le acque fossero sempre[187] simbolo, immagine venerandissima in bocca ai profeti, simbolo d’Ispirazione quando alludono alla futura effusione dello spirito, simbolo di Beatitudine quando Dio è presentato qual sorgente perenne di acque vive, simbolo di Dottrina quando spargansi, dice Salomone, le tue acque per ogni dove, intendendo della propagazione dei buoni studi. Non dirò nemmeno come non solo atto si stimano a lavare di ogni corporea impurità, d’onde le infinite e multiformi abluzioni di ogni maniera immondizia, ma bensì la virtù lor si conceda altresì di santificare e predisporre ai più nobili offici di religione, siccome vediamo aperto nelle ripetute abluzioni del sommo Pontefice nel giorno di Espiazione. Non dirò come la vista del mare, la navigazione si dican capaci di preparare gli animi all’acquisizione del (Hassidut), e già sappiamo gli Esseni dirsi Hasidim d’onde l’adagio i marinari per la massima parte essere Hasidim. Non dirò infine come le rive fossero dai Dottori desiderate dopo la Terra Santa, siccome il più puro ricetto a ospitarne le ossa, siccome vediamo in Ribbi Meir, il quale per attestato del Talmud di Gerusalemme essendosi addormentato (bella metafora[55] per dir trapassato!) in Assia, luogo come altra volta intendesse dell’Asia minore, lasciò detto ai Discepoli Deh! vogliate seppellirmi in riva al mare. Che se questo brevemente trapasso per non tediare, come potrei tacere di cose che tanto a questo sovrastano per gravità? Come tacere che per dottrina tradizionale, per esempi grandi cospicui della Bibbia, il solo luogo atto dopo la terra santa alla fruizione di profezia, sono i lidi del mare o le rive dei fiumi? Come non dire che se Ezechiele profetò, tutto che fosse oltra i confini di Palestina, ei fu solo perchè, dice la tradizione, acconciamente vi si dispose stando in luogo purissimo cioè sulla riva del fiume Chebar? Come non dire che se Daniel ebbe visione, e non[188] in Palestina, ei fu, dice egli stesso al cap. VIII, sul fiume Ulai? Come tacere del capitolo X dove, se ci si narra l’ultima sua visione, ella è pure in riva ad un fiume, il fiume Tigri? Come tacere che se festa vi era in cui si stimava potere l’ispirazione conseguire, quella si era in cui le libazioni di acqua si praticavano;[56] non troppo dissimile da quanto i Pagani favoleggiarono intorno la profetica virtù dell’onda Castalia, dell’Ippocrene, dell’Aganippe e del Lebitrio? Come non ricordare ciò che dice Massimo Tirio parlando dell’oracolo Jonico. Lo Ipopteta, ei dice, della Jonia dopo avere attinto e bevuto l’acqua del sacro fonte predice lo avvenire? E come infine tacere dell’atto più importante della monarchia israelitica della unzione del nuovo Re? La qual cerimonia, è la Bibbia che lo attesta, si faceva e doveva sempre farsi, aggiunge il Talmud (in Oraiot), sulla riva di un fiume, in quella guisa appunto che vediamo nei Re praticato, in Salomone, il quale per ordine di Davide condotto presso a Ghihon, piccola riviera che scorreva vicino a Solima, vi fu solennemente sacrato e proclamato monarca? Ma quanto non riescono al confronto insignificanti cotesti esempi ove ad un fatto grande significantissimo si riferiscano, di cui la Tradizione ci ha serbato memoria! Perocchè tra i Pagani, nei tempj loro più venerandi, negli oracoli più famosi, non altrove, sorgesse l’altare, non altrove si locasse la Pila, a inspirarsi del Nume che colà abitava se non sull’orifizio di un pozzo, questo sapevamo e per storici antichi e per moderni: sapevamlo sopratutto dal Clavier (Les oracles des anciens) di cui non ha guari scorsi le pagine, ove in una dotta Memoria presentata all’Accademia sugli Oracoli degli antichi tolse a dimostrare con squisita erudizione, il fatto da me accennato nei due più famigerati tempj ed oracoli di Grecia antica, in quello cioè antichissimo di Dodona e in quello[189] di Delfo. Il sapevamo da Origene il quale dice la Pitia essere posta sull’orifizio della fonte Castalia; da Euripide nella Ifigenia in Tauride, dove facendo Apollo parlare, sì gli fa dire: Il mio Santuario divino sulla corrente Castalia.—Da Temistio che scrive: Gli Anfizioni furono i primi fondatori di Delfo, un pastore del Parnaso sendosi trovato invaso dallo spirito profetico del fonte Castalio; da Nonnio nei suoi Dionisiaci, che disse: L’acqua divina della previdente Castalia era in ebullizione; da Ovidio che all’antro della Pitia dà il nome di antro Castalio; e infine da Pausania che così si esprime nella descrizione di Delfo: Volgendo a sinistra all’uscire dal tempio di Delfo voi trovate la tomba di Neottolemo; un poco più in alto si vede una pietra che non è grandissima. È unta con olio; ogni giorno ed i giorni di festa è coperta di lana grassa. Questa pietra è, dicesi, quella che fu fatta inghiottire a Saturno invece del figlio e che poi in questo luogo rejesse. Ritornando di là verso il tempio, tu osservi la fontana Cassoti (altro nome della sorgente Castalia) essa è circondata di un muro poco alto, in cui è praticata una porta per cui si crede che quest’acqua si conduce per vie sotterranee nel santuario del Dio e ch’è dessa che ispira le donne che vaticinano lo avvenire. Così tutti gli scrittori summentovati dell’oracolo Delfico. Possiamo dire altrettanto di quel di Dodona? Sì, se portiam fede a Servio nel commento a Virgilio, il quale al libro terzo dell’Eneide sopra il v. 406 così si esprime: Questo paese di Dodona è sui confini della Etolia. Gli antichi vi consacrarono un tempio a Giove ed a Venere. Presso al tempio, immane quercia sorgeva, a quanto sen dice, dalle cui radici una fonte scaturiva, il cui mormorio per divina ispirazione una vecchia donna per nome Pelia interpretava. Ex cuius radicibus fons manabat qui suo[190] murmure instinctu deorum diversis oracula reddebat. E questi furono i due più celebri oracoli della greca antichità, e questo il modo dei loro responsi; nè da questi differirono altri infiniti, comunque meno famosi; non quello dei Branchidi nell’Asia minore di cui così favella Jamblico nel libro sui Misteri: Una donna appo i Branchidi predice lo avvenire, vuoi tenendo la verghetta in origine donata da qualche Iddio, vuoi assisa sopra il tripode, forse ancora i suoi piedi o il lembo del suo vestito stanno immersi nell’acqua, e infine il Dio a lei si comunica col vapore di quest’acqua. Nè quello differiva dei Colofoni, al dire di Jamblico, che ne discorre in questa guisa: Quanto all’oracolo dei Colofoni, ognuno conviene che egli è per mezzo dell’acqua che ci si annunzia lo avvenire. Una fonte vi ha in un edifizio sotterraneo. In certa notte dopo parecchie cerimonie e sacrifizj, il Profeta bee l’acqua del fonte, e non veduto da quelli che vennero a consultarlo predice lo avvenire.
Ma quello che colmare vi dovrà di stupore, quello che io temo forte vi sarà riuscito sinora ignoto, siccome quello che poco eziandio è divulgato tra i cultori delle lettere sacre, egli è questo fatto curiosissimo, il fatto cioè che non altrove era situato il grande altare dei sacrifizj nel tempio di Dio, tranne sulla bocca di un pozzo, pozzo, dice Rascì nel Talmud (14º di Succa), che riceveva tutte le libazioni che si versavano sull’altare; pozzo che si chiama Scitin nel Talmud e che si proclama antico quanto il mondo, Scitin nibrau miscescet ieme berescit, d’onde il curioso anagramma berescit bera-scit; pozzo, secondo i dottori accennato da Isaia, ove paragonando Israele ad una vigna dice: e vi fabbricò il suo padrone una torre, e questo è l’altare; un pozzo vi scavò, e questo è la cavità sottostante; pozzo, interpreta il[191] Moarscià, ch’era come la scaturigine di tutte le acque mondiali, ristretta, contenuta ai piedi dell’altare, sì perchè (stupendo pensiero) imponendovisi sopra quasi suggello l’altare di Dio, rispettin le acque i naturali confini, nè più irrompino a inondare la terra; sì perchè vengano benedette le acque dalla sorgente di ogni benedizione, e le libazioni scorrano all’oceano quasi sangue novello perpetuamente infuso nelle arterie del Globo. E questa è parlantissima analogia oltre le altre già menzionate, oltre altri fatti in gran numero che ometto per brevità col costume che vediamo prevalso tra gli Esseni di ogni colore di abitare le rive. Ma quanto non amerei che più a lungo mi fosse dato d’insistere sull’ultimo e supremo fatto da me accennato di sopra—il pozzo sacro su cui poggiava l’altare! Non solo i tempj e gli oracoli greci potrei chiamare, come dissi, a rassegna, ma molte altre idee con questa principalissima concomitanti potrei accordare, vedreste le idee dei Pagani su quel pozzo, su quelle acque poco procedere dissimili da quelle da Moarscià enunciate, comecchè il solo genio delle dottrine talmudiche gliele abbia ispirate; potrei mostrarvi come ogni qual volta si dava ai Pagani un pozzo profetico, non mancava un idea, una tradizione che lo accompagnasse, voglio dire la credenza comune in Grecia, comune in Fenicia che da quell’orifizio, da quel condotto, fossero tutte scolate e tutte inghiottite le acque del Diluvio quando si ritirarono; e che il tempio e l’altare e l’oracolo quivi eretto, fosse un perpetuo religioso scongiuro contro le onde frementi; vorrei dirvi come quell’intimo comunicare dello altare di Dio colla profondità della terra, quel veicolo che univa l’ara alle viscere più segrete del Globo, riceva lume e tolga senso principalmente dalle dottrine dei Pitagorici. I quali non solo chiamavano il fuoco centrale torre di fortezza (Pyrgos) come i dottori appunto,[192] cosa sorprendente! chiamarono il centro della terra il sito dell’altare col nome Migdal, torre di fortezza, ma ciò che più monta chiamavano i Pitagorici quel centro stesso altare dell’universo come appunto nel centro della terra secondo i Dottori, sorgeva l’altare e il fuoco perpetuo quasi vampa projetta e quasi prolungamento del fuoco centrale di cui favellano i Pitagorici. Ma di questo basti per ora; basti lo avere provato come nemmeno in questa circostanza, in questo costume, nell’amor delle rive si dipartissero gli Esseni dal comune pensare e dalle idee predominanti tra i Farisei.[57]
Rimettiamoci dunque in cammino e procediamo spediti. Che cosa abbiam fatto sinora? si può dire senza errore che poco più abbiam fatto fuorchè aggirarci intorno agli Esseni senza mai investirli. Nome, Origine, Patria, Regione, Solitudine, Sito particolare, tutte cose senza meno opportune, ma che non sono ancora gli Esseni. Tempo è che gli Esseni stessi consideriamo più davvicino. Ma anche adesso conviene procedere ordinatamente e a grado, conviene sapere se sono tutti omogenei o in qualche parte diversi fra sè; in altri termini conviene sapere se classi vi erano, e quali, e quante nel grande Istituto. E qui non potrei senza colpa dissimularvi che le notizie che intorno al subbietto ci son pervenute, procedono a senso mio così confuse e talvolta eziandio così contraddittorie, che dura cosa è mettere ordine e luce in tanta repugnanza di idee.
Voi non volete certo sobbarcarvi a una sottile disamina, nè io lo esigo. Vi risparmierò dunque il Processo, vi risparmierò altresì i considerandi della mia sentenza; questo solo vi dirò, che a quanto ho potuto capire dal confronto dei Testi, due classificazioni debbono ammettersi nel nostro Istituto. Notate che dico due classificazioni e non due classi, dico due ordini di classi, due[193] gradazioni, due gerarchie. La prima riguarda la maggior o minor purità a cui s’obbligavano nel contatto delle cose esteriori, e si deve intendere in quel senso tutto ritualistico e positivo a cui accennano i Trattati sulla materia. E in quest’ordine d’idee, in questa gerarchia quattro gradi o classi rammenta la storia in seno agli Esseni. E principalmente ne favella Giuseppe nel libro secondo delle Guerre Giudaiche, dove così si esprime: «V’ha d’essi secondo il tempo della loro professione quattro differenti classi; e i più giovani sono talmente inferiori agli anziani, che se accade che uno di classe più alta ne tocchi uno della più bassa, convien che si lavi come se avesse toccato un incirconciso.» Resta ora a parlar della seconda classificazione della seconda gerarchia. Ma prima di procedere più oltre, e seguendo il nostro stile, domandiamo a noi stessi: se egli è vero che gli Esseni non altro sono che una frazione, la più sublime frazione dei Farisei, siccome per me si estima; mestieri è pure che di questa quadruplice divisione non solo appo i Farisei resti serbata memoria, ma che i Farisei stessi a dirittura se l’approprino, voglio dire che di se stessi narrino i Farisei ciò che degli Esseni i loro storici ci raccontano. Dov’è questa menzione, e in qual guisa se la appropriano i Farisei? Voi comprendete che ove la divisione esista realmente, laddove poi ai Farisei istessi sia applicata, fatto non indifferente sia cotesto in verità, per la identità da noi propugnata tra Essenato e Farisaismo. Ora dov’è la quadruplice divisione? Voi la troverete a capello nel 2º capitolo di Haghiga dove leggerete le seguenti espressioni: bigde am aarez, medras lapparuschem, bigde paruscum medras leohele maaser scheni, bigde ooele maaser sceni medras leohele teruma, bigde ohele teruma, medras lacodes, bigdes codes medras lehattat.
Dove più cose sono da osservarsi; prima la quadruplice gradazione di purità rispondente ai quattro gradi di purità nella società degli Esseni, per ciò che riguarda il reciproco contatto; e dico quattro nel testo Misnico; giacchè ognuno comprende come coloro che sono al di fuori del farisato, cioè bigde amaarez, non possano ammettersi in conto. Il fatto poi dalla Misna rivelatoci come vi fossero uomini tra i Farisei che senza appartenere al ceto sacerdotale, come Iohanan Ben Gudgheda ivi stesso rammemorato, od anche al ceto sacerdotale appartenendo come Iose ben Ioezer che vien chiamato col nome significantissimo di Hasid, come dico, tali vi fossero che in tutti i loro rapporti quella rigida osservanza serbassero di purità, ora qual si conviene al sacro cibo di Teruma come Iose il Hasid, ora qual si addice anzi alle offerte stesse approssimate agli altari, come l’altro, Iohanan Ben Gualgheda. E questa è la prima classificazione e la memoria ed il segno che di essa è rimasto nei libri rabbinici. Ma io dissi, se ben vi ricorda, come duplice classificazione distinguesse gli Esseni. Qual’è la seconda classificazione? Ella è quella che riguarda, non già come la prima il diverso grado di purità, ma ciò che più monta, il genio riguarda e l’officio diverso delle classi che la società componevano. E quante erano queste classi? Eran due. Si dicevano i primi Esseni pratici, si dicevano i secondi Esseni contemplativi. Che cosa erano gli Esseni pratici? Eran coloro che senza troppo gittarsi nel turbine delle faccende mondane non lasciavano però di conversare familiarmente cogli uomini in società; che non solo praticavano il matrimonio, ma lo predicavano eziandio santo e legittimo, e conforme sopratutto alle mire provvidenziali per la conservazione della specie umana; erano coloro di cui così favellava Giuseppe nel 2º delle Guerre: «V’è ancora un altro ordine di Esseni che ha l’istesso[195] metodo di vita, i medesimi costumi e le medesime regole, toltone l’articolo delle nozze, questi dicono che sia tôrre alla vita umana una delle sue parti più considerabili, lo impedirne la successione col non ammogliarsi, e che se tutto il mondo fosse di questo parere il genere umano presto correrebbe al suo fine. Ma spendono tra anni ad esplorare gli animi delle lor spose; e quando sono state tre volte in questo tempo purgate conchiudono che sono atte ad aver figliuoli, e le sposano.» Queste sono le parole di Giuseppe intorno agli Esseni che si dicono pratici. Se fossero a voi famigliari i libri e le sentenze dei nostri Dottori, trovereste siccome io trovo, una mirabile uniformità di linguaggio tra gli Esseni, secondo Giuseppe e i Dottori più celebrati, intorno la necessità, il dovere del matrimonio; tantochè se non mancano esempj, come altra volta vi dissi, di celibato volontario ascetico in seno ai Dottori, non si può negare che il comun genio e le prevalenti dottrine non consentano piuttosto col genio, colle dottrine di quella parte di Esseni che si nomano pratici. Ma una seconda divisione nell’Essenato vi additava, ed è quella degli Esseni contemplativi. Che cosa sono gli Esseni contemplativi? Sono quelli che ponevano ogni amore nello studio e nella vita contemplativa, quelli che passavano i loro giorni, dice Filone, a meditare i libri sacri e la filosofia dai maggiori imparata; che continuamente rinchiusi nelle loro cellette, nè uscivano, nè parlavano con chicchessia, e che di fronte alle speculazioni e allo studio, continua Filone, ogni altro religioso dovere tenevano a vile. Queste sono le due classi, e questo il ritratto che ce ne offre principalmente Giuseppe. Filone istesso non lascia di autorizzare la esistenza di questa duplice classe. Filone, come altra volta vi dissi, scritto aveva due libri l’uno «ogni uomo onesto è libero» e parlava degli Esseni[196] l’altro, de vita contemplativa e vi trattava dei Terapeuti; ma ciò che grandemente interessa la questione presente, si è il modo, si è la frase con cui Filone trapassa dal 1º libro al 2º da quello cioè che concerne gli Esseni a quello che riguarda i Terapeuti. Egli usa parole che non solo confermano la esistenza della duplice classe da noi accennata, ma ci additano altresì la speciale composizione dello Essenato Palestinese ed Egizio e quale e nell’uno e nell’altro predominasse degli accennati elementi, Pratico o Contemplativo. Avendo già, così dice Filone all’esordire del 2º libro, avendo già fatto parola degli Esseni (e già aveva detto precedentemente come cotesti la Palestina avessero a patria), i quali menano una vita pratica e attiva, conviene al presente ch’io tratti di quelli che si danno alla Contemplazione. Che cosa vedete in queste parole? Non solo vedrete la identità generica, la suprema medesimezza degli Esseni e dei Terapeuti che taluno volle revocare in dubbio; non solo vi vedrete la distinzione delle due classi, ma ciò che al tempo stesso non vi potrà non apparire manifesto si è, come benissimo avvertiva l’illustre sig. Munk, il prevalere del pratico elemento tra gli Esseni di Palestina come la preponderanza che aveva la parte contemplativa tra i Terapeuti, ch’è quanto dire tra gli Esseni di Alessandria. Nè altrimenti poteva procedere la bisogna. L’Egitto, e specialmente l’Egitto siccome fatto lo avevano la greca filosofia e le religioni orientali, era la patria naturale, propria di ogni ascetismo comecchè trasmodante. Il celibato, la solitudine, il disprezzo del mondo, il divorzio di ogni civile consorzio, erano piante che in niun altro terreno meglio avriano potuto attecchire che nel terreno egiziano. Non così per Palestina, dove se la vita contemplativa non cessava di essere in onore grandissimo, non era di quella tempra viziosa, esclusiva che colpisce di[197] paralisi ogni più attuosa facultà, e le più prestanti e rigogliose aspirazioni consuma in un misticismo vaporoso. La vita contemplativa dei Dottori non procedeva per lo più scompagnata dall’esercizio della umana attività, dalla santificazione del corpo, mercè il culto esteriore, dalla santificazione del mondo e dei piaceri e delle occupazioni del mondo, mercè il suggello e quasi non dissi il crisma che gl’imponeva la fede. Misticismo, vi era chi lo nega? Ma era quello di buona lega, quello che non scinde, non smembra, non mutila l’uomo a favore delle facoltà sue superlative, ma che tutto l’uomo, i pensieri come le opere, gli studj come la pratica, il corpo come lo spirito, prende a santificare, e tutto, anche le opre più vili, gli fa praticare in ispirito e verità; era quel misticismo sincero, di cui nobilissimamente discorreva Vincenzo Gioberti presso a cui s’impara più d’Ebraismo che non per avventura presso a tanti sedicenti israeliti scrittori, quando nella Filosofia della Rivelazione dettava queste parole, a cui ogni buon Israelita potrebbe soscrivere «La vera vita contemplativa implica l’attiva, o esterna e sensata. L’attiva perchè la somma anzi l’unica attività, è quella del pensiero. L’esterna perchè questa è necessaria a svolgere l’intelligente e a passare allo stato di mentalità pura; gli orientali e gli ascetici che rigettano la vita esterna e collocano la vita contemplativa nella mera passività, non s’intendono di vera contemplazione.» E Gioberti ha ragione per l’oriente eterodosso. L’oriente ortodosso però, i Profeti e Dottori, comecchè recassero la vita contemplativa sino alle sue ultime conseguenze, non la fuorviarono mai dalla via che conduce al perfezionamento dell’uomo intero, e Paradiso e Civiltà se non eran per essi due termini sinonimi, certo eran strettamente correlativi. Moralmente parlando l’Ebraismo aveva[198] collocato da lungo tempo la terra in cielo, pria che nascesse Copernico. E questo era il misticismo palestinese, e questo principalmente il suo Essenato, in cui la parte maggiore si componeva, voi la udiste, di quei Dottori, di quei fratelli, che tutto che vivessero e conversassero tra gli uomini in società, e nozze contraessero, e gioje e dolori e vicende coi fratelli tutti dividessero, ciononostante tale inflessibile regola presiedeva ad ogni loro atto, tali i vincoli che li univano comecchè disgregati talvolta, tale l’unità di vita e di mire a tutti comune, che per essi non sarebbe profanazione ripetere ciò che fu detto per quel Dio che sì nobilmente adoravano: che la sua circonferenza non è in nessun luogo e che il suo centro è da per tutto. Non si vuol dire con ciò che contemplativi veri, proprj, esclusivi, non esistessero in Palestina, e se io lo dicessi, non solo Giuseppe, ma i Dottori stessi, ma il Talmud, ma il Zoar sorgerebbero a smentirmi. Ciò che dico questo si è, ch’eran pochi, non solo, ma che anche nel concetto universale era quello uno stato di sovrumana perfezione, a cui non avrebbero potuto senza periglio aspirare che pochissimi, a cui natura avesse conceduto la forza di vivere sulla terra la vita dei Celestiali. Ma pure esistevano, e se esistevano, mestieri è per essi come pei Pratici, rinnovare quella inchiesta che non cessammo di ripetere ad ogni nuovo elemento che ci si porse dinanzi della Essenica esistenza. Havvi di questa distinzione memoria tra i nostri Dottori, consuona questa duplice divisione di Pratici, di Contemplativi, con quel che di sè narrano i Dottori delle proprie divisioni? Abbiamo insomma, anche da questo verso, ragione di credere alla identità da noi propugnata delle due scuole di Esseni e di Farisei? La prossima conferenza ce ne darà adeguata risposta.
LEZIONE DECIMATERZA.
Di due sorta classificazioni studiammo nella società degli Esseni nella conferenza passata: abbiamo veduto in che cosa consistesse la prima, e come getti le sue radici in una identica distinzione che la Misna ci additava in seno al Farisato. Abbiamo veduto in che cosa consistesse e su che principalmente si fondasse la seconda distinzione; distinzione di officio, di genio, di peculiare indirizzo, per cui in due principalissime categorie si dividevano tutti gli Esseni, in Pratici, in Contemplativi. Erano i pratici coloro che del tutto non si separavano dal mondo. Eran i contemplativi coloro che all’amor dello studio, al ritiro, alla contemplazione sacrificavano ogni altro culto, ogni affetto, ogni ambizione: di queste due classi noi abbiamo costatato, quanto era mestieri, l’indole, il carattere particolare; abbiamo veduto come più si affacesse ai primi la patria Palestinese, e come piuttosto si acconciasse ai secondi il soggiorno di Egitto. Se questa fosse semplice e nuda esposizione della Essenica organizzazione, se non ci fossimo sin da principio proposti di restituire il nostro Essenato al più vasto seno, alla più vasta scuola dei Farisei, se non dovessimo porre questa identità al raffronto di ogni fatto che si presenta, e da quello nuovo argomento derivare[204] in favor nostro; se questa restituzione non fosse di sommo, di capitale interesse nella storia religiosa del popolo nostro, forse noi, postergato questa sera l’argomento presente, procederemmo difilati più oltre. Però grave debito c’incombe e lo adempiremo. Noi dobbiamo sperimentare quanto e come regga al confronto dei fatti il nostro supposto, dobbiamo vedere se la distinzione di cui si favella nella società degli Esseni, risponde ad altrettale distinzione in seno al Farisato; in una parola, dobbiamo anco una fiata vedere se la propugnata identità non è una favola. Io chieggo dunque: conobbe egli il Farisato distinzione siffatta? Havvi tra esso una scuola, un sistema che sia e che si appelli contemplativo? Havvi al tempo istesso un altro che le dottrine professi e il titolo rechi di Pratici? Io oso dire che la distinzione esiste, e tale esiste che meglio non potrebbe allo scopo conferire. Esiste in tutta la estensione della Enciclopedia Rabbinica dei primi secoli, esiste nei fatti, negli uomini, nelle dottrine e infine sotto due principalissime forme due modi di storica rimembranza. Prima forma io chiamo quei casi innumerevoli in cui l’una o l’altra scuola, i Pratici o i Contemplativi s’introducono ad agire, a parlare isolatamente, separatamente dalla scuola e dal sistema contrario, così che noi esamineremo successivamente, passando prima in rassegna tutto ciò che nella Rabbinica Enciclopedia allude agli uomini, ai fatti, alle dottrine dei Pratici, e poi ai fatti e agli uomini che si dicono Contemplativi. Ma quanto più vivo interesse, quanto più efficacia nella forma seconda! In questa Pratici e Contemplativi, sistema e sistema, dottrina e dottrina più non ti appariscono lontani e disgiunti; ma con bella e parlante antitesi interloquiscono ambedue ad un tempo; e fede fanno ad un tempo della loro esistenza, e la distinzione pongono più chiaramente in rilievo in[205] virtù del contrasto. E prima, che nome recano negli scritti Rabbinici le due scuole? Che nome pei primi i Pratici?—Ora il nome di Iere het, che temono il peccato, ora quello più espressivo di anse maase, gli uomini della pratica, i Pratici, come udirete dagli esempj. Che nome recano i Contemplativi?—Il nome principalmente di Hasidim. Noi dell’uno e dello altro conosciamo i nomi; dove ora le dottrine, dove i fatti e dove gli uomini? Dove in primo luogo i Pratici?—Eccoli quando predicano l’insufficienza della sola speculazione; quando vogliono lo studio delle cose divine congiunto alla pratica dei doveri sociali iafe talmud tora im dereherez, im en dereherez en tora; quando dicono l’uomo non doversi dalla società sequestrare leolam tee datho sceladam meurebat im abiriot; quando insegnano nessuna virtù tornar gradita comecchè trascendente; quando dal centro vivificatore si sequestri, dalla religiosa comunanza, dalla chiesa di Dio; quando levano a cielo la necessità del lavoro ghedola melaha scemehabbedet bealea; ghedolim baale umaniot l’amore dell’industria, la fatica del corpo e i benefici influssi di una vita laboriosa ed attiva alla salute dell’anima. Dove sono i Contemplativi? Vedeteli nel Talmud in Sotà ove coi più celebri Dottori si lamentan perdute altresì le più rare virtù, e dove specialmente con Iose ben Catnuta si dice oscurato il lustro dei Hasidim; vedeteli nel Talmud Gerosolimitano, ove di un’opera e di un titolo si accenna, che non so come si potrebbe desiderare più appropriato pel caso nostro; è la menzione di un’opera che il titolo reca di Misnat hasidim, ed in cui tutto ed al sommo c’interessa, persino una curiosa variante. Interessa una citazione che ivi stesso è riprodotta dell’opera in questione, e dove in brevi ma espressivi tratti ti si dipingon le fattezze dei Contemplativi; ove si legge, p.e.: se tu per un solo giorno mi abbandoni,[206] io ti abbandonerò per due, volendo dire come l’assiduità e la perseveranza sia precipua somma condizione nei sacri studj; e noi sappiamo qual ritratto ci abbia Filone lasciato della applicazione istancabile dei Terapeuti ai cari studj. Dissi persino una variante, e ve lo provo. Io lessi Misna hasidim Lettura o tradizione dei Hasidim per che così recano parecchi autorevolissimi testi, per che così par confermato da altri passi talmudici, come tra poco intenderete, e perchè finalmente, quando pure si meni buona la diversa lezione, pure il senso rimarrebbe a parer mio invariato. Ma qual è la seconda lezione? Leggono invero alcuni testi Meghillat Setarim invece di Misnat hasidim. Ma che vuol dire Meghillat Setarim? Vuol dire il volume dei Misteri. Io non so s’è dato afferrare da ora l’attinenza che corre strettissima fra le due lezioni. Bisognerebbe che precorso aveste in parte il mio dire. Bisognerebbe che voi sapeste come i libri degli Esseni fossero tenuti in gelosissima custodia, nè ad altri ne fosse comunicata contezza, tranne ai più fidi, ai meglio provati. Comprendereste allora l’origine di questa variante; vedreste siccome io veggo come naturalmente siensi presentate ambedue le lezioni, e vedreste ancora come se la vera e originale lezione non è al certo che una, pure non può essere senza grave cagione ammessa, introdotta la seconda lezione, e questa cagione e questa origine e la somma convenienza di libri, di opere esotteriche quando si parla di Esseni; siccome quelli che la storia accenna veramente possessori e custodi di libri siffatti.[58]
Ma in altre parti ancora della Rabbinica Enciclopedia lasciarono di sè vestigia i hasidim. Lasciaronle nel Talmud Babilonico ove a chiunque, ed eziandio a quei Dottori che alle più rigide regole non soggiacquero del Hasidut, e solo allo strettissimo Jure mostrino di attenersi,[207] si suole maravigliando interrogare, ella è forse cotesta la Misna dei hasidim? Quasi dicessero, egli è questo il fare severo, irreprensibile dei hasidim?—Lasciaronla nel trattato Berahot, dove degli antichissimi hasidim si narra il lungo orare, e le protratte preparazioni, e la giornata quasi interamente sacrata agli uffici di devozione quando si dice: Gli antichi hasidim un’ora spendevano in preludio a preghiera, un’ora nell’orare, un’altra pria di congedarsi da Dio e così facevano tre volte al giorno. Ove dunque gli studi e dove l’industria per vivere?—Si ripiglia lo stesso Talmud: sendo costoro hasidim, il poco studio fruttava assai e lo scarso industriarsi sopperiva al bisogno. O io sbaglio, o questo passo del Talmud è un bizarro accozzamento di antiche tradizioni e di più moderne spiegazioni. Mestieri è che sappiate che cosa sia il Talmud Babilonico; come fuori fosse compilato di terra santa, come gli autori che dierongli la forma sua definitiva, nè la Palestina per avventura vedessero mai, nè i partiti, nè le vicende più importanti gli fossero conte di Palestina; quindi i non rari anacronismi nella storia palestinese, i fatti storici a quella relativi narrati in confuso, e quindi infine il sentenziare presente. Per tradizione conoscevano per avventura gli antichissimi Hasidim e li ricordano, udito avevano la vita a perfezione religiosa atteggiata, e così la dipingono; le orazioni lunghissime, la giornata spesa in devozioni e tale la narrano in verità, obbliarono però o non udirono come la speciale loro organizzazione, la comunanza dei beni, il lavoro in comune, questo tenore di vita straordinario gli consentissero, cioè le lunghissime ore trascorse in offici pietosi, quindi le più tarde e forzate spiegazioni, il ricorrere al prodigio, l’attribuire ad una grazia ognor rinnovata ciò ch’era effetto della loro istituzione, e quindi il bizzarro accozzamento di un fatto vero e di una ragione arbitraria,[208] di una tradizione verace e di una interpretazione gratuita.[59] E lasciarono di sè manifeste vestigia in Hasidim, in quella eccezione singolare per cui un ceto intero dei cultori della legge viene formalmente dispensato da ogni pratica religiosa, siccome apertamente dispensa il Talmud da ogni religioso dovere coloro che fanno unica somma loro occupazione la meditazione della legge, o come dice il Talmud, che altra professione non eserce tranne lo studio; e quando infine per colmo di maraviglia volendo citare il Talmud un uomo, una scuola che alle condizioni tutte abbia adempito necessarie a questa dispensa, il gran nome cita e la gran scuola ad esempio.[60] R. Simon ben Johai e i suoi compagni, insegnandoci al tempo stesso nella citazione preziosissima e il carattere ascetico, speculativo, studioso, eccezionale di quella famiglia e la preziosa indicazione della esistenza istessa di una scuola da quel gran nome capitanata, e infine la bellissima coincidenza delle due dispense, quella che il Farisato consentiva al Ben Johai ed alla scuola sua da ogni pratica osservanza, e quella che gli Esseni rispettavano nel più perfetto del loro Istituto da ogni pratica esteriore;[61] e quindi nuova e preziosissima conferma e della identità generale della Farisaica colla Essenica scuola, e tra i medesimi Farisei una più speciale affinità colla scuola mistico-teologica, dei cabbalisti di cui fu principe e restauratore Simon Ben Johai. Ma io vi dissi che non solo disgiuntamente lasciarono di sè vestigio nei Rabbinici monumenti ed Esseni pratici ed Esseni contemplativi; dissi ancora, e vado a provarlo, che la coesistenza in seno al Dottorato di questa duplice ramificazione, resulta anco più spiccata, anco più manifesta in tutti quei luoghi, e sono molti e sono parlanti, nei quali gli uni figurano a costa degli altri, in cui Pratici e Contemplativi si fanno lume, si spiegano, si suppongono scambievolmente, ora[209] Dottrina contrapponendo a Dottrina, ed ora professori a professori. E dove fan questo? Dove in primo luogo l’antitesi delle dottrine? Antitesi, io dico, chiarissima nel Talmud Berahot, dove Pratici e Contemplativi scendono a disputare.—E qual’è del disputare l’obbietto? Niente meno che la quistione grandissima che tra essi verteva, voglio dire la eccellenza maggiore di ambo le vite, della vita pratica e della vita contemplativa. Voi comprendete il gran momento di questo trovato. Ma che sarà poi se il nome intenderete dei disputanti, se vi dico, per esempio, che l’avvocato della vita pratica, della vita socievole è Ribbi Ismaele, e se aggiungessi di più che l’apologista della vita contemplativa è R. Simon Ben Iohai? Certo che in questa disputa, in questi nomi vedreste l’impronta del vero.—Certo direste, ma non invano, il Ben Iohai è sempre nelle pagine del Talmud l’infallibile rappresentante della vita, delle dottrine, della società degli Asceti. Certo, direte, che i vincoli che le sua alla scuola stringevan degli Esseni, vincoli dovevano essere forti, numerosi, strettissimi. Ma che? La verità si fa strada da sè, e non fa d’uopo che lasciarla parlare per rimanere convinto. Udiste poc’anzi un cabbalista, un Fariseo, R. Simon Ben Johai, attribuirsi, patrocinare il sistema, la vita, le idee degli Asceti. Udite ora un altro Fariseo, un altro Cabbalista gli stessi principii propugnare e le stesse dottrine: e chi è cotesto? Egli è Ribbi Akiba, il cui nome nei fasti cabbalistici suona non meno celebre del suo celebratissimo discepolo Ribbi Simon Ben Johai. Ma quanto del disputare il campo non si estende! Quanto più ampliata la discussione! Quanto più il tema elevato! Non si tratta già di sapere soltanto se la vita pratica, la pratica sociale debba entrare qual elemento, qual ausiliare alla vita dell’anima; ma si tratta sapere se la pratica in generale, la sociale come[210] la religiosa, la civile come la spirituale, se sottostia, se sovrasti alla vita speculativa, studiosa, contemplativa. Era pur grande consesso cotesto ove siedevano i più illustri tra i Tanaiti, tra le mura di Lydda in Palestina dove il gran tema fu proposto—Qual sia delle due più eccellente, la vita pratica o la vita contemplativa.
Chi sostenne la prima, chi difese la pratica? R. Tryphon. Chi antepose la contemplativa? Voi l’udiste. Egli è R. Akiba, il visitatore del mistico Pardes,[62] il maestro di Ben Iohai, il corifeo del Misticismo. Or che sarà se vedremo la caratteristica del Hasidut apposta a R. Akiba in tre luoghi del Talmud, vale a dire il distintivo e l’appellazione essenica come noi presumiamo? Nel primo (Berahot 27), secondo la lezione di R. Nissim nell’Ammafteah (25. 2), in cui si dice che chiunque vede R. Akiba in sogno aspiri al hasidut. Nel secondo (Sanedrin XI), ove il verso dei salmi: radunatemi i miei pii (hasidai) s’interpreta per R. Akiba e suoi compagni. Il terzo infine ove per significare, come quel Dottore si dilunghi talvolta dalle abituali sue dottrine, si dice: Abbandonò R. Akiba il suo hasidut.
E non sono persino le più minute circostanze che non abbiano in questo racconto il lor valore. Per esempio quel Mesubbin, quello stare a mensa seduti, quello alternare il pane del corpo col pan dello spirito, quel discutere a mensa, quanto non vi riescirebbe prezioso se potessi dir tutto! Se vi dicessi che questo era il costume proprio, proprissimo della società degli Esseni, a quanto ne attestan Filone e Giuseppe; che dico? se vi narrassi come non dissimile procedesse il costume dei Zoaristi i quali per lo più, mentre a mensa sedevano, un testo togliean a interpretare della legge, e il sobrio pane mescevan col più soave dei condimenti, la scienza.[63] Ma di questo più diffusamente a suo luogo. Dovrò io citare[211] dopo questi luminosissimi, esempi per avventura di men rilievo? Dovrò dire di due altri campioni che la pratica o la contemplativa vita tolgono a propugnare nel 4º di Kidusin? Difende la prima R. Meir quando l’obbligo inculca ai genitori d’insegnare al figliuolo un mestiere: propugna l’altra ivi stesso Ribbi Neorai quando dice: Ogni arte rigetto, ogni mestiere, e solo il figlio mio inizierò allo studio. E chi è Ribbi Neorai? singolare a dirsi. Vedeste R. Akiba, vedeste Ben Iohai, ambo Farisei non solo, ambo cabbalisti, farsi organi, farsi rappresentanti delle idee degli Esseni. Vedetene ora un terzo! Poche, forse non altre volte è di questo Dottore menzione tra i Rabbini, tranne questa ed altra fiata nella Misna di Abot. Ma quanto però e come significativamente nelle pagine del Zoar! Ove R. Neorai è uno dei più famosi anacoreti, anzi è quegli stesso che voi, non è molto, udiste rammemorare tra coloro che il Zoar ci narra abitare la solitudine, e solo nelle feste solenni alla città convenire. E quella fiata istessa che n’è parola in Abot, quanto non ha ella la fisonomia e il linguaggio di un Essena! Curioso a dirsi! Niuno, che io mi sappia, lo notò; eppure notabilissime suonano le sue parole. Chiede R. Neorai che muovasi esule lontano per istudiare la legge, e oh meraviglia! nel Zoar è egli stesso Ribbi Neorai che la gran sentenza profferiva che con questa torna a capello, cioè non altrove potersi con frutto meditare la legge se non nell’esilio, se non nella solitudine. È la menzogna, è il caso che ha create siffatte armonie? No, è la verità che solleva un lembo del suo velo, è l’armonia che, tolto l’ostacolo, prorompe sonora fra la Misna e il Zoar, fra tutte e due poi è la società degli Esseni in quella guisa che due stromenti accordati all’unisono, mandano l’un l’altro amica risposta.[64]
Dissi nella passata lezione come non solo le dottrine[212] degli Esseni, ma gli uomini eziandio sono posti nel Talmud talvolta in contrasto; non solo la Pratica e la Contemplazione figurano una a fianco dell’altra, ma i Pratici eziandio, ma i Contemplativi vengono ad un tempo designati, e in bella e parlante antitesi presentatici quasi due ordini diversissimi. E dove? Tempo è che il veggiamo, che il veggiamo in Abot, ove il Bur è detto non potere essere Jèré het (che teme il peccato), nè l’ignorante poter farsi (Hasid). Ma che cosa è Bur? Chiedetelo a tutti gli interpreti, e tutti vi risponderanno concordi, vi diranno che Bur è colui non solo che di ogni scienza procede destituito, ma le attitudini e qualità eziandio non ha dell’uomo civile.—E che cosa si dice del Bur?—Che non sarà Ièré het, che è quanto dire che non sarà non solo negli studi felice, ma nemmeno uomo civile, uomo pratico, uomo socievole. Che cos’è il Am Aarez? Voi l’udiste, egli è l’idiota, egli è l’ignorante. E che cosa non sarà il Am Aarez? Non sarà, dice il Misnico testo, hasid, ch’è quanto dire non sarà uomo studioso, dotto, contemplativo, e ciò che più fa bella l’evidenza di questa chiosa, si è il nome hasid, nome che voi da lungo tempo udiste qual sinonimo di Essena, nome che quello precesse eziandio di Esseni, siccome gravi autori, e tra altri Scaligero, ce lo attestano, e nome infine che quale specialissima designazione di una setta viene ricordato nei Maccabei.[65] Vi par egli che io proceda nel ragionare stringato? Vi par piuttosto che troppo generosa conceda significazione all’appellativo di Ièré het. Vi par egli che non sia ancora troppo la sinonimia dimostrata, colla parte pratica del nostro Istituto? Or bene udite ancora, e continuate poi se vi dà l’animo, a dubitare. Udite pria in Sotà dove tra i mali che la Era, che la venuta precederanno del re Messia, due ceti, due ceti religiosi si ricordano che dal loro antico lustro miseramente decaderanno. E come si chiamano i due ceti? Si chiamano[213] i primi Soferim, e ad essi si attribuisce la scienza che allora sarà invilita vehohmat soferim tisrah. Si chiamano i secondi Ièré het e si dice che allora saranno in obbrobrio. Non vi dice nulla questo nome di Soferim? Eppure i Soferim di Jah bez, i Nazirei chiamati dal Targum Soferim, il vederli procedere qui di conserva coi Ièré het, dovrebbero a creder mio farvi pensare. Ma voi chiedete più, e la verità non dice mai, basta. Havvi nella Misnà (per altri è Barraità) un frammento antico, preziosissimo che sotto il nome corre di R. Pinehas Ben Iair e che si chiama Barraita di R. Pinehas Ben Iair. Si può chiamare in verità la Scala dei santi. È una descrizione dei gradi per cui dalle più infime virtù si può raggiungere le più eccelse, le più trascendenti senza interruzione, senza salto, ma per una transizione naturale, facile, necessaria. Di tutti i gradi di santità ivi notati, che sono assai, due osserviamone tra i più cospicui, i quali sono il Hasidut e l’Irat het, la pietà eroica e il timore del peccato. Qual posto occupano nella scala dei santi, e quale l’una rispetto all’altra? Il loro posto è il massimo, e dopo il culmine della scala che è lo Spirito Santo, io trovo come gradi sottostanti, più alto il Hasidut, la pietà eroica, quindi più basso lo Irat het, il timor del peccato. Ma non solo massimi ambedue, ma ciò che troppo più monta pel caso nostro, sono contigui, l’Irat het timor del peccato precede, il Hasidut vi conduce, vi predispone. Hasidut n’è lo stadio successivo, la fase ultima, conducente, educante al Ruah acodesc, spirito santo. Che cosa si volle dunque per Irat het? Non certo quel timor del peccato, come ognuno intende, ch’è virtù di nome e di fatto puramente negativa, che consiste meglio nello scansare il male, che nello esercitare il bene. E perchè dico questo nostro Irat het virtù non volgare? Per molte ragioni che me lo persuadono. Me lo persuade in primo la sua[214] contiguità al Hasidut, grado se altro fu mai eccellentissimo e che, come udiste, mena direttamente allo spirito santo, Ruah Acodesc. Me lo persuade poi eziandio non solo le virtù che conseguitano, ma le virtù ancora che lo precedono, ma i gradi eziandio inferiori, i quali tutti, troppo, come vedrete, sovrastano al volgare timore, perchè possano di quello meritamente considerarsi preparazione. Precede non solo il Farisato, lo stato dei Farisei, le virtù farisaiche, lo che già accenna, come intendete, a una parentela strettissima tra ambidue; ma il precede anche la anava, come udiste, l’umiltà, sublime se altra fu mai nella gerarchia teologica delle virtù e appo a cui il timor di Dio è chiamato altrove dai Dottori suo vile calzare, achob lesandelà; e il precede insieme anche la santità, siccome del timore del peccato essa pure avviamento e prodromo. Che cosa dunque vuol dir ciò? Vuol dire, se io non erro, che colle parole che teme il peccato intesero i Dottori uno stato morale che generato è pure dal Farisato, e che di gran lunga eccede tutte le virtù sottostanti, la purità, la umiltà, ed anche la santità, e che è affine, e ch’è contiguo, e ch’è conducente al Hasidut cioè a quello stato, a quel grado onde ebbe nome la società degli Esseni Contemplativi negli antichissimi tempi. O io erro, o fatti sono cotesti che altamente depongono in favor mio. Che sarà poi se il nome intenderete dell’autore della Barraità in discorso? Voi vedeste e vedrete costantemente i Dottori più insigni della scuola cabbalistica farsi nelle pagine del Talmud gli oratori, gli avvocati delle idee, delle massime dell’Essenato, vedeste Rabbi Simon Ben Iohai, contro a R. Ismael, Rabbi Akiba contro Ribbi Tryphon, Rabbi Neorai contro R. Meir, e Ben Iohai e Ribbi Akiba e R. Neorai al tempo stesso cabbalisti e rappresentanti e organi dei principi dell’Essenato. Vedetene adesso un altro nell’autor[215] della Barraità. E chi è l’autore della Barraità? Voi l’udiste: è Rabbi Pinehas Ben Iair, non solo il suocero di R. Simon Ben Iohai, non solo veneratissimo nel Talmud, ma quel che più monta, celebratissimo nel Zoar, le cui parole, le cui dottrine sono ivi con venerazione registrate, e le parole e le dottrine sono esse pure della scuola teologico-mistica dei Cabbalisti. E tutto questo a caso? È a caso che di tratto in tratto sorgono nel Talmud due idee parallele, concomitanti, talvolta opposte, antitetiche, ed alle idee corrispondono dei pratici, dei contemplativi? È a caso che gli avvocati della contemplazione nel Talmud sono sempre quegli stessi che più vanno rinomati pel loro ascetismo? È a caso che tutti i loro nomi primeggian nel libro del Zoar? È a caso che niuno al contrario vi figuri dei loro avversari, non Ismael, non Tryphon, non Meir? Io credo che non è caso. Quel che non è certo a caso son le parole che seguono: e chi ne è l’autore? È lo stesso Pinehas Ben Iair. Dal giorno ei dice, che fu il tempio distrutto furono confusi i soci, i fratelli e i liberi e cuoprironsi il capo e decaddero I pratici. Chi sono i soci, i liberi, e chi sono i pratici? Io lo chiesi agli antichi interpreti e quale n’ebbi risposta? Per pratici l’idea vaga generalissima di religiosi; pei soci o pei liberi sensi che, o nulla significano, o se qualcosa significano, giovano non poco al mio assunto. Ma quanto bene nel nostro sistema! Soci (Haberim), sono i Soci i fratelli della società e della Essenica Frateria; i Pratici, sono i Pratici la frazione più urbana, più cittadinesca dell’Essenato. Ma chi sono i liberi. Benè-horin? Ah chi sono i liberi? Ve lo dica per me un’aurea indicazione da Filone serbataci; quando parlando della costituzione degli Esseni narra di quelli che di fresco introdotti nella società, consumavano il noviziato nel servire, nel ministrare ai provetti, ai maggiori.[216][66] E come dice Filone che si chiamavano dagli Esseni, cotesti? Si chiamavano Liberi, sì, si chiamavano Liberi volendo, siccome ei dice, con un nome contraddistinguerli, che ogni carattere servile escludesse dalla loro persona al quale non poco avrìa indotto a credere i riguardanti, l’officio veramente servile in cui ministravano. Ma liberi essi erano, Benè-horin, e dicevansi liberi comecchè umilmente ministrassero a mensa ai veri soci, ai veri fratelli.[67]
Voi vedeste già molte volte ed ora stesso aperta vi fu mostrata la esistenza di Pratici, di Contemplativi in seno ai Dottori. Non mi resta che chiamare la vostra attenzione sopra un altro fatto soltanto, ma cospicuo, ma rilevantissimo fatto; ove non solo questa duplice ramificazione riprodurrassi e più distinta e spiccata; non solo vedremo Esseni Pratici ed Esseni Contemplativi; ma ciò che a dismisura più monta, li vedremo parlare, agire e certi atti caratteristici eseguire che Filone ci narra, propri, particolari agli Esseni. Dissi un fatto perchè invero ambi s’identificano, si confondono, si unificano in un solo fatto, ma per ora sono due, l’uno fornitoci dagli Esseni è narrato da Filone, l’altro fornito dal Farisato è raccontato dalla Misnà. Qual’è il fatto da Filone narrato? È una festa ed una festa da ballo, ma di quelle ch’è capace di dare un Istituto religioso, un sodalizio quale era l’Essenico. Narrarvi per filo e per segno tutte le circostanze di questa festa da Filone descritta, troppo più a lungo ci menerebbe che nol consentan l’ora e le forze. Pure mestieri è che le cose più rilevanti vi sien conte. Festa era questa che celebravano i Terapeuti, in una delle solennità religiose che resta difficile determinare, ma che ogni analogia ci persuaderebbe essere i Tabernacoli. E dove si celebrava cotesta festa? Si celebrava, dice Filone, nell’aula del chiostro che lor serviva di Tempio. Colà si riuniva la numerosa famiglia dei Terapeuti, e indossata[217] ognuno la bianchissima stola, sedeva ad una mensa, donne ed uomini separatamente da ambo i lati, dove tutti prendevano cibi parchissimi, d’onde carne e vino erano assolutamente banditi, ove ministravano quei Liberi di cui vi discorsi, ed ove i sacri ragionamenti allietavano ed istruivano i commensali. Soddisfatto il bisogno del corpo, ognuno levavasi. Il Presidente intonava un Inno alla gloria di Dio composto da esso o da qualcuno dei predecessori, e tutta la compagnia lo cantava con lui, quindi i giovani recavano in mezzo una tavola, per memoria di quella ch’era in Gerosolima nel vestibolo del Tempio; quindi i balli, e al ballo uniti e suoni e canti; e ballo e canto protraevasi insino a giorno. All’alba, tutti come un sol uomo volgevansi al sole nascente, e supplicato da Dio il buon giorno e la luce della verità, ognuno si ritirava nella sua cella ove riprendeva le usate occupazioni. Questa è la festa che narra Filone, e questo è il fatto che vuole essere adesso paragonato alla storia che di una gran festa ci han trasmesso i Rabbini. Qual’è questa festa? Ella è quella che si celebrava, dice la Misnà, (in Succà) nei vespri del primo giorno dei Tabernacoli, e che fama altissima lasciò di sè in tutta la Rabbinica Enciclopedia sotto il nome di Simhat bet Ascioaba e di cui il nostro Simhat Attora non è che pallida copia e debile reminiscenza. Dove si celebrava il Simhat bet Ascioaba? Si celebrava in quella parte del Tempio che si chiamava l’Atrio delle donne perchè alle donne era quello il limite assegnato, che non poteano valicare. In quell’atrio, dice la Misnà, stabilivasi grandissimo ordine, Ticun gadol. Che vuol dire quest’ordine, dice il Talmud? Vuol dire, risponde, che l’atrio stesso in due parti era diviso ove uomini e donne potuto avrebbero assistere alla festa separatamente. Ma quanto splendido non c’è descritto l’apparecchio! specialmente perciò che riguarda i candelabri,[218] i doppieri, i lampadari infiniti che gettavano per ogni parte del Tempio, degli atrî e di tutta la montagna d’intorno, torrenti di luce. Vi basti dire, dice la Misnà, che non v’era casa, non cortile, comecchè distante dal Tempio in Gerosolima, che un raggio non ricevesse della sacra montagna che tutta pareva divampare in un mare di fuoco. Piacerebbevi egli, o miei giovani, che ove conceduto ne fosse l’accesso, quelle aule visitassimo e quegli atrî santissimi? Orsù, entriamo ed osserviamo. Che spettacolo è questo! Non solo la vastissima sala splende per miriadi di luci, non solo un dolce suono mandano i Leviti, oggi in gran completo dalla loro numerosa e svariatissima orchestra, non solo il caro idioma dei sacri libri risuona in bocca agli astanti nelle lodi, negli inni che celebrano all’Altissimo; ma che cos’è quest’agitazione che veggo: sogno io o son desto? È pure un ballo! Un ballo nella casa del Signore! Un ballo che al canto si marita, si marita al suono istesso dei sacri strumenti, dei sacri cantici, e che pare ad un culto rivolto, ad un oggetto pur esso santissimo! Tersicore negli atrî del severo Dio di Solima non avrei pensato io giammai. Eppure è così. E chi sono i danzanti? giovani forse? adolescenti? pensate! Altro che giovani! Ravvisateli bene, sono venerabili aspetti, sono canuti, sono Dottori, sono le stelle più fulgide del Farisato, ogni altro eccettuato, dice Maimonide, sono essi soltanto, essi soli; sono, diciamolo una volta colle parole testuali della Misnà, sono due ordini di Dottori, i Hasidim e i Pratici, sono essi i quali, in uno slancio di gioja celeste, in un’estasi di mistico amore, intrecciano dotte e mistiche danze, raffigurando nelle armoniche cadenze quello che gli antichi tutti vollero raffigurato nelle danze religiose, vuoi l’armonie delle sfere, vuoi l’armonia più segreta dell’animo umano e delle sue facoltà, vuoi insomma qualche altro[219] consimile intendimento, che lungo sarebbe voler constatare. Sì, sono essi, sono i Hasidim, i Contemplativi e gli Anscè Maasè, alla lettera i Pratici, i quali santificavano, riabilitavano nel culto del vero Dio le danze che narrava il Paganesimo dei Dattili, dei Telchini, dei Coribanti, delle Baccanti. Non sappiamo noi da Luciano egual costume appresso ai Greci? Non è il più bel premio di una mente culta e religiosa quello di potere riposare in una uniformità ammirabile tra il mondo Ebraico e il fiore del Paganesimo? Non abbiamo bisogno in mezzo a tante discrepanze, a tanti antagonismi, un po’ di armonia, un po’ di pace tra Ebraismo e Paganesimo che valgano a costatare che ogni filo non era spezzato tra l’uno e l’altro? Oh! come è bello, per tanto, udire Luciano a descriverci le paganiche danze! «La danza di Bacco (ei dice) specialmente nella Jonia e nel Ponto è esercitatissima; e vi ballano persone nobilissime e i principali della città, che lungi d’averne punto rossore, si compiacciono meglio di questo esercizio, che della nobiltà degli uffici e della dignità dei maggiori.» (ed. Capol., vol 3, 206) Non par egli udire l’apologia di David che danza innanzi l’arca, e i Dottori che lo imitano nella festa della Scioaba?[68] Sublime invero, santo Coribante R. Simon Ben Gambliel, il quale, dice il Talmud, quando tripudiava nel tripudio della Scioaba, otto faci teneva in mano e l’una e l’altra successivamente scagliava in aria e tutte in cadenza regolarmente riafferrava, senza che niuno dei moti complicatissimi fallisse il segno. Ma non solo io li veggo con ordinate movenze menare un ballo, ma parole io odo e canti dal labbro loro sgorgare. Che parole son coteste? Porgete l’orecchio e l’eco lontano ne addurrà la Misnà—Dicono i Contemplativi, dicono i Pratici che incanutiti eran nella fede, nello studio—o felice gioventù, che la vecchiezza nostra non fai arrossire! Ma[220] altri pure altra lode proferiscono, e lode diversa—Che lode è questa? Felice vecchiezza, che il fallo emendasti di gioventù.
È questa la festa, e questo il ballo, e queste sono le parole della Scioabà. Qui separate le donne,—qui il tempio convertito in sala da ballo,—qui musica, qui canto, qui ballo e qui infine cantanti e danzanti; chi? I Hasidim e Anscè Maasè, cioè quei due ordini che abbiamo superiormente veduto per altri fatti moltissimi corrispondere al doppio essenico ordine di Pratici e Contemplativi, che da Filone nella succitata descrizione della festa ci vengono nella stessa attitudine raffigurati, nello stesso luogo, allo stesso oggetto, nell’atto istesso di cantare e ballare. Ma quando avviene questa festa? Avviene di notte, avviene durante una festa religiosa, e di notte e durante una festa religiosa quella avveniva da Filone descritta. E quanto dura la festa? Tutta la notte, dice Filone, sino all’alba spuntata; e tutta la notte risponde per la sua, la Misnà; e ne fa fede—non vaga lontana tradizione, ma uno degli assistenti, uno dei santi danzatori, quell’eccellentissimo Dottore che i colleghi soprannominavano grecamente lo Scolastico scolastica deoraità: io vo dire R. Ieosciua Ben Hanania il quale nel Talmud si esprime così: Dice Ribbi Ieosciuah Ben Hanania quando gioivamo nella festa della Scioaba (che sublime mestizia in queste parole. Il tempio non era più!) non vedevamo (traduco a verbo), non vedevamo sonno cogli occhi nostri: e come? La prima ora del giorno pel sacrifizio cotidiano, di là all’orazione mattutina, di là al sacrifizio addizionale, di là all’orazione dei Musafim, di là alle accademie, di là alla mensa festiva, di là ai vespri, di là al sacrifizio vespertino, e di là sino al mattino seguente nei tripudi della Scioabà. Ed anche in questo, voi lo vedete, la festa di Alessandria e[221] quella di Solima procedean conformi. Che facean poi al mattino? Per quei di Alessandria così dice Filone: All’alba tutti volgonsi verso il sole nascente, e pregano Dio che conceda loro una buona giornata e la luce della sua verità. Così gli Alessandrini. Che cosa facean in Solima? La Misnà ce ne ha serbata fedelissima memoria. Al canto del gallo, ella dice, il corno mandava un triplice suono,[69] e così suonando e strepitando, procedeva la comitiva muovendo verso la porta che guarda ad Oriente. Giunti che erano alla porta che guarda ad Oriente, volgeansi tutti da Oriente a Occidente; e così diceano: I padri nostri che vissero in questo luogo volgeano, come dice Ezechiele, il tergo alla casa del Signore e la faccia loro indirizzavano ad Oriente, all’astro del giorno: ma Noi a Jah sono rivolti i nostri occhi; e ripetevan dicendo: Noi a Jah, ed a Jah i nostri occhi.
Che cosa vedete qui? Tutto procedere appunto come tra i Terapeuti procedeva; tranne una cosa, la parte a cui si volgeano. Gli Ebrei, i Dottori, gli Esseni di Palestina, memori della profanazione che i loro proavi fatto avevan del tempio del Signore, l’idolatrico culto introducendovi delle stelle del cielo, memori dell’attitudine che prendevano nell’adorazione del maggiore astro, che Ezechiele descrive e rinfaccia; giunti ch’erano al punto in cui dovevan pregare, prendevano la contraria positura e il tergo volgeano al sole nascente e gli occhi miravano e la persona al Santo dei Santi che la parte più occidentale occupava del santuario. Pegli Ebrei invece, pei Terapeuti Alessandrini avveniva il contrario. Fosse che a guisa di tutti quelli che vivono fuori di Terra Santa, a guisa nostra anch’oggi, si volgessero nel pregare ad Oriente, fosse che inesatta giungesse loro contezza del modo di pregare della Metropoli, fosse eziandio che il lungo soggiorno[222] dello Egitto, la lunga conversazione cogli infedeli, la diuturna separazione dal cuor della fede, facesse prendere al loro culto una tinta d’Idolatria, siccome l’eco ne perdurava e perdura in scrittori gravissimi che l’adorazione del Sole gli attribuiscono; fatto è, che in questo sol punto tra il culto Essenico di Palestina e quello dei Terapeuti d’Egitto tu ravvisi un’antitesi. Del resto, la somiglianza non potrebbe più esser perfetta, e sopratutto non potrebbe più che in questa festa spiccare il doppio ordine di Pratici e Contemplativi che fu mio officio sinora mostrarvi nella storia, nella discussione, negli atti, nel culto, com’ora vedeste degli antichi Dottori.—E quindi sempre più splendida sorgerà quella conclusione che viene dimostrata perpetuamente dalla nostra esposizione; la identità dell’Istituto degli Esseni colla parte più dotta e più santa del Farisato.
[225]
[226]
[227]
[228]
[229]
[230]
[231]
[232]
[233]
[234]
[235]
[236]
LEZIONE DECIMAQUARTA.
Noi dobbiamo oggi proseguire nello studio delle esseniche istituzioni per passare quindi alle dottrine e quindi al culto. Si parli dunque delle Istituzioni, e per procedere con quell’ordine che più io stimo acconcio, cominceremo da onde appunto cominciava l’Essena nell’atto di votarsi alla società, ch’è quanto dire cominceremo dal Noviziato. Ebbero eglino, gli Esseni, un noviziato? Imposero eglino ai nuovi venuti, un tirocinio speciale, una propedeutica religiosa prima di largir loro il nome e le prerogative di socio e fratello? Ebbero eglino un noviziato a guisa di pressochè tutti i religiosi istituti antichi e moderni, a guisa segnatamente del Pitagorico istituto, col quale tanto amava di raffrontarli il nostro Giuseppe? Sì, rispondono le più autorevoli testimonianze, le quali non solo di questo noviziato attestano la esistenza, ma la durata ancora ne ricordano, la divisione, le prove a cui sopponevansi, lo scopo a cui si mirava. Il noviziato durava tre anni, ma questo periodo di anni tre si distingueva in due parti, o per dir meglio abbracciava due gradi che successivamente percorreva lo iniziato. Durava il primo un anno intero, e in quell’anno le virtù che più si volevano splendidamente provate, erano continenza e temperanza, nè per luminosa che[237] ne emergesse la prova, poteva dirsi ancora assolutamente qualificato fratello. La più intima comunanza che conoscessero gli Esseni, la tavola comune, il refettorio, non si asseguiva che dopo altri due anni dl tirocinio più severo. Pria di sedere al fianco a’ fratelli nei sacri agapi intorno al desco venerato, due altri anni dovevano ancora trascorrere dove, come pare probabile, nulla di sè lasciar doveva desiderare il nuovo fratello. A capo di due anni diveniva Essena compito. Noi abbiamo di sopra toccato del noviziato religioso nelle antiche consorterie, noi abbiamo detto come da quelli non differisse il nostro Istituto. Che dico? Noi potevamo farvi toccare con mano non solo i rapporti che da questo lato lo avvicinano ai Pitagorici, ma ad altri infiniti istituti accennare, antichi e moderni. Potevamo dire della iniziazione sacerdotale dello Egitto, del Noviziato tuttavia superstite nel sacerdozio Braminico, ove una rigida preparazione si esige da coloro tra i Brami, che all’amministrazione voglion dedicarsi del sacro culto, e sopratutto avrei potuto additarvi nelle società religiose derivate dal Cristianesimo una immagine fedelissima di quello che tanto tempo innanzi praticavano i nostri Esseni. Ma questi riscontri, comecchè non destituiti di alta e feconda significanza forse più chè non credesi, debbono ad altri cedere il campo che di gran lunga sovrastano e che compiono quanto abbiamo a dire intorno l’essenico noviziato. Io spero che non l’avrete dimenticato. Fu e sarà nostro officio, ad ogni passo che muoviamo nella esposizione della scuola, trarre dalle viscere del subbietto, sempre nuove, sempre maggiori conferme, a quel fatto rilevantissimo che resulta a parer mio dalla più scrupolosa disamina dello Essenato, la identità dell’Essenato medesimo colla parte più dotta e più squisita dei Farisei. Voi lo ricordate; il metodo da noi prescelto a provare siffatta identità[238] fu, se non isbaglio, il più rigoroso. Chiedere al Farisato tutto che di proprio, di organico si trova nell’Essenato, e ove nulla si trovi nel secondo che il primo non contenga, chiarire vera e fondata la propugnata identità. Il noviziato sarà egli occasione di conferma o di dubbio? si trova egli tra i Farisei come la storia ce lo addita in seno agli Esseni? Se non il chiedessimo che alla Bibbia, la Bibbia ce ne offrirebbe un esempio, un tipo parlante nel sacerdozio. Il sacerdozio aveva un noviziato, e se questo noviziato anzichè tre durava invece cinque anni, non cessava per questo di essere vero e proprio noviziato. E d’onde questo noviziato resulta nei libri sacri? Implicitamente dal testo; esplicitamente poi dalla tradizione. Ella è nel testo una di quelle contradizioni che non tollerano conciliazione se non mercè il dettato della tradizione. Sono due testi che sembrano escludersi a vicenda. Per l’uno il sacerdote ministra nei sacri offici all’età di venticinque anni, per l’altro solo ai trenta adempie agli offici del sacerdozio. Che cosa sono questi cinque anni di differenza? Sono, dice la tradizione, il periodo di noviziato. Ma noi dobbiamo chiederlo altresì ai dottori, dobbiamo cogliere nei loro usi, nei loro dettati l’essenico noviziato almeno in germe. Saremo noi tanto felici di rinvenirlo? Io spero che voi non esigerete una perfetta e circostanziata identità. Comprenderete benissimo come una frase, un cenno sia d’immenso rilievo quando si tratta, come in questo caso, di due scuole che non fu mai usato di confrontare, di cui niuno sospettò o almeno asserì non solo la identità ma nemmeno la somiglianza. Ora, io oso dire che questo cenno esiste, ed esiste nel Talmud di Hollin, ove togliendo a ragionare del tempo in cui il discente può veder dei suoi studj profitto alcuno, altri fondandosi sul noviziato sacerdotale, questo tempo pongono dopo anni[239] cinque; altri in più brevi termini restringendolo lo limitano a soli tre; e tre erano, come udiste, gli anni di noviziato prescritti al nuovo Essena.
Ma questi anni vedeste in due periodi partirsi; ed il secondo che dicemmo più lungo, nuova prova e solenne preparazione al cibo comune, al refettorio. Che cosa significa questa speciale importanza alla tavola conceduta? Solo allora la comprenderete quando lo spirito della antichità e lo spirito dei rabbini vi sarà familiare; quando li udirete proclamare la tavola, imagine, ricordo, rappresentanza dello altare di Dio; quando la mensa santificata dalla legge divina li udirete parificare alla mensa dello Eterno, e i commensali qualificare commensali di Dio; quando vedrete queste idee a maggior altezza poggiare per opera e nel sistema dei cabbalisti successori legittimi, a parer mio, dell’antico Essenato. I quali parecchi usi e procedimenti ebbero a mensa che poi vedremo radicarsi negli antichissimi istituti dell’Essenato, e più solenne appalesare fra essi quella identità che è perpetuo subbietto del nostro argomentare. Intenderete allora come supremo onore e grado supremo d’iniziazione fosse tra essi la commensazione in comune, e come niuna prova per essi si trascurasse onde riconoscere se degno fosse l’ospite nuovo di questo onore. Il volevano sapere perchè delle idee partecipavano gli Esseni e dei costumi dei Farisei; perchè i talmudisti, i farisei primo studio ponevano, quando trattavasi di banchettare, nel sapere chi avrebbe a fianco loro seduto a mensa, perchè questa indagine solevano fare immancabile coloro che i talmud designano col nome di Nekiè adaat sce-biruscialaim gli animi delicati di Gerusalemme; perchè i farisei avarissimi erano della loro persona, quando si trattava di porsi a tavola con chi castigatissimi non avesse i costumi e l’animo culto; perchè carattere precipuo si predica nel fariseo, il non prodigarsi[240] in conviti plebei; perchè il farisato irrideva con appellazioni derisorie a quei degeneri dottori che ponevano cattedra nei Prandj e aringo prediletto agognavano le laute imbandigioni perchè li chiama in suon di scherno scaldaforni e leccapignatte.[70]
Nè questi titoli avriano certo convenuto agli austeri membri dell’Essenato. Ma provatane, come dissi, la continenza, trovato degno di sedere alla mensa fraterna, nel novero senza più era introdotto dei fratelli e dei socj. Allora un bel nome lo attendeva ed oh quanto da quelli testè citato diverso! Lo attendeva il nome, il titolo di libero; e perchè? Perchè libero solo allora estimavasi l’uomo che i vincoli più forti avea se non rotti, allentati, che alla terra lo avvincevano; perchè libero si diceva, come disse Platone, eziandio quello soltanto che alla legge subordinava il volere; e forse come altra volta accennai, libero altresì si diceva perchè gli uffici umilissimi in cui i giovani ministravano un carattere a torto lor non annettessero di mercenari o di schiavi. Ma quanto non consuonano coteste idee colle idee dei farisei! La libertà vera riposta nell’affrancamento dello spirito da ogni maniera mondanità, è teoria se altra fu mai farisaica per eccellenza; liberi Benè korim udiste chiamati dai Dottori nel Talmud (Sotà) coloro che a fianco essendo posti dei Kaberim, a ragione, come dissi altra volta, ci rappresentano i giovani Esseni, i neofiti della setta, coloro che Filone espressamente insegna liberi dagli Esseni appellarsi, liberi di quella libertà che i dottori dissero discesa, scolpita sulle tavole della legge; duplice libertà per cui l’uomo e lo spirito si affranca dal giogo di morte, ed il corpo si sottrae alla signoria dei Potenti del Mondo harut mimmalach amavet umiscibud malkijot. Libertà che gli Esseni conseguivano e colla perfezione dello spirito e colla fuga e coll’abbandono[241] del mondo, libertà di cui i dottori favellarono quando dissero che chiunque si toglie il giogo della legge di Dio si affranca al tempo stesso di ogni giogo terreno, delle terrene dominazioni che nulla ponno oggimai su quello che nulla più chiede alla terra, e tra gli uomini vive come se non vivesse; giogo sociale che dissero hol derek erez, in cui i bisogni e la servitù si compendia, che la società impone ai membri suoi e dai quali l’Essena solo poteva dirsi affrancato, e quindi dello Essena soltanto deggiono aver inteso i dottori quando quello dissero andare immune da ogni peso, da ogni legame sociale, ol dereh erez, il quale sobbarcato si sia al giogo della legge di Dio, ch’è quanto dire, siccome io intendo, che abbia, siccome l’Essena faceva, tutto l’esser suo consacrato ad una vita di ritiro, d’abnegazione, di abbandono. Che il sottrarsi ad ogni giogo sociale a niun altro può si bene attagliarsi come all’Essena che fugge il mondo nel silenzio e nella pace del sacro chiostro. Oh quanto bene ancora non si addice al carattere alla storia dell’Essenato quella virile indipendenza da ogni umana podestà, ol malhut! Oh! quanto acconcie non soccorrono all’uopo le parole di Giuseppe lo storico, quando degli Esseni favellando, non rifinisce di esaltare la fortezza dell’animo, la imperturbabile resistenza che seppero ognor contrapporre alle sevizie, alle persecuzioni, ai martirj di Roma imperante! E queste stesse laudazioni di Giuseppe non sono elleno la miglior conferma di quella identità d’Esseni e Farisei ch’è perpetua dimostrazione di queste conferenze? E chi altro se non i Farisei saranno questi audaci sfidatori della romana tirannia? Chi se non quelli che gli annali empierono del giudaismo della eroica loro resistenza, delle lotte incessanti, dei trionfi, dei supplizi più ammirandi delle stesse vittorie,[242] delle morti cento volte più invidiabili della vita più prosperosa? Chi se non i Farisei, chi se non gli stoici di Palestina con cui ama tanto di compararli Giuseppe lo storico, e con cui tanti e sì profondi ci offrono punti di attinenza non meno di questo rilevantissimi, voglio dire il durare impavidi di fronte al fantasma terribile, implacabile, della romana tirannide? E chi tra i Farisei medesimi meglio in sè riproduce la bellissima caratteristica; chi più altiero levossi sulla mala signoria; chi profferiva più terribile sentenza sui vizi del governo imperiale; chi meglio resisteva al prestigio, al bagliore di quella ipocrita civiltà, se non quella parte di Farisei con cui, a parer mio, più specialmente, più intimamente s’identifica il nostro Essenato, ch’è quanto dire la parte teologica, mistica, ascetica del dottorato ebraico? Singolare a dirsi! Il Talmud ci ha conservato un frammento prezioso in cui il carattere e le opinioni politiche si dipingono di tre tra i più grandi dottori in Israele; in cui tu puoi vedere di ognuno il vario sentenziare su quell’impero, che teneva allora il mondo sotto i suoi piedi; in cui ognuno rivela le proprie impressioni tali quali internamente esperimentavali a quello spettacolo di grandezza, di forza, di ricchezza, di lusso, di sapere governativo, di polizia cittadinesca! E chi sono i grandi interlocutori? Sono Rabbi Jeudà soprannominato lo eloquente o meglio il primo tra i parlatori, Ros amedabberim; è l’altro Rabbi Iosè; ed il terzo è R. Simon Ben Iokai. Favellavano essi dell’impero romano, delle sue leggi, dei suoi usi, della sua civiltà. Sorge R. Jeudà ed esclama: Oh quanto sono belle le opere di questo popolo! Quanto senno nel governare i sudditi! Quanta cura del loro ben essere! Qui aprono strade che la città in se stessa e le città le une alle altre e tutto l’impero congiungano fra le sue parti; qui a valicare fiumi erigono[243] ponti; qui di ogni maniera comodità arricchiscono il paese, e bagni e teatri e passeggi aprendo a ristoro, a vaghezza, a diporto degli abitanti. Il cuore di R. Jeudà era ebreo; chi ne dubita? Ma la mente sua non poteva non ossequiare quel prodigio di arte, di grandezza che l’impero ostentava agli occhi dei popoli vinti. Alla generosa apologia tace R. Iosè, ma Simone favella, anzi Simone rugge, Simone tuona e come terribilmente! Sì; elevano costoro ponti ma per preporvi commissari all’esazione dei pedaggi! Sì; aprirono strade, ma per gettarsi come torrenti sul mondo intiero. Sì; schiusero vie, ma per alloggiarvi i loro agenti, i loro proconsoli, le loro meretrici. Sì; aprirono bagni, teatri, passeggi, ma per snervarvi i popoli colle blandizie, e per conchiudere colle parole del testo, tutto che fecero, a pro di sè operarono. Ma Roma era tutta in orecchi, e in ogni angolo, in ogni città, in ogni ritrovo protendeva la rete del suo spionaggio.—Insieme ai tre dottori eravi un quarto, e questo quarto era Ebreo, e questo quarto era il delatore di Roma. Roma seppe poco stante ogni cosa, seppe la lode, il silenzio, la invettiva, e Roma di li a breve sentenziò: Giuda che esaltò sia esaltato, Jeudá sceillá itallé; Iosè che tacque, tragga in esilio, ighlé lezzipori; Simone che sparlò, perda la vita. Narrarvi le cose che seguirono, la fuga di Simone, la caverna, gli studi e probabilmente la coordinazione delle sue dottrine; non è di questa conferenza l’officio. Ma che animo, che mente, che cuore, che indipendenza di spirito! E che riscontro mirabilissimo colla nota caratteristica che Giuseppe attribuisce agli Esseni! L’indipendenza di Simone lo condusse se non al supplizio estremo, a vita peggiore che morte per tutt’altri che lui; ma qual conforto! Nella sua solitudine ei poteva dire a sè stesso: quando i secoli avranno delle cose presenti abolita ogni traccia, Roma non sarà più;[244] ed uno dei miei più tardi discepoli narrerà ai fratelli ammirati le mie prove, i miei dolori, il mio coraggio, la mia gloria. Questo discepolo non oso dire chi sia, ma questi fratelli siamo noi, siete voi stessi.[71]
LEZIONE DECIMAQUINTA.
Noi abbiam detto nella passata lezione, come il noviziato degli Esseni constasse di due parti o periodi che dir vogliamo, e come secondo fosse quello che preceder soleva l’ammissione al refettorio. Noi abbiamo così conosciuto la durata, la gradazione del noviziato; ne abbiamo, a così dire, veduta sinora la parte esteriore. Mestieri è che meglio in esso ci addentriamo a scuoprirne la verace natura; mestieri che il valore, la guarentigia morale ne sindachiamo; mestieri che al fatto più cospicuo assistiamo che la intima essenza costituiva del noviziato. Qual’è questo fatto, qual’è l’atto più solenne a cui il nuovo Essena era chiamato a adempiere? Egli era in una parola, un giuramento. Non so se io vada errato, ma il giuramento per se stesso, la sua formula avventurosamente conservataci per intero, le parti tutte di cui è composto, la precisa e minuta descrizione di tutti gli obblighi che il Neofita si assume, la viva dipintura che vi si asconde della vita e del genio dell’Essenato, il suo carattere insomma, di sommario, di catechismo, di compendio di tutte le esseniche istituzioni ne fanno, se io non erro, un documento unico nel suo genere e di una tale significanza che vano sarebbe il disconoscere. Potremo noi a tanto trovato rimanerci indifferenti?[248] Potremo non istudiarne a parte a parte gli articoli di cui è composto? Potremo noi non rimirare quasi in vivo speglio la società degli Esseni nell’atto più espressivo e più compendioso della vita sociale, e come a dire nel suo credo, nel suo atto di fede, nel suo programma? Ecco perchè ho meco stesso deliberato, a costo ancora di mandare più che non volessi per le lunghe il nostro corso, esaminare partitamente il giuramento in discorso; ecco perchè senza por tempo in mezzo mi accingo a dirittura al lavoro. Ma prima siamo con noi medesimi conseguenti. Noi vogliamo, non è egli vero, gli Esseni per nulla diversi, anzi identici assolutamente a quel farisato in cui si contengono come parte nel tutto? Ora se questa identità non è menzognera, non solo i Farisei avranno pure essi un noviziato, e ciò vi fu (cred’io) abbastanza dimostrato, ma avranno ancora, lo che più monta, l’equivalente della essenica iniziazione; avranno un atto per cui noverati venivano nel bel numero, per cui al patto sociale, ai suoi doveri, ai suoi dettati promettevano leale osservanza. Eravi nulla di questo in seno al farisato? Se vi era! Basta gettare ancorchè superficiale uno sguardo sulle pagine talmudiche per convincersene immantinente. Basta aver udito a parlare dei Dibrè habrut, e della iniziazione a questa consorteria chiamata cabalat dibrè habrut, l’assunzione, l’accettazione dei doveri sociali. È vero che la memoria che ne serbò il Talmud va quasi sempre improntata di quel carattere pratico, esecutivo, rituale, ch’è genio specifico di quasi tutto il Talmud; è vero che non conosciamo siffatta consorteria che dal lato suo positivo cerimoniale; è vero che la parte organica, ideale, dottrinale di questo habrut, è rimasta nel Talmud ricoperta da densissimo velo; ma quante d’altra parte non ci offre col nostro Essenato parlantissime analogie! Basti accennarvene le più cospicue, intorno[249] alle quali mi abbisognerebbe dettare un trattato per esaurir tutta quanta la vastissima materia. Vi basti in primo luogo che le più ovvie resultanze delle memorie talmudiche altamente ci attestano come nel mentre che cotesti haberim o soci si radicavano profondamente in seno ai Farisei, e da essi, vita, dottrine, soci, indirizzo e tutto accogliessero onninamente, cionnonostante del farisato medesimo formassero quasi elettissima schiera, ed a certi doveri e pratiche gissero sottoposti a cui sottoposti non erano il comune dei Farisei. Testimone quel rilevantissimo passo della Misnà ove a chiare note si distingue il semplice Fariseo, il semplice Talmid haham, da quello che ivi stesso si noma Haber; e le norme ivi stesso si dettano e le regole che dovranno all’ammissione presiedere dello stesso Talmid haham, prova se altra fu mai irrecusabile, a parer mio, come a senso della Misnà Talmid-Haham e Haber non sono sinonimi; ma il primo di semplice Fariseo alla più elevata condizione può trapassare di Haber, e come io intendo di Essena di Terapeuta. Curiosissima indagine sarebbe, tutte le parti della rabbinica enciclopedia perscrutare ove dei Haberim è menzione, ove questa società innominata, indeterminata, ha lasciato di sè traccie sensibili. Vedreste in primo affaticarsi i tardi comentatori come il Maimonide a giustificare l’appellazione di Haber ai Farisei conceduta, e ragioni così esigue, sì aeree allegare che dopo il pasto hai più fame che pria. Siccome quella V. G. che il Maimodine proponeva non per altro, dicendo, chiamarsi i dottori Haberim o soci se non per che fida e durevol società è la loro, quasichè non resultasse da tutto il Talmud lo speciale e superlativo indirizzo dei Haberim; e quasi infine generale denominazione fosse cotesta dei Farisei, e non piuttosto ad una parte di essi peculiarissima, siccome ho abbastanza, se non erro, provato. Vedreste[250] poi la memoria dei Haberim tornar frequente e rinomata nelle pagine del Talmud, li vedreste nel trattato Niddà, comechè fosse da lungo tempo il sacrifizio abolito, nelle antiche lustrali aspersioni perseverare colle ceneri della vacca rossa. I Haberim, dice il Talmud, tuttora aspergono di acque lustrali in Galilea. Vedreste dottori contraddistinguersi con questi nomi e intitolarsi come dai Haberim Zeirà demin Habrajà. Vedreste in altri luoghi i dottori dirsi in generale Haberim, non perchè tutti lo fossero attualmente, ma perchè tutti erano capaci di divenirlo. «Haberim Machscibim elu Talmidim scemachscibim zè lazè baalakà» Vedresti nel trattato Sciabuot, cap. 4, i dottori l’un l’altro scrivendosi, col noto nome appellarsi di Haber e con quello diverso sì, ma equivalente, di Amit. Vedreste due fatti che più davvicino ci accostano alla consorteria degli Esseni: in primo luogo nel Talmud quelle larve, quei fantasmi che in sembianza umana era dato di suscitare apertamente dirsi fattura dei Haberim, lo che a dirittura ne mena il pensiero al carattere ascetico taumaturgico del nostro istituto. Vedreste poi non più nel Talmud, ma lo che è più, lo che è tutto nella nostra disquisizione, vedreste nel Zoar, che è quanto dire nell’Emporio del cabbalismo, un fatto semplicissimo ma d’una immensa rilevanza a parer mio, ed è questo: che la sola, la comune, la indistinta denominazione che tutti recano i dottori cabbalisti, quella e non altra si è di Haberim, o come in dialetto arameo ivi costantemente si legge, Habrajà.
Io non so se mi faccio illusione, ma più che non fôra mestieri parmi aver argomenti accumulato a provare l’esistenza di un legame, di un vincolo sociale in seno al farisato. Lo prova il carattere e il nome tanto significantemente ripetuto di Haber, lo prova di più l’atto di ammissione di iniziazione, che i libri rabbinici chiamano,[251] come vi dissi, cabbalat dibrè Habrut e di cui le norme, le forme tutte sono prescritte nella Misnà e nel Talmud.
Abbiamo perciò esaurito quanto di più concludente ci offrono gli antichi rabbinici monumenti? Oso dire che rispetto alle cose che intenderete, poco parrarvi l’udito sin ora. Io vi dissi, e non è molto, che sino quasi ai nostri tempi non si credeva in generale che le opere rabbiniche dei primi secoli dell’Era volgare niuna traccia contenessero di Esseni e di Essenato. Oggi però si comincia a sospettare il contrario e non poco studio si rivolge a quante vestigia per avventura ne conservano i libri talmudici. Io credo aver posto la mano su tale memoria che mentre attesta come vedrete la identità degli Esseni e dei Haberim, ci fa udire forse per la prima volta sul labbro ai dottori vivo e parlante il nome di Essena, ed in circostanze e ad uno intendimento siffatto che il valore ne accrescono a mille doppi. Giudicatene voi stessi. Narra il Talmud gerosolimitano come un Assià (alla lettera medico o terapeuta) chiedesse ad un dottore la comunicazione del nome di Dio, come questi lo interrogasse se mai avvenuto gli fosse di profittare degli averi altrui, come a ciò replicasse l’Asseo dicendo essere uso cibarsi della decima che si prelevava sulle derrate, e come infine concludesse il dottore dicendo: non potersi comunicare il santo nome di Dio a chi riceva d’altri qualsiasi cosa in dono. Quanti dubbi, quante domande non provoca il frammento citato! Chi è questo medico o Terapeuta così voglioso di conoscere addentro i nomi di Dio quasi fossero aforismi ipocratici? Che è questo inaudito cibarsi della decima in chi non appartiene alla tribù di Levi? Che cosa significa questa condizione posta alla desiderata comunicazione—il nulla ricevere in dono? Ma quanto bene, se si accettano le nostre premesse! Avremmo[252] allora nell’Assià del Talmud il vero e proprio nome dei nostri Esseni; nella sua domanda, una domanda che nulla più confacente ad uomini che studiavano le arcane cose contenute nella legge di Dio, e sopratutto i nomi divini, i nomi degli angioli che apertamente impromettono di gelosamente custodire nel loro giuramento d’amissione, e tanto più a costoro conveniente s’egli è vero ciò che noi reputiamo verissimo, che non altro fossero gli Esseni che gli antenati dei cabbalisti ai quali mirabilmente si acconciano siffatte speculazioni. Ma che cosa, direte, è la decima di cui si cibano? Ovvio lo intenderla purchè vi piaccia con me convenire che non altro sono gli Esseni, non altro quindi il nostro Assè o Assià del Talmud, che i Haberim o soci talmudici, gli uomini delle raffinate purità. Perciocchè di questi si legge nello stesso Talmud di Gerosolima (Sota cap. 9) che della decima si cibavano al pari dei poveri e dei leviti.
Non solo: ma il nome di Haberim soci è dato dallo stesso Talmud (Nedarim VI) a quei Harasc e Masgher (alla lettera falegnami e fabbriferrai) che si narra nei Re essere stati trasferiti in numero di mille per ordine del vincitore da Gerusalemme a Babilonia. E finalmente un visitatore d’infermi, anzi un loro assistente, era detto nel Medrasc (Berescit Rabbà sez. XIII) appartenente al ceto dei Haberim; senza dire di altri luoghi moltissimi in cui tal nome ritorna; segnatamente nel Talmud già citato (Ghittim Iº) ove i Haberim o soci si fanno interpreti delle dottrine di R. Jeosciuah Ben Levi, uno dei dottori i più manifestamente cabbalisti di tutto il Talmud.
Io dissi non ha guari come il carattere di questa iniziazione talmudica partecipi in grado eminente del carattere generale del Talmud, che mira unicamente ad un complesso di osservanze più minute, più rigorose, alla costituzione di una frateria vivente con regole più severe[253] di purità religiosa; dissi in fine che la iniziazione onde è discorso non si mostra nei libri talmudici, che dal lato suo rituale e positivo, per la semplicissima ragione che il lato rituale e positivo è quello che universalmente primeggia nelle pagine talmudiche. Quindi è, che solo brevi fugacissimi lampi ci è dato vedere per entro al Talmud della interiorità, del midollo del lato ideale dottrinale dogmatico, dell’istituto medesimo e sotto l’opaco velo talvolta adombrato dell’essoterismo dei riti. Egli è per questo che dovremo credere null’altro esser i Haberim del Talmud che uomini più gelosi degli altri del governo del corpo, dei reciproci contatti, del lecito e dell’illecito? Io credo che la conclusione sarebbe assurda in principio ed assurda in fatto, e come oggi si dice a priori ed a posteriori. Perchè dico assurda in principio? Perchè egli è contro ogni sana induzione il supporre un’organizzazione, vuoi sociale, vuoi religiosa, un complesso di pratiche, una regola di azioni senza alcuni grandi principî che siano di quell’organismo la vita, l’anima, il pensiero, il genio supremo; perchè non appena mi vien fatto di udire il verbo dell’uomo, di assistere all’esercizio ragionevole dei membri suoi, di udirlo parlare, muoversi, agire, io sono senz’altro e per questo solo criterio fondatissimamente autorizzato a supporre in lui comechè invisibile, un principio ragionevole che le azioni ne governi, un complesso di idee di pensieri che sieno come le molle dell’azione che mi si spiega dinnanzi, in una parola l’anima di quel corpo. Ho detto che sarebbe anche un errore di fatto. Perchè s’egli è vero, come ho già detto, che l’elemento dottrinale del talmudico Haberut sia in gran parte invisibile, non è sì che altri monumenti, altri attestati, altre sorgenti non soccorrano all’uopo; non suppliscano a quanto ha di manchevole la storia talmudica del haberut; non completino di esso la verace fisonomia e quella non[254] restituiscangli che nei libri talmudici fu unicamente abbozzata. E dove si trova questo? Lo si trova ove deve naturalmente, ove non potrebbe a meno di trovarsi: nel libro del Zoar: che è quanto dire in quel libro che adempie verso le dottrine, il dogma, la teologia, l’acroamatismo, quell’ufficio medesimo che il Talmud verso la pratica, il rito, l’essoterismo.[72] Per modo che il Zoar e il Talmud ci forniscono per parte loro una metà per ognuno della fisonomia del Haberut, e quella appunto che alla indole speciale si attiene di ognuno: le quali parti poi insieme combinate non solo bellamente si connettono, si completano, si integrano, prova se altra fu mai della loro intima originaria unità, ma ci danno ancora il vero e fedele ritratto che andiamo cercando. Che voglio dire pertanto? Voglio dire che il Zoar ci offre la iniziazione al Habrut da quel lato che manca precisamente nel talmud dal lato dogmatico, voglio dire che il Zoar contiene per gran ventura pochi, ma preziosissimi fatti, in cui la iniziazione di cui si parla assume il colore proprio al genio dell’opera; e più palesi ne rivela le armonie coll’istituto che studiamo colla società degli Esseni.[73] Io lo credo fermamente. Percorrendo con occhio diligente le pagine del Zoar, parecchie altre non meno gravi dimostrazioni, non meno appropriati esempj si potrebbe scuoprire. Ma chi potrebbe a tanta opra non venir meno? Io non pretendo aver ogni ricerca esaurita; e pure due grandi esempi mi fu dato trovare, due grandi scene di cabbalistica iniziazione, due ritratti parlanti dello Epopsi essenico-cabbalistico, l’ultimo specialmente che per la maestà e stupenda semplicità vince ogni credere. E il primo al vol. 2º p. decimoquarta, ove tu vedi il maggiore dei Hyà, Rabbi Hyà Rabbà, tutte subir le prove, le esitanze, le trepidazioni; e infine il premio dei nuovi iniziati; ove lo vedi soffermarsi alla porta del capo-scuola[255] e per parlare il linguaggio dei misteri, del Jerofante; qui naturalmente non altri che R. Simhon ben Johai ove una cortina il divide dal seggio e dalla scuola venerata, ove ode la voce delle sacre dottrine e vaghezza il prende di penetrare, ove l’esitazione s’impadronisce dello stesso ben Iohai non sapendo se degno sia il nuovo venuto di partecipare ai santi misteri, ove tu vedi il figlio suo R. Eleazar profferirsi di fare da Epopta, da introduttore al dotto straniero, dovesse ancora, siccome testualmente si legge, restarne incenerito; ove una voce si dice allora essersi udita la quale con parole che tuttavia riescon dure ad intendersi, sembra volere il soverchio zelo affrenare del giovane dottore; ove lo straniero rinnuova il pianto e le suppliche; ove aperta infine la cortina, si rimane nonostante lo straniero esitabondo non osando penetrare; ove infine levatosi R. Simone, egli stesso introducelo, e vedendo il nuovo iniziato gli occhi tenere sommessi e il capo chino per timidezza soverchia, ordina al figlio suo, udite singolarità! di fare a R. Hyà quell’atto così celebre, così comune a tutte le società che vivono di segreto, voglio dire, la chiusura e l’aperizione della bocca.
Ma quanto il secondo sovrasta d’incomparabile maestà! Egli appartiene a uno di quei due antichissimi frammenti la cui autenticità l’ossequio ebbe eziandio di coloro che più dubitosi procedevano intorno all’opera in generale; e che sotto il nome sono conosciuti di due Iddarot.[74] È in quella che il titolo riceve di maggiore, che il venerato maestro R. Simone intendendo i più sublimi misteri ai discepoli rivelare, è sovrappreso dapprincipio da cruda perplessità; non sa se parlare o tacersi; chiede una parola che a dire lo conforti; e questa parola si fa finalmente sentire. Egli è R. Abbà il futuro scriba e compilatore del Zoar[75] che supplicante[256] gli dice: Deh! o maestro, ti piaccia liberamente favellare perciocchè si trova scritto: «I misteri del Signore sono per coloro che lo temono» e cotesti fratelli tutti timorosi sono di Dio; e in altri augusti consessi sedettero e felicemente ne uscirono. Sedette R. Simone e pianse. Quindi sclamò: Guai se svelo e guai se mi taccio! I soci che si trovavano là si tacquero. Ma sorse R. Abbà e disse: «Piaccia a te, o maestro, di svelarci i misteri, perciocchè dice la scrittura: il mistero di Dio è per chi lo teme. Ora questi nostri compagni tutti temono Iddio e già furono introdotti nella camera del tabernacolo.» Allora dopo avere tutti gli assistenti passati in rassegna, tutti in circolo si posero intorno al maestro. Le mani loro ei raccolse e fra le sue le strinse, e poi quasi in atto di giuramento tutti levaronle al cielo, il cielo chiamando a testimone della sete che tutti consumava per la parola di Dio. Quindi, dice il Zoar, trassero ai campi la prediletta dimora, e là, dice il testo, all’ombra degli alberi sedettero tutti; e il venerato maestro dopo avere in piedi orato, sedette pur esso. Ma egli è qui dove si vede quel riscontro che io dapprincipio avvertiva tra il giuro degli Esseni e il sacramento dei cabbalisti. Perciocchè, dice il Zoar, non appena seduti impose loro il maestro che le mani di nuovo ognuno fra le sue ponesse,[76] sul suo petto come legge un testo, sul proprio cuore dei giuranti come legge un altro; e dopo aver tutte in un fascio strette le mani ai discepoli, terribilmente prorompe con quella spaventosa imprecazione con cui i leviti sulla montagna di Ebal dovevano la vendetta di Dio invocare sul capo degli Idolatri, e maledetto con essi ci grida colui che immagine o scultura facesse opera di arte e tenesse celata; volendo con questo premunire i discepoli contro ogni arbitraria e personale intrusione di umani opinamenti, di umane innovazioni nel giro del[257] misterioso insegnamento: prova tra mille come da ogni straniera importazione profondamente abborrissero i Patriarchi del cabbalismo, e come stranamente vadano errati coloro che la origine del cabbalismo ripongono nelle anteriori e contemporanee scuole di filosofia orientale.
Ma la fedeltà non è unico dovere che il maestro imponga ai discepoli: egli ricorda loro immantinente come la riserva, il segreto comandato dalla legge nelle cose del mondo, nelle cordiali espansioni dell’amico che il cuore ci apre; a mille doppi allora più doveroso che Dio stesso ci apre, a così dire, la mente sua sacrosanta, ci inizia ai suoi misteri, ci fa copia dei suoi segreti, i quali voglionsi con quella gelosia custodire che basti agli sguardi sottrarli dei curiosi, degli indegni e dei profani. Quante cose egualmente preziose contenute in questo mirabile esordio! Quale inesausta miniera di peregrine indicazioni! Oltre la maestà del quadro, e a tutto dire il pregio estetico di questo prologo sublime, innanzi a cui impallidiscono le più vivide gemme della classica antichità; quanti bellissimi documenti per noi per la società degli Esseni, per la identità da noi propugnata! Prima di tutto il giuramento; tema della presente lezione, il giuramento che chiaro spicca e luminoso dal fondo del quadro. E poi quante conferme, quanta maniera di prove, quante nuove e minute attenenze! Il grado più eccelso della iniziazione cabbalistica, il nome di soci, di fratelli così parlante, così chiaramente alludente ad una consorteria, ad un legame sociale. L’amore dei campi e degli alberi ombrosi, il mistero comandato, l’orrore delle innovazioni così proprio, come vedremo, agli Esseni medesimi; e finalmente quella attitudine con cui si dipingono colla mano sul petto. Verrà tempo, quando parleremo del culto e delle pratiche[258] degli Esseni, che la storia antica, ignara assolutamente del Zoar e delle sue dipinture, ci parlerà di una attitudine curiosa inesplicata che soleano prender gli Esseni, una mano lasciando andare sul fianco, l’altra al cuore premendo, allora il ravvicinamento fra il Zoar e la vita degli Esseni si farà spontaneamente, naturalmente nell’animo vostro; si farà senza neppure che a così fare siate guidati per mano, ed allora crederete anche voi alla identità delle due scuole.
«A guisa del ver primo che l’uom crede»
LEZIONE DECIMASESTA.
Noi abbiamo nelle passate conferenze accennato all’Essenico giuramento. Dobbiamo adesso questo giuramento osservare più da vicino; dobbiamo brano a brano sottoporlo a disamina; dobbiamo al tempo stesso a quell’ufficio comparativo adempire che imprendemmo a principio, rilevarne cioè le idee, gli obblighi in seno al Farisato nei suoi volumi, nei suoi dottori, onde quella identità emerga sempre più luminosa che fu nobilissimo compito di queste lezioni.
Principalmente dicono le istorie: giurava il nuovo Essena Adorare e onorare Iddio, e giustizia e carità serbare alle sue creature.
Parvi egli sterile insegnamento cotesto?
Parvi egli che queste idee a prima vista sì ovvie, sì comunali, così oggi universalmente consentite—non offrano per nulla argomento alla critica ed alla istoria? Così veramente sarebbe se le glorie nostre, le nostre dottrine fossero state sempre nostre credute, se niuno avesse preteso redare l’unico retaggio glorioso che i padri nostri ci trasmisero, il maestrato di Religione; se il primato niuno ci avesse conteso nella proclamazione delle più sacrosante verità religiose e morali; se quando lo Evangelo insegnava Ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo[262] tuo come te stesso, ognuno applaudendo alla santità della massima, all’eco fedele della ebraica morale, non si fosse l’ebraismo fraudato della legittima priorità che gli spetta; se si fosse ognuno di Mosè ricordato quando l’amore prescrive di Dio al disopra di ogni cosa terrena più degli averi, più degli affetti, più della anima nostra; quando imprecando alle vendette private prescrive l’amore del prossimo come se stesso, fosse pur egli nemico nostro, siccome manifesto appare dal contesto; se rammentato avesse Illel, lo stipite glorioso del Dottorato palestinese; quando al gentile che anelava alla cognizione della legge—Ama, gli rispondeva, il prossimo tuo come te stesso. Ecco tutta la legge. Il resto n’è la chiosa; di Rabbi Hachibà quando insegnava: Ama il prossimo tuo come te stesso; ecco della legge l’assioma supremo «Ze Kelal Gadol battorà» di Ben Azzai quando riponeva cotesto assioma nel dettato mosaico: Ama il Signore Iddio tuo come tutto il tuo cuore, l’altro elemento in tal guisa fornendo della morale evangelica. Se infine, per tornare agli Esseni, obliato non si fosse il giuramento che tra essi il novizio prestava ove la morale evangelica costituisce il prodromo, la base dell’Etica degli Esseni.—Proseguiamo l’esame intrapreso. Essi giuravano dopo le cose anzidette di non nuocere a chicchessia, sia per propria volontà, sia per dovere di ubbidienza, e noi vedremo in seguito, quanto fedelmente osservassero gli Esseni gli obblighi assunti, vedremo quant’oltre spingessero l’orrore del nuocere altrui sino al punto d’interdirsi il maneggio e la fabbricazione delle armi da guerra; sino al punto di non offrire ad altri ne manco indirettamente i mezzi di distruzione; e nuova e inaspettata armonia allora sorger vedremo tra Esseni e Farisei. Per ora una idea, una parola sorge degnissima di nota nel paragrafo ricordato.[263] Voi l’udiste, il dovere dell’ubbidienza. Come intendevano gli Esseni il dovere dell’ubbidienza? In quella guisa appunto che i Farisei. L’obbedienza non cieca, non gesuitica, non assoluta, non la teoria assurda, immorale, che annulla l’arbitrio, la libertà, la responsabilità umana sotto il giogo macchinale inintelligente di una autorità collettiva. L’obbedienza sino all’ara, sino al dovere, sino al santuario della coscienza e come dicevano gli antichi Usque ad aram. Obbedienza ove cose non s’impongano contro la voce di Dio e della coscienza En scialiah lidbar aberà. Obbedienza che al suddito, alla creatura non conceda quel primato che si deve al Creatore Dibré arab vedibré attalmid, dibré mi sciomein? Obbedienza che ha un limite insuperabile nella nozione chiara del dovere che favella alla coscienza; tanto, che ove il sommo magistrato della nazione imponga l’esecuzione di cosa che osti direttamente ai principj ricevuti, la rivolta, la disubbidienza, non solo è chiarita giusta e legittima, ma pur anche doverosa, Bet din scesciaghegù veorù laakor guf migufé torà veasa akaal al piem, bet din peturem, vehol ehad veehad haiabim. Obbedienza che non solo la conformità per tal guisa ci manifesta tra Farisei ed Esseni, ma quella non meno tra ambedue e i Pitagorici; dei quali dopo aver alquanto discorso l’illustre Gioberti nella Protologìa, così seguitava dicendo:—Ciò basta a mostrare, che intento del pitagorismo non era di spegnere e snervare il genio individuale nazionale e le virtù native dei soci, ma di avvalorarle, che l’individuo non ci era soggetto a una obbedienza cieca, nè immolato a una falsa unità innaturale, e che insomma la compagnia di Pitagora non era come quella di Gesù. Obbedienza infine che svela quanto erroneamente si vada del continuo identificando spirito farisaico e spirito gesuitico, quasi due aspetti di[264] un sol tutto, mentre nulla havvi, a mirar bene, di più ostile, di più repugnante.
Giuravano poi di serbar la fede ai magistrati, ai rettori dello Stato, conciossiachè senza la volontà di Dio stimavano non fosse stabilita la loro potestà. Che cosa s’intende per Maggiori, per Magistrati e per Rettori? S’intenderà forse pegli Esseni, i principi e dominatori stranieri che Dio prepose al governo di Palestina; dei principi tra cui gli Ebrei emigrarono dopo la distruzione del Tempio? Io non saprei categoricamente rispondere: ma se pure così s’intendeva, ella non è la prescrizione degli Esseni senza precedenti, senza esempj grandi autorevoli nella ebraica antichità. Non lo è nei profeti, dove Geremia il popol suo premunisce contro la disperazione, la irritazione e le tentazioni vane perigliose dello esilio, siccome quello che voluto e preordinato era da Dio pietosissimo alle mire ultime e adorabili della sua provvidenza, dove li esorta di cercare nella salute del popolo, tra cui emigrarono, la propria salute, nel suo bene il proprio bene, e una seconda patria riconoscere ovunque li balestrasse fortuna, preludendo con questo consiglio a quel genio cosmopolitico che i padri nostri spiegarono nella loro dispersione; genio e fattezze assumendo secondo lo speciale asilo in cui ripararono senza pregiudicare però all’intima propria speciale caratteristica di ebreo; e con maraviglioso magistero in uno accoppiando e il cosmopolitismo più generale e il più stretto e rigido particolarismo di nazione e di fede. Non lo è in secondo luogo nei dottori fedeli in tutto e continuatori legittimi dei profeti loro predecessorj, quando sotto il flagello eziandio della spietata dominazione romana ammonivano i fratelli a pregarne da Dio la salute, la conservazione per quella ragione grande, filosofica, umanitaria, che sotto alla più orribile tirannide vede[265] sempre la fautrice dell’umano e civile consorzio, l’ultimo vincolo della società perigliante, e che ogni più barbaro reggimento preferisce alla sociale dissoluzione e alla vita ferina e eslege delle genti selvagge.—Raro esempio di meravigliosa abnegazione e di stupenda imparzialità di giudizio che fa tacere i più legittimi nazionali risentimenti di fronte all’ultimo e supremo bene della società in pericolo, quando nel Medrasc Coelet in nome di Dio scongiuravano i fratelli a tollerare pazientemente i decreti, fossero pure dei più acerbi che loro imponessero i nuovi padroni, che non ne scuotessero insofferenti il giogo comunque durissimo.—Che se poi per l’autorità a cui giuravasi dagli Esseni obbedienza, vorremo piuttosto intendere l’autorità religiosa, i maggiori, gli anziani, i principi della Scuola, e’ non sarà senza grave autorità fra gli antichi che a così intendere ci ammonisce. Io vo’ dire di Filone; il quale parlando del giuramento essenico, lo spiega appunto in quel senso che non ha guari udiste, che è quanto dire degli anziani, dei dottori, dei sacerdoti, ed al voto dei più tra i soci, tra i riuniti fratelli. In questo senso sarà egli mestieri cercarne esempj precedenti, similitudini nelle dottrine, nei fatti della storia dell’Ebraismo? Io oso dire che nulla havvi di più naturale, di più proprio, di più speciale nell’Ebraismo, non solo dell’ossequio, della riverenza dovuta ai grandi, ai dotti, ai magistrati della nazione; ma quello che più amo farvi notare perchè men conosciuto, si è l’ossequio, si è la deferenza all’opinione comechè dalle proprie, dalle comuni differenti. Testimone R. Josè che, interrogato come avesse da Dio meritato di vivere così longevo, rispose tra le altre cose di non aver mai preso a vile i dettami dei suoi colleghi comunque dal parer suo differissero; che così oltre ei spingeva l’ossequio, al parere altrui, che non ostante destituito ei fosse di carattere sacerdotale, esercitato nonostante[266] ne avrebbe i pubblici offici, quando così fosse piaciuto ai colleghi. Testimone R. Achibà, quando sostenuto da lungo tempo in prigione, e vedendosi venire allo stremo quel poco d’acqua che giornalmente gli si forniva, preferì piuttosto impiegarla all’abluzione delle mani come volevano i colleghi, che valersene ad estinguer la sete che il divorava, come aveva egli stesso altra volta opinato. Testimone il discepolo suo, R. Simone, quando uscito dopo 13 anni di reclusione da una oscura caverna, sgridò colui che in onta all’opinione dei suoi colleghi andava mietendo alcune spiche cresciute nell’anno sabbatico, nonostante che si giovasse, come ei si scusava, dell’autorità dello stesso Simone. Testimone Accabià figlio di Maalalel, che dopo avere in onta ai colleghi costantemente sostenuto alcuni principj, sendo vicino a morire chiamò il figlio suo, e l’abbandono gli impose delle tesi proposte.
Ma gli Esseni non si contentavano di praticare il rispetto ai maggiori, alle autorità vuoi politiche o religiose; essi ne davano la teoria. Ei dicevano, e voi l’udiste, che l’autorità era essenzialmente d’istituzione divina, e come quella che era da Dio preposta al governo degli uomini tributavangli reverenza. Il credereste! Erano i Farisei non solo nella pratica agli Esseni conformi, ma lo erano eziandio in teoria. Ei credevano niuno poter venire assunto al reggimento degli uomini, se a questo officio non fosse stato anzi tratto destinato dal cielo; ei credevano che non solo a questa prerogativa partecipassero i principi e rettori delle nazioni, ma qualunque altra benchè subordinata autorità, e come essi testualmente si esprimono, eziandio gli esattori di balzelli, e come allor si diceva, i Pubblicani.—
Noi abbiamo veduto quali principj professassero gli Esseni sulle autorità costituite: vediamo adesso come[267] ne intendessero e praticassero l’esercizio. Giurava l’Essena nella sua ammissione, che ove egli dovesse un giorno comandare ad altrui, si guarderebbe dall’imperare con fasto, con alterigia. Come intendevano i Farisei l’esercizio dell’autorità? Ei volevano nel soprastante scopo nobile e puro, e tutto rivolto a gloria e a servigio di Dio, vehol aosechim ghim azibur ijù osechim immaeim lescem sciamaim. Essi esigevano una pazienza, una longanimità nei Rettori del popolo a tutta prova; di subire dei soggetti i capricci, le rivolte, gli scherni e l’odio ancora; e per tutto in breve compendiare, di sostenere imperterrito quel fantasma che spaventa i falsi amici del popolo, e che è sfidato e vinto dai suoi amici veraci, la impopolarità «Al menat sceischehlù ethem; al menat sceibzù ethem,» essi imprecavano a quei maestrati, a quei superiori che spargono di sè terrore e spavento in cuore ai soggetti, veassotem resciaim ascer natenú hittitam beerez haim; zè parnas amattil emà al azibur. Essi benedicevano invece alla memoria di quelli che il gregge di Dio pascolavano con verga di mansuetudine e di clemenza, col parnas scemanhig et azibur benahat, zohè umanigam leolam abbà. Essi proclamavano, or sono 30 secoli, quando la forza reggeva a sua posta i popoli soggetti, quando l’unico diritto degl’imperanti era il diritto del più forte, quando si credeva generalmente il popolo esser fatto pei principi anzichè i principi pei popoli; essi quella teoria politica proclamavano onde si onora il secolo nostro, che è base dei governi più civili, e che nel principe considera unicamente il più eccelso ministro, il più eminente servitore dello Stato, della nazione, vehi serarà ani noten lahem? Scihbud ani noten lahem.
Giuravano poi d’amare sempre la verità, e di svelare i mentitori.—La verità! Niuna cosa più amarono nè più[268] riverirono in atti e in parole i Farisei.—La verità impone Mosè proseguire in ogni cosa «Midebar scecher tirhak.» La veracità posero per condizione i dottori onde conseguire la visione di Dio, da cui dissero separati in eterno i mentitori. Verità praticarono, e verità rigidissima, nelle civili transazioni; testimone quel Rab Safraà che avendo in cuore aderito ad un prezzo propostogli, ricusò quell’aumento che immediatamente profersegli il compratore standosi contento di quello che aveva per lo innanzi in cuor suo accettato. Testimone quell’altro, che essendo uscito a diporto fuori della città, ed essendosi con altro dottore a caso imbattuto che tolse a ringraziarlo per essergli, siccome credeva, uscito ad incontrare, ingenuamente confessò non aver egli avuto siffatto intendimento. Testimone quell’orrore in cui ebbero ogni ipocrisia e simulazione alla quale sotto il nome imprecarono di «Goneb dahat Abiriot.» Sino al punto d’interdire ogni apparenza che un simulacro offrisse di Pietà o Religione non sentite; che dico? che ponesse in luce o divulgasse pratiche eziandio realmente osservate; testimone tra gli altri lo esempio di quel dottore non troppo dai nostri tempi remoto, che trovandosi in amica brigata un certo giorno che trascorreva in digiuno, ed essendosi ad ognuno presentata ospitale bevanda, amò meglio troncare, che palesare la particolare sua devozione ai circostanti. Tanto è vero che a niuno meno che ai nostri antichi dottori si potrebbero quelle accuse attagliare che una Religione rivale non cessò di scagliare in capo ai Farisei. E quanto non riesce la loro veracità più ammirabile al confronto! Al confronto dico di un popolo allora esistente che lo stringeva da ogni parte colle sue leggi, colle sue istituzioni, coi costumi; che aveva dato al mondo la sua letteratura, la sua scienza, la sua lingua, e che maestro sedeva allora di civiltà alle genti. Voi l’avete nomato: ella[269] è la Grecia, la Grecia il cui carattere del mendacio, dice uno scrittore inglese, passò perfino in proverbio, che Luciano e Giovenale rimeritarono colla ironia e col vilipendio; e che in niun luogo così manifestamente si appalesa come in un passo di Plutarco, ove togliendo a dimostrare la opportunità di vincolarsi talvolta con certi voti agli Dei, egli novera tra i voti, possibile tra i laudabili, quello di astenersi per un anno dal vino e dalla lussuria, e quello infine di interdirsi per un certo tempo ogni menzogna: prova a parer mio manifesta come l’eloquio dei Greci ordinario, abituale, non solamente tollerasse, ma quasi non dissi esigesse, l’ingrediente indispensabile della bugia. Ecco quale era l’ambiente morale in cui vivevano i Farisei, ecco l’esempio che porgeva la pagana civiltà, ed ecco quali seppero in mezzo a sì grand’infezione conservarsi; puri, veridici, odiatori del falso e del simulato, della maschera d’ogni maniera. Ed ecco nobilissimo pregio ove, a differenza dei popoli dominanti, convengono insieme Esseni e Farisei.
Ma gli Esseni non solo vogliono che si ami, che si pratichi veracità; esigono ancora, e voi l’udiste, che si svelino i mentitori. E i mentitori svelati vogliono essi pure i Farisei quando insegnano mizvà lefarsem et ahanefim, quando dicono cioè dovere ognuno strappare la maschera di faccia agli ipocriti, doverne mostrare i vizi e l’abiezione denudata, dovere trarre d’inganno coloro che presi sono dal fàscino dal bagliore di una falsa virtù.
Giuravano gli Esseni di serbare le mani incontaminate da ogni illecito lucro, che è quanto dire da quei raggiri, da quelle trappole che pur sono tollerate in società, e che non sono giudicabili che dal fòro interiore. Il nostro Farisato non ha bisogno di chiarirsi innocente di siffatte bassezze: quindi in fatto di lealtà non può subire comparazione: egli aspira al primato. È egli per ciò che[270] questo brano dell’essenico giuramento nulla dice, nulla ammaestra, nulla insegna? E pure preziosissimo documento vi è racchiuso, nè a voi perspicaci sarà difficile lo scuoprirlo. Vedrete in quello la prova come quella Comunanza di beni, onde andarono così famosi gli Esseni, non fosse così universalmente dagli Esseni praticata, che una parte almeno di essi non si permettessero di possedere; vedrete in esso le traccie sensibili di una privata proprietà a cui si giurava inviolabilità e rispetto.—Vedrete infine quella istituzione attenuata che può a prima giunta parervi ostacolo alla perfetta e intera identificazione tra Farisei ed Esseni, la Comunanza di beni.
Noi siamo giunti quasi alla fine dell’essenico giuramento. Se le cose che intorno ad esso mancano a dirsi fossero di più lieve momento che non lo sono, noi avremmo quest’oggi al tutto esaurito l’esame proposto.—Ma le ultime formule del giuramento dell’iniziato accennano a fatti, a costumi imponentissimi. L’arcano delle dottrine.—Il silenzio e il segreto ai profani.—L’insegnamento agli iniziati.—I libri.—I nomi degli angioli.—Cose tutte il cui nome soltanto accenna la importanza. Egli è per questo che ad altra volta ne serbo la trattazione, e che intorno a queste mestieri è, come Dante diceva, un’altra volta ancora «sedere a mensa.»
LEZIONE DECIMASETTIMA.
Il giuramento degli Esseni fu da noi nelle precedenti lezioni sottoposto ad esame, e trovato in ogni sua parte conforme alle idee, alle pratiche di que’ Farisei dai quali crediamo avere gli Esseni tratta l’origine. Pure una parte tuttavia restava a vedersi dell’essenico giuramento, che è quella per cui l’istituto Essenico sino adesso veduto quale sociale sodalizio si palesa dal suo lato scientifico religioso dottrinale; in cui l’insegnamento, il mistero era carattere precipuo solenne peculiarissimo; per cui spiegasi più luminosa quell’attenenza da noi certamente propugnata fra la scuola farisaica e la società degli Esseni. Giuravano gli Esseni di nulla nascondere ai fratelli dei misteri della setta, di nulla agli altri rivelare ove n’andasse eziandio della vita, e nei casi di legittimo insegnamento di non comunicare le dottrine sociali se non nella guisa in cui fur ricevute, e finalmente di conservare studiosamente i libri della setta e i nomi degli angioli. Gran parole son queste, vuoi per la intrinseca loro significazione, vuoi per i preziosissimi ravvicinamenti che ci offrono col sistema dei Farisei. Permettete che noi riandiamo gli articoli a parte a parte.
In primo luogo, l’obbligo di insegnamento di comunicazione ai fratelli delle dottrine sociali. Avvi nulla che meglio consuoni colle teorie dei Farisei? Io oso dire[272] che non si potrebbe dare analogia più manifesta. Per essi il maestro, il dottore, chi avaro procede degli ammaestramenti ai discepoli, triste messi raccoglierà di maledizioni dalle labbra dei pargoli, e da quelli eziandio che stanno ascosi nell’alvo materno. «Col ammoneagh alakà, mippi talmid, affilù obarim» ecc. ecc. ei frauda lo innocente del retaggio dei padri suoi, della legge, patrimonio comune di tutto Israel. Per essi quella solamente si chiama Legge di Grazia (torat hesed) che ama diffondersi, che si spande, che si comunica, (Torà al menat lelamed zò torà scel hesed) titolo che a sè unicamente arrogava una religione che da noi trasse l’origine.[77]
Per essi colui all’opposto che si fa de’ figli altrui istruttore meriterà di sedere nel consesso e delle speculazioni fruire dei celesti: «col ammelamed et ben haberò torà zoké veiosceb biscibà scel maghta» i egli potrà ogni più duro decreto squarciare col merito suo, «affilù gozer ghezerà mebattelà.» Per essi il vanto maggiore onde possa andare glorioso un Dottore, quello si è di aver molto insegnato, testimone il maggiore Eliezer, che prossimo a morire levò al cospetto dei discepoli radunati le due braccia in suono mestamente esclamando: O braccia mie che quasi due aste del santo volume, poichè la lettura si è consumata, siete prossime a ripiegarsi![78] Molto a svolgere vi stancaste i sacri libri per imparare, molto più vi affaticaste nello insegnare. Deh sia la pace nel mio riposo!
Che se santo è l’obbligo d’insegnare a chi indegno non sia, se dal lato positivo tanta veggiamo conformità col giuramento e colla pratica degli Esseni, sarìa egli lo stesso in ciò che il giuramento contiene di negativo, nel divieto cioè di comunicare le dottrine religiose agli indegni, agli stranieri. E questo pure[273] a veder bene è comune ai Dottori; comune quando pronunciavano il divieto di comunicare la legge, le sue dottrine, i suoi misteri agli idolatri, non già perchè avari procedessero dei veri posseduti, ma per la ragione semplicissima che i Gentili volevano e credevano salvi senza le speciali conoscenze dell’ebraiche dottrine, le quali l’officio e il carattere sostenevano verso i Gentili di dottrine jeratiche sacerdotali, e di inviolabile acroamatismo, a cui accostarsi solo era lecito per le vie gelose e riservate di una regolare iniziazione; comune quando ci narrano di un discepolo cacciato per indiscreta propagazione di cose udite già erano vent’anni, come dei Pitagorici si narra che parecchi soci ebbero espulsi per indiscreta divulgazione dei loro misteri. (Ritter, I, 300) Comune quando la legge comunicata allo indegno, alla pietra parificavano, che gli adoratori di Mercurio o del Siro Meeracles deponevano sui mucchi a loro onore innalzati nei capi strada. E quando più specialmente togliendo di mira quelli che espressamente si dicono Sitrè Torà, Misteri della Legge, e che sono appunto a parer mio le dottrine di cui eran pubblici depositari e cultori gli Esseni, precise e severe regole imponevano alla loro trasmissione, virtù, qualità richiedendo particolarissime nello iniziato, come a dilungo può dimostrarsi in Haghigà, e di cui non è qui luogo a discorrere. Che sarà poi se gli specialissimi libri rammenteremo e le regole dei cabalisti? Certo che l’analogia sarà più parlante, se vera è quella identità che non ho cessato di propugnare fra le due sette; certo che troveremo allora nel Zoar frasi siccome quelle che nel terzo volume si leggono della grand’opera ove il verso dei Proverbi chebod eloim aster dabar «si onora Iddio serbandone i santi misteri» ai misteri si applica ed all’insegnamento dei cabalisti, nè troppo saprei dire veramente a chi altro si potrà meglio[274] riferire che agli arcani di religione, alle norme eziandio attenendosi della Esegesi più imparziale. Troveremo nell’istesso volume un verso solo che sembra suonare contradditorio, autorizzando e vietando al tempo stesso la propagazione dei misteri d’Iddio, seco stesso pacificato, distinguendo gl’iniziati, i soci kabrajà, gli entrati ed esciti a salvamento, come si esprime il Zoar per l’ordinario, dagli indegni, dai profani, dagli inesperti, leekol lesobà velimhassè attik. Troveremo a coloro imprecato che trasmettono (per tradurre testualmente) i misteri delle leggi, i misteri della tradizione della Genesi, e della ortografia dei misteri di Dio ad uomini indegni; troveremo infine l’essenico divieto ripetuto ad ogni tratto e qual tutela e palladio raccomandato per la conservazione delle riposte dottrine.
Ma il giuramento degli Esseni un’altra clausola conteneva che noi dobbiamo esaminare. Non solo volevano generosa trasmissione agli iniziati, non solo volevano ogni cognizione interdetta a chi nol fosse; ma volevano fedele eziandio ed inalterato lo insegnamento; ma giuravano eziandio di comunicare le dottrine religiose nella guisa stessa che erangli state insegnate. Potrebbe darsi riscontro più evidente coi costumi, colle regole, colla pratica dei Farisei? Havvi nulla di più provato, di più costante della fedeltà, quasi non dissi servile, che ponevano i Farisei nella trasmissione delle ricevute dottrine? Eppure non si comprese come cotesta bellissima sia e perentoria dimostrazione della veracità della tradizione; e pure gli uomini che si facevano scrupolo di ripetere perfino gl’idiotismi dei loro maggiori, si accusarono di inventori e falsari; eppure non si vide infine quanto Esseni e Farisei procedano per questo verso eziandio per conformità ammirabili; eppure le infinite prove che ne somministrano i Farisei furono travolte in oblio; si obbliarono[275] quelle formule che tornano ad ogni passo nel Talmud; che sono il preludio obbligato di ogni recitata tradizione; che di maestro in maestro, di trasmissore in trasmissore risalendo, ascendono sin dove le superstiti memorie lo permettono; si obliarono quei dottori che per niuna cosa andarono tra i posteri così famosi come per essersi ogni opinione interdetta che dal proprio maestro non avessero ricevuta come si narra in Succà, se non erro, per Eliezer il maggiore: sciellò amar dabar sciellò sciamagh mippi rabbò micòdem. Si obliò come tra i peccati che causa sono della cessata insidienza di Dio in Israel quello si annoveri, la propagazione di dottrine non ricevute; e nulla, a mirar bene, di più ragionevole; conciossiachè la tutela e la possessione del vero eterno siano il segno della presenza di Dio infra gli umani; si obliò lo scongiuro che il restauratore della Teologia, Ben Johai, il Socrate del cabbalismo, dirigeva ai discepoli, ai suoi Kabrajà, instantemente esortandoli non volessero lasciarsi di bocca uscire una parola di religione, che saputa ed udita non avessero da uomo autorevole, o come dice il Zoar, da Albero magno. Bemattutà minaiku de la tafcum mipummaihu milà deoraità dilà scemahtun meillanà rabrebà; e quel titolo obbrobrioso si obliò che ai propagatori di novità imponevano i dottori, adoratori chiamandoli di Simulacri veri e propri, e di quel comando violatori che è secondo nel Decalogo, dove la fattura s’interdice di imagini e sculture; dehol man demappich beoraità ma delà jadagh vela chibbel merabbò alé chetib lo taasé lekà pessel, la taghbed lak oraità ahrà delà jadagh velà amar lah rabbah.[79]
Ma gli Esseni, voi lo udiste, volevano esatta e fedele la trasmissione delle loro dottrine, e quindi a questo fine preordinarono il giuramento. Perciò imposero la fedeltà della orale trasmissione come abbiamo veduto, e perciò[276] stesso introdussero quell’altro inciso che di conservare imponeva, di custodire con cura, con fedeltà i libri e scritture dell’Essenato. Che vi par egli che abbia pensato e praticato a tal proposito la scuola dei Farisei; che idea vi formate della loro fedeltà bibliografica? Ah! che se io volessi trattare dell’argomento in tutta la sua ampiezza bene più oltre ne spingeremmo i confini che l’ora ed il tema non lo consentano. Ricorderemmo il deposto biblico, il suggello di autenticità che reca manifesto, ed a cui piacquersi di porgere ossequio i dottori eziandio della Chiesa cristiana, ed una schiera infinita di critici di ogni stirpe e religione; i lavori prodigiosi colossali dei Massoreti che resero ogni alterazione impossibile col tessere l’elenco minuto circostanziato delle frasi, delle parole, delle lettere di tutta la Bibbia, e queste ed altre infinite cose riandando, potremmo offrire della farisaica fedeltà luminosa testimonianza. Ma noi ci contenteremo di scendere da tanta altezza, e le più antiche e gravi prove trasandando ci acqueteremo nelle più modeste. Ricorderemo il divieto soltanto di conservare eziandio un libro che non fosse corretto, e quindi l’obbligo della rettificazione, e della soppressione. Assur leasciot sefer sceeno mugghè miscium al taschen beaoleha avlá, e soprattutto ricorderemo un passo del Talmud di Gerosolima nel trattato di Chetubot, che mentre conferisce da un lato a sempre maggiore dimostrazione dello scrupolo e delle esattezze bibliografiche dei Farisei, ci offre da un altro lato tutto il carattere ed il valore di una vera Rivelazione. Io non oserei questo vocabolo adoperare se non avessi sempre letto in autori gravissimi, qual fatto costante dimostrato, il silenzio dei Dottori intorno gli Esseni; se le ricerche eziandio più moderne non si fossero arrestate innanzi questo fatto strano incomprensibile, se infine il luogo da me citato del Jeruscialmi a quei[277] pochi ma rari e preziosi luoghi non appartenesse, che nella rabbinica enciclopedia alludono, a parer mio, manifestamente alla società degli Esseni. Giudicatene voi stessi. Vuole il Talmud accennare quei libri, quegli esemplari da cui si può impunemente togliere criterio per la trascrizione dei libri sacri, accennarli insomma quai libri modelli. Rab Kannà amar lemedin misefer mugghé. E quali sono, credereste, quei libri modelli? Sono quelli, aggiunge il Talmud, quei libri che libri s’intitolano da un Esseno o Esseo come più precisamente legge il Talmud. «Chegon illen deamrin sifroi de Assè.» Strano a dirsi! Quando i chiosatori tolsero a darci di questa frase l’intelligenza, che cos’avvenne? Essi ignoravano o in quel punto obliarono che nei secoli misnici, talmudici, eravi una scuola famosissima che si diceva degli Esseni, che come gli stessi farisei avevano libri; che come essi scrupolosamente ne praticavan la custodia, che la gelosa conservazione eragli imposta per giuramento e tutte queste cose obliando, girono in cerca di meschine, di assurde interpetrazioni. Si disse: eravi allora celebratissimo scriba che il nome portava di assè, i cui libri si prendevano per modello delle copie trascritte, e di quest’uomo intese favellare il Talmud quando disse Sifroi de Assè. Ma dov’è questo Assè nella storia? Dove sono i luoghi in cui di esso si ragioni nel Talmud? Come il singolare parlante nome reca egli appunto di Assè, e come infine il solito inseparabile aggiuntivo non si legge di Maestro o di Rab? Ma quanto meglio nel nostro sistema! quanto più naturale, storica, espressiva, piena di vita e di verità la frase talmudica ove degli Esseni s’intenda, ove si ammetta niun più acconcio esempio aver potuto citare il Talmud di esattezza e religione bibliografica, che lo esempio pubblico famosissimo della bibliografia degli Esseni! Il qual esempio vediamo citato in verità nella[278] frase summenzionata, che mentre conferma la fama di periti e probi bibliografi che vantavano gli Esseni, e che è l’oggetto specifico di questa lezione, ci offre al tempo stesso uno dei più pellegrini luoghi che la storia degli Esseni vanti nelle pagine Rabbiniche, siccome quella che prova contro l’opinione generalmente accettata, la cognizione degli Esseni presso i Dottori.
Ma gli Esseni promettevano nel loro giuramento altra cosa non meno preziosa conservare, e voi lo udiste, il nome degli angioli. Chi è che questo giuramento ci ha trasmesso e quindi anco la frase presente? Egli è Giuseppe Flavio che grecamente dettava le opere sue, e grecamente in pari modo narrava dell’essenico giuramento. Come suona nell’originale la frase di Flavio? Suona ella così chiara, così formale che nè incertezza nè contradizioni abbia tra gli interpreti ingenerato? Io vel debbo confessare. Le parole di Giuseppe furono diversamente comprese dai suoi traduttori. Ove Basnage, ove Munk, ove altri moltissimi leggono, come udiste, il nome degli angioli, l’antico traduttore francese Arnauld d’Andilly, e forse altri che io non conosco, intesero e tradussero, il nome di coloro dai quali furono i libri ricevuti, che è quanto dire il nome dei loro antichi autori. A quale delle due diverse lezioni dobbiamo attenerci? Io non vi obbligherò a sì lungo e duro processo; piuttosto più breve e spedito cammino preferiremo, e prendendo in esame or l’una or l’altra lezione, dimostreremo come qualunque versione ci piaccia anteporre, sempre naturale e luminosa sorgerà tra gli Esseni e i Farisei nuova e concludentissima attinenza. Piacevi la versione d’Arnauld d’Andilly? Volete che si tratti degli scrittori, degli autori antichissimi della scuola il cui nome si volle scrupolosamente conservato? Ed allora potrei io tacere quei luoghi autorevolissimi, ove di questa regola[279] e costume si costituisce obbligo, dovere impreteribile? Non sono i Dottori che insegnarono che chi degli antichi autori i nomi ricorderà, è fattore di Redenzione? Non sono essi che ammaestrarono desiare ardentissimamente le anime dei trapassati udirsi ricordate in quanto insegnarono in questo mondo? Non imposero essi ad ognuno immaginare presente nell’atto d’insegnare l’autore dell’antico dettato. Leolam jekaven adam baal scemuà lefanav. Non posero eglino stessi il precetto in pratica risalendo per lo usato nella recitata tradizione, di autore in autore, tutti per nome distinguendo sin dove la superstite memoria lo permetteva? Io vorrei potere farvi qui apprezzare il doppio oggetto che, sì facendo, si proponevano i Farisei; l’ossequio che in tal modo amavano prestare agli antichi maestri, lo spediente che per tal guisa usavano efficacissimo a serbare inalterate le religiose tradizioni perpetuando le vetuste trasmissioni, e quasi i titoli e diplomi di legittimità invariabilmente accompagnando alle loro dottrine. Ma questo troppo più oltre ci menerebbe che il tempo ed il tema non lo consentano.
Voi lo udiste; udiste come non sia la sola versione che si ammise in Flavio. Si volle e per moltissimi e forse pei più autorevoli, che la frase di Flavio suoni diversamente cioè nome degli angioli. Io vorrei che poteste quanto è d’uopo misurare tutta la importanza di questa frase, che ricordaste come la esistenza, nei tempi di cui parliamo, di una scuola che professasse il culto di una recondita teologia, fu subbietto ed è tuttavia di lunghe, ostinate e dottissime controversie, e come in ultimo questa frase gettata nella bilancia non può non farla, a creder mio, inclinare dalla parte del vero, del diritto. Ma queste preziosissime circostanze basti lo avervi accennato. Noi dobbiamo solo domandare: Saremo noi così[280] felici nel rinvenire di questo giuramento il riscontro nei Farisei, come non infelici fummo, se io non erro, nelle cose discorse? Troveremo noi l’obbligo tra i Farisei di conservare dottrine arcane e certi nomi di Dio venerati? Io non rifinerei giammai se qui dovessi tutto quello esporvi che ci porge di analogia il Talmud; e benchè di significato fecondissimo e di momento stragrande meglio che altri non crede, nonostante non riguardando da presso l’argomento presente, e potendo con un singolo esempio tutto ad un tempo provare, ogni altra talmudica citazione preteriremo.[80] E qual è questo esempio di cui favello? Egli è tratto da quel libro che nell’officio comparativo che abbiamo intrapreso non potremmo desiderarsi più concludente. Egli è il Zoar al volume 3º sul fine, ove oltre moltissime attinenze che è facile notare colla società degli Esseni, oltre il narrarvi di un libro di un Asseo per nome Cattinà, oltre il citarne le parole che a guisa di commento pare avesse dettato sull’ultimo canto di Moisè, oltre il riferirvi tutto quanto in quell’opera si prescriveva sui doveri del medico, oltre il rivendicarvi la legittimità dell’arte salutare contro i sofismi che in nome di una religione fatalistica ne proscriveva l’esercizio, oltre lo accoppiarvi nella stessa persona, mirabile a dirsi! la cura del corpo e la cura dell’anima, carattere precipuo distintivo della società degli Esseni, oltre il parlarvi di un medico o Assià celebratissimo che più si diceva operare guarigioni colla preghiera che non colle arti sue, qualità se altra fu mai convenientissima agli Esseni, oltre a tutto questo, ed è già molto e rilevante, si aggiunge: quel libro esser stato veduto, esaminato prima da un Nomade, da un Solitario. Tajaha il quale redatolo dall’avo suo, dice tutte le dottrine mediche contenute fondarsi sui misteri della legge, prescriversi certi mezzi curativi che non sono[281] precisamente nè umani nè scientifici; e poi lo stesso libro veduto, esaminato per ben dodici mesi da uno dei più celebri dottori Zoaristici, da R. Eleazar, che da quella lettura riportò, siccome egli narra, un senso di venerazione e terrore. Ma ciò che più davvicino riguarda l’argomento presente, la gelosa conservazione dei nomi degli angioli è il fatto, di cui depone il Zoar istesso.—Il contenervisi in quel libro registrato il nome degli angioli, l’aggiungersi da R. Eleazar, vero e scrupoloso Essena, che quei nomi non parevangli esattamente ordinati, cose tutte che rispondono pienamente a quello che vedemmo praticato presso gli Esseni.
Noi abbiamo esaurito il tema del Giuramento, abbiamo parte per parte esaminato questa specie di programma che ogni Essena dovea soscrivere e giurare al suo nascere all’Essenato, e lo esame intrapreso tornò, come dovea, a sempre maggior conferma di quella identità tra il Farisato Cabbalistico e gli Esseni, che fu costante argomento delle nostre dimostrazioni. Adesso un nuovo lavoro ci chiama, un nuovo esame; l’esame delle istituzioni organiche, fondamento del nostro istituto. La comunicazione dei beni, il celibato, gli usi e la vita pratica del chiostro. Ecco gli argomenti che ci occuperanno nelle successive lezioni.—Prove maggiori ci attendono, a me di studio, di indagini serie, a voi di cortesia sempre crescente. A chi valica un mar tempestoso nulla più vale a ispirargli coraggio che una voce amica, che un volto, un’espressione che gli auguri dalla riva propizie le aure.
LEZIONE DECIMOTTAVA.
Il sistema che abbiamo seguito nella esposizione della storia degli Esseni ha almeno il pregio, se io non erro, di essere naturale. Noi abbiamo quell’ordine esterno seguito che l’Essena seguiva nel passaggio che dalla vita faceva del mondo alla vita ascetica e contemplativa del chiostro. Passava dal mondo all’Essenato con un tirocinio di tre anni, e questo tirocinio studiato abbiamo sotto il nome di noviziato. Varcato così le soglie dell’istituto, un atto secondo e più intimo celebrava soscrivendo agli obblighi che lo attendevano nella vita claustrale, e questi obblighi e questo impegno abbiamo considerato sotto il nome di giuramento. Entrato così nel novero dei soci e tutti i doveri adempiendo, e che cosa dovrà formarne delle nostre ricerche subbietto? Certo, i doveri appunto che adempiva, le istituzioni a cui s’uniformava, le leggi che ne regolavano la vita. Ma in questa stessa disquisizione un qualch’ordine dobbiamo pure serbare. Dobbiamo da quelle istituzioni esordire, che prendevano lo iniziato al suo entrare; dobbiamo poi a quelle volgere la mente che lo iniziato accompagnavano, e che gli atti tutti informavano della sua vita sociale.
Una istituzione, singolare istituzione, attendeva lo Essena[285] alla porta. Al suo giungere non solo i vizj, non solo l’errore doveva deporre, ma una mano invisibile lo spogliava di tutti i beni eziandio, e questi ora alla comunità appartenevano, all’erario sociale, ora in favore ai congiunti quasi per morte si rinunciavano: così Giuseppe nelle Guerre giudaiche. Ma lo Essena se di ogni presidio terreno si spogliava, ci trovava nella società una madre la quale per mezzo di socj a questi uffici preposti, e che la storia rammenta sotto il nome di Economi, provvedeva incessante agli abiti, al vitto, ai bisogni dei figli. E questa istituzione si dice Comunanza di beni. Furono in questo senza predecessori gli Esseni? Non ebbero modelli, esemplari tra il fiore dei Pagani, nelle patrie ricordanze e nei Dottori contemporanei? Vediamo gli uni e gli altri. I Pagani! Chi potrebbe dimenticarlo?—Chi potrebbe porre in oblio a questo proposito i Pitagorici? I quali oltre le altre moltissime analogie, in parte vedute e che in parte vedremo ancora colla società degli Esseni, questo pure parlantissimo riscontro porgevano col nostro istituto nella Comunanza di beni. Il Ritter, I, 299, crede che la comunità dei beni sia piuttosto dei moderni Pitagorici che degli antichi; ad ogni modo non nega l’istituzione. Ed ai Pitagorici somigliavagli pure il nostro grande correligionario Flavio Giuseppe quando ai suoi lettori pagani voleva porgere un termine di comparazione coi suoi cari solitarj.—Che Flavio Giuseppe non a torto, così sentenziando, si apponesse, abbiamo veduto altre volte e vediamo oggi non meno; ma forse altro meno atteso resultamento racchiudesi nel citato ravvicinamento, se gli Esseni sono ragionevolmente posti a fianco dei Pitagorici, se il carattere e le istituzioni hanno comuni indivisi. Se i Pitagorici, a confessione di valentissimi autori, hanno comuni le fattezze coi cabbalisti, chi non vede per nuova via accostarsi, abbracciarsi,[286] confondersi in uno Cabbalisti ed Esseni? Se è vero in matematica che due quantità uguali a una terza sono uguali fra loro, chi non vede la verità di questo altro ragionamento? Esseni e Cabbalisti sono eguali a Pitagorici—dunque Esseni e Cabbalisti sono eguali fra loro—sono sopra un tipo stesso, un’idea sola improntati?
Il Paganesimo, noi lo abbiamo veduto, ci ha dato i Pitagorici quale ordine, quale istituzione affine alla società degli Esseni. Che cosa ci darà l’Ebraismo, la storia dell’Ebraismo? Voi lo sapete; parliamo qui di una linea sola della fisonomia degli Esseni, della comunanza dei beni, del voto di povertà. E dove meglio potrìa questa istituzione ravvisarsi che trai Leviti ed i Sacerdoti? Sacerdoti e Leviti secondo le leggi mosaiche nulla possedevano.—Sola fra tutte, la tribù di Levi fu di ogni retaggio in terra santa destituita, sola fra tutte vivea del Tempio e dei proventi del Tempio, sola fra tutte avea per ogni avere sortito l’Eterno, la sua Dottrina, il suo Culto. E questa è visibilissima attinenza tra Esseni e Leviti. Ma non è sola, voi lo ricordate. Quando parlavamo dell’astinenza dal vino, quando degli abiti, dei candidi pannilini, quando degli studj e della vita contemplativa, ei furono sempre i Leviti che tutti questi caratteri ci offrirono comuni agli Esseni. A questi caratteri un nuovo dobbiamo aggiungere, e questo è il voto di povertà, la comunanza dei beni. I Leviti appartengono alla biblica antichità e quindi recano i caratteri ed il genio essenico nelle epoche più vetuste di nostra esistenza. Sono soli i Leviti in quel periodo di nostra storia a offrire cogli Esseni questa nuova similitudine? Sarebbe errore il crederlo, riflettendo ai Recabiti dei quali parecchie cose udiste per lo passato. Certo spero non avrete dimenticato come nelle espressioni di Geremia[287] io vi facessi osservare una frase la quale altro senso non può avere che il voto di povertà, che la comunanza di beni. Così prima Leviti e Sacerdoti e poi i Recabiti di Geremia preludono, come in altri infiniti anco in questo carattere, alla società degli Esseni.
Ma l’Ebraismo, voi lo sapete, ha due ère, due grandi, e come oggi si dice, organici periodi; Bibbia e Talmud, Profeti e Dottori, ispirazione e scienza, parola scritta e parola parlata. Abbiamo veduto della comunanza di beni gli avvisi nell’epoca prima; vediamone adesso i segni, il passaggio nella seconda. Questi segni e queste vestigia di due constano principalissimi ordini: idee e fatti, teorie ed esempj, principj e pratica applicazione. Si trova la povertà insegnata in principio, si trova poi in fatto applicata, esercitata. La povertà proclamata in principio, e questo è già molto; ma assai più sarà, se non sbaglio, quando vedremo a chi riferita, quando vedremo qual portano nome i suoi professori. Io ebbi parecchie volte occasione di ripeterlo, l’ho secondo me innalzato al grado di fatto presso che dimostrato. Il nome con cui pei rabbini si distingue l’Essena è quello di Kassid, e riandando tutte le prove da me in mezzo recate, troppo più oltre la bisogna procederebbe che non fa di mestieri. Questo per certo riteniamo, come l’abbiamo ad esuberanza provato, che il nome Hasid è sinonimo in bocca dei Dottori a quello che Giuseppe Flavio ci trasmise di Essena e Terapeuta.
Or che sarà se oltre i contrassegni infallibili onde questi nomi per noi si confusero, s’identificarono, questo pur esso si aggiungesse della comunanza dei beni? che sarà se oltre le condizioni tutte che abbiamo veduto comporre la personalità del Hasid, quello pur esso udissimo annoverarsi della povertà volontaria? E pure oso dirlo, nulla di più ovvio, dirò anche, di più ripetuto. E[288] la parte più popolare del testo Misnico, e il trattato più accessibile, più conosciuto, più recitato di tutta la vasta raccolta, è quello che ricorre eziandio sulle labbra dei parvoli, che prezioso ne acchiude e perentorio insegnamento. E pure non si comprese; e pure tanto può di luce ed evidenza diffondere uno storico ravvicinamento. E pure era tanto facile comprenderlo quando si fosse agli Esseni pensato, quando si lesse nel Testo: Colui che dice il mio è tuo, il tuo è tuo, egli è Hasid; vi fu nessuno che dubitasse che sì dicendo si alludesse ad alcun che di storico, di reale, di organico istituto? Quando si lesse ivi stesso per contrapposto: Colui che dice il mio è tuo e il tuo è mio; vi fu nessuno che pensasse a quei famosi progetti che dopo Platone e Licurgo correvano per il mondo di repubbliche, di città socialistiche; chi esaminasse se in questa frase approvato o riprovato fosse il sistema dai nostri dottori? Certo ch’io mi sappia, nessuno: e se qui il luogo fosse di trattarne per disteso, quanto non riescirebbe interessante l’ultimo di tai raffronti eziandio? Platone, Licurgo, Fourier, Saint-Simon, Blanqui, Owen, giudicati dai dotti Ebrei non sarebbe tema di piccol momento senza dubbio. Ma di questo si taccia per lo migliore. Solo ci piace insistere sulla prima parte del testo Misnico, su quel rinunciamento a cui s’allude dei proprj beni in favore dei poveri. Strana, insulsa, parassita allusione ove un fatto non vi fosse stato contemporaneo a cui si riferisse, quando si fosse di una virtù favellato che nessuno praticava, quando si fosse voluto soltanto un ideale tratteggiare a cui niuno si fosse accostato, quando a fianco delle altre tre classi reali, esistenti, positive, si fosse una quarta accompagnata che condannata fosse stata a rimanere esclusivamente teorica.
Ma noi dobbiamo mostrarla questa virtù in azione, dobbiamo passare nel dominio dei fatti, dobbiamo toccare[289] degli uomini, degli atti, delle circostanze che di questa essenica istituzione ci offrono in numero infinito ad esempio i dottori, e così avremo le due grandi parti della storia ebraica poste a contributo. E prima un tratto caratteristico che si legge in Cammâ. Si narra d’un uomo, che le pietre che la casa ingombravangli, andava rotolando sulla pubblica via. Chi passa, direste, in quel mentre? Passa, dice il Talmud, un Hasid, ch’è quanto dire tale che il titolo stesso recava che noi abbiamo altravolta ad esuberanza provato, proprio propriissimo degli Esseni, e con mal piglio apostrofandolo si narra che così gli dicesse, o Raca, o Sciocco! per che le pietre sgombri dal dominio nostro per gettarle nel tuo verace dominio? Voi lo udiste. Egli il hasid chiama suo dominio il dominio comune, la via pubblica, la proprietà comunale; egli chiama invece dominio non suo la casa, la propria dimora, la privata proprietà, in quella guisa a un dipresso che quel poderoso intelletto di Proudhon difiniva un furto la proprietà. La propriété c’est le vol, e spiegava il Lo tignob del Dicalogo come se dicesse piuttosto non possedere. Chi avrebbe pari linguaggio tenuto se non un Essena, ch’è quanto dire appunto un Hasid, uno di quei cotali che sotto questo medesimo nome di Hasid ci palesarono in mille incentivi la società degli Esseni? Ma gli esempj non scarseggiano, che anzi ve ne sono di avanzo. Fra gli antichi un Monobaze principe degli Adiabeni, che si dice avere i suoi averi ai poveri distribuito, e Monobaze era, curiosissimo a dirsi! figlio di quella Elena regina degli Adiabeni che noi, favellando altra volta del Nazirato, trovammo affiliata all’ordine dei Nazirei,[81] che è quanto dire, quell’ordine che tante e sì parlanti analogie vedemmo offrire colla società degli Esseni; alla quale il figlio suo Menobaze avrebbe in quella guisa aderito che i principi e monarchi aderiscono alle più[290] illustri consorterie del loro Stato. E qui pure un Ribbi Isbab di cui si dice essersi di ogni avere spogliato in favore dei poveri; qui Ribbi Iohanan che traendo da Tiberiade alla vicina Zippori e giunto presso un campo, voltosi al suo compagno di viaggio, questo, disse, era mio e lo sarebbe tuttora se non avessi ad esso preferita la vita studiosa, contemplativa. E qui un fatto, un gran fatto che solo dalla storia dell’Essenato, delle sue istituzioni, del suo voto di povertà, può ricevere lume adeguato, ed aspetto di verosimile, voglio dire la manìa che invase, l’andazzo, il trasporto generale ai primi albori del cristianesimo, di togliersi indosso il grave giogo di povertà, ed eleggersi volontaria indigenza; che dico? il genio stesso, le parole formali dell’autore del nuovo culto quando diceva: più agevole il passare di un elefante per la cruna d’un ago che un ricco varcare le soglie del cielo. Quando alle turbe di seguirlo desiose, imponeva dicendo: Dividete tutto il vostro ai poverelli e seguitatemi; quando gli ultimi diceva dovere essere i primi nel regno dei Cieli; ed altre infinite somiglianti sentenze che tutte, consuonano coi principj dello Essenato allora in fiore.
Potremo dubitarne? Potremo dire che il Cristianesimo, che il suo autore non abbia volgarizzato le teorie ed i precetti del grande istituto? Potremo appuntare coloro di errore che colsero tanti strettissimi legami fra le due sette? Potremo dire che non bene si apponesse un poeta francese, non ha guari tolto alla patria, quando il fondatore del Cristianesimo chiamava recisamente un philosophe Essénien? Certo che non potremo, se punto ci cale della verità; ma tutti intenti nello spettacolo di sì gran filiazione, diremo ai grandi fondatori del nuovo culto, ai figli un poco degeneri degli Esseni, ai nipoti un poco ingrati dei Farisei, ciò che Dante disse dei grandi ingegni, che vostra arte a Dio quasi è nepote.
LEZIONE DECIMANONA.
Se la comunanza dei beni fu propria istituzione della società degli Esseni, come veduto abbiamo nella passata lezione, non meno tralle altre distinta procedeva, per un altro suo particolare istituto, il celibato. Il celibato fu ed è tuttavia fama avere appartenuto, come ad altri, così a quello antichissimo istituto eziandio, e gli appartenne in verità, purchè si voglia in questa sentenza procedere colle debite distinzioni. Che il celibato praticassero una parte, la più ascetica delli Esseni, nessuno negò, anzi formalmente asserironlo tutti quelli che degli Esseni presero a trattare da Giuseppe sino ai nostri giorni. Ma quanto a partito s’ingannerebbe chi volesse a questa regola astretti tutti quanti gli Esseni! Vi confesso il vero, giovani miei, quando le prime, le più superficiali nozioni acquistando del grande istituto, mi venne fatto di leggere questa regola severissima; quando pensai tutti dover gli Esseni rigorosamente conformarvisi; un dubbio mi assalì, e dissi fra me: che sarà del mio elaborato sistema, dei raffronti perpetui dei Farisei, della strettissima parentela, anzi della perfetta identità tra i due Sodalizj, se il celibato fu invero proprio costitutivo elemento di quello istituto? In qual guisa gli Esseni identificare con quei Dottori, che levavano al cielo il matrimonio,[293] che il gridavano mezzo, condizione di spirituale eccellenza? Ed allora un certo scoramento mi prese, e dubitai un istante della bontà del sistema. Ma quanto ingiustamente! La contradizione che si parava gigante a traversarmi la via, veduta più davvicino, meglio studiata, meglio analizzata, simile ai giganti che vide l’Eroe della Mancia, si convertiva in mulini. E per due ragioni e per due diversi lati deponeva lo scoramento, e quello immenso intervallo che pareva il celibato frapporre tra le due sette sorelle, era in parte da ognuna di esse superato e ricolmo. Farisei ed Esseni che il celibato faceva così discrepanti si porgevano da lungi una mano fraterna, e muovendo ognuno verso dell’altro fornivano una parte di quella distanza che dividevali. Si accostavano gli Esseni ai Farisei togliendo al celibato quel carattere organico, fondamentale che parevagli attribuito, nè i Farisei meno davvicino agli Esseni si appressavano, parecchi e grandi e autorevoli esempj porgendosi non solo di celibato fortuito, involontario, ma di celibato studiatamente voluto, e amato e osservato; e qual grado eminentissimo reputato di spirituale perfezione. Ma parlino i fatti più di me eloquenti. Parli Giuseppe che la preziosa distinzione stabilisce tra Esseni ed Esseni, tra quelli che al celibato si attenevano, e quelli che, comunque veracissimi Esseni, non pertanto non solo il celibato non professarono, ma il matrimonio ad esso preponevano per molti rispetti. Havvi, dice Giuseppe, altra specie di Esseni che convengono coi primi, nell’uso degli stessi cibi, negli stessi costumi e nelle stesse leggi, e in nulla ne differivano, notate preziosissime parole, tranne perciò che riguarda il matrimonio, a cui il rinunciare stimano quanto estinguere dalla faccia del mondo la specie umana. E questo è il punto in cui Esseni al centro farisaico convengono. Ma Esseni, voi direte, vi furono[294] nonostante i quali il celibato praticarono ed a regola parziale sì, ma pure venerata eressero del loro istituto. Nè io lo nego, nè il potrei. Lo attesta Giuseppe, come vi dissi; lo attesta Filone pei suoi Terapeuti, e lo attestano infine i due pagani Plinio e Solino. Ma quanto lo stesso attestato di questi due ultimi, che pure sembra osteggiarne, non reca un’aspettata conferma al nostro sistema! Quale è questo sistema? Voi lo sapete; l’identità suprema tra Esseni e Farisei. Ma chi erano i Farisei e qual concetto di sè porgevano al mondo pagano? Certo di quelli che la immensa maggioranza rappresentavano della nazione, il fondo a così dire della Ebraica società, il popolo vero, il popolo Ebreo. Udite ora le parole di Plinio. Egli non rifinisce dallo stupirsi, egli celebra quale inaudita meraviglia che una nazione per secoli e secoli si perpetui, nella quale, per dirla colle sue parole stesse, non nasce nessuno. Che cosa vi dicono queste parole di Plinio? Certo che un attestato vi porgono rilevantissimo, come altra volta vi feci osservare, della rispettabile antichità dello Essenico istituto, e come stranamente siano andati errati coloro che circa a quel torno gli assegnarono il nascimento, mentre Plinio favella di secoli e secoli. Ma non vi pare che le parole citate confermino la propugnata identità? Vi par egli che Plinio avrebbe così favellato, che avrebbe ad una setta, e scarsissima di numero, il pomposo nome assegnato di popolo e nazione; vi par egli che del suo perpetuarsi avrebbe fatto le meraviglie, se gli Esseni come i Sadducei fossero uno scisma, un membro putrido e divelto, anzichè il fiore e la eletta della nazione? se nel concetto di Plinio e Solino, Essenato ed Ebraismo farisaico non fosse tutt’uno? Vi par egli che luogo vi fosse a gridare mirabilia pel durare, comunque lunghissimo, di uno Istituto ove, s’egli è vero che niuno nasceva corporalmente, pure moltissimi erano[295] i nascenti per le vie di affiliazione e di noviziato? Se d’altra parte Essenato ed Ebraismo non fossero stati nel concetto di Plinio una sola cosa, e se il suo errore da questo appunto provenuto non fosse, dalla naturale identità tra gli Esseni, espressione più alta dell’Ebraismo Farisaico, e lo istesso Farisaico Ebraismo?
Ma nè queste nè altre simili inattese conferme da un obbligo ci dispensano imperiosissimo; dallo spiegare in qual modo il celibato, almeno parziale, si concilia colla identità dei due Istituti. E qui mestieri è di buon grado il concediate. Se ci volessimo di una semplice analogia accontentare, egli è gran tempo che sarìa stata da noi indicata; se ci bastasse il dimostrare che i Farisei se non ebbero il celibato, n’ebbero almanco lo spirito, n’ebbero almeno le lunghissime astinenze, n’ebbero almeno l’applicazione temporanea ai grandi stati, ai grandi momenti della vita religiosa; gli esempj altra volta da noi ricordati sorgerebbero all’uopo opportuni, ed il Farisato di nuovo ricondurrebbero tra le braccia dell’Essenato; sorgerebbero gl’Israeliti separati da lunga mano dalle loro donne nell’aspettazione di Dio rivelato; sorgerebbe Mosè sacratosi secondo i dottori a perpetuo celibato perchè la voce udì che gl’intimava Rimanti con me, e di cui bello indizio comecchè indiretto ci fornirà il gran fatto, che dopo i due figli avuti pria della sua vocazione, niuna altra prole di lui rammemorino le istorie. Sorgerebbe David, il quale al sacerdote di Nob ripugnante di ammetterlo alla mensa d’Iddio protesta esso ed i suoi da parecchi giorni da ogni venere astinenti. Sorgerebbe, lo che è più, una schiera di Dottori Talmudici dei quali si narrano le lunghe separazioni dalle donne loro, sino ai dodici, sino ai venti e più anni, per vivere della vita studiosa appo qualche famoso dottore lontano; nè tra questi sarìa da[296] pretermettere Rabbi Achibà che un carattere particolare ci offre notabilissimo nello appartenere a quei quattro privilegiati che si dicono ammessi al Pardès; ch’è quanto dire iniziati alle più alte speculazioni di una recondita Teologia. E questo, ne converrete, sarìa già molto, e molto del còmpito nostro noi avremmo fornito. Ma se il sistema nostro è vero, se resiste a tutte le prove, dobbiamo volere di più: dobbiamo chieder una precisa e formale dispensa dal matrimonio, dobbiamo chiedere una precisa e formale sanzione del celibato: Non basta; dobbiamo chiedere, perchè sia congenere e quindi identificabile perfettamente coll’Essenico celibato, dobbiamo chiederla quale virtù ascetica, trascendentale, qual mezzo di superlativa perfezione religiosa, quale sacrifizio di ogni affetto carnale ad un affetto morale sopramondano. Parvi egli che io proceda meco stesso più che non s’addica indulgente? Parvi egli che più potrebbe esigere il più severo Aristarco? Parvi egli che se questo trovato avremo, avremo tutto trovato? Ebbene, noi lo abbiamo trovato; abbiamo il Talmud, e dopo di esso un lungo ordine di Trattatisti, i quali tutti, dopo avere tra i precetti di Dio annoverato il matrimonio, pure stabiliscono una eccezione, e questa eccezione è pegli Asceti, è pegli uomini che pongono ogni loro amore nella Contemplazione, per quelli, dice il Talmud, che lo esempio vogliono seguire di Ben Azai. Che nome è questo, e qual nuovo raggio di luce diffonde sull’argomento? Chi era Ben Azai? Il credereste! Era anch’esso uno dei quattro che sopra gli altari si dicono nel Talmud ausati a’ più eccelsi voli della speculazione teologica; era pur esso uno dei quattro che entrarono nel Pardès, ed esso, oh meraviglia! è Ben Azai, è il modello del celibato in bocca ai Dottori, ed egli stesso fu celibe, come celibe o quasi celibe fu Rabbi Achibà, come celibe fu Ben Zomà, se non[297] erro, tutti componenti il gran consesso del Pardès. È egli a caso cotesto? È a caso che non solamente si trova il celibato autorizzato praticato nel Talmud, ma lo che è di gran lunga più importante, si trova appunto, si trova esclusivo in quel consesso, in quei Dottori che se antenati ebbero i Cabbalisti negli antichi tempi, sono dessi di certo? È egli a caso che lo stesso argomento che prova la presenza del celibato trai Farisei, prova egualmente la particolare affinità degli Esseni con quella parte di Farisei che furono precursori, progenitori della grande scuola di Cabbalisti, tanto che si può dire che lo argomento che a noi saria bastato, sorge di nuova luce rivestito che ne prova la verità e meglio e più urgentemente conclude di quello che chiedevamo? Io credo che uno dei migliori criterj di verità, per giudicare di un sistema sia appunto cotesto, quando cioè affaticandoti a solvere una repugnanza apparente, non solo il filo trovi che ti trae d’impaccio, ma quasi per mano ti riconduce a rivedere, a riconoscere, a ricostatare tutte le altre parti del visitato edifizio provando al tempo istesso il tutto colla parte e la parte col tutto, e intimamente armonizzando non solo colla idea in controversia, ma con tutti gli altri caratteri del tuo sistema.
Abbiamo veduto lo stato economico degli Esseni, la comunanza di beni, il loro stato, in parte coniugale in parte celibatario. Adesso dobbiamo più davvicino osservare la vita privata, le costumanze, le abitudini. E prima di ciò che riguarda il loro esteriore, la loro persona. Quali erano i loro abiti? Noi abbiamo di questo argomento toccato laddove della origine discorrevamo del nostro Istituto. Voi lo ricordate. Questi abiti non erano per tutti uniformi, e forse cercando di questa diversità la origine, la troverete per avventura in quel doppio ordine di Esseni che abbiamo veduto comporre[298] il grande istituto Pratici e Contemplativi. Vestivano altri di ruvide pelli, secondo ne ammonisce Giuseppe nell’Autobiografia, altri poi procedevano ammantati di bianchissimi lini. Noi chiedevamo, voi lo rammentate, all’antichità ebraica, alla storia, al culto ebraico di questo duplice costume i precedenti. Vedevamo l’origine del primo nell’uso generalmente adottato dai profeti, e che n’era siccome pare il principal distintivo. Vedevamo l’origine, il modello dei candidi lini, in parecchi e venerande istituzioni in Israel; il vedevamo tra i sacerdoti che di bianco lino vestivano nell’interno del Tempio; il vedevamo tra i Leviti, tra i Nazirei, presso i quali un verso preziosissimo delle Lamentazioni ci attestava egual costumanza; il vedevamo nelle rappresentazioni degli esseri angelici quando i profeti ce li dipingono biancovestiti, quando in Daniel l’antico dei giorni ci è presentato cuoperto di veste bianca qual neve; il vedevamo tra i Dottori, specialmente in uno tra essi celebratissimo R. Iehudà Bar Ilhai, del quale si narra che approssimandosi il sabbato indossava candida veste onde non dissimile, dice il Talmud, appariva dagli Angeli. Che sarà pure se lo epiteto intenderete, col quale questo santo Dottore vien designato? Certo non negherete che niuno più parlante modello da paragonarsi agli Esseni. L’epiteto di cui si parla egli è quello col quale, a senso nostro, si designava dai Dottori lo Istituto degli Esseni, l’epiteto di Hassid. E Hassid è detto nel Talmud questo stesso Ribbi Ieudà Ben Ilaì di cui vediamo la singolare conformità esteriore col costume degli Esseni. Fatto di gran rilievo ove specialmente si consideri che a detta del Talmud, ogni qual volta il nome, l’epiteto ricorre presso gli antichi, di Hasid, egli è di questo stesso Dottore di cui si è voluto parlare. Ma non è egli il solo di cui si narri il bianco vestire. I Dottori di Babilonia[299] si distinguevano pei candidi manti; onde erano detti, perciò appunto Malahè asciaret, secondo avverte il Talmud in Chiduscim ed in Nedarim. Ed oh quanto non torna all’uopo nostro significante la voce Hassid! Voi lo vedeste le mille volte come l’uso storico speciale che di questo vocabolo fecero gli antichi consuoni sempre coll’istituto degli Esseni, tanto che, ciò che i Dottori dissero, narrarono dei Hassidim, è vero alla lettera, dei grandi solitari. Ma non è perfino il nome stesso di Hassid che non acchiuda in seno una squisita convenienza coll’uso, col costume in discorso. Il senso suo cotanto vago, cotanto generale, pure talvolta si determina, si fissa, si circoscrive e l’idea ci offre bene chiara, bene specchiata di candore e bianchezza. Ce l’offre quando è adoperato in senso di onta siccome quella che in ebraico si dipinge col pallore e la bianchezza del volto; Malbin. Ce l’offre poi nel nome Hassidà che il traduttore Arameo traslata a dirittura la bianca; Havarità per il bianco colore delle sue penne.
Sono queste alcune linee di quel grande sistema d’identità che abbiamo cercato di dimostrare del continuo in queste Lezioni; ma la precipua sua forza sta nell’insieme, nell’armonia delle sue parti; in quel vicendevole connettersi, spiegarsi, completarsi, che fanno tutti i suoi elementi, ed in cui l’animo non può fare a meno di ammirare o uno strano capriccio del caso, o un titolo ed un carattere innegabile di evidenza.
LEZIONE VENTESIMA.
Dopo avere nella passata lezione descritto l’esteriore costume degli Esseni, le loro vesti ora candide quai sacerdoti, ora aspre e pelose quai solitari e profeti, diremo adesso degli usi loro, della pratica della vita privata. Grande era il conto che gli Esseni facevano della mensa comune, delle comuni imbandigioni. E nel farlo fedeli erano alle patrie idee, alle patrie tradizioni, e fedeli eziandio a’ più cospicui, a’ più religiosi istituti della pagana antichità. Delle prime faccia fede la Bibbia che ove avvenga chi di solenne banchetto faccia menzione, sempre un gran nome, un nome santo, gli conferisce, quello di sacrifizio,[82] faccian fede i dottori che a dirittura asseriscono, la mensa ove presiede la fede tenere degnamente le veci dello altare di Dio, e le imbandigioni il luogo tenere di sacrifizio espiatorio. Le quali idee comecchè leggansi nelle più autorevoli opere de’ prischi dottori, pure e forse per ciò stesso, consuonano a maraviglia colle teorie cabbalistiche; prova ad un tempo che tralle prime e le seconde anzichè divario, come altri presume, grandi invece ci corrono e sensibili affinità, e che gli Esseni anche per questo verso esprimono con mirabile fedeltà il genio non solo della scuola de’ Farisei, ma più specialmente di quelli che la età moderna distinse sotto il nome di Cabbalisti.
Dissi però di costumi, eziandio, di idee pagane da queste non dissimili de’ nostri Esseni. E qui potrei, le greche e le barbariche istorie invocando, far mostra di facile erudizione. Potrei citare e Persia e Atene e Sparta e le Repubbliche pressochè tutte di Grecia antica, ove i pranzi comuni, ora al grado si elevarono di pubblica, di sociale istituzione, ora, lo che è più, di religioso cerimoniale. Ma su queste e altre simili ricordanze trapasseremo per brevità. Solo dirò con Plutarco che la mensa dice rappresentazione e figura della Terra; l’una e l’altra di forma sferica concepite. Ma Plutarco dice di più: egli aggiunge che perciò stesso, Vesta da taluno si appellava la mensa, e Vesta era simbolo di fuoco centrale, dell’altare, della torre di fortezza, come altra volta vedemmo appellato esso fuoco centrale; e quindi al nome mirabilmente corrispondente di Mizbeak che reca ne’ nostri libri la mensa, ed ambedue e mensa ed altare come tra i pagani così tra noi indicanti un unico principio. Tra i primi Vesta, il fuoco centrale, la vita del mondo, e tra noi l’Ente Metafisico che i Dottori chiamano Malhut, e che tutti i caratteri offre appunto or ora discorsi. Sono questi arbitrari accozzamenti o armonie spontaneamente prorompenti dal cuor del subbietto? Per ora ci basti il fatto enunciato, il concetto uniforme che della tavola formaronsi, e la Bibbia e i migliori tra i pagani, e gli Esseni, e i più eruditi scrittori del paganesimo quale Plutarco. Nè Plutarco è il solo. Cicerone prende a posta sua la parola, ed arguto quale egli esser suole in fatto di etimologia, accenna la superiorità del latino che convivio chiama il banchetto quasi vivere insieme, sul greco che lo qualifica simposio quasi bevere insieme. Ma che avrebbe Cicerone pensato se del nome ebraico avesse avuto contezza? Egli avrebbe certo trovato lo equivalente di simposio nell’ebraico nome di mistè,[302] e quindi inferiore anch’esso al convivio latino. Ma quanto più splendida qualificazione avrebbe egli ravvisato nel nobilissimo Zebach? Che se il primo ogni volgare accenna ed anche licenzioso banchetto, il secondo ai grandi, a’ solenni allude e religiosi convivj.
Nè quelli degli Esseni avrebbero questo nome demeritato. Non lo avrebbero pel silenzio profondo che durante il pranzo regnava d’intorno, e di cui celebre esempio ci offrono pur essi i Farisei, quando esigono in principio non doversi per ragione di igiene conversare mangiando; del qual divieto solo allora comprenderemo lo spirito che a memoria ci ridurremo l’attitudine che prendevano a quei tempi sui letti loro i commensali. Non lo avrebbe poi, aggiunge Filone, pei dottrinali trattenimenti che, conchiuso il pranzo, si intavolavano tra i commensali. Ma quanto non suonano preziose le frasi Filoniane, specialmente ove si badi alle circostanze a cui si accenna. Non solo ei dice che si proponeva a mensa una questione tratta da’ libri sacri; ma egli ne addita l’indole peculiare, ei dice quei discorsi composti di allegorie sulle sacre scritture. Nè di questo si accontenta Filone: ma trapassando al criterio generalissimo con cui dagli Esseni si procedeva nella interpretazione delle scritture, la legge dice considerano pur essi qual’Ente animato i cui precetti sono il corpo; e spirito e mente, le allegorie. Abbiamo ben udito? Sono elleno coteste le espressioni testualissime di Filone? È egli questo il concetto che della scrittura formavansi Terapeuti ed Esseni? Che se così è, che cosa resta per identificarli a’ Teologi del Farisato, ai Cabbalisti? Non sono essi che lo esempio ci offrono continuo luminoso di dotti ragionamenti a tavola intrapresi? Non ne riboccano ad ogni pagina e Talmud e Medrascim ed il Zoar sopratutto? Che dico? Non sono eglino soli, soli i Cabbalisti gli autori, e propugnatori del gran principio esegetico dagli Esseni[303] bandito, la duplice natura della legge di Dio spirituale e corporea? Non sono eglino appunto che all’animale somigliandola (nel 3º Volume del Zoar) i precetti dicono appunto come gli Esseni dicevano, il corpo della legge, e le allegorie, non meno com’essi ancora ne dicono, lo spirito?
Ma se la teoria degli uni a quella degli altri perfettamente risponde, ciò che aggiunge Filone, non pare, se ben si mira, di manco rilievo, e forse meglio che le grandi affinità varrà a stabilire tra i due istituti la medesimezza, siccome quello che poggia non già sopra certe somiglianze che possono essere effetti di cause congeneri, ma sopra alcune circostanze singole arbitrarie che rivelano una medesima provenienza. Egli è Filone che parla, Filone che dice come, conchiusa la sposizione allegorica quando trovata sia laudabile, ognuno applaude. E questa circostanza ove la troveremo? Nel Zoar se la cercherete, ove vedrete non una nè dieci, ma cento e mille volte seduti i dottori Cabbalisti al desco comune, lunghi e dotti tessere ragionamenti, i quali conchiusi, sono ora i baci fraterni che fanno fede del cuore appagato, ora certe frasi che tornano immancabilmente dopo ogni festeggiato discorso, e che suonano, a mo’ d’esempio: Se la vita ci fosse stata solo, per questo udire, largita, già ne sarìa di avanzo. «Illù la atena leàlmà ella lemiscmagh dà, dai.»
Nè i dotti ragionamenti nè gli applausi erano la sola parte che negli Essenici banchetti si dava alle lettere, si dava allo spirito. Eranvi altresì i canti, vi erano gli inni. I quali, dice Filone, coronavano gli Essenici Agapi colle lodi di Dio, e colla memoria de’ suoi benefici. Questo inno era tal fiata opera personale del Patriarca, del Presidente; tal’altra era dettato di qualche antico poeta, perocchè i poeti, dice Filone, hannoci lasciato de’ versi metrici spondei[304] esametri ed inni che accompagnano le sacre danze. Dove sono gli inni a mensa cantati nell’antico Farisato? Il Talmud non li disconosce in verità, per quanto per la indole dell’opera stessa non troppo, se non isbaglio, ne son numerosi gli esempi.[83] Pure già ne è dato l’uso travederne sino da remotissimi tempi: che dico? sino da’ tempi profetici, sino nella Bibbia. La quale volendo dire come nell’ultimo nazionale esizio cessato sarebbe ogni tripudio, annunzia come non più a suon di canto, sarìa il vino ne’ conviti libato: d’onde traevano i dottori argomenti a interdirne l’uso dopo l’esilio. Pure la interdizione non è tale che l’uso non ti apparisca di quando in quando nell’istesso Talmud: testimone quel banchetto ove invitato Rab Hasdà a sciogliere giojoso un canto trista invece intonava e lugubre elegia. Ma questi, per quanto non ispregevoli esempj, poco sono, se gli Esseni sono non solo Farisei ma Farisei cabbalisti, se la identità di cui abbiamo finora discorso non è una favola.
Ebbene il Cabbalismo, i suoi usi, i suoi personaggi ne danno la più parlante, la più espressiva imagine della Essenica costumanza. Io non so se sbaglio, ma se il Talmud, se tutta la biblioteca rabbinica de’ primi secoli fa per avventura menzione di un poeta rabbino, di un poeta fariseo, questi è un solo, chiaro, celebre se volete, ma pure un solo. E questo unico poeta chi è egli? Egli è uno de’ più eminenti della teologia cabbalistica, egli è il cervello, la mente della scuola, come Ribbi Abbà ne fu lo scriba, ne fu lo scrittore; egli è in una parola il figlio stesso del grande maestro, egli è Ribbi Eleazar figlio di Simone che fu, dice il Medrasc, Carobì vetanoi upoeti. E ciò che più monta, egli è che di questo officio, di questo carattere di poeta non fa fede il Zoar, parte interessata nella questione e monumento esautorato dagli anticabbalisti, ma fanno fede libri a niuno sospetti,[305] di indubitata autenticità, di imparzialità manifesta. I quali lo dicono fregiato delle triplici doti, come vedemmo, di Poeta, Oratore e Rapsoda tradizionale e il vogliono ancora perito cantore e identico a Ribbi Elleazar Hisinà per non parlare della tanta controvertita identità col poeta nostro, conosciuto più tardi sotto il nome di Callir o di Calliri, intorno al quale tanto dottamente s’affaticarono i nostri moderni eruditi. E questo è senza meno antichissimo e per ciò stesso concludentissimo esempio di analogia, Esseno-Farisaica ed Esseno-Cabbalistica. Ma quanto più prossimi e più comuni gli esempi se per poco scendiamo in ordine di tempo! Quanto illustre ce n’offrirebbe l’esempio dico di magnifiche poesie, parte più specialmente consacrate alla mensa, parte alla preghiera, alla liturgia, e tutte stupendamente improntate di una siffatta elevazione che rende a mille doppi mirabile il poetico magistero. Fra i primi non si potrebbe non menzionare il Loria principe de’ moderni Cabbalisti, prodigio di speculativa fecondità, comecchè nulla abbia scritto ma tutto lo insegnamento suo abbia trasmesso oralmente. Che dico nulla scritto? Egli scrisse pure qualche cosa, e queste sono brevi e mistiche poesie dettate in linguaggio Arameo e destinate alla mensa sabbatica. Gli altri poi sono egualmente Cabbalisti ma scrittori esimj nella purissima favella della scrittura. Possiamo dire che se a ragione vi ha chi possa dire di aver generato la mistica poesia ebraica, la più bella che io conosca, ella è senza meno la Italia nostra. La quale se non avesse in questo genere dato la vita che a Moise Zaccut di Venezia, avrebbe già un titolo glorioso alla riconoscenza de’ cultori della santa lingua. Bisogna leggere le poesie del Zaccut e persuadersene. Bisogna avere qualche sentore delle Dottrine cabbalistiche, bisogna avere anche il gusto dell’ebraica poesia,[306] per ammirare il magistero stupendo, con cui concetti sublimissimi sono vestiti di forma non meno sublime, ed in cui non sai veramente discernere se più l’idea conferisce alla venustà della forma, o la squisita magnificenza di questa alla grandezza e nobiltà del concetto. A me poi la lettura di quelle poesie cabbalistiche dettate nel più puro idioma della scrittura produce un effetto singolarissimo. Mi pare che un grande abisso sia ricolmo, mi pare un grande intervallo superato, mi pare in un istante la distanza soppressa, che i Profeti divide da’ Dottori, da’ Dottori cabbalisti. E quando vedo quanto la forma profetica scritturale si attagli al concetto cabbalistico, quando vedo e l’uno e l’altro immensamente più belli, più grandi farsi al contatto, e quasi la parola biblica incarnarsi, immedesimarsi col concetto cabbalistico, allora la unità primitiva e della parola e dell’idea rivelata, la sintesi che ha preceduto l’analisi, la separazione sofistica, mi si rivela in una luce, in una evidenza intuitiva che non si potria la maggiore.
Ora di due altri punti che il sistema, che la forma e l’ordine concernono della tavola essenica. Questi due punti sono in primo, l’ora, e poi l’abito che a tavola indossavano. L’ora dicono gli storici era la sesta. Dopo avere, dicono essi, lavorato sino a 5 ore si bagnavano nell’acqua diaccia, e bagnati che erano si riunivano per il pasto. Entravano nell’aula ove cibavansi, con aria solenne, quasi fosse in un tempio; sedevano nel più profondo silenzio, e prima e dopo il pasto i sacerdoti pronunziavano una preghiera. Le parole udite sono pregne di allusioni, di reminiscenze, di analogie farisaiche; analogia l’ora al cibo assegnata; questa ora era pegli Esseni la 6ª e lo era egualmente pei Farisei; i quali, prescrivendo e determinando a ciascuno l’ora di sedere a mensa, assegnano a’ Farisei la 6ª ora[307] del giorno, quella stessa che udiste sulle labbra di Filone particolare agli Esseni; analogia la lavanda, l’abluzione che gli Esseni praticavano nella sua forma più religiosa, Tebilà, e che i Farisei non imposero che nella sua forma più mite l’abluzione delle mani Tebilat Iadaim; analogia il concetto grande ed augusto che si formavano del refettorio al quale si accostavano come ad un tempio, consuonando in tal guisa col farisaico dettato che la tavola parificano all’altare, e il carattere gli assegnano espiatorio che era proprio all’ara di Dio. Sciulkan scel Adam mechap per ghalav. Analogia infine la benedizione che si dice pronunziata prima e dopo il convito, e di cui abbiamo continuo quotidiano l’esempio innanzi gli occhi.
L’ultimo de’ punti accennati non merita meno la vostra attenzione. Se gli Esseni indossavano abiti particolari durante il pasto egli è perchè nobilissimo siccome udiste si formavano concetto della mensa comune, alla quale siccome i sacerdoti all’altare, così essi non si appressavano che con abiti specialissimi; egli è perchè, nè si dee dissimularlo, tale correva allora comunissimo l’uso tra i più distinti Romani i quali andavano, dice uno storico, al pranzo vestiti di un abito più o meno leggiero secondo le stagioni e che serviva solamente per la tavola. E nomi pure recava distinti, pomposi: si diceva vestis cœnatoria, triclinaria, convivalis e in una parola sintesis. Presentarsi al festino senza quest’abito sarebbe stata inescusabile malcreanza. Cicerone fa un delitto a Vatinio di esservi venuto in abito nero comecchè convito funebre fosse quello. Quando il convitato avesse mancato d’indossare l’abito comune, il padron di casa glielo prestava come prestavanlo, al dire di Capitolino, Alessandro e Settimio Severo ai loro commensali. Ma l’uso in discorso è di gran lunga più rilevante ove ad un uso si raffronti, bello per mirabile identità de’ dottori Cabbalisti.[308] I quali appunto come gli Esseni, appunto come i più grandi tra i Gentili, non si avvicinavano alla mensa che dopo aver vestito abiti esclusivamente alla mensa sacrati, applicando all’atto della commestione ciò che i Farisei del Talmud praticavano in ordine alla preghiera, per la quale lindi e puri serbavano abiti peculiari. Ma ciò che più mi ha colpito, che meglio ha posto agli occhi miei in rilievo questo nuovo argomento d’identità fra le due scuole, si è appunto, vel confesso ingenuamente, ciò che per altri sarebbe stato per avventura soggetto di dubbio e di esitazioni, voglio dire quell’apparente mancanza di continuità nella pratica di quest’uso tra i Farisei, quella lacuna storica che tu ravvisi tra l’antichissimo Essenato e i moderni Cabbalisti, e per cui dopo aver letto di quest’uso la pratica in una società da tanto tempo estinta, tu lo ritrovi senza che ti sia dato discuoprirne le orme, vivo, attuato nella scuola cabbalistica. Se i Farisei, dissi fra me, da’ quali potuto avrebbero i cabbalisti quest’uso imparare non lo conobbero; se i Cabbalisti non si addarono unqua dell’esistenza neppure, e tanto meno delle istituzioni degli Esseni in quella guisa che niuno di se stesso può vedere il sembiante; e se non ostante gli antichi usi degli Esseni si riproducono senza il vincolo farisaico in seno a’ Cabbalisti e si riproducono ne’ dettagli eziandio più minuti della pratica giornaliera, egli è segno che la vita de’ primi si è ne’ secondi trasfusa, che cambiando nome, forma e certi caratteri altresì deponendo, si perpetuò l’Essenato, si rinnovò ne’ Cabbalisti moderni, tra i quali tu ravvisi certi usi i cui storici precedenti mancano affatto nei predecessori naturali degli Esseni, nella Bibbia, ne’ profeti, ne’ Farisei, e di cui tu trovi invece il tipo antichissimo nella società degli Esseni.
Che se questo fatto ed altri di simil tempra non provassero[309] l’identità, che cosa proverebbero e quale più rimarrebbe spiegazione escogitabile? Certo che altra sola rimarrebbe possibile, ma tale che per la sua assurdità niuno vorria menar buona. Bisognerebbe supporre che in seno ad una stessa nazione, gli Ebrei; sotto gli influssi di una medesima religione, l’Ebraismo, in breve sotto l’azione di un concorso di cause identicissime, due istituti siensi generati, che tutto o pressochè tutto vantano comune, dottrine, genio, pratica giornaliera, usi, costumi e nonostante non si tocchino, non si combacino, non s’identifichino fra di loro, e nonostante sieno due riproduzioni fac simili di uno stesso tipo, due manifestazioni successive di uno stesso principio, di uno stesso genere. Io credo questa ipotesi inammissibile. Io credo che nella stessa guisa che nella vita di un popolo, di una fede, di una scienza, ogni principio, ogni germe nasce una sola volta, vive di una sola vita, e morto ed esaurito mai più comparisce in quella guisa medesima che la Grecia ebbe un sol Platonismo, una sola Stoa, un sol Peripato; l’età moderna un sol Cartesio, un sol Leibnizio, un sol Spinoza, un sol Kant, nè saria stato possibile che due ve ne fosse perchè nulla d’insulso, di inutile si produce in natura, così io credo che l’Ebraismo non ebbe nè poteva avere che un sol Essenato, come non ebbe che un sol Farisato, un solo Sadduceismo, un sol Caraismo; e che questo Essenato cangiò sì di nome col cangiare de’ secoli, senza cangiare però di natura, e le fattezze antiche serbando tutt’ora riconoscibili.
LEZIONE VENTESIMAPRIMA
Le istituzioni degli Esseni ci hanno sinora occupati. Celibato, comunanza di beni, abiti, refettorio furono da noi nel novero posti delle loro istituzioni; e come tali studiati. Potremo noi obliare il lavoro l’esseniche occupazioni? Potremo noi il carattere e l’esame disdirgli di organica istituzione quando le regole dell’istituto come tale lo consideravano, come tale ai socî lo imponevano? Io credo che nol possiamo. Troppo era per essi essenziale il lavoro perchè possa da noi pretermettersi. Il lavoro, dice il Salvador, era una delle tre basi su cui la società si fondava, e queste basi erano Lavoro, Carità, Contemplazione. Le quali basi attentamente osservando, mi venne fatto dimandar a me stesso: sarebbe egli possibile che di questa triplice caratteristica si faccia parola nelle antichissime sentenze di Abot? Sarebbe possibile che un equivoco, sino adesso perpetuato, ci abbia conteso la vera e genuina intelligenza della parola Abodà, e che non ad altro se non alla essenica organizzazione allude il testo antichissimo, quando tre dice essere le basi su cui poggia il mondo, il sociale edifizio, Carità, Lavoro, Contemplazione? Io non ardirei asserire che così sia veramente, che a questo e non ad altro abbia alluso la Misna e che la parola Abodà sin ora intesa come il culto esprimente e il servigio di Dio, stia piuttosto[312] a significare lavoro, come pure il potrebbe. Tanto io non ardisco, ma ciò che si può a dirittura affermare, egli è che la congetturata interpretazione può stare a fronte di altre mille che la critica moderna partorisce ogni giorno; egli è sopratutto il conto grandissimo in cui il lavoro si tenne presso gli Esseni.
Ma qual lavoro? certo non il commercio per cui gli antichi professarono dispregio anzichè altro; per cui parve condegno agli Egizj, agli Indiani, antichissimi popoli, rilegarne i professanti sino alle ultime classi sociali. Per cui i Greci stessi non ebbero che parole di biasimo e di sdegno, che lo dissero proprio peculiare officio della classe servile, e non solo in pratica l’ebbero a vile, ma vile ancora l’ebbero in teoria i filosofi, i publicisti, come a bastanza apparisce nel 7º libro della Politica di Aristotile, e come dal nostro stesso Flavio Giuseppe apertamente risulta, il quale più obbediente ai paganici pregiudizj che alla storica verità, disse che gli stranieri soltanto praticarono appo noi il commercio ai tempi di Salomone; troppo disdicendo a popolo nobilissimo inchinare la mente ai pensieri, agli officï della mercatura. Queste frasi provano almeno una cosa, provano il concetto che del commercio prevaleva, ai tempi dello Essenato, il quale, siccome quello che aspirava a sovrumana perfezione, non poteva a quegli offici ossequiare che dallo universale e dal volgo medesimo erano dispetti.
Che se il commercio non era la occupazione prediletta dei rigidi solitarj, potremo dire lo stesso dell’agricoltura? Egli è certo che Filone attesta il contrario. Ricorda Filone come gli Esseni si compiacessero attendere eglino stessi ai rusticani lavori, e le terre eglino stessi coltivare alla società pertinenti. Nè certo consuonavano, in questo, i lor costumi con quelli dei più famigerati popoli del mondo antico. I quali non meno che il commercio[313] ebbero a vile l’agricoltura, e l’uno e l’altra affidarono a mercenarj, a schiavi. Testimoni gli Indiani che solo all’infime classi sociali concessero il lavoro dei campi; testimone l’Egitto, la Grecia, e Sparta segnatamente; e se una eccezione dovesse farsi fra i popoli antichi, ei sarebbe senza meno pei Cinesi e pei Romani. Ma dove oblio il popolo nostro? Che agricola per eccellenza, non alle conquiste, non alle arti, non alle scienze, poco ai commerci rivolse la mente, ma tutte si ebbe le sue cure la coltivazione della terra: e le terre feconde e le mèssi e i frutti abbondanti, si udì per secoli e secoli riprometter qual premio della sua fedeltà, e per contro suonar terribile, continua minaccia al peccato, la sterilità e la terra ingrata ai prodigati sudori.
Nè l’agricoltura fu meno in reverenza appo i Dottori. I quali non solo la consigliarono qual onesta, utile occupazione; non solo eglino stessi talvolta la praticarono (nella più corrotta epoca dello Impero romano rinnovando le virtù dei Cincinnati), ma preludendo alle grandi e famose quistioni, sorte ai nostri giorni tra i più celebri Economisti, in due campi, in due scuole si divisero; l’una il primato concedendo all’agricoltura, l’altra a questa anteponendo i commerci e le industrie; l’una vaticinando il definitivo trionfo dell’agricoltura, l’altra all’aspetto florido dei campi anteponendo il fervore, l’attività dei commerci e dell’officine. (V. Talmud Mezihà.)
Ma gli Esseni, e voi l’udiste, l’agricoltura onoravano ed esercitavano come esercitata ed onorata fu in progresso di tempo da illustri e famosi sodalizi che sul tipo dell’antico essenico istituto si modellarono nella Chiesa cristiana, a ritiro, a solitudine, a contemplazione. E non solo ricorda la storia onorata, e praticata da essi l’agricoltura, ma ricorda altresì lo studio che gli Esseni facevan solerte delle virtù e proprietà dei semplici, dei vegetabili specialmente[314] in quanto potevano offrire di terapeutico, di curativo, dediti, come veduti li abbiamo, non meno a risanare gli spiriti che a restaurare nei corpi la perduta salute, siccome la doppia significazione ce lo avvertiva da bel principio del loro nome di Esseni o Essei, palesemente originato da quel di Assia medico e terapeuta. Nel quale studio ebbero non so dire se a imitatori o modelli la setta dei Pitagorici, che non solo della origine si occupò e della cura dei morbi, ma che lo studio e l’applicazione predilesse dei semplici e della musica, della prima specialmente, per la epilessia o morbo sacro, e per i morsi dello scorpione.
E che diremo dei Dottori? Se di questi volessi distintamente favellare, e se troppo la materia non soverchiasse, questo sarebbe il luogo di riandare quei molti e preziosi esempj che per entro si colgono alle pagine del Talmud, ove i semplici, i rimedj tratti dal regno vegetabile, si veggono studiati, celebrati e costantemente messi in opera dai più antichi Dottori; sarebbe il luogo di fare nell’ordine botanico ciò che il dottore Rabbino Levinson fece, non ha guari, rispetto alla zoologia, e dettare una Botanica talmudica siccome egli scriveva una Zoologia talmudica, che ebbe l’onore di essere letta e pubblicamente laudata dal principe dei naturalisti moderni, dal venerabile Alessandro di Humboldt.
Ma coteste sono opere meglio che lezioni, meglio che digressioni, e noi dobbiamo stimarci felici di costeggiare le rive anzichè ai pericoli avventurarci di lunghe navigazioni.—Ci basti che il Talmud, che i Medrascim ci porgono di questo studio e di queste terapeutiche applicazioni l’esempio, e sopratutto ci basti che l’uno e l’altra ci sieno porti dal Zoar. Il quale siccome quello che rappresenta il Cabbalismo e i suoi Dottori, meglio torna all’uopo opportuno per quella identità dimostrare, che è[315] costante e prediletto argomento delle nostre lezioni. E che il Zoar ce lo porga, ne son testimoni quelle frequenti allusioni alla natura, alla proprietà delle piante, degli alberi in ispecie, e del palmizio segnatamente, del quale si descrivono le maravigliose proprietà sessuali così esattamente dai moderni chiarite, e presentite se io non erro, sino dall’antichissimo Empedocle, filosofo greco delle scuole antisocratiche: testimone il 2º vol. a pag. 15, ove si tenta una classificazione dei vegetabili improntata, non v’ha dubbio, di caratteri mistici, trascendentali, ma pure senza meno un tentativo di classificazione: testimone il fatto di cui vi feci non ha guari menzione, in cui di un medico si favella, di un Asia, che un libro possedeva preziosissimo per lo studio dei semplici, e per la cura dei morbi; e infine, testimone lo stesso 2º vol. a pag. 20, ove si parla in termini apertissimi della distillazione. Gran che! quando rilessi di recentissimo questa pag. 20, quando intesi a favellare di distillazione non era molto tempo trascorso dacchè le pagine aveva svolto di un trattato di Fisica elementare, ove con termini più che non era mestieri laconici, si attribuiva l’origine, l’onore della distillazione agli Arabi, ai Musulmani. Io dico il vero; quelle parole mi avevano tratto in errore: aveva creduto che gli Arabi, della distillazione inventori, fossero gli Arabi del Medio-evo, i conquistatori della Spagna e della Sicilia, i coetanei di Averroe o di Avicenna. Epperò dissi fra me: qual occasione, qual festa, qual trovato non sarebb’egli cotesto per gli anticabbalisti? Come facile il provare la età modernissima del Zoar che del moderno trovato favella, della distillazione? Perciò, che feci? Usai, perdonate la mia franchezza, usai un’astuzia; ma non temete; una pia e religiosa astuzia, pia et religiosa calliditas, un’astuzia innocente; scrissi all’illustre amico Professor Luzzatto, siccome a quello che più splende tra[316] i moderni cospicuo per la guerra intimata al Zoar e ai Zoariti; e senza favellargli del Zoar e del suo contenuto gli chiesi semplicemente se nulla poteva dirmi della origine della distillazione; e se i libri rabbinici più antichi ne facessero, ch’egli sapesse, menzione alcuna. Mi rispose con quella sincerità che lo distingue: della distillazione non ne so nulla. Io non aveva nulla guadagnato; e i miei dubbj perseverarono, più che mai fastidiosi, quando una buona ventura venne a tempo a togliermi d’imbarazzo. Le indicazioni da me pur lette nel trattato di Fisica elementare erano incomplete. Non gli Arabi del Medio-evo, ma i più antichi loro predecessori, eran quelli di cui si era voluto favellare, e questi stessi appreso avevano l’arte del distillare dalle orde tartariche. Ecco il Zoar tutelato, ed ecco al tempo istesso riprova degli studj e delle cognizioni comuni tra Esseni e Cabbalisti.
Io dissi non ha guari come larga mèsse di cognizioni, d’idee mediche, potria dai libri talmudici raccòrsi e dalle opere contemporanee, e come tanta ne sia la copia, che da ogni particolar citazione mi saria rimaso. Pure egli è un passo tra mille che sarebbe colpa tacere, perchè più davvicino riguarda i nostri Esseni: che dico? egli è uno di quei pochissimi in cui a parer mio i Dottori alludono manifestamente all’Essenato ed ai suoi costumi. E dove è? È nel trattato Sciabbat a pag. 133, ove parlando di un farmaco composto di cera e resina e per non so quale malore indicato, si aggiunge che questa indicazione fu comunicata da Rabbà ai suoi uditori in un pubblico sermone, ma che (udite, significantissime parole!) a quella indiscreta propalazione, la scuola di Beniamino l’Asseo die’ segno di dolore e di sdegno squarciandosi persino le vesti, ch’è quanto dire, come io intendo, che uno dei farmaci che formavano parte della Materia[317] medica riservata gelosa dell’Essenato fu propagato, vuoi a pubblico vantaggio, vuoi per indiscreta osservanza degli Statuti sociali, da Rabba in Mahoza, e tanto più mi confermo in questa sentenza, in quanto veggo lo stesso Raba nella stessa Mahoza, esporre al pubblico la misteriosa lettura del nome di Dio, ed esserne ripreso da un Sabà, da un Dottore anonimo, lo che prova e la indole di Rabà, e il suo sistema di propalare i segreti della scuola, e la presenza nell’uno e nell’altro caso, di persone, di Dottori che protestano contro la divulgazione delle dottrine sociali.
Ma di questo basti per ora. Bisogna dire degli altri offici a cui sacravano le ore i nostri Esseni, come detto abbiamo sinora, dell’agricoltura, dello studio dei semplici, e della pratica medica. Gli Esseni non abborrivano dai mestieri. Filone ci ammonisce come parecchi di loro si dessero ad opere manuali non isdegnando passare dallo studio al lavoro, e dal lavoro allo studio; ed altra e parlantissima analogia al tempo istesso offerendo coi più antichi e venerandi tra i Farisei. I quali ogni arte o mestiere reputavan nobile purchè onestamente esercitato: nè di tanto è mestieri che io vada oggi esempj accumulando, sì perchè è il fatto per se stesso notorio, sì perchè non è molto che fuori di qui ne parlai pubblicamente a disteso, esempj recando sì numerosi e autorevoli da persuaderne, se bene estimo, i più dubitosi. Ed altrettanto fecero pur essi gli Esseni al dir di Filone. Non sì però che certi mestieri severamente non s’interdicessero, nè a niuno di essi fosse dato rivolgere lo ingegno e la mano. E quali erano i mestieri interdetti? Ve lo dica Filone colle parole stesse del testo. «Tu, egli dice, non troverai tra costoro niuno artista che voglia lavorare intorno una freccia, un dardo, una spada, un elmo, una corazza, uno scudo nè di alcuna spezie di armi, di macchina, o strumento che serva alla guerra.»
Che vi dirò? Quando lessi queste parole in Filone io ringraziai Iddio, e lo ringraziai di cuore. Lo ringraziai in primo per avermi posto nella buona via inspirandomi il mio favorito sistema d’identità essenico-farisaica; e poi lo ringraziai di non avere comunicato vana infondata congettura ai miei uditori. E se di tanto lo ringraziai, ne ho ben d’onde. Perocchè egli è questo uno dei punti più culminanti ove Esseni e Farisei s’incontrano, si abbracciano, s’identificano. Come gli Esseni, aborrivano i Farisei, come un antico Baraita lo attesta, dal fabbricare, dal vendere, dallo affilare spade o armi qualsiasi, da vendere o fabbricare ceppi, catene, collari, ad uso di guerra; e se qualche contestazione si produce egli è a proposito degli scudi.—Ne vogliono gli uni lecita la vendita, la fabbricazione perchè armi sono puramente difensive. Ne vogliono gli altri interdetto lo spaccio perchè, notate singolare ricordo, perchè, dice il Talmud, quando nel bollor della pugna ogni arma è spezzata, è caduta, si suol non di rado battagliare cogli scudi; che dico? non è lo scudo soltanto che fu subbietto di disparere tra i Farisei, egli è il cavallo, il cavallo che per alcuno si dice strumento di guerra, per altri come tale non si qualifica. Vogliono i primi che venderlo non sia lecito, perciocchè, notate quest’altra storica singolarità, egli avviene non infrequente, dice il Talmud, che il prode cavaliero ammaestri il focoso animale a finire con calci e coll’orribile calpestare i nemici caduti in battaglia, e quindi a buon diritto estimare si debba bello e forte arnese di guerra, e terribile guerra. Ecco due capi soltanto intorno a cui si avvolsero discordi le dottrine, le opinioni farisaiche; lo scudo e il cavallo; pel resto per le altre armi o strumenti qualsiansi, che a strage, a schiantare, a oppressar possano essere rivolti, una fu la voce, una la sentenza per interdirne la fattura, la propagazione.
Nè qui si fermava lo scrupolo farisaico: vollero all’israelita interdetto il vendere ai Pagani orsi, leoni, pantere, elefanti, che facevano allora frequenti comparse negli stadj, nell’anfiteatro e nel circo, a sollazzo della plebe corrotta e servile; e sotto ai cui morsi, ai cui artigli cadevano trafitte, sanguinose, migliaja di vittime; vollero interdetta la cooperazione dell’Ebreo alla edificazione di quelle basiliche o tribunali ove si rendevano allora iniqui e ipocriti giudizj; di quei luoghi di supplizio ove tanti innocenti sostenevano crudeli martirj; di quegli stadj ove l’uomo contro l’uomo, o la belva contro dell’uomo venivano scatenati a trastullo di un popolo feroce e corrotto; e infine di quelle cupole balnearie che ornavano gli edifizi destinati ai pubblici bagni, e che la Misnà chiama chippà; volta o cupola dove pare che la imagine fosse sculta o dipinta di qualche paganica divinità, spesso di Venere afrodisea, come mi è dato dedurre da una preziosissima Misnà in Aboda Zarà. Ed egli è là che Raban Gamieil vediamo alle prese con un Proclo detto filosofo, che io dissi, se non erro, altra volta identico per avventura a quel Proclo che fu seguace di Iamblico e di Plotino nella schiera dei nuovi Platonici.—Questo orrore di ogni arme, di ogni strumento di omicidio vediamo altresì in due leggi, in due pratiche, biblica l’una, rabbinica l’altra, prova tra altre mille della medesimezza del genio, dello spirito che informa ambidue. È la prima la prescrizione che si legge nell’Esodo per cui a comporre l’altare di Dio, pietre s’impongono intiere e dal contatto immuni di ferro o scalpello: è l’altro il consiglio di rimuovere ogni ferro, ogni arma dalla mensa privata quando conchiuso il pasto ci accingiamo a benedire, appunto per quell’analogia che abbiamo altra volta notata tra l’altare e la mensa, nel concetto, nei principj e nelle pratiche eziandio di Esseni e di Farisei.
Ma questi abbiam veduto non solo abborrire dal nuocere al corpo, interdicendosi il commercio dell’armi, ma dal nuocere altresì allo spirito, ai costumi, astenendosi da por mano a basiliche, a cappelle, a tempj pagani. E del come osservassero il presente divieto, illustre ce n’offre un esempio lo storico Giuseppe, anzi Ecateo Abdiretano dallo stesso Giuseppe rammemorato nella risposta ad Apione, quando narra di un governatore di Babilonia per nome Alessandro, che volendo riedificare il tempio di Belo ed obligati avendo i suoi soldati a cooperarvi colla persona recando i mattoni necessarj allo edifizio, gli Ebrei furono i soli che a quest’opra si ricusarono; nè minaccie poterono nè castighi persuaderli; tanto che furono alla perfine dispensati. Nè meno scrupolosi osservatori ci appariscono infatto dell’armi, non solo ogni fabbrica o vendita interdicendosi di armi da guerra, ma anche il portarne indosso considerando qual disdicevole cosa. E chi lo dice? Egli è lo stesso Giuseppe che ce lo attesta e con parole non meno formali: «Dal divieto delle armi nasce, egli dice, che quando vanno attorno da una città in un altra, per i latrocini solamente si armano, e da questo caso in fuori niun’arme recano indosso.» Voi lo udiste, Giuseppe è esplicito. Gli Esseni non recano armi tranne in luogo di imminente pericolo. Ma ciò che non meno riesce esplicito, egli è la doppia bellissima analogia che ne offrono i Farisei e i Farisei Cabbalisti. La prima ci è offerta dalla Misnà, la seconda ci è porta dal Zoar. È la prima in Sciabbat laddove indagando quali sono gli arnesi d’impune trasporto fuor del recinto murato, s’interdice la spada, l’asta, la alabarda e non sì tosto mostra R. Eliezer di volere assolto chi li trasportasse, perchè egli dice tornano spesse fiate ad ornamento, che i Dottori ad una voce insorgono, e non ornamento, gridano, ma disdoro sono coteste, conciossiachè sia scritto. E nei giorni del Re[321] Messia le spade saranno in vanghe converse, le aste in falci mutate, perchè le armi più non impugnerà popolo contro popolo, e l’arte disimpareranno del guerreggiare. Se l’Abate di S. Pietro, se Cobden, se Bright, se tutto il congresso della pace fosse stato a quei tempi, e Cobden e Bright e tutti i promotori della pace universale sariano stati Farisei.
Ma io dissi di un secondo esempio che il Zoar ci porge, e questo è di gran lunga più interessante perciocchè ci offre ad un tempo e la regola e l’eccezione; la regola di non impugnare le armi nei tempi e luoghi quieti, normali, la eccezione nei luoghi e nei tempi torbidi ed anormali, e l’uno e l’altro si veggono come dissi nel Zoar in un fatto ivi narrato. In cui R. Hja e Ribb Josè per via procedendo veggono un uomo venire a loro incontro.—Egli recava indosso un manto sacro ornato nei quattro angoli delle frange di obbligo.—Però sotto a quello si travedeva una cintura e dalla cintura pendergli di ogni maniera micidialissime armi. A quella vista sclama R. Hija: grande giusto è cotesto, o grande impostore—e qui notate come potesse e dovesse a senso di R. Hija essere giusto e pio in sommo grado cotesto che pure in sì strana guisa se ne giva armato di tutto punto.—Ma l’incognito si appressa, e salutato dai due Dottori, al saluto non risponde. Discostatisi dallo straniero i Dottori, ripigliano le dotte e sante consuete conversazioni.—Ciò che non potè il saluto poterono le parole sante dai Dottori profferite. A quel suono gli si fà lo straniero dappresso, e salutatili come l’usato: Deh mi dite, lor chiede, o Maestri, qual giudizio vi formaste della mia scortesia quando da voi salutato, al saluto non corrisposi?—Forse, dicemmo, pregavi, forse meditavi, ripresero i Dottori. Allora datosi a conoscere, prese lo straniero a narrargli le sue avventure; come andando un[322] dì per cammino e imbattutosi in un masnadiero ne ricevesse molestia, come non conoscendo chi essi si fossero avere di essi pure sospicato, come da ciò provenisse il tacer suo, e dallo essere in quello istante immerso in qualche meditazione. E volendo dar loro prova, chi egli si fosse, prende a ragionare sur un verso dei Salmi ove si palesa veramente per ciò che era, per Dottore, e Dottore cabbalista.—Qual fatto e qual comento! qual comento dico all’uso, alla pratica da Giuseppe e da Filone narrata pei nostri Esseni, di non gire mai colle armi sulla persona tranne ove muovendo di luogo in luogo se ne munissero per propria difesa.—E qual eloquente conferma della identità essenico-cabbalistica, se ben si mira agli autori del Zoar ignari al tutto della esistenza degli Esseni se essi medesimi nol sono, e quindi alla impossibile imitazione! Nè più bella infine potrebbe sorgere presunzione in favore dell’autenticità di quel libro ove schiette e genuine si son dipinte le figure, i costumi delle sètte contemporanee, tali quali il nostro tardissimo confronto li fa sorgere dopo 18 secoli vivi e parlanti al paragone, e che niuna impostura avrebbe potuto togliere a contraffare perchè mancava il tipo istesso da imitare nella mente del falsario, nulla cognizione particolare avendo avuto i posteriori Dottori dell’antica società degli Esseni, e nulla quindi di essi avendo potuto prendere ad imitare.—Bacone diceva: Poca filosofia fa l’uomo incredulo, molta lo fa religioso. Noi diremo a nostra posta: Poca critica fa credere apocrifo, falsato lo Zoar, molta critica lo chiarisce autentico.
LEZIONE VENTESIMASECONDA.
Colpa sarebbe, e colpa non lieve, se discorrendo degli Esseni e delle loro occupazioni quella trasandassi che agli studj si riferisce, specialmente, quando di un Istituto si parli eminentemente studioso qual fu l’Essenato. Degli studj dunque si parli e tanto più a proposito in quanto avendo in animo di toccare dei dogmi loro, delle loro credenze, saranno gli studj, se io non erro, facile e naturale transizione per cui dai lavori e dalle occupazioni loro trapassiamo a ragionare delle dottrine e dei dommi; participando gli studj e del carattere di occupazione e di quello di dottrine e credenze.
E prima del modo. Il quale facile torna lo argomentare quando si pensi alla vita solitaria ed agreste che menava la parte contemplativa dell’Essenato, nella pace dei campi, all’ombra amica degli alberi e sulle rive che tanto vedemmo altravolta la società prediligere. Il qual modo era pur quello che vediamo ai Dottori seguire non rade volte nel Talmud, quasi sempre nel Zoar, che maggiori deve per sua natura offrirci analogie, e maggiori infatto le offre col nostro istituto; dove i Dottori, i Maestri affidano i loro misteri alle tacite rive dei fiumi, all’ombra dei boschi ed al cupo orrore delle caverne, o alle falde inaccesse di qualche altissimo monte. Sistema tanto dal nostro diverso cui la vita cittadinesca stringe da ogni lato[324] colle sue braccia di ferro, e che tanto conferisce non solo alla elevazione e perfezionamento dello intelletto, ma alla conservazione, all’incremento della salute corporea. Nè voglio altri a testimone che il più grande pensatore d’Italia moderna, Vincenzo Gioberti, che nel 2º della Protologia tali dettava concise ma eloquenti parole. L’uso, diceva, la vivacità, la celerità della mente giovano alla salute, non le nocciono come si crede. Rousseau disse: L’homme qui réfléchit est un animal dépravé. Falsissimo. Esempio di Giulio Cesare e in generale degli antichi. Non lo studiare, ma il modo dello studiare moderno rovina il corpo. Elementi necessarj allo studio, l’aria e la luce. L’aria e la luce giovano alle facoltà dell’intelletto ed al corpo unitamente. Studiare a cielo aperto fra gli arbori, lungo le acque correnti o almeno in camere ben areate. I nostri dotti sono più dilicati delle donne. Fin qui Gioberti.—Voi l’udiste, egli voleva lo studio a cielo aperto fra gli arbori e tale era appunto lo studio degli Esseni e dei Cabbalisti. Egli lo vuole lungo le acque correnti e non solo gli Esseni prediligevano le rive, ma i Dottori notarono come lo spirito profetico riempia, ispiri, i suoi ministri a preferenza lungo le acque correnti, sicura prova come tutto ciò che valga ad esaltare le potenze dell’intelletto conferisca eziandio in sommo grado alla più facile fruizione della profetica intuizione, testimone per tutte la musica di cui si valsero qual prima promozione alle cose celesti i profeti d’Israele, di cui gli effetti psicologici sono da ognuno esperimentati, e per cui non pare sia al tutto menzognero il dettato dei Pitagorici: L’anima essere un’armonia.
Che se questo è il modo dagli Esseni seguito, vediamo l’oggetto, e a così dire la materia dei loro studj. Bisogna pur confessarlo. Vi è una disciplina, per cui gli Esseni[325] non professavano nè stima nè amore, e questa è la logica. Ecco come ne parla Giuseppe: Quanto allo studio della filosofa, dice lo storico illustre, lascian la logica a quelli che si dilettano di quistioni di parole, e la tengono per inutile affatto all’acquisto della virtù.—La logica, pria si può dire dei nostri tempi, non fu che un’arte, e bella pagine di storica filosofia; sarebbe quella che notasse le vicende, per cui l’arte logica ascese per gradi a quel posto eminentissimo che occupa oggi nei sistemi eziandio più trascendentali formandone poco meno che la volta suprema, e il sostegno massimo dello edifizio. Lungo il discorrere le ragioni del mutamento e come la logica dallo essere un semplice interno regolamento del pensiero, sia divenuta la legislatrice suprema dello scibile e tutte da essa s’informino le parti della universal metafisica. Ma se in antico era un’arte, non sempre era arte ragionevole ed onesta. Testimone Socrate che coll’arguto suo conversare confuse, vinse la logica dei sofisti, e per parlare di cose meno dall’Essenato remote, anzi a dirittura contemporanee, testimone la logica delle scuole accademiche ed in ispecie dei Pirronisti che se ne valsero a detrimento di ogni sapere e di ogni virtù, togliendo, col dimostrare il pro e il contro, valore alla umana ragione, ed ogni autorità ed ogni sanzione alla morale.[84] E questo è già prezioso rilievo per ciò che riguarda gli Esseni, mostrandoci a dito l’origine di quel dispetto, in cui ebbero gli Esseni la logica così abusata. Ma egli è nulla, di fronte alla mirabile conformità che in questo come in altre infinite occasioni veggiamo sorgere tra gli Esseni e i Farisei. I quali ultimi non meno che i primi, severamente imprecarono contro la logica depravatrice del secolo, esortando a tenere discoste dall’attossicata bevanda le labbra dei giovanetti. Minhù benehem min Aeghion. Singolare a dirsi! questa[326] voce Eghion che unica suona, se non erro, in tutto il Talmud, fu torta dal suo verace senso a significare ora lo studio della Bibbia ed ora altra cosa. E pure il suo senso di logica è innegabile, e se non sempre fu dai posteriori dottori confessato n’avevan ben d’onde. Erano eglino filosofi di professione e la logica studiavano ed amavano qual nobilissima scienza. Ma devoti eran pure al Talmud ed osservatori sopratutto delle sue prescrizioni. Il Talmud, aveva detto Eghion e se per Iggajon inteso si fosse qual veramente dovuto avrebbero la logica colle sue pretensioni, coi suoi abusi, che sarìa stato dei nostri platonici, dei nostri peripatetici, dei nostri insomma filosofi di ogni ordine, d’ogni colore? Certo che sarebbero stati in odore tenuti di Eterodossi. Ma se Iggajon volesse dire altra cosa, se dire volesse lo studio biblico, la grammatica, come oggi si dice l’Esegesi biblica, allora la Logica sarebbe salva, e i suoi scrittori potuto avrebbero svolgere in pace i suoi volumi. Ecco l’origine della fraintesa interdizione, l’origine istessa che fece intendere nell’istesso Talmud per hohmà ievanit tutt’altro di ciò che significa veramente, vale a dire, la scienza, la cultura, la civiltà tutta del popolo greco.
Ma non solo della Logica furono poco studiosi ed amanti gli Esseni, ma se le mie congetture non son temerarie del tutto, un altro genere pure di disciplina non raccolse per avventura la stima e l’attenzione dell’Essenato. Se un passo del Talmud Babilonese non m’induce in errore, tanto poco studiosi si mostravano gli Esseni della rituaria quanto poco di attenzione concessero alla Logica istessa. Io vel dissi, or non è molto, e spero ne avrete conservata memoria. Un tratto vi è nel Talmud ove ci è sembrato vedere apertissima allusione agli studj medici dell’Essenato. Egli è là ove a proposito di certi misteri terapeutici svelati da un dottore, a pubblico benefizio,[327] si narra che la scuola di Beniamino l’Asseo squarciossi per dolore le vesti: indicazione se altra fu mai parlantissima del genio terapico e riservato della Società degli Esseni. Or bene, un altro luogo si ha nel Talmud ove la stessa scuola di Beniamino l’Asseo è ricordata. Ed a che proposito, se il sapete? A proposito del poco conto che per taluno si faceva della scienza dei riti e di chi la coltiva. E chi ci è offerto di tal disistema ad esempio? Ci è offerta la scuola appunto di Beniamino l’Asseo la quale, dice il Talmud, quando voleva porre la inferiorità in rilievo dello studio dei Riti: a che giovano, esclamava, i suoi cultori? Forse hannoci mai permesso un corvo? Forse ci hanno unqua interdetto una colomba? Non so se io erro, ma il passo in discorso parmi a quel novero appartenere di prove, di memorie, di documenti, i quali provano come antica perpetua sia stata tra noi quella gara legittima, nobile, religiosa tra i cultori del Rito, e i cultori del Dogma, tra i Teologi e i Ritualisti, gara di cui si veggon le traccie nello stesso Talmud, ove il Maasè mercabà, ossia la scienza del Dogma è talvolta chiamata Dabar gadol di fronte a quella dei Riti che il nome reca di Dabar Caton; gara che trasparisce nel Zoar ove i Marè Misnà sono posti a riscontro, in grado però inferiore ai Marè Cabbalà, questi chiamati Efrohim, i primi chiamati Bezim quasi a indicare uno stato spirituale embrionico; ove la scienza dei riti è chiamata il Corpo della legge mentre quella del dogma si è appellata l’Anima, lo Spirito; ove la dialettica dei talmudisti è presentata qual duro e scabro esercizio dell’intelletto e personificata nei durissimi offici che sostennero gli Israeliti in Egitto, la forma del Calvahomer nel homer e nei lebenim, il libbun alaha lo sceveramento e ultima formulazione della legge. E gara per ultimo i cui effetti veggonsi tuttavia[328] perdurare non solo nei dissensi che sorgono talora tra i dogmatici e i ritualisti, ma eziandio in quella non dirò antipatia ma certo non piena cordialità nè stima soverchia che invano si desidera tra i cultori dei due studj, e il cui difetto non è l’ultimo tra le cause che ostano alla perfetta riabilitazione degli studj dogmatico-cabbalistici.
Ma queste sono le parti a cui meno gli Esseni sacravano il loro tempio e il loro studio: egli è d’uopo vedere quali quelli si fossero, e quale il metodo a cui a preferenza si applicavano. Possiamo dirlo arditamente; le preferenze non meno che la educazione, gli studj adottati non meno che i rejetti provano sempre più la identità tra Farisei ed Esseni da noi propugnata.
Precipua e diletta occupazione era pegli Esseni la interpretazione delle Sacre Scritture, la Sacra Esegesi, come oggi direbbesi. Ma quale Esegesi? Egli è quì ove la parentela più chiaramente si mostra tra Farisei ed Esseni. L’Esegesi, la interpretazione allegorica, ch’è quanto dire quella istessa che formava e forma le delizie del più puro Farisato e in ispecial modo di coloro tra essi che si dicono Cabbalisti. E non solo gli Esseni nella pratica, ai dottori nostri si conformavano, ma ciò che merita tutta l’attenzione dei dotti, quello che suona veramente significante egli è il rapporto che gli Esseni, al dire di Filone, stabilivano tra la lettera della legge ed il suo spirito, o per dir meglio tra la chiosa letterale e la interpretazione allegorica. Essi, dice Filone, comparano la legge ad un animale i cui precetti sono il corpo, e l’allegoria lo spirito, in quella guisa che lo stesso Filone, terapeuta esso pure, chiamava nella Migrazione d’Abramo l’allegoria anima, e la lettera corpo della legge; e in quella guisa pure che Aristobulo, ebreo filosofo contemporaneo, seguiva il sistema delle allegorie scritturali, e Aristea, che volendo dipingere il genio ebraico dei[329] tempi suoi, ci offre nel Sommo Pontefice Eleazaro un modello degli interpreti allegoristi della Scrittura. Ora ch’il crederebbe? Gli Esseni, Filone, Aristobulo, sembra quasi che abbiano veduto lo Zoar, e lo abbian copiato, tanto il loro dire suona conforme alle parole dello Zoar, il quale non solo è quasi una perpetua conferma del loro dettato, mettendolo continuamente in pratica coll’allegorizzar la scrittura, ma questa pratica stessa erige in Teoria: non basta, si vale della stessa imagine, della stessa similitudine di cui si valse Filone, si valser gli Esseni, a indicare la relazione tra i due sensi scritturali, il litterale e lo allegorico. Pel Zoar sezione Beaàlotèha come per Filone e gli Esseni i precetti della legge ne sono il corpo, gufà deoraità, l’allegoria ne forma lo spirito, Nismeta de-oraita. Anzi per far più completa la similitudine imagina lo Zoar una veste che tutta ricuopre il corpo della legge, santissima veste tessuta dei racconti, delle istorie, degli episodj, onde tutto va cosparso il divino volume, e che ne formano quasi il manto e l’involucro esteriore come i precetti ne sono il corpo, e come le allegorie ne sono lo spirito.[85] Non è questo il luogo di occuparci più specialmente di questo senso scritturale che diciamo allegorico, della sua origine, della sua legittimità, delle vicende che ha subìto. Se questo ne fosse il luogo, io dovrei additarvi nella storia della esegesi scritturale due specie di allegorismi, l’uno, il buono, il legittimo, l’ortodosso che anzichè colla lettera pugnare e tanto meno escluderla, con essa si concilia e armonizza perfettamente, e questo è l’allegorismo del Zoar e degli Esseni, l’altro lo spurio, l’eterodosso che pugna anzi colla lettera e col corpo della legge, e sulle rovine s’inalza del senso pratico, letterale, storico della scrittura, ogni loro realtà dileguando nel vaporoso orizzonte di un fantastico allegorizzare; e questo è il simbolismo[330] di Filone tra gli Ebrei; di Origene tra i Cristiani e più o meno di tutti i Padri ed Esegeti della chiesa, i quali stretti, più che loro non talentasse, dal senso preciso, pratico, esecutorio, positivo delle leggi e dei Profeti dissero, figure parabole, similitudini ciò che l’Ebraismo credette sempre e sempre seguitò a credere e praticare quale propria e formale indicazione di fatti o di azioni materiali e positive. Gioberti distinse il duplice allegorismo, ma non si accòrse la sua gran mente, siccome quello che egli chiarisce ostile, anticristiano, eterodosso, sia stato per primo introdotto, praticato, e qual arma di guerra impugnato dal Cristianesimo contro l’antica ortodossia, esautorando di ogni senso reale ed esecutorio tutti i precetti di Dio, e reducendo a vani tipi, e figure e parabole, la storia, i riti, i precetti; insomma tutta la parte reale e positiva della antica alleanza.[86]
Ma ciò che abbiamo superstite della Esegesi degli Esseni, non si stringe soltanto alle cose suesposte. Altri punti culminanti ci rimangono avventurosamente da porre a confronto col sistema dei dottori e nuove conferme dedurne della propugnata identità. Testimoni le etimologie greche, il senso greco che gli Esseni al dire di Filone solevano assegnare a certe frasi, a certe parole della Scrittura. Per Filone, Piscion, Havilà, che quai nomi l’un di fiume e l’altro di paese, si leggono nei primi del Genesi, sono grecamente foggiati e quai vocaboli grecizzanti, intesi, interpretati dallo stesso Filone. E non solo i due ricordati vocaboli, ma per dirla colle parole del Frank, c’est généralement sur les termes de la traduction des LXX et des étymologies purement grecques que se fondent ses interpétrations mystiques. Ma ciò che non vide o non notò il professore di Parigi, ella è la consonanza perfetta col sistema d’esegesi farisaica. Curiosissimo a dirsi! Un fatto vi ha che non abbastanza[331] riscosse sin’ora l’attenzione dei dotti, ma che pure la merita in sommo grado. I Farisei, i Dottori, i Rabbini di Palestina, non v’è cosa che più prediligano nel deciframento delle espressioni scritturali, che il ricorrere alla lingua greca, alle greche etimologie. Se la parola Nof non suona loro abbastanza intelligibile, il greco idioma gli porgerà nel vocabolo Ninfa il senso di vergine, di fanciulla, di amante. Se il vocabolo Meherote-em, suona loro duro a intendersi, la lingua greca glielo farà aperto col vocabolo Mahaera, Spada, o arme qualunque da taglio. Che più? Una disposizione legale di prim’ordine, una questione di vita e di morte, una dispensa dalla pena capitale si deve nel Talmud, a una greca etimologia, e per non dire ancora di altri moltissimi, se il cedro ebbe tra tutti gli altri frutti benchè formosi, la preferenza nella festa di Sucot, egli è perchè la parola Adar suona affine coll’Idro greco, acqua, e quindi accenna al cedro che al dire del Talmud cresce a preferenza in riva alle acque sulle sponde dei fiumi. Ed ecco, se io non erro, abbastanza espressiva analogia nel sistema interpretativo, considerato eziandio nei suoi più minuti dettagli.[87]
Che se ciò paresse scarsa affinità tra le due scuole, non lo sarebbe certo lo spirito, il genio esegetico che si mostra in ambidue improntato di un sol conio. E chi un esempio ne volesse quanto più si può categorico, il chieda a Filone. Il quale, Terapeuta egli stesso, e del sistema dei Terapeuti illustre modello, non solo nel sistema etimologico concorda coi Farisei, ma ben anche nello spirito, nel genio delle interpretazioni scritturali. Testimone per tutti quel passo nella vita di Mosè, ove toglie ad esporre le cause per cui tacque il divino legislatore sui diritti dei padri alla successione dei figli. Le Législateur se tait, per dirne il senso con un autore francese, sur le droit des pères à hériter des enfans.[332] Mais, dit Philon, comme la loi de la nature veut que les enfans soient héritiers des parens, et non les parens ceux des enfans, la législation se tait sur ce qui serait désastreux et malsonnant. La legge tace, secondo Filone, ciò che suonerebbe sinistro e ingiocondo a udirsi. Or bene. Io affermo arditamente che se vi sono interpretazioni che vadano di questo spirito, di queste tendenze informate, elleno sono senza meno quelle dei nostri dottori, pei quali se il testo accenna con una perifrasi, anzichè in modo più diretto, gli animali impuri, egli è per istudio ed amore di castigato linguaggio; se lo stesso giaciglio si noma per l’uomo letto, per la donna sedile, egli è per rimuovere ogni pensiero di oscenità; se l’imbrunire luce si chiama anzichè tenebre, egli è per esordire con meno tristo vocabolo; e pei quali finalmente è principio ammesso, accettato, doversi ogni idea trista, luttuosa, inonesta circondare di ombre discrete, che ne velino la bruttezza e l’orrore. Petah debareha iair. Che dico? Non è persino il caso di successione quello appunto che forma subbietto dell’osservazione Filoniana che non si contempli dai Dottori in Batra; e cosa assai più singolare, ella è la stessa ragione da Filone messa innanzi, che i dottori assegnano al caso stesso ivi considerato, argomento che più non potrebbesi concludente in favore dell’indole comune delle due scuole.
Che se poi dagli studj per sè già abbastanza conformi, vogliamo al sistema trascorrere di esposizione, alla forma esteriore, al metodo dei loro studj; non solo troveremo questo metodo, punto da quello dissimile dei dottori in generale, ma più specialmente simigliante a quello dei Cabbalisti. A noi più non rimangono i libri degli Esseni; ma ci resta Filone, il quale, e degli Esseni ci narra il costume, e nei suoi libri ci offre, Essena egli stesso, un autorevole esempio del far comune dei suoi confratelli.[333] Ci narra il metodo di esposizione, agli Esseni peculiare, nel libro da esso dettato sulla vita di Mosè, lib. 7, e lib. 2, pag. 81, dove dice che la tradizione orale conservata appo gli anziani d’Israel Presbiteron (d’onde il prete cristiano) era comunemente insegnata sul testo della Scrittura; che è quanto dire lo stesso ordine assumeva della medesima Scrittura, e di essa forma vestiva e ordine di comento. Ci offre pur Filone in sè stesso l’esempio di questo generalissimo costume, non seguendo nei suoi libri un filo logico e ordinato di pensamenti, ma piegando piuttosto l’ordine alla successione dei testi od argomenti scritturali. Filone, dice un illustre scrittore, Filone non ha un corpo completo di dottrine; espone i suoi pensamenti in ordine d’interpretazioni simboliche alla Scrittura. Ora che altro è lo Zoar? Egli è appunto ciò che or ora udiste qual definizione delle opere Esseniche e di quelle di Filone, una serie di pensieri esposti in ordine d’interpretazioni simboliche alla Scrittura. Tanto è vero che ciò che all’uno conviene, non meno conviene all’altro eziandio, e che la gran scuola farisaico-cabbalistica è quel mare vasto ove il sistema di Filone mette la foce, e dove l’intero Essenato «ha pace con i seguaci sui.»
LEZIONE VENTESIMATERZA.
Istituzioni, dottrine, e pratiche, furono la triplice divisione da me sino da principio assegnata alla storia degli Esseni. Noi abbiamo coll’esame delle occupazioni loro chiusa la prima parte di questa storia: la storia delle esseniche istituzioni. Delle occupazioni degli Esseni ultimi comparivano all’esame gli studj, lo spirito, il metodo da essi negli studj seguito. Tempo sarebbe quindi che passando alla seconda parte di questo lavoro noi citassimo a giudizio le loro dottrine, i dogmi e le credenze al cui esame ci ha in qualche modo spianato la via la conoscenza dei loro studj, del loro genio esegetico, dei loro metodi. E pure, un’ultima ricerca rimanci ancora ad esaurire pria di tôrre ad esame i dogmi e le credenze degli Esseni. Questa ricerca si attiene ancor più davvicino alle loro dottrine, siccome quella che anzichè trattare della forma degli studj si occupa piuttosto della materia, dell’oggetto dei loro studj; in una parola delle sorgenti, delle fonti dalle quali attinsero com’è naturale le loro dottrine. Egli è questo, se non isbaglio, un punto di contatto e di natural transizione tra la prima e la seconda parte di questa storia, tra la storia delle loro istituzioni e quella non meno interessante, delle loro dottrine. A chi chiederemo le sorgenti, le fonti da cui gli Esseni attinsero le loro dottrine? Chi ne darà contezza dei libri da cui tolsero gli Esseni, la regola del loro credere? Questa notizia[336] ce la darà pel primo Filone, tanto col suo proprio esempio, quanto coi preziosissimi ragguagli che più direttamente egli stesso ci offre dei libri, delle fonti dell’Esseniche dottrine. Ce la dà, col suo proprio esempio quando, Essena egli stesso, ci offre in sè la imagine, il modello dei meno celebri confratelli. Filone era Essena, e da chi tolse Filone principalmente le sue dottrine? Certo che molto egli deve alla greca filosofia, alla Platonica in ispecie, perciò che riguarda sopratutto la forma, ma ove si voglia nelle viscere penetrare del suo sistema quali ne diremo le fattezze, e quale l’origine? Certo che alla sentenza soscriveremo di un autore tanto più nelle asserzioni sue autorevole, quanto niuno altro si prefisse scopo al suo lavoro, se non quello di storica verità. E questi è il Frank, il quale colpito dalle profonde analogie che al sistema dei Cabbalisti congiungono le dottrine degli Esseni, e dopo avere escluso che i primi siensi fatti imitatori o plagiarj dei secondi, queste parole dettava significanti che raccomando alla vostra attenzione: Ne serait-il pas juste de penser que Philon a trouvé ces doctrines toutes faites dans certaines traditions conservées parmi ses corréligionnaires, et qu’il n’a fait que les parer des brillantes couleurs de son imagination? E quanto il Frank si apponga in questo giudizio, il vegga ognuno in questa apertissima confessione di Filone medesimo; il quale in modo che non si potrìa più esplicito va egli stesso additando ciò che per il Frank non era sinora che nudo e mero conghietturare. Philon lui-même nous assure avoir puisé à la tradition orale conservée par les anciens de son peuple. E questo dice Filone nella Vita di Mosè sul principio del 1º libro, ove veramente appella ad una tradizione orale conservata appo gli anziani d’Israele ch’egli qualifica Presbiteron, d’onde il prete cristiano, e ch’era comunemente insegnata sul testo della Scrittura. Ed ecco[337] una prima capitalissima fonte all’Esseniche dottrine, la tradizione.
Ma questa non è sola fonte, o per dir meglio non veste sempre esclusivamente la sua forma verbale che più gli è comune. Pegli Esseni non è sempre come pei semplici primitivi Farisei, una orale trasmissione che sarìa sacrilegio deporre per iscritto. Ella veste, anzi ella assume la forma scritta; e mentre la voce del Maestro era il solo organo che avesse nei prischi tempi l’insegnamento farisaico, gli Esseni per contro vantavano libri, e libri che spingevano anche a tempi a quelli anteriori la loro origine. E questa preziosa contezza n’è data da uno che nell’esseniche vicende non si potria più esperto, da Filone medesimo, il quale attribuisce alla setta dei Terapeuti dei libri mistici di una remotissima antichità. Parole testuali e di senso fecondissime delle quali impareremo fra poco ad apprezzare il valore. E non solo Filone, ma Giuseppe nelle Guerre Giudaiche, al libro 20, al § 12, degli Esseni favellando, dice a dirittura che studiavano con zelo i libri degli antichi, parole che suonano esplicita conferma a quanto disse Filone dei suoi Terapeuti. E questa è la seconda sorgente dell’Esseniche dottrine, i libri dei loro antichissimi, o per dir meglio la tradizione stessa deposta e formulata per iscritto.
Ora che abbiamo veduto, constatato questo duplice fatto, l’esistenza e la formulazione di una religiosa tradizione presso gli Esseni, tollerate che solo vi accenni da lungi la importanza e la grandezza delle sue conseguenze. Due poi ne emergono capitalissime, di cui siate, se vi piace, giudici voi medesimi. Riguarda l’una la tradizione rabbinica in generale; contempla l’altra più specialmente quella che mistica o cabbalistica si appella. Chi non vede la prima? Ella è una prova estrinseca e tanto più concludente della necessità e legittimità di una tradizione; ella[338] è un attestato dai rabbini indipendente, di quel principio in ogni tempo dai rabbini sostenuto, la tradizione; ella è un ausiliare, non cerco, non provocato, non interessato, della tradizione e dei tradizionalisti. E pure ammirate la forza del pregiudizio! Il Franck, che queste cose riferisce, non vide o vedere non volle la conseguenza che ne deriva, chiara, limpidissima in favore dell’antichità della tradizione. Per esso come per il Jost, celebre storico, come per altri nostri e non nostri dottissimi della Germania, le tradizioni nostre, le tradizioni rabbiniche non più oltre risalgono di due secoli innanzi l’E. V. Due cento anni prima del cristianesimo nacquero, se lor si crede, quelle tradizioni che poi fecero e fanno tanta parte integrale dell’ebraismo. E pure gli Esseni, e quel ch’è più i Terapeuti d’Egitto, accennano, alludono e religiosamente inchinano a una tradizione, a libri tradizionali. D’onde in essi della tradizione contezza, se alle origini non risale dell’ebraismo? forse glie ne giungeva notizia allora allora di Palestina? Mai no, dice il Frank, e dice bene, perchè tra Palestina ed Egitto relazioni intime dottrinali non esistevano; ed anche perchè, aggiungo io, un sistema specialmente religioso ch’è in sul nascere, una tradizione che manda allora appena i suoi vagiti, che s’insinua allora allora di contrabbando nelle antiche credenze, non può avere tanto di credito, d’influenza, d’autorità da trapiantarsi in regioni lontane e barbe gettare così profonde come tra i Terapeuti ha gettato; e sopratutto per che i Terapeuti spingon tant’oltre l’antichità dei loro libri tradizionali da trascendere di gran lunga quella data che pel Jost, pel Franck e per altri, segna delle tradizioni rabbiniche il nascimento. Ma di queste cose si taccia per ora per brevità, e solo ci basti avere come da lungi accennato a un ordine di prove che nuovo e vastissimo campo ci apre d’apologetica tradizionale.
Che diremo poi del secondo passo, della esistenza in tanta antichità, di libri, di opere tradizionali appo gli Esseni? E pure nulla di più provato, e nulla al tempo stesso di più sorprendente. E perchè dico sorprendente? perchè, vera verissima anomalia è cotesta ed eccezione alla regola farisaica; perchè rovescia da capo a fondo quel principio così trito così comune per cui si credeva e si crede assolutamente interdetta ai primi tempi rabbinici la redazione tradizionale; perchè inconcusso, generale, inviolato pareva quell’assioma rabbinico che suona le orali cose non potersi scrivere, e le scritte non potersi oralmente insegnare; perchè infine prima della Misnà, prima di tutte le opere talmudiche, prova il fatto presente la esistenza di libri tradizionali presso gli Esseni. E se mestieri fosse di prova dopo le citazioni ricordate, allegheremmo il Jost nella recentissima Storia del giudaismo e delle sue sètte. Il Jost è vivente autore consultatissimo, e per quanto non mi fu dato leggerne le scritture perchè dettate in tedesco, non è sì che oltre la conoscenza personale dell’uomo insigne, e di cui mi onoro, qualche contezza non siami pervenuta delle idee nell’opera contenute. Ecco che cosa dice il Jost: Les Esséniens (ei dice) n’observaient pas si rigoureusement les scrupules rabbiniques sur la transcription de la loi orale, et les Meguillat Setarim mentionnés dans le Talmud ont été écrits par des Esséniens. Non dirò dell’ultima congettura dei Meghillat Setarim, di cui spero avere non ha guari mostrato la ragionevolezza e probabilità quando mi fu dato produrre quella parlantissima variante che alle parole Meghillat Setarim sostituisce, come nel Jeruscialmi, Meghillat hasidin, nome, come ognun vede, più direttamente allusivo alla società degli Esseni. Ma quanto più non avrebbe il Jost al suo assunto giovato, se oltre ai Meghillat Setarim da esso allegati, citato avesse qual[340] vestigio della essenica bibliografia, nel Talmud quei casi numerosi parlanti, che nei due Talmud, nei Medrascim, in tutta, a dir breve, la biblioteca rabbinica de’ primi secoli, fanno fede apertissima di altre opere, di altri libri. E forse li avrà il Jost rammentati, forse non avrà obliato quei Sifrà deagadtà che ricorrono tanto di frequente nei libri talmudici, che figurano quali opere di gran lunga più antiche della stessa Misna, che il Talmud ci mostra in mano dei più antichi Tanaiti, e che collo stesso carattere, colla stessa vetustà figurano, mirabile a dirsi! nel Zoar medesimo, che li cita, li commenta ed ai più antichi e venerandi uomini ne attribuisce la redazione. Le quali cose potuto avrebbero più urgentemente concludere in favore del Jost, e più luminoso farci apparire il gran fatto di Libri tradizionali esistenti pria dell’epoca comunemente assegnata alla redazione delle tradizioni. Alla luce di questo gran fatto, che cosa diviene una delle più forti obiezioni, e quasi a dire l’Achille che contro lo zoar e le sue dottrine sieno state dirette dagli avversarj? Pareva a costoro impossibile che sotto l’impero di una legge così severa che ogni scrittura interdiceva delle tradizioni, mentre niuno ancora pensava a violarne il rigore, colle prime raccolte della Misnà non solo le tradizioni si scrivessero, ma quelle in ispecie che più sembravano segrete e gelose, le parti più sublimi della religione, i terribili misteri della Mercabà. E pure quest’argomento, che anche senza il fatto presente della società degli Esseni non saria rimasto senza risposta, al confronto di questo fatto, a paragone dello esempio illustre, provato, del nostro Essenato, nulla più conserva di terribile, e quella confutazione riceve più concludente, che mai sariasi potuto desiderare.
Che se provato non ostante il fatto, pur si volesse di[341] questo fatto medesimo, di questa strana eccezione indagare le cagioni, facile sarebbe le cause additarne più verosimili. Se diceste in qual guisa quel mistero, serbato per la tradizione comune, non lo fu per le più gelose e per le più rispettate, ecco che cosa risponderei. Vi mostrerei la forma nella quale queste ultime tradizioni furono dettate, la forma che assunsero in tutte le opere scritte, forma se altra fu mai metaforica per eccellenza, in cui l’allegoria procede così uniforme, così complicata, e in cui sì denso velo ricuopre il pensiero recondito, che tutta la penetrazione sfida dei più oculati ove alla parola scritta non soccorra l’insegnamento orale del maestro, a tal chè si può dire che niuna maggiore divulgazione procurare poteva la scrittura a cotal tradizione, che già non avesse pria di essere per iscritto deposta.—E non è questo il luogo di maggiormente diffondersi intorno questo argomento; ma se lo fosse, facil sarebbe mostrarvi di questo procedere dei dottori parlantissima analogia nei primi tentativi di redazione tradizionale, nei primi saggi Misnici talmudici ove questa stessa forma parabolica vediamo prevalere, ed ove le più antiche formule suonano brevi, oscure, talvolta metaforiche siccome i famosi Simanim di cui va copiosa la Biblioteca Rabbinica dei primi secoli.
Ma di questo si taccia per lo migliore, ed il corso riprendiamo della nostra storia. Noi sappiamo le fonti d’onde i dogmi loro attinsero gli Esseni: giusto è che alla cognizione dei dogmi stessi trapassando, quel cenno ne facciamo che le scarse memorie e il mistero appunto ond’erano circondati, ce lo consenton maggiore. E quando si parla di credenze, mestieri è pure di quelle eziandio favellare che falsamente agli Esseni si attribuirono, sì perchè mondati procedano d’ingiuste imputazioni, e sì perchè non è raro il vedere che sotto una[342] calunniosa imputazione alcun che si asconda di vero e di fondato, d’onde a guisa di malinteso abbia rampollato l’errore, il dogma supposto, e quindi la fama che accusava, in documento si converte in qualche guisa di storica verità.—Gli Esseni, come gli Ebrei in generale, furono appuntati di supposte adorazioni. Lo furono di adorare il Sole, e sopra un passo di Giuseppe Flavio fu fondata l’accusa. Io non istarò a decifrare il vero senso delle parole flaviane. Grecisti insigni vi si provarono, e quanto vi siano riusciti lo dicano i dubbj tuttavia perseveranti. Io farò meglio. Io supporrò chiara e limpida l’espressione di Flavio; io dirò che a dirittura egli attribuisca agli Esseni, siccome veramente io credo che gliele attribuisca, l’adorazione del Sole. Saranno per questo gli Esseni idolatri? dovremo intendere Flavio come lo intese il Prideaux, a rigor della lettera? Io credo che sia avvenuto al Prideaux ed a chi lo segue, ciò che avvenne agli antichi Missionarj Gesuiti nell’Impero cinese. Dove avendo udito i più famigerati filosofi insegnare la fede nel nulla, tornarono pieni di sorpresa e di ira raccontando dovunque in Europa che i filosofi Cinesi facevano pubblica professione di ateismo e nullismo. E quanto i buoni Padri andassero errati, quanto goffamente frantendessero la fraseologia dei Cinesi, facile sarebbe qui dimostrare se l’ora e l’argomento lo permettessero. Io credo che un qualcosa di simile sia pegli Esseni avvenuto. E a così credere già sarebbermi argomento sufficiente le tante prove e gli esempj cospicui che il Sole ci mostrano sotto un senso allegorico, lo mostrerebbe il Pastoret quando, a proposito degli Esseni, il Sole dice non essere stato per molti popoli che il Rappresentante dell’Ente Supremo; lo proverebbe l’uso, onde parla il De Jurieu nei termini seguenti: «De là est venue la coutume de se tourner toujours du côté de[343] l’orient dans tous les sacrifices qui se faisaient aux dieux célestes,» e di cui è discorso nel XII dell’Eneide, v. 172; lo proverebbe il costume prevalso nei prischi tempi nella Chiesa cristiana, di volgere verso l’oriente, e che solo Leone I condannò come intollerabile superstizione; lo proverebbe Fausto Manicheo quando compara Cristo a Mitra, il Sole Persiano, e dice, i doni recati dai Magi all’infante Gesù quelli essere appunto che gli orientali al Sole offerivano come oro, mirra ed incenso; lo proverebbe Ermogene che alla fine del II secolo referiva il culto di Cristo a quello del Sole, e il corpo di Gesù credeva assunto nell’astro del giorno; lo proverebbe Dante quando al Iº del Paradiso chiamava poetando Dio Sole degli Angioli:
E Beatrice cominciò: Ringrazia,
Ringrazia il Sol degli Angeli, che a questo
Sensibil t’ha levato per sua grazia;
lo proverebbe la Bibbia quando Dio chiama Sole il Talmud, quando narra di chi ad un Cesare che richiese di vedere Iddio mostrò il Sole ultimo dei suoi Ministri; e tutte queste prove già grandemente infermerebbero l’accusa contro gli Esseni articolata di adorazione del Sole. E poi quanti fatti nel culto ebraico potuto avrebbero dare origine a quest’accusa! Basti dire dell’orazione al cui proposito appunto, e tanto più è notabile, rammenta Giuseppe l’adorazione in discorso. Basti dire dei Vatichin, forse altro nome degli Esseni, che studiavansi principiare col sorger del Sole la prece di mattutino in adempimento del verso; basti dire della perfetta orientazione del Tempio di Gerosolima, intorno a cui, dice il Talmud, tanto affaticaronsi gli antichi Profeti affinchè la porta di Oriente ricevesse i primi raggi del sole; basti dire il nome stesso che quella porta recava[344] di porta del Sole; basti la lastra d’oro tersissimo che votò Elena regina e Nazirea, affinchè in luogo si situasse che ai primi raggi del sole infinite mandasse scintille nunziatrici ai sacerdoti del rito che cominciava. E se questo fosse il luogo di tal raffronto, aggiungerei della perfetta orientazione, oggi costatata, delle Piramidi, che oltre il loro carattere funerario, fa grandemente dubitare non forse qualche rapporto possano offrire col culto del Sole, con Osiri Dio infernale e Giudice delle anime nello Amenti come Cristosole scende in Inferno e ne trae le anime dei giusti, e giudice sederà de’ risorti nel giudizio finale.
Ma mirate la forza del vero! Egli è soltanto, egli è principalmente al confronto della simbologia cabbalistica che cessa ogni possibil recriminazione, che tacciono, anzi, e ciò di gran lunga più monta, che si spiegano, che s’intendono le accuse in discorso e che con tutta verità, con tutta precisione, si può dire degli Esseni che adoravano il Sole.—E certo lo adoravano perchè furono dei Cabbalisti progenitori, e certo ne fecero, come ne fanno i Cabbalisti, emblema, simbolo, principalmente nella loro Teologia; e certo non solo il sole, ma la luna, ma i pianeti tutti fecero parte della loro simbologia, siccome S. Girolamo lo attesta, rincarando sopra Giuseppe e dicendo gli astri tutti avere gli Esseni adorato.—S. Girolamo pare che compia l’accusa, ed invece non fa altro che finire il ritratto degli Esseni, che identificarli assolutamente coi Cabbalisti, che porre, a dir breve, l’ultima mano a quella identità da noi propugnata. Perciocchè mestieri è che il sappiate, non solo il Sole, simbolo fra ogni altro cospicuo, ma la Luna, ma Giove, ma Marte, ma Venere, ma Mercurio, e se ai tempi loro conosciuto fosse stato Urano, anche Urano avrebbero tolto a far parte della ricca e complicatissima loro Simbolica. Ecco[345] i veri astri, il vero sole, la vera luna che adorarono gli Esseni, il sole e la luna e gli astri del cielo dei Cabbalisti, ecco l’accusa; che accusa si, ma solo la identità dei due sistemi e delle due scuole, al difuori della quale io oso dire che ogni sforzo spenderebbe invano la critica a dare una spiegazione plausibile a questo culto strano idolatrico, che austeri gravi autori non temono di attribuire alla più scrupolosa e severa scuola che sorta sia nel seno dell’ebraico monoteismo. Ecco la chiave per capire ciò che ha di vero il sistema del Dupuis che trova in Cristo il sole, e negli apostoli i 12 segni dello Zodiaco; la chiave ne è la parentela tra Cristiani ed Esseni, e tra questi ed i Cabbalisti.
LEZIONE VENTESIMAQUARTA.
Sotto le forme di un’adorazione idolatrica, di un’apparente astrolatria del culto del Sole, noi abbiamo trovato una nuova analogia coi Cabbalisti, e al tempo stesso l’origine di quest’accusa, della supposta adorazione del Sole. Possiam dire che non è persino l’errore che non rechi in qualche modo il suo tributo al nostro sistema, e non concorra esso pure al più grande e più luminoso trionfo del vero. Noi abbiamo iniziato un sistema di critica storica intorno agli Esseni che, spero, vedremo parecchie altre volte vittorioso alla prova, dileguando quelle nubi che si frappongono alla contemplazione del vero, additando la sorgente di altri malintesi, e sotto l’aspetto paradossale di altri culti, di altre formule non meno strane nè indecifrate, accennandoci la equivocata e malcompresa simbologia dei Cabbalisti. Noi andiamo a vederne prova novella. Noi abbiamo un altro culto, un’altra accusa, un’altra idolatria da spiegare, la quale non reggerà, spero, al contatto del criterio da noi assunto alla storica interpretazione dell’Essenato, più che non resse l’altra accusa d’astrolatria, l’adorazione del Sole. Strano a dirsi! furono accusati gli Esseni d’adorare creature mortali, individui umani quali siam noi; di adorare due fratelli, il cui nome ci fu per ventura conservato, Elxai e Jessaus, di adorare eziandio le due loro sorelle, Marta e Martana. Queste cose udiva l’antichità e non ne stupiva.[347] Erano ancora poco distanti i tempi nei quali il cielo si popolava d’intere famiglie di dèi e di dee, di padri e figliuoli, di fratelli e sorelle; nè mancavano nella mitologia orientale e in quella di Grecia e di Roma gli esempj di numi scesi incarnati, e cogli uomini stessi conversanti in guerra, in amore, in politica, coi legislatori, coi guerrieri e colle ninfe dei boschi. L’Oriente ce ne porge tuttavia distinte le traccie. Il Lama, il gran Lama del Tibet, chi non lo sa? è creduto incarnazione perpetua di Budda, e ciò che non è men vero per esser men conosciuto, egli è che al fianco del Lama si adora dai Tibetani la Lamessa, incarnazione, siccome egli di Budda, così essa della sua virtù, del principio suo femminile, della sua energia, di quella che i Cabbalisti dicono Coah. Nè i tempi dei nostri Esseni correvano meno propizi a siffatte aberrazioni, e le incarnazioni erano, si può dire, allora le credenze alla moda. Testimonio, per non dire di altri, quel Simon mago da Dante nostro apostrofato coi miseri seguaci, il quale non solo adorato era qual uno degli Eoni o delle emanazioni di Dio, ma la donna sua modello, siccome dicono, non troppo specchiato di onestà, riscoteva eziandio al suo fianco pubblici divini omaggi qual Dea; reputata essendo qual sua virtù e qual emanazione ella stessa del femminile principio. Ho io mestieri parlare del cristianesimo? Religione all’Essenato contemporanea, ella si fonda sul dogma capitale della incarnazione dell’uomo-Dio, che contiene, come dice Gioberti, in germe tutto il cristianesimo, e questo tutti sanno e perfettamente concordano. Ma se il cristianesimo ebbe il suo Elxai, ebbe ancora il suo principio femminile, la sua Martana, la sua incarnazione femminile. Chi il crederebbe? Si accusano oggi i Gesuiti di aver effemminato il cristianesimo introducendovi il culto di Maria, e troppo più alto elevando,[348] che non s’addica, il seggio di Colei che fu a Cristo e figlia e sposa e madre, secondo la sentenza Manzoniana. Tuona contro di essi Gioberti, e adulteratori li chiama insieme ad altri del dogma e della fisonomia del cristianesimo. E pure, sel tolleri in pace la sua grand’anima, i Gesuiti, se non hanno ragione, non hanno nemmeno tutta la colpa che gli si vuol affibbiare. Il culto di Maria è antico antichissimo più che non si crede. E non solo fu culto secondario e di dulia, ma primario e di latria, se si risale a’ prischi secoli e presso i cristiani d’Oriente, specialmente fra gli Arabi. Perciocchè non solo ci parla S. Epifanio della setta dei Colliridi, che ponevano la Vergine Madre al pari di Dio e culto rendeangli di vera divinità, offrendogli una focaccia in forma di serpe, d’onde il nome loro di Colliridi: ma sino nel famoso concilio Niceno furono padri che sostennero la divinità della Vergine dicendo, due divinità doversi adorare, oltre il Padre, il Cristo e la Vergine. La quale associazione del culto di Dio a quello di Maria diede origine alla setta dei Marianiti, e che sotto questo nome figura nel concilio di Nicea, e più o meno prospera protrasse la sua esistenza fino al 6º secolo dell’èra volgare, in cui eranvi tuttavia cristiani che facevano della Vergine una Dea, chiamandola membro e compimento della Trinità. Il quale errore, come quello di Simone il Mago, come quello attribuito agli Esseni, fu una deviazione e una corruzione dei principj Cabbalistici; come deviazione congenere, benchè serotina, fu quella che eresse in oggetto di culto divino il Pseudomessia Sciabetai Zebi, e ciò ch’è di gran lunga più degno di nota, la sua donna istessa, quale incarnazione femminile di una delle divine emanazioni, come probabilmente frutto dello stess’albero fu il culto della Dea ragione, o sapienza, o Hohmà, personificata in una prostituta per quella corrente segreta che[349] univa le Francomassonerie allora erompenti alla luce cogli antichi istituti Pitagorici e Cabbalisti. E come finalmente un esempio preclaro ci s’offre ai tempi profetici dell’adorazione di una Dea, della Regina dei cieli, Regina coelorum, come oggi è chiamata la Dea Maria, e contro di cui tuona Geremia dicendo: I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, e le donne con grano e farina compongono focaccie e fanno libazioni alla Regina dei cieli. Posto ciò che hanno di comune tutti questi culti diversi, dobbiamo domandare a noi stessi: caddero eglino gli Esseni in questo culto idolatrico che gli s’attribuisce; adorarono essi in due fratelli in due donne carnali, in una creatura mortale la incarnazione di un principio divino? precipitarono essi nell’errore di Simon Mago, dei Marianiti, di Sciabetai Zebi, e di tutti i fautori in generale delle avatara o incarnazioni indiane, orientali, greche, cristiane; o non piuttosto mantennero il dogma cabbalistico nella sua purità, serbando inviolati i confini tra l’ideale e il reale, tra la mente e il corpo, tra il divino e l’umano; e se accusa vi fu, solo a malinteso, solo ad equivoco si dovrà imputare? Io credo che nulla ci autorizzi a menare l’imputazione per buona. Se gli Esseni parlarono di fratelli e di sorelle, se ne dierono i nomi, se ossequiaronli quai numi, nulla ha tutto questo di sorprendente per chi per poco abbia svolto le pagine dei Cabbalisti, presso i quali, come Oromaze e Arimane tra i Persiani, come Osiri e Tifone tra gli Egizj, come Giove e Plutone tra i Greci, tutti fratelli ma nemici ed antagonisti tra loro, così tra essi Jacob e Esau, personaggi storici quanto altri fur mai, prendono nonostante veste simbolica e stanno a significare due idee, due principj tra essi contraddittorj, e che non è qui luogo di costatare, di definire. Non sono persino i due nomi che la tradizione ci trasmise dei due fratelli dagli Esseni adorati,[350] che non stiano in qualche modo a provare la bontà del supposto. Elhai è nome mirabilmente conservato, ed oltre il suo senso biblico usitatissimo di Dio vivente, appartiene alla nomenclatura cabbalistica delle Sefirot, e sta a significare quella in ispecie che il nome reca di Jesod, il qual nome a parer mio fu riprodotto nel nome essenico di Jesseus, se pure lo stesso essenico Jesseus, come par più probabile, non sia il José Rabbinico identico al biblico Josef, che è lo schema storico rappresentante appunto la Sefirà di Jesod. Che se questi sono i fratelli Essenici e il loro nome, che diremo delle loro sorelle adorate, Marta e Martana? Non solo qui ritornano non meno espressive in campo le analogie pagane, Isi e Nefti in Egitto, Giunone ed Ecate in Grecia, e via discorrendo, ma tornano non meno e forse anche più parlanti le analogie cabbalistiche. Marta e Martana sono nomi quasi integralmente conservati, e ci offrono le fattezze quasi inalterate dei nomi cabbalistici Martà e il Meerat del Zoar, come Mariana è corruzione della Matranita Cabbalistica, la prima accennata, secondo il Zoar, nel Jei Meerat, l’altra sinonimo di donna e signora; come, mirabile a dirsi, il nome greco di Giunone, Hera, fu sinonimo di donna e signora, ed ambo sorelle; l’una buona e l’altra rea; l’una autrice di bene, l’altra di male; l’una identica a Lilit regina delle tenebre, l’altra identica alla talmudica Scehinà; l’una nel suo nome istesso recante il segno della esecrazione Meerat da Meerá, anatema maledizione, l’altra Matranita, da Matar, guardiana e custode. Però, affrettiamoci a dirlo, gli Esseri or ora ricordati non furono solo enti metafisici e mere astrazioni; per quella concordanza che è propria dei Cabbalisti trovare tra l’ideale e il reale, essi, gli Esseni, tolsero dalla storia i personaggi rammentati, e ne fecero copie e rappresentanze dei loro esemplari e prototipi celestiali. E[351] comecchè non sia officio di queste lezioni discorrere della storia degli Esseni, ma solo della loro teologia, pure per quella connessione che vedemmo or ora tra la storia e il dogma, ed anche pel valore secondo me insigne di questo tratto della loro istoria, non sarà male che per noi se ne faccia qui stesso breve menzione. Egli è a S. Epifanio che noi dobbiamo le presenti indicazioni. Nel suo libro delle Eresie egli rammenta come, imperante Trajano, l’istituto degli Esseni subì una modificazione, o come oggi direbbesi, una riforma. E chi ne fu, al dir d’Epifanio, l’autore? Ei fu un Essena per nome Elxai, del quale ci referisce il Padre istesso in tre sommi capi le riforme introdotte. Egli è gran ventura per la storia degli Esseni, che un momento così interessante della loro esistenza ci sia stato conservato colle sue più minute circostanze, e fra poco vedremo di quante conseguenze sia fecondo per il sistema nostro d’identità cabbalistica. Ci narra Epifanio le riforme introdotte, e queste sono in numero di tre. Consiste la prima nello insegnare ch’ei fece ai seguaci a giurare per le cose create, pel sale, per l’acqua, per la terra, come se fossero, dice Epifanio, altrettante divinità. Consiste la seconda nella condanna ed abolizione del celibato e quindi nella riabilitazione del matrimonio. La terza poi suona alquanto più dura ad intendersi, ma spero riceverà non scarso lume dal nostro sistema. Secondo S. Epifanio, Elhai, il riformatore della scuola, avrebbe insegnato ai seguaci la dissimulazione idolatrica, che è quanto dire, a simulare culto, ossequi, adorazione ai numi del Paganesimo quando altrimenti non potesse farsi senza presentissimo pericolo della vita. Noi abbiamo qui nelle parole di Epifanio un documento importantissimo, i cui rilevantissimi insegnamenti mestieri è analizzare a parte a parte. Abbiamo in primo luogo cenno, memoria di un’epoca[352] di crisi religiosa per lo Essenato, in cui gli ordini antichi subirono una qualunque siasi metamorfosi per opera d’un capo-scuola, d’un riformatore per nome Elhai; e questo fatto non potrebbe non consuonare mirabilmente col maestrato cabbalistico che si assegna nel Zoar a R. Simone Ben Johai, e coll’immenso impulso che si dice da esso alla teologia comunicato, onde il suo secolo qual secolo ci si offre impareggiabile negli Annali dello istituto. Ed abbiamo la data. La quale, fissata da Epifanio sotto l’impero di Trajano, consuona con quella che segna il fiore, l’apogeo della scuola cabbalistica, e colla predicazione e riforma di R. S. B. J.; fatto altresì di massimo rilievo in quanto stabilisce eziandio una concordanza cronologica, fra la riforma di una parte dell’Essenato e quella narrata dal Zoar della scuola cabbalistica per opera di R. S. B. J. Ma qual’è della Essenica riforma l’autore, e qual nome ei reca in bocca ad Epifanio? Egli è Elhai, che oltre l’offrirci non ispregevole concordanza di suono con Ben Johai, col qual nome semplicissimo è designato non rade volte nel Talmud e nel Zoar, è nome pregno altresì di altre preziose indicazioni, che tutte alla persona collimano e ne riconducono di R. S. B. J. Poichè, s’egli è vero che voi udiste, or non è molto, essere questo nome divino, e speciale appellazione della ottava Sefirá o Eone, non è men vero che anche nel suo senso più ovvio di Dio vivente si addica in sommo grado al principe dei Cabbalisti, a R. S. B. J. Non voglio qui confortare l’asserto con lontane ma pur vere analogie bibliche e talmudiche, comechè grandemente ne rimarrebbe giovato l’assunto; ma mirando senza più al cuor del subbietto, io recherò in mezzo tali prove ed esempj tolti a dirittura al Zoar istesso, dei nomi cioè di Dio applicati per magnificenza di traslato al divinissimo uomo, che ognuno, spero, dovrà[353] dirsi dell’argomentare contento. Or eccone uno. Se la mente non erra, è il caso in cui il Zoar chiama con nomi divini il gran maestro della scienza divina, ed è là ove chiedendo Man aadon adonai? risponde a dirittura, Da ù R. Simone ben Johai, testo empio, scandaloso, e degno subbietto alle recriminazioni infinite che levarongli contro, ove colla grossolana s’interpreti e inescusabile ignoranza dei tempi, degli uomini, del linguaggio, delle dottrine, ma innocentissima e naturalissima espressione, se di tanto vorremo consultare la Bibbia, che appunto per avere prodigato gli epiteti celestiali agli uomini, alle cose terrene, fu causa benchè innocente che altri fraintendendone il significato ne torcessero il senso fino a trovarci le traccie di dottrine dall’Ebraismo le più aliene.
Abbiamo veduto la data, il personaggio, il nome del riformator degli Esseni, e tutti coincidono col riformatore dei Cabbalisti. Troveremo egual concordanza nella materia stessa della riforma?—Veggiamo i particolari conservatici da Epifanio. Insegnò, ei dice, ai seguaci a giurare per le creature, pel sale, per l’acqua, per la terra, quasi fossero Enti divini, parole che suonano strana, mostruosissima accusa, ove alla lettera si capiscano per un dottissimo e nobilissimo istituto del quale ci trasmisero gli antichi i sensi più elevati monoteistici, in fatto di religione. Ma il sistema nostro, oso dirlo apertamente, è il solo che lasci un senso possibile alle parole di Epifanio, che purghi gli Esseni dalla taccia d’idolatria senza distruggere d’altra parte, anzi confermando e spiegando un attestato così esplicito, così grave qual è quello di Epifanio. La simbologia, le figure, i tipi cabbalistici saranno per noi il filo conduttore, il filo d’Arianna. Nella cui varia e ricchissima nomenclatura i nomi di sale, di acqua, di terra, figurano tra[354] i primi quai terreni rappresentanti e tipi e figure delle virtù, degli attributi, delle emanazioni divine, e di cui facile sarebbe qui riprodurre le rispondenze cabbalistiche, se opera vana non mi paresse avvolgermi in ricerche puramente nominali, il cui senso non è qui certo il luogo di sindacare, di stabilire. Per lo scopo nostro, per la interpretazione del documento di Epifanio, bastano le cose discorse riguardo al primo soggetto delle rammentate riforme. E basterà non meno ricordare la seconda innovazione rammentata da Epifanio. La quale consiste nella condanna e abolizione del Celibato. Io vi prego ridurvelo alla memoria. Quando passavamo in rassegna le istituzioni degli Esseni, quando in queste volevamo trovare quell’identità da’ nostri perpetuamente propugnata tra Esseni e Cabbalisti, quando ci imbattemmo nel Celibato, un ostacolo ci parve sorgere a proseguire nella favorita nostra dimostrazione, e a rimuoverlo adoperammo fatti, argomenti che non sono, se io non erro, da prendersi a vile: ma quanto meglio non riesce allo scopo, quanto più naturale e piena eliminazione della difficoltà in discorso non è egli il fatto presente, la condanna, l’abolizione del Celibato? La quale non solo meglio identifica l’Essenato coi Farisei, ma più specialmente lo immedesima coi Farisei Cabbalisti, i quali a segno tale rincararono nel Zoar sulle prescrizioni del matrimonio e della propagazione della specie, che certe frasi così severe vi corrono, che ebbero bisogno di miti ed attenuanti interpretazioni? Ed ecco il secondo capo della riforma di Elhai coincidere appuntino colle idee e col sistema dei Cabbalisti. Che sarà poi del terzo punto della Essenica riforma, della dissimulazione idolatrica che si dice ammessa, sancita dal riformatore Elhai? E in qual guisa potrà una sì strana concessione consentire colle idee e coi principj di Ben Johai,[355] di quegli che crediamo identico all’Essenico Elhai e che è uno dei più grandi e famosi dottori tra i Farisei? E pure io non credeva a me stesso quando l’opinione testè udita io lessi nelle Agaot Maimoniot, attribuita a R. S. B. J. E perchè meglio comprendiate di chi si tratta, mestieri è sapere come, secondo le opinioni più comuni, più accettate, tutti i precetti di Dio, vuoi positivi vuoi negativi, possono impunemente prevaricarsi quando vero e presentissimo si corra pericolo della vita, tranne tre soli, la cui osservanza deve anteporsi alla vita istessa e sono: Idolatria, Incesto ed Omicidio. Ora aprite Maimonide nel trattato d’Idolatria, e mentre nel testo Maimonideo troverete la decisione formulata nel senso appunto or or ricordato, volgendo per poco gli occhi alle note che vanno attorno al testo, e che si dicono Agaot o Scoree Maimonidee, leggete a proposito delle tre eccezioni rammentate: Ad onta dell’opinione di R. Simone che disse prevarichi e non muoja, ch’è quanto dire, per parlare col linguaggio di Epifanio, ad onta del riformatore degli Esseni Elhai che insegnò fra l’altre cose ai seguaci dissimulazione nella Idolatria.
Noi abbiamo compiuta gran parte del nostro assunto; abbiamo trovato l’origine delle voci accusatrici che corsero nell’antichità contro l’idolatria degli Esseni; abbiamo trovato l’Edipo della pretesa loro astrolatria; e della loro antropolatria eziandio, ossia dell’adorazione degli esseri umani. I quali furono ad un tempo virtù divine e storici personaggi, ma l’uno e l’altro furono senza mischianza idolatrica, senza incarnazione alla foggia del Cristianesimo e del Buddismo, ma in virtù di quel rapporto che insegnarono i Cabbalisti esistere fra un grand’uomo e una grande idea, fra l’ideale divino e il sensibile umano, fra le idee eterne che risiedono in Dio e la loro esplicazione e sviluppo mondiale per opera[356] or di questa or di quella espressione e veste finita di una idea infinita.—E tutte queste cose vedemmo e vediamo sempre più ridondare al trionfo di quella identità che stimammo guida sicura e fedele in queste nostre ricerche. Ma Epifanio con una frase compie il ritratto di R. S. B. J. quando dice che Elhai lasciò un libro ai seguaci delle sue profezie, e questo libro, se il giudizio non erra, non è certo il Zoar tal quale ora si trova, in cui tanti diversi e posteriori vestigi tu riconosci al grande Teosofo, ma è certo la prima idea, il primo saggio, il primo nucleo, il primo germe di essa opera, e sopratutto i pensieri, le dottrine e la distribuzione fra i discepoli dei vari offici di redazione; è quell’opera per cui disse il gran maestro nell’ultima grand’assemblea: Rabbi Abbà scriva, ed Eleazario mio figlio mediti o detti; è l’opera da cui potrebbe uscire ed uscirà la restaurazione e il rinnovellamento dell’Ebraismo.
LEZIONE VENTESIMAQUINTA.
Escluse, spiegate le credenze ingiustamente attribuite agli Esseni, trovata l’origine degli errori che gli si apposero, noi dobbiamo procedere all’esame delle loro dottrine, di quelle intorno a cui niun dubbio sorse a impedirci l’ammissione.—Noi cominceremo da quella parte che riguarda l’uomo, la sua natura, il suo destino, i dogmi tutti che si attengono all’uomo, ai suoi rapporti con Dio e col Mondo; da quella parte insomma delle scienze filosofiche che si chiama Antropologia. La quale formò sempre parte di tutte le religioni, quando si studiarono sopratutto di conciliare la libertà dell’uomo e la potenza di Dio, l’arbitrio e la grazia, l’azione di Dio e la responsabilità dell’uomo.—Il quale problema essendo stato subbietto di una triplice soluzione, così dà origine a tre scuole, a tre sistemi, a tre modi di concepire i rapporti morali, etici di Dio coll’uomo. Fu per gli uni la libertà immolata all’azione di Dio; fu dagli altri ogni influenza negata al divino volere; fu pei terzi l’azione di Dio e quella dell’uomo in guisa contemperate che la responsabilità intera rimanesse all’uomo, senza ledere la universalità e pienezza dell’azione divina. Ora queste tre soluzioni che si verificano in ogni età, in ogni religione, che ebbero rappresentanti in seno al Cristianesimo, nei cattolici, nei giansenisti e calvinisti, e nei pelagiani, si verificò, dice Giuseppe, nel giro delle[358] credenze ebraiche, e furono dalle tre scuole rappresentate che più illustri sorsero nell’Ebraismo.—Proclamava il Farisato destino ed arbitrio—grazia e libertà. Volere di Dio e volere dell’uomo, quali forze insieme cooperanti all’atto dell’uomo. Pretesero i Sadducei, autonomo assoluto il libero arbitrio.—Vollero per ultimo gli Esseni, aggiunge Filone, che ogni atto dovesse referirsi al destino.—Qui vediamo cosa che sembra a prima vista osteggiare il nostro sistema d’identità essenico-cabbalistica. Vediamo gli Esseni procedere distinti dai Farisei: non basta, li vediamo discordi in una delle quistioni più capitali che siensi divise le coscienze negli antichi e odierni tempi, e se dovessimo stare alla scorza delle espressioni flaviane, ne dovremo concludere non solo la distinzione delle due scuole, ma la loro ostilità eziandio. Ma quanto ingiustamente! Egli è certo che bene s’appone Giuseppe quando i Farisei disse conciliatori e partigiani della grazia e dell’arbitrio. Basta volgere uno sguardo alle pagine talmudiche per vedervi alternativamente costatata l’azione reciproca combinata dell’arbitrio e del volere di Dio nelle azioni dell’uomo, e che parrebbemi opera soverchia in questo lungo rammemorare. Ma non meno, a veder bene, s’appone Giuseppe quando gli Esseni dice, tutte le umane azioni riferire al destino.—Ma qual destino? Io non so che cosa abbia inteso così dicendo Giuseppe.—Forse concepì il destino degli Esseni, nel senso volgare, dello stoicismo contemporaneo e del paganesimo, forse a significare cosa ben diversa di una cieca fatalità, si valse di un vocabolo che forse il più acconcio, benchè inadeguato, suonava allora a significare l’essenico concetto. Checchè ne sia, la formula essenica non potrebbe meglio consuonare colle dottrine dei Cabbalisti, i quali soli proclamarono in seno dell’Ebraismo un[359] principio che vano sarebbe cercare nel Talmud, cercare nei Medrascim, ed in qualunque altro libro estraneo alla scienza dei Mistici; forse perchè solo armonizzando colle rimanenti loro dottrine può deporre quel senso immorale e fatalistico che altrimenti avrebbe immancabilmente. Quando il Zoar, referendosi a libri e dottrine ad esso anteriori, insegnava: Tutto dipendere dal Mazal—fosse ancora la Legge di Dio deposta nell’Arca—annunciava quel principio che meglio consuona col dogma essenico asserito da Flavio, e tanto più intimi ne svela i rapporti quanto più speciale e peculiarissimo ai Cabbalisti appartiene.
Se questo ne fosse il luogo, non malagevole tornerebbe il mostrare quanto il Cabbalistico Mazal si dilunghi da quello che comunemente s’appella Destino. E forse non andrebbe errato chi volesse trovare nell’antico Fato dei Greci alcun che di consimile al Mazal cabbalistico, non essendo, a quel che pare dalle antiche teogonie, destituito il greco di ogni intelligenza e volontà, e solo in tanto distinguendosi dalla folla degli Dei, che a differenza di essi siedeva il Fato in regioni ove le passioni e le lotte umane non giungevano a disturbarne gli impassibili e sovrani decreti. Quello ch’è certo si è, che il senso, la etimologia della parola Mazal bene dà a divedere a chi la intende quanto intimamente si connetta colla Dottrina dell’Emanazioni, null’altro a mirar bene significando che influsso, emanazione, o come dire vogliamo discorrimento.
Ma noi dobbiamo procedere oltre nell’esame degli essenici dogmi, e poichè dell’anima umana abbiamo preso in prima a discorrere, dopo avere stabilito quei rapporti che a Dio la congiungono, al dire degli Esseni, mestieri è pure che di quei rapporti pur noi si favelli che, secondo gli Esseni, al suo corpo istesso la congiungevano.[360] E intorno a questo, Giuseppe e Filone son categorici. Per essi, o per dir meglio per gli Esseni di cui ci riferiscono le credenze, se l’anima al corpo si unisce egli è a suo malgrado, egli è, dicono essi, per una certa invariabile attrattiva che la spinge a subire tutte le vicende della vita terrena insieme al corpo. Ora chi potrebbe negarlo? Chi potrebbe dire che non siano queste le idee, e i più ovvj insegnamenti dei Farisei? Non solo la Misnà, e la più popolare della intera compilazione, ne intima la verità del principio al corhah attà nozar, ma i Rabbini posteriori prendendo a svilupparne i dettati, siccome è loro stile, e drammatizzando la troppo austera semplicità del placito minico, dicono di un Angiolo che invita le anime a rinserrarsi nel femminil chiostro, nell’atto della concezione; dicono delle repulse, delle resistenze che l’anima gli oppone, siccome quella ch’è rifuggente dalle turpezze e infermità della carne; e dicono infine che agli inviti ed alle esortazioni succede la forza, un vero compelle intrare, ma intimato questa volta dal Dator della vita. E qui sarebbe il luogo, dopo le mostrate analogie col farisato, di far scendere in campo Platone e la sua scuola, da cui appunto s’intitola principalmente la discorsa teoria della unione forzata col corpo; e tra i Dottori e gli Esseni da una parte e Platone dall’altra, quei rapporti additarne che corrono forse speciosi e parventi meglio che profondi e reali. Ma di rammentare Platone un dotto rabbino olandese mi dispensa, l’antico Menascè ben Israel. Il quale nella dotta e pia sua opera, Nismat Haïm, non mancò di notare, versato qual egli era nelle filosofiche discipline, come la Misnà, come il Medrass, quello stesso insegnavano che aveva insegnato Platone quando dicevano che gli spiriti scendevano riluttanti a rinserrarsi nel corpo. Il Menascè ben Israel avrebbe potuto aggiungere anche i Pitagorici,[361] i quali, come avvertiva il Ritter nel primo volume della Storia della filosofia, precorsero a Platone in questo modo di concepire l’unione dell’anima col corpo. Se non che, come io dissi non ha guari, l’analogia tra Platone e gli Esseni e i Farisei è più apparente che reale; e se questo fosse il luogo di rilevare la distinzione profonda che divide le due Teorie, tanto più volentieri lo farei quanto più la Teoria platonica ci offre della vita terrena un concetto punitivo e sinistro, che non entrò giammai nei pensamenti dei Farisei e tanto meno dei Cabbalisti. Ma di queste cose ci basti qui lambire soltanto la superficie, dovendoci pel compito nostro interdire ogni benchè seducente digressione che troppo lungi ci meni dal subbietto in discorso.
Che se questi sono dell’anima i rapporti con Dio e quelli col corpo, in qual guisa ne compresero gli Esseni la natura e l’essenza? Distinsero, se bene m’appongo, la sua parte materiale da quella che dissero il Noo, ovvero intelletto. E la parte materiale dissero essere il sangue.—A queste parole chi non ricorda Mosè? Aveva pur egli stabilito, in termini che più non si potriano formali, l’anima essere il sangue. E non solo Mosè, che della immaterialità delle anime umane o si tace, o di oscuri accenni si accontenta; ma i Rabbini pur essi, che questa immaterialità riconobbero, dissero come Mosè l’anima, l’anima del corpo, il principio vitale, il pneuma, come oggi si direbbe, essere nel sangue; prova se altra fu mai concludente come a torto si vorrebbe intendere l’espressione mosaica com’escludente la immaterialità delle anime, dappoichè i Rabbini che a questa formalmente ossequiarono, non si astennero dall’usare la stessa espressione che Mosè aveva usato prima di loro. E non solo la riproduzione della frase mosaica n’esclude la interpretazione materialistica, ma[362] quel senso ce ne offre più adeguato che i Dottori intesero nell’adoprarlo. Il quale si connette colla triplice divisione che fecero dell’anima i Dottori, i Cabbalisti; distinguendone tre gradi o tre parti, la prima che dissero vegetativa, l’altra sensitiva, la terza intellettiva. E la prima forse è quella che dissero parte materiale, e posero il suo seggio nel sangue. Ma non solo sentenziarono del principio di vita e del suo seggio, ma di questo seggio istesso, ma del sangue ancora dierono la teoria fisiologica. Il sangue pegli Esseni era composto di due elementi, di aria e di fuoco. Il quale principio non solo meglio si comprende al paragone dei sistemi medici agli Esseni contemporanei, ma se io troppo non oso, un senso tuttavia potrebbe avere anco nei sistemi dei giorni nostri. La storia della antica medicina, specialmente quella dottissima di Giusto Hecker professore berlinese, ricorda sistemi pressochè agli Esseni contemporanei, che ammettevano nelle arterie circolante una specie di pneuma o spirito vitale, rispondendo con singolar disinvoltura a coloro che obbiettavano l’esperienza la quale mostra l’arteria ferita mandare sangue. Chi volesse poi in linguaggio moderno tradurre l’essenica dottrina, la combinazione di aria e di fuoco, potrebbe pensare alla combustione ed all’ematosi, ambidue effetto della respirazione, la prima palesantesi nella emissione del carbonio, la seconda consistente nella ossigenazione, ch’è quanto dire nell’introduzione dell’ossigeno nella massa sanguigna.
Ma gli Esseni, noi lo abbiamo veduto, riponevano in un principio diverso la causa, l’origine del pensiero. Questo principio immateriale è chiamato da Filone il Noo e talvolta Pneuma o spirito divino, ed in mancanza di ragguagli più diretti della essenica nomenclatura dobbiamo contentarci delle indicazioni di Filone, che può[363] avere, come dicemmo altravolta, rivestito di forme greche l’ebraico pensiero, ma che lo mantenne, così è lecito credere, immune di sensibile alterazione. Però non è sì che questa fedeltà filoniana qualche volta non si smentisca, e che obbedendo forse alla necessità in cui era di far comprendere ed accettare dal mondo pagano le dottrine dell’ebraismo, non si valga talvolta di espressioni un po’ equivoche, testimone quando parla della natura dell’anima, quando dice le anime umane della stessa natura essere degli angioli; anzi quando null’altra differenza addita tra le une e gli altri, se non la discesa ed il soggiorno nel mondo dei corpi.—Per Filone può l’anima discendere ed abitare nei corpi una sol volta, può altre fiate ripetutamente vestire la forma carnale, può infine restare in eterno immune da ogni coabitazione e commercio coi corpi.—E in quest’ultimo caso, dice Filone, ei sono gli angioli, anzi e’ sono i genii di cui parlano i filosofi.—Se Filone intese parlare con filosofico rigore, egli ha torto nel senso dell’ebraismo. Il quale tanto profondamente distinse la natura dell’angelo da quella dell’uomo, che niuna più famosa disputazione narrano gli annali dell’ebraismo di quella che a proposito s’impegnava della preminenza dell’una e dell’altra. Nella quale i nomi più famigerati figurano non solo del Talmud e dei Medrascim, ma dei più celebri posteriori Dottori eziandio, quali furono, a mo’ d’esempio, Rabbenu Saadia, Abenesra, ed una schiera illustre di dottori cabbalisti. Ma quanto ad un tempo fedele e felice interprete ai Pagani non si mostra Filone delle antiche dottrine degli avi suoi, quando parla del soggiorno delle anime!—Udito avevano i Pagani i lor filosofi insegnare, avere le anime dei trapassati per abituale loro soggiorno l’atmosfera, o come allor si diceva l’aria intermedia; e basta leggere il Ritter e i cenni ivi contenuti sulle scuole[364] antisocratiche, per vedere quanto comune fosse tra gli antichi questo pensiero sulla sede degli spiriti. Or bene che credete che faccia Filone? Egli traduce nel linguaggio del paganesimo ciò che aveva letto nella Bibbia, non già delle anime de’ giusti ma di quelle dei riprovati, ciò che disse Abigaille accennando alle sorti eterne dei nemici di David, i quali dic’ella: Andranno balestrati in qua e in là, come pietra nella balestra, ciò che gli era giunto da Palestina qual eco della mitologia rabbinica, che ripone nell’aria intermedia gli spiriti che vi nuotano, dice il Talmud, in numero infinito; e per toccare di alcun che di più serio, ciò che aveva imparato nelle dottrine essenico-cabbalistiche, avere le anime residenza nella sefirà che si chiama Jesod, e che per colmo di maraviglia, reca in quelle dottrine il nome di Rakia, di atmosfera, alla quale, dicono essi, alluse Mosè quando parlò degli uccelli che volano per l’aria pei quali intesero le anime che hanno sede e radice nell’atmosfera divina cioè nel Jesod, come Dante chiamò l’angelo, nella Commedia, divino uccello. E siccome tutte queste cose aveva udito e imparato Filone, così quando scrivendo per i Pagani volle dire del seggio delle anime, dir volle in guisa che la terminologia convenzionale restasse intatta, che udito avea dai maestri di religione, in guisa che rispondesse alle idee che d’abantico avevano i Pagani addottato forse per un’equivocata interpretazione dell’antica simbologia patriarcale, e disse, come udito avete poco anzi, aver le anime seggio nell’atmosfera. Ma se i dotti intendevano per rakia, atmosfera, tutt’altro che l’aria che ne circonda, se intendevano la matrice, il repositorio delle anime umane, anzi l’anima universale, il Paramatma degli Indiani, la Psiche di Platone, non è sì che il popolo non intendesse della vera e propria aria che ne circonda, non è sì che gli stessi cabbalisti[365] segnatamente l’Aari non dicesse di vedere le ascensioni e le discese degli spiriti umani nell’aere circostante, non è in somma che Filone non fosse interprete fedele, ancorchè alla lettera interpretato, delle credenze almeno popolari degli avi nostri.—Però eran tra i due popoli, tralle due mitologie una differenza essenziale. Pei Pagani era l’aere seggio delle anime indistintamente, fossero esse buone o ree uscite da questa vita. Pei nostri, per l’Aari, per i cabbalisti, egli è seggio soltanto di quegli spiriti che la sorte balestra errabondi e incerti negli spazzi infiniti, indegni del cielo per che non l’han meritato, indegni ancora dell’inferno e de’ demonj che vi soggiornano per che troppa onoranza avrian d’elli. Io vorrei che tutto comprendeste il poetico magistero dei teologi nostri ed insieme la profondità filosofica che vi si acchiude: prova, se pur altra ne occorresse, che la poesia non è che una filosofia potenziale e implicata, come la vera filosofia non è che poesia esplicita ed attuale, ed altra differenza non correndo tra esse se non quella che corre fra il pensiero intuitivo e il pensiero riflesso.—Chi non vedesse di questi pensieri e teorie cabbalistiche che la corteccia, chi non risalisse ai principj che dominano tutta la scienza, altro non si vedrebbe che vaghe sì e piacevoli finzioni in cui il cielo, l’aria e l’inferno sono designati qual triplice seggio delle anime beate, sospese, e di quelle penanti: ma per poco che si risalga ai principj, qual metamorfosi! Fra i quali, principio capitalissimo per l’ordine morale cosmologico, provvidenziale, egli è quello che ogni cosa terrena dice copia, ombra, riflesso di una idea che vive eterna e sta nella mente divina, principio che ammette anteriore e superiore a questo mondo dei corpi, in Dio, cioè nell’assoluto, nell’infinito, un mondo ideale che è la parola interna di Dio, il Logos endiatetos di Filone, il piano architettonico,[366] il prototipo celeste, il disegno infinito anzi la verace realità, l’essere verace di cui le esistenze corporee non sono che ombre che si proiettano dalla mente di Dio, che figure che passano come le ombre degli astri che si proiettano nell’ecclisse come le vesti di cui parla il Salmista, che i rami estremi del grand’albero della creazione il quale ha le sue radici nell’intelletto divino nell’eterno esemplare, vero Olam abbà, vero paradiso, vera beatitudine. Ora, se rispetto al nostro pianeta, tre si distinguono principalissime regioni; se vi ha la regione celeste dimora degli astri; se vi ha l’aria intermedia, l’atmosfera che tramezza tra il cielo e la terra; se vi ha, come è provato in Geologia, un fuoco centrale, un centro incandescente che è il centro terreno perpetuamente in fusione, e se, ricordatelo bene, il mondo fisico è esemplato sul modello divino; se tutto ciò ch’esiste quaggiù ed ogni forma e relazione delle esistenze tra loro, ed ogni stato terreno risponde a uno stato celestiale supremo che lo ha generato, come l’originale crea la copia; se è vero che non è che il pensiero di Dio estrinsecato, come il pensiero di Dio non è che la creazione stessa mentalizzata; se è vero che la internità del Cosmo è l’idea di Dio, come la esternità dell’idea è il Cosmo, è la creazione; chi non vede la efficacia, la verità del simbolo, quando tolsero a significare lo stato dei Beati, il cielo o la regione suprema, lo stato dei sospesi, l’aria intermedia, e quello dei riprovati l’inferno, o come suona il vocabolo stesso, le regioni infere ultime, fisicamente incandescenti, del nostro pianeta? Egli è questo uno dei simboli che dovrebbe piuttosto, secondo Gioberti, nomarsi Tecmirio, dappoichè fra il simbolo e la cosa simboleggiata non corre solo una relazione e similitudine arbitraria e puramente fantastica, ma una relazione intima, logica, soprasensibile,[367] appunto come la relazione ch’esiste fra l’originale e il ritratto.
Noi abbiamo gran parte esaurito di ciò che concerne la psicologia degli Esseni, le credenze intorno l’anima umana, i suoi rapporti con Dio, quelli che ha col corpo che veste quaggiù, la sua essenza, la divisione delle sue forze, e infine il suo soggiorno. Io vorrei potere porre compimento a questa parte della Dogmatica degli Esseni, se non che l’ora breve mi fa protrarre ad altro giorno lo studio di altri due punti non meno interessanti, la metempsicosi e la resurrezione, secondo gli Esseni. I nuovi studj non faranno che confermare l’antico nostro sistema d’identità essenico-cabbalistica. Noi udiremo, come abbiamo udito sinora, l’eco lontana delle dottrine cabbalistiche ripercuotersi a traverso dei secoli, e giungere sino a noi che eravamo sinora assuefatti al silenzio di quelle dottrine nei primi secoli dell’E. V. Quel sistema che pareva non esistere in quell’antichità, si mostrerà per organo degli Esseni non solo esistente, ma vivente e parlante, e tanto più andremo persuasi col Frank, con il Munk, col Ritter, coi dotti veramente nella questione imparziali, quanto antico sia quel sistema teologico nel nostro popolo.
LEZIONE VENTESIMASESTA.
Prendendo noi a trattare della Dogmatica Essenica, e di questa avendo anzitratto discorso di quella parte che si attiene alla Psicologia ossia alle dottrine sull’anima, noi abbiamo, se ben vi ricorda, due punti riservati alla odierna trattazione, e sono la metempsicosi, vale a dire la trasmigrazione delle anime, e la risurrezione dei corpi, quali furono intese e credute dalla società degli Esseni. Io oso dire che se altro punto di contatto non fosse tra Cabbalisti ed Esseni che la credenza alla metempsicosi, se questo solo ci rimanesse documento dell’illustre sodalizio, egli sarebbe già un gran passo compiuto in questa via d’identità essenico-cabbalistica, in cui ci siamo impegnati. E pure nulla di più provato per ciò che riguarda gli Esseni. I quali ossequiarono, al dir di Filone, al dogma anzidetto quando discorrendo della sorte divina che incogliere può agli spiriti immortali, parte dissero, lasciare la vita terrena per mai più ritornarvi, parte iteratamente vestire queste carni mortali, secondo una legge providenziale diversamente dispone. Io farei opera interminabile se qui dovessi il solo novero ricordare dei popoli illustri antichi e moderni, di sistemi filosofici, di teorie eziandio socialistiche che al dogma inchinarono della metempsicosi, e comecchè opera non vana, ma utilissima e profonda sarebbe questa, ciononostante rimarrommene per brevità, sì perchè[369] mestieri è pure che entro i limiti di una storica esposizione mi circoscriva, sì perchè è tale questo delicatissimo argomento, intorno a cui ogni ragione ne comanda riserva. Ma io non posso da due cenni astenermi che troppo degni mi sembrano invero di ricordanza. È il primo quella bella conferma che dalla descrizione di Filone emerge, pel concetto che degli Esseni offriva ai suoi lettori Flavio Giuseppe quando li diceva simili, affini ai Pitagorici. Giuseppe, che io mi sappia, non dice esplicito ciò che disse Filone; non assevera formalmente la metempsicosi presso gli Esseni, ma dice solo essere costoro i Pitagorici dell’ebraismo, come i Farisei ne dice gli Stoici, e come i Sadducei seguaci egli dice di Epicuro. Ma quanto è il suo dire eloquente! Poichè il nome solo dei Pitagorici fa fede, se io non erro, a bastanza della presenza della metempsicosi in seno agli Esseni, non essendo dogma a parer mio per cui siano andati più distinti e famosi i Pitagorici, di quello appunto della trasmigrazione delle anime. E se alcuno di ciò dubitasse, ogni dubbio svanirebbe, ne son certo, dopo la lettura del Ritter. Il quale è il solo, se io non sbaglio, fra gli storici della filosofia che più proceda meticoloso, e secondo me, spesso ingiusto per troppa esigenza nella critica dei testi, nella scelta dei fonti, quasi interamente esautorando di ogni critico valore gli scrittori tutti che per poco furono posteriori agli immediati successori di Socrate; i quali pure sono, come ognun sa, le più ricche e preziose miniere di storici ragguagli intorno le più antiche scuole eziandio antisocratiche, qual fu per esempio quella appunto italo-greca che si disse dei Pitagorici. E pure al Ritter non bastò l’animo negare l’esistenza del dogma della metempsicosi fra i Pitagorici; tanto sembrava a lui stesso caratteristico della scuola, e tanto altresì a fortiori sembrar doveva[370] al nostro Giuseppe che questo special distintivo della scuola aveva, senza meno, presente quando diceva ai suoi lettori pagani essere i nostri Esseni, i nostri Cabbalisti i Pitagorici dell’ebraismo. L’altro punto che voglio toccare di volo, riguarda più davvicino il dogma in se stesso, ed a cose ed a uomini si riferisce a noi coetanei. Io non uscirò riguardo al dogma dalla riserva che mi sono imposto: ma chi potrebbe al tutto trattenere le parole quando il più imponente e vasto pensiero che capir possa nella mente dell’uomo si vede ad una critica soggiacere frivola, superficiale e buona appena per una finzione da romanzo? Ciò che non posso tacere è lo strano spettacolo che mi si offerse non ha guari nel Journal des Débats. In Parigi, nel secolo decimonono, nel grande trambusto e commovimento di religioni, di filosofia, di sistemi d’ogni maniera, si udì una voce che sorse a rivendicare l’antico dogma della metempsicosi, e questa voce fu del Martin, nell’opera che chiamava Cielo e Terra. Ma il Martin doveva subire pena condegna al grave fallo. Nella terza pagina del Débats ove si fanno le apoteosi e gli autodafè delle opere nuove, un filosofo, uno dei guerrieri riservati per le grandi occasioni, doveva fare del Martin e della opera sua adeguata vendetta. Io vorrei potervi qui proporre le obiezioni colle quali si pretese schiacciare l’opera del Martin, e giacchè le mille voci del giornalismo recarono dovunque l’eco ripetuto della disputa insorta, io non so chi ci tenga di mescere a quelle infinite voci anco la nostra. Ma io nol farò, solo per non protrarne all’infinito l’opera assunta. Questo solo dirò, che ciò che tornavami a vedere più doloroso si è il nome che sottostava a quel lavoro di critica filosofica. Io ebbi parecchie volte occasione di nominare il Franck, e con quale stima e venerazione per me si facesse, ditelo voi che ne foste le mille volte i testimoni.[371] Io credo e crederò sempre l’opera del Frank sulla Kabbale ottimo servigio reso alla scienza e alle credenze ebraiche, e Dio volesse che l’illustre Luzzatto e consorti, anzichè occuparsi a denigrarla, mirassero a compirla, a perfezionarla. Ma se gli antichi dissero sed magis amica veritas, io non posso questa volta trovare nè bello nè serio l’officio dal signor Frank adempito. Non bello, perchè male s’addice allo storico e apologista dei Cabbalisti, al discendente degli Esseni, stendere l’atto d’accusa della metempsicosi; non serio, perocchè non è difficile trionfalmente replicare alle obiezioni ivi stesso suscitate dal Sig. Frank. Le quali, parte consistono nelle antiche e più comuni confutazioni del dogma, parte nuove ma tutt’altro che inoppugnabili. Ma questo ed altro simile abbiamo detto trapassare in silenzio, ed al proposito nostro ci atterremo. Solo piacemi ora toccare del secondo dogma in questione: è il dogma della Risurrezione. Per non avere trovato esplicitamente insegnata l’esistenza di questo dogma presso gli Esseni, alcuni moderni critici specialmente imbevuti del genio ipercritico dell’Allemagna lasciarono libero il freno al loro congetturare a priori, e dalle idee che formavansi gli Esseni dei rapporti primigeni dell’anima col corpo, crederono poter dedurre la negazione del dogma resurrezionale in seno agli Esseni. Vi ha in Parigi un giornale letterario che si è tolto l’assunto d’informare la Francia dotta, religiosa, letteraria dei grandi lavori che giornalmente s’imprendono, si compiono nella vicina Germania, che per ciò appunto si noma Rivista Germanica e che per ciò appunto dovrebbe ricercarsi e possedersi dovunque, che per mancanza di rapporti più immediati, non è concesso attingere direttamente alle vive e abbondanti fonti della scienza ed erudizione germanica. Or bene; nel nono numero di quest’anno istesso 1858,[372] trovai inserito un articolo di sommo interesse per le nostre ricerche, e che all’autore Michel Nicolas, professore di Teologia in Montauban, piacque d’intitolare Gli antecedenti del Cristianesimo. In un articolo che si chiama degli antecedenti del Cristianesimo, il nome degli Esseni non poteva non figurare in luogo eminentissimo, come difatto vi figura; e molte delle questioni da noi lambite, vi sono profondamente e maestrevolmente trattate. Ma sia vaghezza di fare meno che è possibile tributario il Cristianesimo della società degli Esseni; sia non avere compreso le strettissime affinità tra gli Esseni ed i Farisei; sia la mania di argomentare per vie insolite e non battute trasandando i raziocinii più ovvii e più alla mano, fatto sta che secondo Michel Nicolas gli Esseni non conobbero o negarono il dogma risurrezionale. E perchè così giudica il Nicolas? Perchè egli crede incompatibile il principio della unione forzata col corpo, col ritorno dell’anime a vivificare i corpi una volta abbandonati, perchè egli crede il distacco da tutte le cose corporee essere stato il perpetuo conato, e la perfezione ideale che l’Essenato si proponeva senza pensare che le tendenze anticorporee dell’anima a sè stessa lasciata, non montano nulla nè agli ordini universali della Provvidenza di Dio, la quale può volere la seconda e ultima volta come volle la prima, quell’unione che non si compiva nè compirassi che a malgrado dell’anima; senza pensare che il dogma risurrezionale implica per sè stesso la rigenerazione, e per dirla tecnicamente la Palingenesi dell’Universo, e quindi il ritorno alla purità primigenia di quella carne che non è, secondo l’Ebraismo, rea per sè stessa ma che tal divenne per un principio a lei esteriore; e quindi per ultimo corollario che l’antipatia o antagonismo fra lo spirito e la materia potrà e dovrà cessare allora, quando la primigenia[373] armonia sarà ridonata, della quale furono preludii e quasi presentimenti Mosè sul monte e soprattutto Elia, Elia che s’incielò vestendo tuttavia carne mortale, per lo cui insigne privilegio io credo che presegga alla culla dell’uomo come angiolo della creazione, ed alla sua tomba come angiolo della resurrezione, quasi perpetuo iniziatore e ierofante della vita mortale, identico al greco Mercurio, all’Erme egiziano, al Sireo o Cane Celeste, guida e conduttore delle anime. E, mirabile a dirsi, i Cabbalisti dierono il cane per simbolo ad Elia e nel nome suo trovarono aritmeticamente il nome Cheleb, ambedue sommando egualmente cinquantadue, e prima di essi i Talmudisti muovendo evidentemente dagli stessi principj dissero le grida gioiose e gli scherzi dei cani annunziare Elia che entra in città. Ma io mi sento trascinare senz’addarmene punto, da digressioni certo nè inutili nè volgari, ma che troppo il libero corso arresterebbero dei nostri studj. Noi dicevamo come a torto negasse agli Esseni il Nicolas il dogma di risurrezione. E fortunatamente non siam soli a così opinare. Il Nicolas stesso s’incarica d’informarcelo. Telle n’est pas, egli dice, l’opinion de M. Hegenfield, qui dans un ouvrage récent (e che si chiama l’Apocalittica ebraica) attribue aux Esséniens la composition des Apocalypses Juives, ou du moins les range parmi les Juifs qui s’occupèrent le plus des idées apocalyptiques. Ora le apocalissi, le idee apocalittiche importando per lor natura il supposto di un ciclo apocalittico, di un cielo palingenesiaco, ossia di rigenerazione cosmica, universale, egli è chiaro come gli autori delle apocalissi non potevano disconoscere un dogma che tanto davvicino si attiene alle loro teorie, anzi che n’è parte inseparabile, che vediamo immancabilmente figurare in tutte le superstiti apocalissi, vuoi spurie o legittime, quali sono, a mo’ di[374] esempio, il libro di Daniel e l’apocalissi o rivelazione di Giovanni. Ma contro l’opinione ricordata, e ch’è la nostra, potrebbe alcuno argomentare; potrebbe dirsi: Filone e Giuseppe sono i soli o almeno i principali storici dell’Essenato. Ora Giuseppe e Filone quando favellano degli Esseni non parlano della Risurrezione, non l’annoverano tra le loro credenze, non ne fanno parte del sistema lor teologico, con qual diritto attribuirgliele, e come la lacuna colmare di nostro arbitrio? Ma quanto labile quest’obiezione! Se io volessi, per sovrabbondanza di prova, far tesoro di argomenti, di repliche vittoriose, sareste voi piuttosto stanchi d’udire, che non io di favellare. Potrei citare l’autorità del medesimo Nicolas quando, in altro punto del suo lavoro mi porge egli stesso le armi onde al nulla ridurre la forza della sua negazione, quando misurando il grado di contezza che dell’illustre istituto possedevano Giuseppe e Filone, dice del primo: «Joseph, qui avait passé un an dans la société, n’avait pas franchi le premier degré de Noviciat, et ne connaissait pas par conséquent le fond de ses doctrines;» e del secondo aggiunge non men categorico: «et Filon, comme Neander le fait remarquer, les présente non tels qu’ils étaient en réalité, mais tels qu’il lui convenait qu’elles fussent pour que les Grecs éclairés vissent dans les Esséniens des modèles de sagesse pratique.» Il Nicolas dice assai, dice anche troppo secondo me, nè io accetterei in tutta la sua estensione il suo asserto se non colle più delicate restrizioni e riserve. Ma finalmente che valore dopo queste parole può avere il silenzio di Giuseppe, di Filone quando tacciono della Risurrezione, perchè veramente di silenzio si tratta anzichè di esplicita e formal negazione? E quante cause non possono avere questo silenzio cagionato, anche allora che gli Esseni avessero ossequiato, come hanno a[375] parer mio veramente ossequiato, al principio di Risurrezione. Può esserci stata ignoranza in Giuseppe e Filone, come il Nicolas istesso ci autorizza a supporlo, comecchè poco invero io inclinerei ad ammetterla trattandosi specialmente di dogma popolare ed esoterico anzichè di insegnamento acroamatico.—Può essere stato studio, desio sincero di non urtare violentemente i pregiudizj pagani ai quali nulla più tornava assurdo e mostruoso ad udirsi che il risorgimento dei morti a vita eterna, testimone il riso, lo scandalo che suscitarono nel mondo pagano le prime predicazioni del Cristianesimo, quando annunziarono Cristo risorto dai morti, e primogenito, come gli Apostoli dissero, del Regno futuro, e se non temessi di riuscire troppo diffuso, non mi sarebbe difficile recare in mezzo prove ed esempj di silenzii discreti, di opportune varianti, di calcolate infedeltà, concesse, ammesse, usate in grazia appunto dell’opinion dominante di cui, per non dire di altri, fu cospicuo e manifesto esempio, ed è tuttavia, la traduzione dei Settanta.—Ma le cose anzidette, che molto han pur di probabile, del verosimile, debbono cedere il luogo al provato ed al vero, alla ragione che io credo solo storica, solo reale, che può essere stata coadiuvata sì dalle altre citate, ma che sarebbe egualmente vera, decisiva, perentoria, quando pure fosse sola. Ed è questa che Giuseppe principalmente ed anche Filone, quando parlano degli Esseni, quando dei Sadducei, Farisei ed altre sètte dell’Ebraismo, solo quelle cose ricordano che distinguono la setta in discorso, dal comune dell’Ebraismo, solo quella parte pongono in luce della sua fisonomia, che discorda dalle generali fattezze dell’Ebraismo; quello in somma che hanno di speciale, di esclusivo. E poi, chi volesse con un sol fatto spogliare di ogni valore il silenzio di Giuseppe e Filone, chi volesse sin dalle barbe[376] sradicare la negata resurrezione degli Esseni, basterebbe citare i Farisei, ai quali non è nessuno che negar possa il dogma della risurrezione, tanto vanno colmi i loro libri di espliciti insegnamenti di questo dogma. E pure, guardate Giuseppe. Egli parla a lungo dei Farisei, come parla degli Esseni, dei Sadducei; ne narra i costumi, le credenze, le somiglianze colle scuole analoghe del Paganesimo, ma nè un sol cenno nè un sol motto avviene che dalla penna gli sfugge intorno il dogma in discorso. Per certo questo silenzio non è a caso, sia che tacere abbia voluto ai Pagani un dogma che destato avrebbe il riso e lo scherno dei loro filosofi, sia, come dissi poc’anzi, che di quelle cose soltanto abbia preso a favellare che eran subbietto di controversia, tacendo delle altre generalmente consentite; sia infine ambedue le ragioni anzidette, fatto è che il silenzio di Giuseppe nulla prova riguardo ai Farisei, e nulla egualmente conclude rapporto agli Esseni, i quali come tutti gli Ebrei, e forse più di tutti gli Ebrei, diedero, come fecero i Cabbalisti, luogo eminente al dogma resurrezionale. Che se a tutte le ragioni finora discorse aggiungete il silenzio del Talmud, che nel mentre narra le dispute dai Dottori sostenute contro i settarj d’ogni maniera in favore di questo dogma, non è mai che tra essi faccia menzione dei nostri Esseni; se aggiungete il dogma della metempsicosi che, per chi bene lo intende, suppone qual ultimo suo corollario la immanente ultima e definitiva unione delle due nature; se pensate a certi fatti e credenze generali dell’Ebraismo che gli Esseni non potevano ricusare sendo esse il fondo e il patrimonio comune dell’Ebraismo, e che menano difilati, per poco che vogliamo essere logici, al dogma in discorso; se pensate, a mo’ di esempio, ad Adamo, creato in principio immortale, a Henoh di cui si tace,[377] anzi si nega fino a un certo segno la morte, ad Elia rapito in corpo ed anima, nella vita celeste, ai singoli fatti dalla Bibbia narrati, di uomini da morte a vita risuscitati, a Mosè che disse: Ani amit va-ahaié, ad Anna che cantò: Morid sceol vaiaal, che cala nel sepolcro e ne riscuote i caduti, a Isaia che poetò: Ihiù meteha ec. a Ezechiele che profetò: Inneni poteah et Kibrotehem, per non dire di Daniel, che una critica troppo ardita potrebbe dire sconosciuto o non ammesso dai nostri Esseni, e che è il profeta della risurrezione per eccellenza. Se pensate a tutti i fatti e alle credenze narrate, chiaro vedrete come troppo precipitosa sentenza abbia proferito il Nicolas, quando volle la Risurrezione ignota, negata dall’Essenato e come per esso e per chi opina con lui potrebbe dirsi con Petrarca:
Ben fa chiunque impara sino al fine.
LEZIONE VENTESIMASETTIMA.
Se degli Esseni abbiamo studiato sinora ciò ch’insegnarono, rapporto all’anima, alla sua natura, ai suoi destini, parmi questo luogo conveniente di studiare altresì ciò che insegnarono delle straordinarie manifestazioni delle facoltà psicologiche nelle predizioni, nelle profezie di cui andarono gli Esseni celebri per il mondo. Giacchè narra la storia parecchi e famosissimi casi, in cui gli Esseni annunziarono da lungi un avvenire, che non mancò giammai, dice Giuseppe, di avverarsi.—Si avverò, dice Flavio nel decimoterzo delle Antichità, quando Giuda, Essena di nazione, per esprimermi com’esso s’esprime, predisse la morte d’Ircano nella torre di Stratone; e tanto superlativo si formava concetto del medesimo Giuda, che non teme Flavio di aggiungere, per valermi della traduzione francese di Arnauld d’Andelby: que ses prédictions ne manquaient jamais de se trouver véritables.—Si avverò, oltre altri casi moltissimi narrati da Flavio, in quello veramente memorabile d’Erode il Grande, quando un Essena per nome Menahem che menava, dice Flavio, una vita sì virtuosa che lodato era da ognuno e che aveva da Dio ricevuto il dono di profezia, vedendo Erode ancor fanciullo studiare insieme coi bambini dell’età sua, gli disse che avrebbe un giorno regnato sopra gli Ebrei. Quando Erode inalzato al trono si vide al colmo della prosperità,[379] ricordossi di Menachem e delle sue predizioni, e chiamatolo presso di sè, trattò da quind’innanzi con segnalato favore tutti gli Esseni. Sono queste parole pressochè testuali di Flavio Giuseppe, nelle quali misi uno studio particolare di fedeltà onde le conseguenze storiche dottrinali che ne dedurremo, sieno sopra basi fondate, solide, incrollabili.—Questi fatti provano, non è dubbio, come gli Esseni s’occupassero di predizioni; e qual credito insigne godessero tra i lor coetanei eziandio più illustri, di veridici vaticinatori delle cose avvenire. Ma l’ultimo dei fatti narrati, l’episodio dello inalzamento di Erode al trono di Giuda, prova inoltre due cose; prova quanto ingiustamente sia stato sinora creduto tacersi affatto gli antichi Dottori della società degli Esseni, dacchè, singolare a dirsi, al fatto or’ora discorso si allude manifestamente nel Talmud, come fra poco vedremo. E prova poi altra cosa. Prova quella identità che non ho cessato un istante di proclamare tra gli Esseni ed il Farisato, non altro essendo i primi, a parer mio, che la parte eletta ed i teologi della scuola. Ora chi non vedrà e l’una e l’altra cosa nel Talmud di Kaghigà? Ove descrivendo le prime primissime origini delle controversie dei Farisei, e i primi tra i Dottori ad erigersi tra essi antagonisti, narra qual prima coppia ch’ebbe discorde il sentire in fatto di religione, un Illel, l’antico il famoso Illel, che il chiarissimo Luzzatto crede identico al Pollione di Giuseppe, e per secondo non già Sciammai che non intervenne che tardi, ma il nostro, lo storico, l’Essena Menachem che precorse a Sciammai nel rabbinico patriarcato e che solo a Sciammai cesse il luogo, l’ufficio, quando la sorte chiamollo altrove, come vedremo. E perchè dico il talmudico Menachem identico al nostro, all’Essena Menachem di cui parla Giuseppe? Perchè è il Talmud stesso[380] che ce lo insegna, per chi bene lo intenda, il quale, dopo aver detto che a Menachem sottentrò nell’officio Sciammai, chiede a se stesso.—Che cosa avvenisse di Menachem leehan iazà.—E Dio volesse che fosse la risposta concorde. Ma no! Da Menachem al Talmud, o per dir meglio, ai personaggi che qui interloquiscono nel Talmud, Abaje e Rabbà, non solo più di tre secoli eran trascorsi, ma l’esilio, lo spostamento delle accademie e dei centri studiosi avevano di tale dubbiezza avviluppate le cose che immediatamente precessero la grande catastrofe, che si vedevano sì, ma come gli obbietti si veggono per l’aer caliginoso. Che volete pertanto? Abajè e Rabbà rispondono sì, ma onninamente discordi, alla domanda del Talmud. Dottori ambidue Babilonesi, nati, cresciuti lungi da Palestina patria di Menachem, ognuno di essi narra le cose tali quali le aveva udite per avventura da una tradizione discorde. Per Abaje, Menachem uscì letarbut rahà, frase talmudica che vale quanto apostatare od uscire dal grembo della ebraica ortodossia.—Per Rabbà invece se Menachem non è più tra i Dottori annoverato, egli è perchè (notate prezioso ricordo!) fu assunto al servigio e ministero del Re, il quale come ora vedremo non è, nè può essere altri se non Erode il Grande.—Ora di fronte al dubitar del Talmud chi oserà asserire che le cose avvenissero come noi le dicemmo avvenute? Quando due opinioni tenzonano, come vediamo, con egual forza, chi ci autorizza a stare piuttosto alla seconda che non alla prima, e soscrivere alla versione favorevole di Rabbà, piuttosto che a quella a noi ostile di Abaje?—Ah! il perchè è facile a dirsi, e voi uditolo, spero, mi darete ragione. Due sono gli argomenti capitalissimi che ci persuadono vera, preponderante la tradizione di Rabbà. È il primo un principio che corre comune e divulgato assai tra gli studiosi[381] del Talmud, che ovunque cioè una controversia si verifichi tra Abajè e Rabbà, egli è al secondo che dobbiamo attenerci, tranne pochi singoli casi nominativamente eccettuati dallo stesso Talmud. Che nelle quistioni critiche storiche, anco dogmatiche, questo criterio non abbia avuto sempre forza di legge, concedo anch’io volentieri, ma con qual giustizia, con qual coerenza?—Certo con quella stessa giustizia e coerenza che manomise nello studio del Talmud tuttociò che non ha rapporto immediato colla pratica religiosa, senza pensare che ove di un albero tu trascuri le radici, il tronco, i rami ed anco le foglie, è vana opera occuparsi del frutto che non crescerà mai, o crescerà misero e tristanzuolo, quale lo fece il mal governo dello stupido cultore.
A noi però che recammo sempre nell’animo la sintesi, la reintegrazione della scienza ebraica in tutte le svariatissime sue parti, teoriche e pratiche, non è lecito adottare criterio diverso nel rito da quello che nella storia, nel domma, nell’esegesi adottiamo, e in queste come in quelle diciamo e continueremo a dire Ilheta che rabà. E questo è argomento che abbastanza identifica il Menachem del Talmud coll’Essena Menachem, di cui Flavio discorre. Ma qual’è il secondo? Il secondo è lo stesso Talmud che ce lo fornisce, ed è tale, che ove pure si volesse niun valore concedere alla massima già esposta che dà ragione a Rabbà contro Abajè, basterebbe per se solo a far prevalere l’opinione del primo contro il dir del secondo. E perchè? Perchè reca un inaspettato ed autorevolissimo ausilio alla tradizione del primo, in un’antica Barraità, che oltre essere opera di Dottori Palestinesi conterranei di Menachem, è di gran lunga più antica del Talmud e dei suoi autori, e quindi maggiormente si avvicina all’epoca di Menachem, e più veridica e sincera ne ragguaglia dell’avvenuto. La Barraità o[382] testo misnico si pronunzia a dirittura in favor di Rabbà, e quella ragione assegna al ritiro di Menachem che Rabbà assegnava, vale a dire i nuovi offici che fu chiamato a sostenere in corte di un Re che non può essere altro che Erode, Tana nammè akì iazà Menahem laabodat ammelech. Non basta. La Barraità ci conserva memoria di una circostanza taciuta dallo stesso Rabbà, e che più compiutamente risponde alla narrazione di Giuseppe. Certo voi non lo avete obbliato. Oltre i favori personali che asseguì Menachem, narra Giuseppe il credito, l’estimazione in cui salirono, la mercè sua, gli Esseni: e come (sono sue parole) da indi innanzi trattasse con segnalati favori i nostri Esseni. Or bene, la Barraità pare che faccia eco alle parole di Flavio, e dopo aver detto come udiste di Menachem che passò al servigio del Re, queste parole aggiunge memorandissime che a voi raccomando: E con esso passarono allo stesso servigio ottanta coppie di giovani dottori in serico ammanto—segno della nuova dignità a cui furono assunti, secondo era stile degli antichi principati rivestire i nuovi eletti di abiti distinti, secondo si legge in Assuero e in Faraone. Ma questi due argomenti, per quanto grandi, non sono i soli: ve ne sono altri due che grandemente favoriscono il nostro sistema: l’uno è la concordanza cronologica dei due fatti, l’altro è la produzione di un’autorità tanto più concludente quanto più inconsapevole e spontanea. Che cosa è la prova cronologica? È quella che dimostra come il Menachem, di cui parla il Talmud, visse appunto in quel tempo in cui visse, al dir di Giuseppe, il Menachem degli Esseni, il favorito di Erode, rendendo tanto più probabile la loro identità, quanto più strano sarebbe ammettere al tempo istesso due Menachem ambo dottori, ambo favoriti da Erode, ambo seguiti da lunga schiera di Dottori favoriti[383] com’essi. Or bene: noi abbiamo un punto fisso di partenza nel calcolo cronologico, ed è la data dell’esistenza d’Illel collega di Menachem. Il quale visse e sostenne il patriarcato cento anni prima della distruzione del tempio, nel quale tempo deve aver vissuto e figurato lo stesso Menachem che gli fu collega nel dottorato, anzi capo della scuola avversaria, alla cui testa si pose, dopo di esso Menachem, il più famoso Sciammài. Questo punto dimostrato costante, che cosa ci resta a fare per compire la dimostrazione e provare sincronici i due Menachem? Dobbiamo, se non erro, provare che il Menachem di Giuseppe visse, fiorì giusto cento anni prima dello esilio. Or bene: aprite Giuseppe, e dove è menzione del fatto della predizione di Menachem troverete notato dall’Arnauld d’Andelby essere ciò appunto avvenuto nell’anno 40 prima dell’era volgare, la quale avendo preceduto circa un 60 anni la distruzione del tempio, torna l’istesso che dire cento anni prima della distruzione, ch’è quanto dire quella stessa data in cui, secondo il Talmud, veduto abbiamo esistere, fiorire il talmudico Menachem.
Ci resta ora ad allegare l’autorità la quale indirettamente, e per ciò stesso tanto più concludentemente, depone in favor della identità dei due Menachem. Io non so se ne abbiate contezza. Ma oltre le opere di Giuseppe in greco dettate, e che furono tradotte, si può dire, in quasi tutte le lingue dell’Europa, ve ne ha un’altra in puro ebraico distesa, che mostra di appartenere allo stesso autore, ma della cui autenticità molti dubbj sorsero e durano tuttavia. Or bene in quest’opera ebraica, nel Josifon, al cap. 55, dove si parla della restaurazione del Tempio per opera di Erode, narra pure la famosa predizione del regno fatta da Menachem ad Erode ancor fanciullo.—Ma come la narra? Certo come la narrava[384] l’antico Giuseppe, tranne solo una frase che nel primo non esiste e ch’è per noi il più luminoso attestato della identità dei due Menachem. E là, ove nominando per la prima volta il profeta Menachem, oltre porlo nel novero dei hasidim e hahamim, cenno, come vedete, di gran rilievo, lo qualifica a dirittura collega di Sciammai, lo che è appunto ciò che andiamo cercando, null’altro potendo essere un Menachem collega di Sciammai se non quello che appunto come collega di Sciammai è qualificato dai Talmudisti. Se poi a tutto questo aggiungete che Erode fu, secondo il Josifon, secondo il Talmud, e secondo il greco Giuseppe intimo dei Farisei, sotto le cui bandiere acquistò e conservò la corona; che fu stile generale, costante dei Dottori farisei l’annunziare da lungi i grandi destini, specialmente ai fanciulli come Gamaliel a Giosuè ancor fanciullo prigioniero in Roma, come Rabba di cui leggesi in Berahot ai due discepoli che aveva commensali; che più particolarmente si occuparono di vaticinare il regno ai futuri monarchi, come Rabban Joanan Benzaccai a Vespasiano ed a Tito, come Ribbi Achiba a Barcohaba, l’Arminio di Palestina, se pensate che tutti i Rabbini posteriori come il Seder Adorot che lessero nel Josifon il fatto di Menachem, l’intesero qual personaggio identico di fatti al Talmudico Menachem; se tutto questo aggiungete, avrete un fascio di prove così stretto, così aderente, che insieme al racconto talmudico, rispondente al racconto flaviano, insieme alla concordanza cronologica dei due avvenimenti, forma tale congerie di fatti così cospicui da costituire una vera e propria dimostrazione evidente, da provare soprattutto questi due fatti capitalissimi: la conoscenza che ebbero degli Esseni i Dottori nostri contro la sentenza comunemente adottata, e la identità appunto di Esseni e di Farisei, dappoichè questi ultimi dei primi[385] favellano in guisa nel loro Talmud, come se proprj fossero del Farisato gli Esseni, propria la loro storia; proprie le glorie, e proprio tutto ciò che ad essi si attiene.
E poichè abbiamo preso a narrare le loro predizioni, mestieri è pure che d’altro qui si favelli che merita pure tra quelle narrate luogo cospicuo; e forse pegli autorevoli deposti, merita anzi sovra tutte il primato. Voi avete udito Giuseppe narrare delle esseniche predizioni. Or bene: Giuseppe, siccome quello che visse un anno nella società degli Esseni, doveva pure pretendere al Profetismo, e difatti Giuseppe apertamente v’aspira. Che dico? Narra egli stesso nel 3º libro delle Guerre Giudaiche come, stretto d’assedio in Jotapat, predisse agli abitanti che la città cadrebbe dopo 47 giorni di resistenza in poter dei Romani, e ch’egli stesso sarebbe caduto vivo in poter loro. Non basta.—Ciò che il Talmud narra di R. Johanan Ben Zaccai, ciò che udiste poc’anzi da questo Dottore qual presagio di prossimo regno a Vespasiano, ed a Tito, Giuseppe di sè stesso lo narra. Racconta Giuseppe come condotto nel campo nemico, e presentato a Vespasiano, questi deliberasse inviarlo a Nerone allora imperante; come a sua notizia pervenuto l’intendimento di Vespasiano, alla presenza di Tito e di altri due testimoni lo ammonisse dicendo, lasciasse pure d’inviarlo a Roma perciocchè Nerone ed i suoi successori poco avrebbero ancora da vivere; sapesse che egli solo dovrebbe ormai riguardarsi qual Cesare, giacchè egli, Vespasiano, e dopo di esso Tito suo figlio sarebbero saliti sul trono. Mentiva nel racconto Giuseppe, e fama volle usurpare di profeta agli occhi dei posteri? Così sentenzierebbe una critica superficiale, ma quanto ingiustamente! Poichè se il caso favorisse il temerario annunzio del prigioniero, o piuttosto, le potenze recondite dell’Essena, dell’iniziato, si risvegliassero[386] all’occasione, questo non saprei accertare; ma che Giuseppe non abbia peccato per frode, ella è tal cosa che sfida ogni dubbio in contrario. E sapete chi me lo dice? I contemporanei o poco posteriori a Giuseppe, i Pagani nemici del nome ebraico, quelli che raccolsero di bocca alla fama il prodigioso vaticinio, come correva allor rumoroso sulle labbra di tutti; egli è Dione Cassio nel libro 66; egli è Svetonio nella vita di Vespasiano al 12º libro; e se Tacito non si può annoverare qual testimone della profezia di Giuseppe, si può qual autorità allegare di una predizione almeno congenere. Ella è quella di cui favella nel 2º libro delle Storie, parag. 78. Sorge, egli dice, tra la Giudea e la Siria un monte che si chiama Carmelo, il Dio che in quel luogo si adora reca il nome stesso (qui Tacito sentenzia a sproposito). Nulla statua di quel Dio e niun tempio: un altare solo si erge e il rispetto lo circonda. Vespasiano vi andò e sacrificò. E mentre volgeva nella mente i suoi piani, il sacerdote, consultate le viscere dell’animale, gli disse: Qualunque sia il pensiero che ti preoccupa sappi che ti attendono un vasto palagio, senza limiti possedimento, e lo imperio di genti innumerevoli. Ecco ciò che Tacito racconta. E certo qui di Giuseppe non è memoria; ma se tutte le circostanze valutate del racconto di Tacito; se fate la parte dell’ignoranza nel Dio Carmelo, che non ha mai esistito; la parte del paganesimo nelle consultate viscere dell’animale Beto, sconosciuto e riservato nell’Ebraismo; se cernete infine la narrazione tacitiana di quanto v’ha d’inesatto, d’eterogeneo, rimarrà questo fatto per sè stesso parlante, la predizione del regno a Vespasiano annunziata in Giudea da un Ebreo, da un sacerdote. Il quale fatto posto a confronto colla predizione attribuita dal Talmud a R. Johanan Ben Zaccai, con quella che a sè stesso[387] attribuisce Giuseppe, verrà con essi fuso, assimilato e tutt’insieme faranno un solo fatto, un sol vaticinio, le cui varianti sono in Giuseppe, in Tacito, e nel Talmud, in cui ardua opera sarebbe quella parte d’onore assegnare ad ognuno, che per diritto gli spetta.
Checchè ne sia, gli Esseni si occupavano di predizioni. Ma gli Esseni vantano un testimone di gran lunga più illustre, un pagano dottissimo, un celebre filosofo, il quale conferma le avverate predizioni degli Esseni, e che interdice a chi glie ne pigliasse vaghezza, di prendere non troppo sul serio le esseniche predizioni. E questi è Porfirio, uno dei più grandi neoplatonici che siano sorti nei primi secoli del Cristianesimo. Il quale al dire di Giulio Simon nella Storia delle Scuole di Alessandria, non solo conobbe gli Esseni e le loro predizioni, ma le confessò veridiche e confermate dal fatto. Confessione di gran rilievo, e per la religione e per l’ingegno non comune del filosofo pagano, il quale meritò che nel Trionfo d’Amore di esso poetasse il Petrarca:
Porfirio, che d’acuti sillogismi
Empiè la dialettica faretra.
LEZIONE VENTESIMOTTAVA.
La storia delle predizioni degli Esseni ci ha occupato nella passata lezione, qual corollario della loro antropologia, qual parte della loro dogmatica. Ma di queste predizioni noi non abbiamo fatto che la storia reale esteriore, particolare, di alcuni singoli fatti. Ci manca saperne la teoria, la forma con cui procedevano gli individui che se ne occupavano a preferenza. La forma prediletta, peculiare agli Esseni, era l’interpretazione dei sogni. E chi ne ammonisce è Flavio Giuseppe nel 17º delle Antichità, cap. 15, dove narra di Archelao che esposto il suo sogno ad un’Essena, ne ode la predizione della sua futura caduta la quale avvenne veramente com’era stata dall’Essena vaticinata, sendo stato all’epoca prefissa relegato da Cesare in Vienna città delle Gallie. E non solo gli altrui sogni toglievano a subbietto delle loro predizioni, ma di una spezie di rivelazione fornivano altresì nei loro sogni medesimi.—Alla quale e’ pare che si preparassero con le diurne meditazioni, se prestiam fede a certe parole che sul proposito ne trasmise Giuseppe. Pensano, egli dice, a Dio del continuo, attalchè nei loro sogni altro nella fantasia non sorge loro che le bellezze e le eccellenze delle perfezioni divine, e bene spesso dormendo fanno discorsi mirabili di questa divina filosofia. Queste sono testualissime[389] parole di Giuseppe. E benchè siamo nella regione dei sogni, si tratta di cose seriissime più che non credesi, e da fare molto a lungo vegliare. Noi non solleveremo le gran questioni psicologiche, religiose e fisiologiche altresì, che emergono naturalissime da quel curioso fenomeno che si chiama il sogno. Il volgo che crede ovvio, semplicissimo tuttochè non comprende, crede il sogno uno stato, una condizione fisico-morale, spiegabilissimi. Ma per i dotti! I dotti sieno essi filosofi, moralisti, medici, fisiologi, non hanno creduto il fatto così semplice come il volgo s’immagina. I loro libri, le congetture, i dispareri, e specialmente la grandissima questione si può dire odierna del sonno magnetico e quella più antica dei sonnambuli, fanno fede come qualche cosa vi sia là entro che resta tuttavia indecifrato. Ma queste cose basti accennare, e come da lontano additare, senza più oltre soffermarvici che l’argomento non comporta. Piuttosto diremo dei sistemi delle scuole, che credettero i sogni capaci, suscettibili d’interpretazione, fra le quali quella figura per prima che fu tanto meritamente da Giuseppe equiparata all’istituto degli Esseni, la scuola dei Pitagorici. E chi ce lo insegna è tale che già altre volte abbiamo veduto anche troppo circospetto nella scelta e nella critica delle memorie antiche, è il Ritter nella Storia della filosofia. I Pitagorici dunque anche per questo verso porgono la mano ai nostri Esseni, e nuovo punto ci offrono di contatto col grand’Istituto nella interpretazione dei sogni. E se io dovessi di tutto discorrere di quei tempj, di quegli oracoli, che in Grecia tutta, e fuora eziandio, girono famosi per sogni, che colà si procuravano, s’interpretavano, io farei opera interminabile benchè grandemente curiosa e istruttiva. Piuttosto è da vedersi il Clavier nella Memoria letta all’Accademia di Francia sugli oracoli antichi;[390] e se non fosse troppa temerità per me l’esprimere un voto il quale è forse a quest’ora adempito, io vorrei che qualche scienziato, appo il quale non sono in conto di fole le prodigiose indicazioni di alcuni malati sottoposti al sonno magnetico, studiasse i rapporti di questi sogni, di queste cure istintive, e quasi direi autoterapie, colle famose cure di Epidauro, ove i malati dopo diuturne preparazioni ricevevano la notte in sogno i presagi e le indicazioni dell’esito finale dei loro morbi. Ma gli Esseni non hanno solamente l’antichità a complice del loro sistema di predizione. I tempi moderni ci somministrano esempj grandi, cospicui, vuoi di uomini gravi che non del tutto rifiutarono le indicazioni dei sogni, vuoi di fatti storici straordinarj che molto dànno da pensare sulla natura e sul valore dei sogni. Fra i primi non citerò Menasce ben Israel che un capitolo dottissimo consacrava dell’opera sua alla materia dei sogni, e solo nol citerò perchè sendo egli alla perfine Teologo e Rabbino, meglio alle sacre autorità appartiene che alle profane, delle quali soltanto per adesso ci occupiamo. Nemmeno citerò Galeno che narra di un uomo, al quale parevagli in sogno avere una coscia di pietra e che divenne dopo pochi dì paralitico.—Nemmeno dirò di Plinio il quale riferisce di Cornelio Rufo, a cui avvenne di credere in sogno d’aver la vista perduta, e che si destò cieco per amaurosi; nemmen parlerò di Corrado Gemed, che sogna d’essere morso in seno da un serpente, e che gli nasce in fatti sotto l’ascella un bubbone pestilenziale che lo rapisce in cinque giorni di vita; e di questi ed altri simili tacerò, perchè sanno sempre alcun poco d’antico e perciò stesso per i più sanno ancora di incredibile, di stravagante. Ma quanto più singolare a vedersi non è l’ossequio di alcuni dei più illustri moderni! Fra i quali riluce per splendore d’animo e di[391] mente Beniamino Franklin di cui così parla il materialista Cabanis. «Io conobbi, egli dice, un uomo savissimo e istruitissimo, l’illustre Beniamino Franklin, che credeva essere stato più volte ammonito in sogno degli affari che l’occupavano. La sua testa forte e d’altronde libera di pregiudizj, non aveva potuto premunirsi da ogni idea superstiziosa quanto a questi interni avvertimenti.» Così sentenzia Cabanis. E pur, vedete curiosissimo scherzo di fortuna, o piuttosto grave monitorio di provvidenza! Era riserbato al corifeo del materialismo moderno, a Voltaire, all’uomo che involse ogni cosa in un riso universale, il porgere, e porgere, lo che più monta, nella sua stessa persona luminoso attestato della efficacia o almeno della tuttor enigmatica natura dei sogni. Tutti sanno come opera sua sia la Enriade; ma non tutti sanno un curioso episodio nella genesi di quel Poema. Vi è un capitolo che è opera sì di Voltaire, ma non già di Voltaire desto, ma di Voltaire dormiente. Anzi di Voltaire che sogna, e nel sogno prosegue l’opera incominciata nel giorno, e destato si trova più ricco di un capitolo nella tessitura di quel Poema. Non si legge che Voltaire abbia preso da indi innanzi a rider meno dei sogni; la sua filosofia non era ancora passata allo stato di pregiudizio, perch’egli come degli altrui pregiudizj se ne facesse irrisore: ma si legge bensì di un altro, di un vivente, che io non metto certo a paro di Voltaire, perchè troppo lo amo e rispetto, ma che pure non ci offre a veder bene meno sensibile anomalia. E quando dico anomalia per Luzzatto il prestar fede ai sogni, non è certo per quei sogni storici straordinarj, profetici in cui Dio parla all’uomo che sogna, come parlar può e parla difatti all’uomo ch’è desto; ognuno che creda alla rivelazione, che creda alla Bibbia, non può senza incoerenza, senza empietà, discredere a questa[392] specie di sogni; ma dico dei sogni in generale, di quelli che tutti possiam conseguire, della natura loro semiprofetica, del valore loro proprio naturalissimo, e non solo qual mezzo, qual veicolo d’ispirazione. Le quali cose, se non ammesse, quasi consentite dal nostro Luzzatto provano due cose ad un tempo, che le idee Cabbalistiche quando non entrano in certi spiriti per la gran porta, vi entrano per certi calli obliqui ed oscuri pertugi, e quasi non dissi di contrabbando.
Che se dalle autorità e dagli esempi scientifici trapassiamo agli esempi, ai precedenti, ed alle autorità bibliche talmudiche cabbalistiche, vedremo come sempre gli Esseni radicarsi nella più venerata e autorevole antichità ebraica. Io stimo soverchia opera citare gli esempi e le autorità della Bibbia, tanto mi sembrano ovvii e conosciuti. Il sogno non solo lo vediamo figurare in fatto quale suprema manifestazione dei divini voleri, e presagi dell’avvenire in Giacobbe, in Giuseppe, in Faraone, ma egli è altresì, qual grado infimo sì, ma pur legittimo annoverato di profezia, ogni qual volta della gerarchia si favella dei veggenti, e della profetica gradazione; testimone il verso ove Dio parlando ad Aronne e Miriam, chiama a fruire delle sue ispirazioni chiunque per visione o per sogno si sentisse capace di aspirarvi; testimone Saulle, che consultò invano il Signore, dice la Bibbia, per tutte le vie per le quali è consultabile, per la via dei sogni, della profezia e dell’oracolo degli Urim, testimone Giobbe ove qual mezzo di cui Dio si vale per svelare agli uomini le sue intenzioni, parla dei sogni e delle visioni notturne, e di questi tratti chi volesse nella Bibbia raccôrre, ne troverebbe più ch’io non dica espliciti e numerosi. E il Talmud in questo come in altre cose procede alla Bibbia conforme. Non solo il carattere semiprofetico del sogno vi è confessato halom ehad miscisceni bannebuà; non solo[393] il rimanere per sette giorni senza sognare vi è chiarito qual indizio di anima non buona; non solo un lungo novero vi è tessuto delle cose che indicano in sogno lieto o sinistro presagio; non solo i sogni vi si dicono subordinati alla loro interpretazione, massima incomprensibile se non si intende alla luce della pratica essenica che i sogni considerava qual esteriore incentivo, alla mente ispirata dello interprete, non solo si narra de’ Cesari che ai Dottori ricorrevano per la interpretazione dei sogni; non solo mirabilmente conferma il deposto rabbinico una satira di Giovenale, la VI se non erro, ove racconta degli sciocchi Romani che la interpretazione dei sogni chiedevano agli Ebrei colà dimoranti; non solo tutto questo, ma quello speciale carattere eziandio da Giuseppe attribuito alle esseniche visioni quali ispiratrici di discorsi e ragionamenti filosofici, dottrinali, rifulge non meno nei sogni dei Farisei. Nei quali non è raro il vedervi Dottori ammoniti a ritrattarsi di una interpretazione, a più esatta formarsi l’idea di una impurità, a meglio comprendere la pratica di un rito; e ciò che più fedelmente riproduce la fisonomia dei sogni profetici dell’essenato, è quello che vediamo tra i cabbalisti e tra quei Dottori eziandio che senza fare del misticismo precipuo scopo dei loro studj, ne ammettono almeno la veracità e i titoli. Singolar cosa ma pur verissima, oltre gli esempi non oscuri, non scarsi che ne porge lo Zoar, di sogni istruttivi, dottrinali, rivelatori, quali appunto furon quelli dei nostri Esseni, ella è una pratica tra i cabbalisti e tra i loro aderenti, che meglio a capello non potrebbe ritrarre la pratica degli Esseni.—Se qualche urgente bisogno li spinge a consultare l’avvenire; non basta, se qualche dubbio in capo gli tenzona intorno ad un subbietto vuoi dogmatico, vuoi rituale, o in qualche siasi maniera religioso, ella è una via autorizzata, accreditata in cui si[394] mettono speranzosi, anzi fiduciosissimi nella bontà del responso, ed è quella che dicesi sceelat halom.—Nel riposo dei loro sensi, nella concentrazione delle forze loro psichiche, spirituali, eglino credono l’anima capace di comprendere cose che nello stato di veglia saria tornato loro duro a comprendere. E ciò che non è meno singolare a notarsi egli è, come questa specie di responsi siano stati disposti in iscritti e per le stampe eziandio pubblicati, siccome fa fede, per non dire di altro, la edizione non ha guari mandata fuori in Conisberga di un’antichissima compilazione di tai consulti, e di cui informava il mondo israelitico, nel prezioso suo giornale bibliografico Mazchir, il mio dotto amico Marco Steischneider di Berlino.
Ma noi abbiamo detto, se non erro, abbastanza della forma particolare che assumevano a preferenza le predizioni dei nostri Esseni, la forma di sogni profetici: dobbiamo dire ora chi erano coloro che nell’Essenato più credeansi capaci di tale straordinaria irradiazione profetica. Giuseppe, il grande storico dell’Essenato, quì pure soccorre all’uopo opportuno, e naturali e più consultati interpreti dell’avvenire ci addita quei fanciulli che sino, egli dice, dalla loro tenera età venivano alla profezia educati collo studiare dei sacri libri dell’Essenato.—Voi l’udiste, sono i fanciulli al dire di Giuseppe che rendono i responsi sulle cose avvenire in seno agli Esseni, o per dir meglio ei sono i profeti tra gli Esseni, che sino dalla loro fanciullezza si vanno al grande officio educando di profetare. Se vaghi voi foste di pellegrina erudizione, se vi piacesse nella esposizione nostra soprassedere, onde a popoli e a religioni antichissime chiedere esempi e fatti, analoghi a quello che vediamo tra i nostri Esseni, ci converrebbe fare in questo punto lunghissima sosta, e tutte citare le istorie che i fanciulli ci narrano, consultatissimi[395] nel mondo pagano, e ciò che sarebbe più curioso ad udirsi, in seno eziandio del Cristianesimo. Se v’ha scrittura che abbia tolto a insegnare exprofesso i vari modi di consultare lo avvenire, egli è il Clavier che ebbi luogo di citarvi altravolta. Se le sue pagine svolgerete, troverete copia più ch’io non dico di fatti, di esempi, in cui erano i fanciulli quai veridici oracoli, stimati e consultati eziandio delle cose avvenire. E specialmente tra gli Egizi ed i Greci.—Ma ciò che più davvicino s’attiene ai nostri Esseni, egli è la storia dell’ebraismo. La quale nelle due sue grandissime epoche, Biblica e Rabbinica, non scarsi, non oscuri ci offre esempi congeneri a quelli che udiste nell’Essenato. Che i profeti sin da fanciulli si arrolassero nella sacra milizia, che prendessero sino dalla più tenera età ad esercitarsi nel sacro aringo di profezia, ella è cosa che emerge dai sacri libri per poco che si consultino. Basta pensare ai Bene annebiim, che a suono di musica sacra, concitatrice, magistrale schiudevano il petto ai grandi pensieri, ai grandi affetti, scala e prodromo di profezia; basta pensare a Samuello, votato dalla madre sua appena trienne al servigio e al culto di Dio, che ignorando ancora che ci fosse al mondo profezia, ispirazione, ebbe in quella scena di una sublimità ed amabilità senza pari, il primo assaggio di quella profetica elevazione che dovea collocarlo a fianco di Mosè ed Aronne; pensare a Giosuè, che tuttavia fanciullo, siccome io interpreto, già ministrava nel divin culto; pensare a Giuseppe che ebbe sogni e visioni profetiche, mentre inconsapevole del loro senso, andava ingenuamente riferendoli a chi lo astiava; pensare ai Nazirei che si reclutavano principalmente tra i giovanetti, e che non alieni procedevano, siccome vedemmo altra volta, dal profetico officio, e soprattutto pensare a un verso di Joele, ove presagendo i doni profetici restituiti in Israel, augura i[396] figli nostri e le figlie e gli impuberi stessi, ai gradi eccelsi, sublimati di profezia.
Ma l’epoca Rabbinica non meno feconda procede di analogie e di esempj parlanti, che tanto più intima provano la parentela tra Farisei ed Esseni.—Chi per poco volse lo sguardo al Talmud, già comprende quello che io dico, già le citazioni previene, e già corre colla mente alle legittime conseguenze. Non si potrebbe tanto esigere di somigliante, d’identico tra Farisei ed Esseni, che più la storia, che più il Talmud generoso non porga. Se il fanciullo è proclamato stromento condegno di profezia dai nostri Esseni, tale non meno è gridato dai dottori, dai talmudisti. Se gli Esseni i fanciulli profeti consultavano a divinazione del futuro, ed essi pure i Farisei li consultavano, dei quali infinite si narrano nel Talmud le domande ai fanciulli rivolte, colla frase solita sacramentale: Pesok li pesukih. E chi volesse riandare nel Talmud tutti i singoli fatti che depongono della esistenza di tal costume, opera farebbe lunga interminabile, tanto ne vanno gremite le pagine di quella grande compilazione. Nè io il farò, troppo standomi a cuore la speditezza di questa istoria. Solo, ingenuamente ve lo confesso, vi ha un fatto nel Talmud Babilonico che grave troppo sarebbemi sotto silenzio trapassare, e di cui pertanto piacemi fare in questo luogo breve menzione. Egli è là, ove si narra di alcuni fanciulli che sendo entrati secondo il solito nella scuola, nell’accademia e tardando tuttavia a venire i loro maestri, si dierono a favellare sull’alfabeto, sul nome, sulla forma eziandio delle lettere ebraiche; a trovare cenni, allegorie, moralità nella figura e nella posizione relativa delle lettere nell’alfabeto, tralle quali non poche si leggono locuzioni, sentenze che duro riesce, malgrado gli interpreti, tuttavia ad intendere, e che a parer mio non altrove possono trovare intelligenza adequata[397] che nel sistema e nella terminologia dei cabbalisti. Or bene, se a prima giunta cotesti potessero parere non altro, che felici o forse anco capricciosi trastulli, non così dopo avere udito il maestro che sopravvenne. Il quale, presa ch’ebbe contezza delle costoro combinazioni alfabetiche, non ebbe scrupolo di sentenziare a dirittura, cose simili non essersi unqua udite dai tempi di Giosuè figliuolo di Nun. Ei pare che noi assistiamo ad un consesso, ad un esercizio di giovani Esseni, il luogo sacro, la solitudine, l’abbandono di quei fanciullini, e quindi lo spontaneo sbocciare delle loro idee, l’alfabeto, testo della puerizia, tolto a materia, a incentivo di più serie lucubrazioni, le parole glorificanti del maestro sopravvenuto; e sopratutto la convenienza anch’oggi sensibilissima delle frasi, delle imagini di quei parvoli colle frasi e colle imagini dei cabbalisti, ci sono altrettante linee, espressioni, fattezze riconoscibilissime della grande scuola dell’Essenato, ed altrettanti diplomi di consanguineità tra Farisei ed Esseni, tra questi ed i cabbalisti. I quali, e questo fia suggel ch’ogni uomo sganni, ammisero, celebrarono nei loro annali fanciulli celebri, straordinarj che verificarono nell’ordine religioso quei portenti che le passate e le moderne età, videro non infrequenti nei fanciulli, prodigiosi per ingegno prematuro, specialmente in matematica, qual fu a mo’ di esempio il Mangiamele. E benchè copiosa messe mi si offrirebbe dinanzi, se tutti volessi percorrere i vasti campi dei cabbalisti, pure di due fatti, di due fanciulli porteni farò menzione, l’uno antico, l’altro moderno. È il primo quel famoso Ienocà di cui si legge nello Zoar, nella lezione Balac; e l’altro quel Gaddiel Naar, non meno celebre per la precoce santità. E questo è, se non erro, abbastanza per confermare anche per questo verso l’identità Essenico-Cabbalistica. E qui pertanto potrei far punto, ma nol farò sintantochè[398] non vi abbia un’altra non meno preziosa storica attinenza, additata nel fatto suaccennato dei fanciulli talmudici. Voi non avete certo obliato la filiazione o almanco le grandi attinenze tra Cristianesimo ed Essenato. Or bene, fra i Vangeli apocrifi ve ne ha uno, se non erro l’arabo vangelo, ove il fanciullo Gesù, non solo è presentato disputante coi dottori della legge, ma nell’atto ci è mostrato altresì di studiare, di scuoprire ancor fanciullo, nella forma, nel nome delle lettere ebraiche, i misteri della legge di Dio, ch’è quanto dire quello stesso esercizio che vedemmo prediletto dai fanciulli talmudici, e che noi crediamo esatto esempio, e pratica essenica per eccellenza, e come tale tolta a modello dal fanciullo Gesù, allievo dei nostri Esseni, o almeno dai vangelisti che ne scrisser la vita.
Quest’ultimo riscontro non è men prezioso degli altri precedentemente ricordati. Egli è indizio, sintoma, di quell’armonia che solo il vero può produrre nell’esame e nella considerazione dei fatti, ed alla cui vista s’ingenera nell’animo dello studioso quel senso medesimo indefinibile di ben essere, che s’ingenera nel corpo dall’armonico funzionare di tutti i visceri, che non sapresti dire se risieda in questa parte od in quella, ma ch’è la resultante, ossia il quoziente della simultanea azione e riazione di tutte le parti.
LEZIONE VENTESIMANONA.
Le predizioni degli Esseni, da noi studiate nelle passate lezioni, chiusero quella parte dell’Essenica dogmatica che noi dicemmo antropologia, ossia la scienza dell’uomo.—Egli è pertanto nella sfera istessa delle dottrine degli Esseni tale un subbietto, che se non è del dominio istesso dell’antropologia, molto a questa si avvicina, e gli è per questo che un luogo gli assegneremo immediatamente successivo, e che dopo le cose discorse stimiamo qui opportuno doversi a dirittura trattare. E questo è la Morale, l’Etica degli Esseni. L’Etica, la scienza dei costumi, forma parte integrale di ogni sistema vuoi filosofico, vuoi religioso; nè si può dare religione, filosofia completa che nella stessa guisa che le basi propone della Metafisica, quelle eziandio non fondi della Morale, stringendo in alcune formule supreme generalissime, il primo principio, l’Idea madre, da cui tutto il sistema s’ingenera dei diritti e dei doveri dell’uomo. Qual’era l’etica degli Esseni, e quai furono i suoi principii, o come detto abbiamo, le supreme sue generalissime formule? Qui è ove Filone ci trasmise memoria preziosa dei suoi Terapeuti, gli Esseni d’Egitto.—Filone che i Terapeuti conobbe, e nel novero di essi professò e praticò i principii della scuola, Filone può insegnare ed essere udito. I Terapeuti, dice Filone, triplice base[400] assegnarono alla morale, o per dir meglio in tre principii generali compendiarono la scienza dei costumi. E questi tre principii erano appunto tre amori.—Insegnarono l’amore di Dio, l’amore della virtù, l’amore degli uomini; e dall’amore triplice che tutto congiunge e stringe ed unifica, fecero derivare tutta la serie dei morali principii, ed il mondo crearono sociale, politico, morale, religioso, in quella guisa che le antiche cosmogonie e la nostra eziandio riserbatissima, tutto l’universo fecero emergere dall’amore eterno. Fedele al sistema sin dall’origine intrapreso, io dovrei qui citare Bibbia e Rabbini, dovrei cercare i precedenti, i germi, le segrete radici dell’essenato nella Bibbia e nei Dottori. E pure l’esame di questi ultimi basterà al duplice intento: i Rabbini per sè risponderanno non solo, ma pur anco per la Bibbia, anzi le idee bibliche che nel codice santo vestono forma popolare oratoria esortativa, prendono nelle loro labbra la forma severa di dottrina.—Quando Mosè nelle bellissime concioni del Deuteronomio spandeva fiumi di eloquenza,—aveva pure dopo la confessione di Dio Uno, insegnato l’amore di Dio, profondo, attuoso, illimitato; aveva pure altrove, dopo imprecato alla vendetta, favellato dell’amore fraterno; ma dov’è in questi due principii la maggioranza incontrastabile, la legittima preminenza, e quella paternità che vantano a buon diritto su tutti gli altri sociali e religiosi doveri? Certo che nullo esteriore distintivo per tali costituisceli nelle pagine bibliche: e forse se a questi esteriori contrassegni si avesse rispetto, ei converrebbe l’officio di assioma, di principio assegnare a tanti comandi che un seggio occupano più illustre, che più enfatica hanno l’enunciazione, e che duplice e triplice vantano ripetizione nelle pagine del Pentateuco. Ma quanto facile tutto questo a intendersi, quando di esso libro si sia la natura e destinazione compresa![401] Il quale, e questa è convinzione che profondissima io reco da molti anni, essendo un libro meglio oratorio, esortativo, politico, ceremoniale che scientifico, dommatico e dottrinale, non serba appunto, secondo è stile degli oratori, dei politici, quell’ordine e successione logica rigorosa tra principio e conseguenza, quella gerarchia di idee, di pensieri che solo ha luogo nei trattati didascalici, insegnativi, ma le idee, i principii, le conseguenze, gli assiomi, i corollarj si affollano promiscuamente sulle labbra dell’oratore, dell’ispirato, del politico, e rompono in lampi e tuoni di eloquenza, o in formule e prescrizioni politiche cerimoniali; solo quell’ordine e successione serbando meramente esteriori, che son richiesti dal subbietto pratico, sociale, politico, cerimoniale a cui i grandi principii della religione e della morale sono applicati. Ora quest’officio d’ordinazione, di ricostituzione logica della Bibbia egli è ai dottori che appartiensi; ei sono i dottori che vi dierono opera, sì perchè rappresentando eglino, per rapporto all’Ebraismo, l’epoca della riflessione succedanea a quella dell’intuito, ad essi per diritto appartiene la gerarchia delle idee, sì perchè sendo eglino depositarj della tradizione retrosalgono in certa guisa ai biblici primordii, assistono alla genesi delle idee, ricollocano ogni cosa al suo posto naturalissimo, sono per sè stessi anacronici anzi omnicronici; e sono sotto questo rispetto più antichi dei tempi biblici, e i padri e genitori spirituali dei contemporanei eziandio di Geremia e di Ezechiello.
Or bene: i tre amori che gli Esseni posero a base della loro morale, quelli che vi feci conoscere in germe, in confuso, nelle parole mosaiche, sono quelli che i dottori eressero a principio, a formula suprema non solo delle umane e sociali, ma delle religiose virtù eziandio: e se fra gli Esseni e i dottori corre una differenza qualunque,[402] ella è questa sola. Egli è lo avere questi ultimi divisamente considerato ciò che gli Esseni considerarono indiviso; egli è il proporre che fecero or l’uno or l’altro dei tre grandi amori qual unico supremo criterio di morale; egli è il dividersi le opinioni sulla preminenza dell’uno, e dell’altro; egli è il contrastarsi che fanno la morale sovranità, quando gli Esseni, invece, indiviso, collettivo ne volevano l’impero. Pei dottori se tutti convengono esservi un principio regolatore di nostre azioni, non tutti convengono sulla scelta di questo. Se per l’uno è l’amor di Dio indicato nel Deuteronomio, per l’altro è l’amor del prossimo nel Levitico comandato, pel terzo è il sacrifizio adombrato nei Numeri, per l’ultimo infine è l’unità di origine, e la fraternità universa insegnata nel Genesi.—Per tutti è una formula generalissima da cui tutti emergono sociali e religiosi doveri, e forse non andrebbe errato chi dicesse non escludersi per l’uno il principio dall’altro proposto, ma potersi tutti questi criterj conciliare in sintesi amica, non altro avendo ognuno proposto che una parte della comun tradizione.
Che se l’Etica farisaica e l’Etica degli Esseni si congiungono, si unificano in tant’altezza e sublimità di pensieri, chi potrà vantare più al lor confronto primato, sovreccellenza di dottrine morali?—Certo non il Vangelo, il quale è di tanto posteriore agli Esseni, anzi sua creatura e figlio, e che nelle scuole crebbe, si educò dei nostri dottori, come fedele ne abbiamo espressione in Gesù disputante coi dottori nel Tempio.—Ciò ch’è vero, ciò che ingiusto sarebbe disdire al Cristianesimo, egli è in primo luogo la figliuolanza, la derivazione dell’Essenato fatta eziandio più chiara dall’uniformità dei morali principj; egli è in secondo luogo la propagazione che per il mondo gentile avvenne la mercè sua della purissima morale essenico-ebraica, facendo patrimonio di tutti, ciò ch’era stato sin[403] a quel punto tra i Pagani retaggio esclusivo di pochi eletti.
Giunti a questo punto, l’ordine di questa istoria ci condurrebbe naturalmente a parlare dei dogmi delle dottrine teologiche dei nostri Esseni. E qui invero vasto, e qui nobilissimo aringo ci si schiuderebbe dinanzi. Ma perchè nol poss’io tutto percorrere? Gli Esseni che chiusero ai profani l’accesso delle loro credenze, poco o nulla lasciarono agli storici tralucere delle loro dottrine. Egli è per questo che quelle tenebre istesse che contendevano ai coetanei la cognizione dei loro dogmi, a noi pur la contendono: egli è per questo che anzichè lasciare il freno alle ipotesi, io amo meglio confessarmi ignorante. Certo non si potrebbe negare. Vi sono due sistemi grandi, celebri, antichissimi che gran parte potrebbero restituire delle dottrine dell’Essenato, in cui le idee, lo spirito, si trasfusero del grande istituto, e che perpetuarono sino a noi non pochi di quei segreti di cui furono gelosi i nostri Esseni. Questi sistemi veduto abbiamo parecchie volte soccorrerci all’uopo nelle lacune storiche dell’Essenato; questi sistemi sono quel di Filone, e l’altro di gran lunga più momentoso dei Cabbalisti, ambidue intimi dei nostri Esseni, ambedue risponderebbero eloquenti ove interrogati fossero, con scienza, con critica imparziale, con quel tatto particolare che sa ricostituire i sistemi mutilati corrosi dal tempo, come in paleografia si ricostituisce una iscrizione con parole e frasi mutilate e sconnesse. Il faremo noi? Io confesso l’opera al di sopra delle forze mie; e se non infelice provammo qualche tentativo di siffatta ricostituzione nel corso lungo di queste lezioni, ciò nonostante ella è tale la generale restituzione del dogma essenico, che infinite vi si oppongono e gravissime difficoltà, il campo vastissimo delle indagini, la miscela nel filonismo operatasi[404] di idee greche e platoniche, le tenebre densissime che involgono tuttora la teologia dei cabbalisti, e sopratutto le difficoltà proprie naturali di questo genere di lavori.—Egli è per questo che lasciando a tempi, a ingegni meno infelici il gigantesco lavoro di cui parlo, non più oltre spingerò per ora le mie indagini che le dirette notizie a noi pervenute non lo consentano. E queste, bisogna dirlo, sono poche se non al tutto insignificanti. Riguardano esse meglio la espressione, la veste esteriore che la sostanza delle idee; meglio l’imagine che involge il pensiero che non il pensiero medesimo. E pure, forse sbaglierò, ma credo fermamente che allo scopo da noi prefisso, alla dimostrazione della identità essenico-cabbalistica più monti la omogeneità della forma, che la medesimezza delle dottrine, meglio la imagine che è per sua natura meramente arbitraria che il pensiero che può nascere spontaneamente uniforme in scuole diverse. Ora io oso dirlo. Chi cercasse nel superstite simbolo già degli Esseni le imagini, i tipi che ha comuni coi Cabbalisti, larga mèsse raccoglierebbe di parlantissime analogie: testimone ciò che dice Filone avere appreso da un seguace di Mosè intorno un uomo che si diceva Oriente; ove per seguace di Mosè egli senza meno intende uno dei nostri Esseni. I quali, oltre alla somma venerazione che professavano per quell’uomo di Dio, come attestano in molti luoghi Giuseppe e Filone dal nome suo intitolandosi, meglio vi sembreranno il gran titolo meritare di Mosaiti, se ciò che dissi nelle prime lezioni ritornerete alla memoria, ed ove seguendo le traccie ultime che gli Esseni lasciarono nelle istorie, mi avvenne, se ben vi ricorda, di rammentare Beniamino di Toletola ed i suoi viaggi. Vi dissi allora come narrando egli le pellegrine cose da lui vedute sulle rive dell’Eufrate e del Tigri, di uomini pure va raccontando ch’ei vide menare vita[405] austerissima, anacoretica; ch’ei chiama a dirittura Benè Moscè ossia Mosaiti, e che pel ritratto somigliantissimo noi dicevamo allora ultimo vestigio lasciato nelle istorie dalla primitiva forma del grande istituto.—Io non aveva allora letto per anco uno degli ultimi numeri del buono e dotto giornale Magghid. Ma quale fu la mia sorpresa scorrendo un recentissimo articolo di quel periodico! In esso con bella e giudiziosa erudizione si prova appunto ciò che io non osava proporre che quale ipotesi; si prova cioè non altr’essere i Bene Mosciè di cui favellarono i nostri viaggiatori del Medio evo, di cui parlò Beniamino di Toletola, di cui parlava eziandio Eldad adani; che gli ultimi e sbandati successori dei nostri Esseni. Ch’io mi sappia, niuno finora recò in mezzo il nome che loro impone apertamente Filone, niuno avvertiva qual peso immenso rechi nella critica bilancia la deposizione di tal uomo. E pure Filone non potrebb’essere più esplicito, tanto più che di niun altri può intendere Filone per Mosaìti che dei nostri Esseni; e pure nulla più osta all’uso, allo stil di Filone che il supporre in questo nome significato il popolo ebraico ch’egli mai sotto il nome non designava di Mosaìti. Ma se Mosaìti sono indubbiamente, come vediamo, gli Esseni, che cosa di essi dice il nostro Filone? Ei dice, e voi l’udiste, che un uomo, un essere riconoscevano, che si chiamava Oriente. Io vorrei che voi aveste potuto leggermi in cuore quando la prima volta imbattevami in questa frase, la sorpresa, la dolce sorpresa che provai in quell’istante.—Ma quanto per voi facile ora stesso l’imaginarlo!—Pensate ai gravi dubbii promossi sull’antica data del Cabbalismo; pensate al confronto non mai intrapreso tra gli Esseni d’indubitata antichità, ed i Kabbalisti gridati da alcuno modernissimi; pensate che una delle emanazioni divine si chiama appunto nella fraseologia cabbalistica ora Chedem, ora[406] Mizrah, ch’è quanto dire Oriente; pensate che nei libri Talmudici che alludono ad ogni tratto, checchè ne dicano critici ingiusti, alle idee cabbalistiche, che nel Talmud, io dico, Dio stesso è chiamato a dirittura Chedem Oriente; pensate a questo e poi mi dite che cosa avreste provato al mio posto leggendo dei Mosaiti di Filone, che dicevano esserci un essere che si chiamava Oriente. Certo che la sorpresa, l’aspettazione sarebbe stata già grande. Ma quanto più grande dopo lette le parole gravissime di Filone, che seguono!—Nelle quali dopo aver detto testualmente che questo nome non s’addice ad uomo mortale, che si parla della imagine immateriale di Dio, dimostra poi a lungo non altro essere quest’Oriente che il Pensiero e la Parola eterna di Dio, che l’archetipo delle cose create, che il mondo intelligibile, modello, come vi dissi in una recente lezione, del mondo sensibile. A queste parole chi per poco abbia fruito della riposta nostra teologia, non può a meno di sentirsi colmo il petto di soavità ineffabile, la quale sempre e sempre più andrà crescendo colla lettura di Filone quando dirà essere questi il verace uomo, come verace Adam il chiamano i cabbalisti, Adam aelion, e nella parola Adam trovano il Scem Ma che si appunta nello stesso principio; quando lo chiama sommo sacerdote, come sacerdote supremo Coen gadol il chiamano i Cabbalisti, e più altre infinite cose che per la natura loro astrusissima e gelosa bello è il tacer, siccome il parlar colà dov’era. Ora, da tant’altezza conviene calare a regioni più basse; e pure nuovo documento ne trarremo a provare, mercè la identità dei segni tra le due Scuole, l’unità, la medesimezza della origine. Quando parlerò delle pratiche esseniche, e sarà questa l’ultima parte di questa istoria, ne farò allora, siccome a luogo opportuno, nuova menzione; ma egli è un uso, una pratica degli Esseni, che esprimendo una[407] delle forme, uno dei segni più comuni del loro pensiero, mestieri è pure che qui abbia luogo condegno. La destra, dicevano buona, sacra, fausta eziandio; la sinistra gridando invece rea, impura e nefasta: quindi alcune regole pratiche che muovevano dallo stesso principio: quindi lo sputare a destra interdetto: quindi la destra qual segno di onore conceduta al maggiore. Queste pratiche verranno in campo a tempo opportuno, e vedrete quanto in esse eziandio vi sia di Biblico, di Rabbinico, di Farisaico; ma ciò che si vuole qui apprezzare, è il simbolo la destra e la sinistra, tolte, l’una qual sinonimo di bene, l’altra qual imagine rappresentatrice del male.—Nel qual simbolo, due ebbero famosissime scuole i nostri Esseni.—Certo più a discepoli che a maestri ebbero in primo luogo i Pitagorici che nella loro Decade posero Destra e Sinistra quali idee ed espressioni antagonistiche. Ebbero poi, e questo è più rilevante, i teologi cabbalisti, i quali come gli Esseni, come appunto i Pitagorici, posero a loro posta nella Decade loro il Jamin e il Semol, quai principj avversi antagonistici, nella guisa stessa dei due principj del dogma iranico Otmuzd e Arimane; ma colla gran differenza che mentre i Persiani ne costrussero il Dualismo facendo due Esseri, due Dei, due principj indipendenti, l’Ebraismo serbò intatta l’unità suprema di azione, di piano, di ultimo fine, come lo stesso simbolo il prova di Destra e Sinistra, quasi due braccia che si radicano nell’unità del corpo, e ad una mente sola obbediscono, ad un solo volere. Io potrei qui, a proposito di Destra e Sinistra, recare in mezzo due luoghi d’oro che attestano la presenza fra noi delle idee cabbalistiche nei tempi talmudici—l’uno tratto dal Talmud in Scebuot, l’altro, non v’imponga il brusco passaggio, nelle Clementine—opera semiapostolica di cui fu fatta recentissima edizione, non saprei dire se in Berlino[408] o Parigi. Fatto è che tutti i lettori del Debats del 25 di agosto passato, potuto avrebbero avvertirlo in un seguito di articoli, se anche i giornali fossero letti con quel nobilissimo intendimento di trovare dovunque le sacre vestigia della verità.
LEZIONE TRENTESIMA.
Questa Lezione chiude la seconda parte della Storia degli Esseni, quella che riguarda la loro dogmatica. E comunque troppo più a lungo sarebbe proceduta la presente trattazione, se completo ci fosse stato trasmesso il sistema lor teologico, ciononostante e perchè ciò non è avvenuto, e perchè duro troppo tornerebbe al presente ricostituirlo per intero coi frammenti del Filonismo e del Cabbalismo, egli è perciò che, più breve forse che il tema non comporta, riesciva l’esame, la sposizione della loro dogmatica. Questa lezione dirà quel poco che ci rimase dei nomi divini tra gli Esseni gelosamente serbati, della loro Fisica o Cosmogonia, del concetto nobile superlativo che si formavano gli Esseni delle proprie dottrine, e in ultimo quell’autorità sarà qui riprodotta, che attesta in generale la concordanza da noi propugnata fra il sistema degli Esseni e quello dei Cabbalisti.
Voi non lo avete certo dimenticato. Quando parlavamo della istituzione degli Esseni, quando toccavamo degli Iniziati, del giuramento che lor s’imponea, noi trovammo, nella formula del loro giuro, l’obbligo di conservare scrupolosamente i nomi degli Angioli.—Non basta: io vi feci notare allora come sempre le intime corrispondenze fra Cabbalisti ed Esseni; ma se luogo vi è di questa menzione meritevole, egli è senza meno il presente, nel quale si favella della Dogmatica degli[410] Esseni, e dove per diritto debbono entrare i sacri nomi onde si parla; i quali benchè rechino il titolo di nome degli Angioli, pure per poco che le frasi si conoscano, e le appellazioni dei Cabbalisti, alludono manifestamente ai nomi, agli attributi di Dio e delle sue emanazioni. Non per questo ripeterò le cose già dette, ma se oltre le discorse analogie in proposito, oltre la nomenclatura angelica solo esistente nei due sistemi che diciamo identici se oltre il carattere fra loro comune di nomenclatura gelosa, riservata, vi può essere qualche cosa che meriti ancora attenzione, che destar possa la curiosità degli studiosi, che sappia, se non erro, di novità, che sia, se oso dir tanto, una verace scoperta, ella è la citazione presente, che appunto pel suo insigne momento vi ho serbato per la presente lezione. Quante volte non abbiamo udito gli storici sentenziare, della niuna contezza che i dottori nostri si ebbero dell’Essenato; quanto subbietto di meditazione e sorpresa e quante volte altresì abbiamo côlto in fallo la pretesa ignoranza e mille cenni ed allusioni rintracciato fra i dottori dei nostri Esseni. Io credo che i dotti di buona fede non ne ricuseranno la importanza, le conseguenze. Ma per la citazione che qui si dice, il potrebbero quando pure il volessero? potrebbero continuare come s’è fatto finora a proclamare muti, inconsapevoli, i Rabbini dei nostri Esseni. Il provino se pure il possono. Provino a cancellare quanto è scritto nel III di Jomà nel Talmud di Gerusalemme. Provino a far sì che non si legga come vi si legge—di un Asseo di Sipporì in Palestina che disse a Rab Papà figlio di Hamà: Vieni e ti comunicherò i santi nomi di Dio.—Rispose l’altro: Nol posso. E perchè? Perchè mi cibo delle decime; e chi li apprende, non può mangiare il pane di nessuno. Qui tutto parla con eloquenza irresistibile dei nostri Esseni. Il nome di Assè più manifestamente[411] e irrecusabilmente essenico dello usato, perocchè scritto in guisa (Assé) che non si potrebbe confondere con Asiâ medico il quale esigerebbe un Alef finale che qui non esiste; lo assurdo che semplicissimo medico s’intrometta nei nomi di Dio, e tanto addentro se ne addottrini da erigersi a maestro di teologia di un dottore; il luogo patria dell’Essenato, la Palestina Sipporì in ispecie, nelle cui vie per singolare coincidenza abbiamo veduto nelle prime lezioni aggirarsi un Rohel,—venditore di farmaci, sotto la maschera del farmacista riconosciuto abbiamo un della setta;—nomi di Dio che gelosamente si comunicano, come si comunicavano tra gli Esseni; e per ultimo, il gran rifiuto fatto da R. Papà per la eloquentissima ragione, ed essenica per eccellenza, che non essendo egli della scuola, non vivendo della vita sociale, vale a dire, com’egli dice, cibandosi alla tavola altrui, non sentivasi degno aderire all’offerta.
Ora di ciò che insegnavano gli Esseni, dell’origine delle cose, degli elementi primitivi della fisica o cosmogonia che facevano parte del loro sistema. E qui mestieri è prendere a guida Filone, e ciò ch’egli sul proposito insegnava. Filone professò la fisica della scuola Jonica di Talete di Mileto; e se di Grecia e Talete unicamente favellò, non è già che l’Oriente non offra esempj più antichi ed illustri; ma solo perchè la scuola Jonica esercitò più diretta influenza sulla formazione dei sistemi successivi, e protrasse la sua azione sino ai tempi di Filone, che in Grecia e in Palestina attinse gli elementi della sua filosofia. Filone dichiarò l’acqua materia prima di tutte le cose, e se Defendente Sacchi disse deridendo avere così detto Talete perchè l’acqua vedeva entrare in gran parte nella vegetazione delle zucche, il principio di Talete, non solo offre grandi analogie colle cosmogonie antiche Orientali, ma si riappicca[412] alla cosmogonia mosaica, si riflette nel sistema dei dottori.—Ciò che più monta, nel sistema e nella simbologia dei Cabbalisti, e non lascia di avere un senso, un valore, una riproduzione nei sistemi scientifici odierni di geologia e cosmogonia.—Delle prime, delle affinità, delle relazioni colle cosmogonie dell’Oriente, non parlerò perchè troppo vasto il campo delle ricerche. Ma come tacere delle altre! Della cosmogonia Mosaica che chiaro e spiccato offre il principio Essenico che mostra nell’acqua lo stato primigenio e l’origine di tutte le cose.—Dei dottori Talmudisti che ragionando sul Genesi, meglio ancora posero in luce e più precisamente formularono il principio cosmogonico di Mosè; che fecero uno studio geloso, riservato, formulato dei primi capitoli della Genesi, che chiamarono Maasè Berescet; che oltre al senso fisico, cosmogonico che ha il racconto Mosaico, ne rivolsero le frasi, e il vocabolo acqua rivolsero a significare l’idea filosofica astrattissima di sostanza, quando dissero dei Maim aelionim e dei Maim attahtonim, quando Rabbi Achibà, in un dettato aureo momentosissimo ed attamente deponente in favore dell’antichità cabbalistica, diceva ai discepoli: Quando a contemplare giungerete le pietre marmoree purissime, non dite: acqua! acqua!—Dei dottori Cabbalisti che fecero eco alla simbologia dei dottori e del vocabolo acque fecero applicazione estesissima in senso multiforme; e infine del senso che potrebb’aver tuttavia nella scienza moderna. La quale si divide anch’oggi in due campi nemici, sull’origine delle cose; e dà quindi luogo a due diversi sistemi di geologia. Si forma il primo di quei geologi che credono la terra avere ab ovo presentato una massa fluida, che andò di mano in mano indurando, e che per questo appunto si chiamano Oceaniti o Nettuniani. Si forma l’altro di quei geologi invece, che ammettono nell’origine[413] uno stato di incandescenza, che andò di mano in mano raffreddandosi e che per questo appunto si dicono Plutonisti.
E non solo gli Esseni, e con essi Filone e con essi Talete, e la scuola Jonica in generale, e con essi per avventura i Talmudisti e la Genesi, ma con essi ancora, se ben lo intendo, il Signor dell’altissimo canto, l’antichissimo Omero. Il quale con una frase che diè molto a pensare agli interpreti, e che parvemi sempre cosmogonica e geologica per eccellenza, chiama frequentissimamente gli Dei col titolo d’oceaniti; null’altro volendo significare a parer mio, che lo stato primitivo della materia caotica dalla quale sursero le forze tutte della natura o, per parlare colla lingua dei Greci, gli Dei maggiori e minori, i quali com’è facile provare coi filosofi e coi poeti alla mano, altro non erano in verità che quelle forze istesse personificate, primogenite sì della creazione, ma figliuole pur esse della gran madre natura, che nel suo stato primitivo, confuso, disordinato, portava il nome di Caos; il quale Caos vediamo infatti figurare a capo delle greche teogonie, anteriore agli immortali medesimi, padre e generatore antichissimo di tutte le cose. E questo basti della fisica e cosmogonia degli Esseni, potendo ognuno, che più a lungo sedere volesse a mensa sull’argomento, consultare Filone da cui i brevi cenni abbiamo imparato che qui si espongono.
Ora che conchiuso abbiamo quel che concerne la dogmatica degli Esseni, o per dir meglio, quel poco che di essa ci resta, dobbiamo far due cose: dobbiamo prima dire del concetto che delle proprie dottrine si formavano gli Esseni; dobbiamo dire in ultimo, del concetto che noi stessi ce ne dobbiamo formare. Voi lo avete le mille volle udito. Se v’è nulla di vero, di dimostrato nella storia degli Esseni, è la loro parentela coi Cabbalisti.—Se[414] i Cabbalisti ebbero padri antecessori, ei sono gli Esseni. Se gli Esseni ebbero figli discendenti continuatori, ei sono i Cabbalisti. Or bene: questa verità che non ho cessato di proclamare, è posta, se è possibile, in luce ancor più sfolgorante dal giudizio, dalla stima, dal concetto che di sè, che delle proprie dottrine si formavano gli Esseni.—Ch’è quanto dire il giudizio che di sè tuttavia e delle proprie dottrine si formano i Cabbalisti. Concetto grande, altero, superlativo, se altro fu mai; concetto che fa della loro dogmatica, la sola vera, la sola divina, la sola rivelata; dogmatica che ingenera nei suoi professori il vanto pubblicamente spiegato di possedere intiero, esclusivo il midollo, il secreto, la vera essenza del Mosaismo, che fa loro riguardare come profani i fratelli loro di religione che discredono o disconoscono la verità dei loro dogmi, e che per stringere tutto in breve detto, gli meritava e gli merita tuttavia dagli avversarj l’epiteto di esclusivi, d’intolleranti, mentre, com’ho provato nella mia ebraica operetta, niuno più meritossi invece il nome di tollerante, se si tratta delle persone; e niuno più legittimamente di essi mostrossi intollerante se si tratta delle avverse dottrine. Or bene questo giudizio qualunque esso sia, egli è quello, ve lo diceva, che di sè e delle proprie dottrine si formavano gli Esseni. E nel riferirvelo userò parole non mie, non arbitrarie, non parafrastiche, ma rigorose, testuali, quali uscivano da penna per nulla interessata nella presente questione, e che consuona mirabilmente coi vanti poc’anzi uditi dalle labbra dei Cabbalisti. E questa penna è quella del Nicolas, professore in Strasburgo, che tali scrive nella Revue Germanique memorande parole, nelle quali vi scongiuro ammirare la perfetta conformità coi vanti dei Cabbalisti:—Les Esséniens prétendaient avoir le secret du Mosaïsme:—non basta—et regardaient comme[415] des profanes ceux de leurs corréligionnaires qui étaient privés de cette connaissance.—Ma volete di più? volete misurare il valore dell’argomento, volete vederne la forza probatoria? Or bene; riprendete il Nicolas, e vedrete che da questo fatto medesimo, da questo vanto, da questo concetto, che di sè formavansi gli Esseni, egli prova, egli conclude trionfalmente, e che? forse la derivazione stessa dei Cabbalisti? No! ciò è poco, perchè il proverebbe nella questione parziale; ma prova e conclude da questo fatto la derivazione dall’Essenato, di quella setta di filosofi che si dissero Gnostici, i quali non dissimile vantazione menavano pur essi delle loro dottrine: la illazione pare evidente; l’argomento che vale pel Nicolas, vale anche per noi, e se si può dimostrare la derivazione del Gnosticismo dai più antichi Esseni, potrà quella eziandio dimostrarsi dei dottori Cabbalisti.
Ma io vi diceva che oltre il concetto che di sè formavansi gli Esseni, e questo abbiamo veduto, quello altresì, quel giudizio, quella sentenza avremmo dovuto non meno esaminare, che noi stessi ragionevolmente dobbiamo recare sulla dogmatica degli Esseni. Io credo che sia necessario formarsene un concetto generalissimo, e tanto mi par necessario, quanto non avendo potuto noi esaminarne i dogmi, parte per parte ci convenga più precisa, ed accertata, formarsi una idea dello insieme in quella guisa che Mosè non potendo entrare nella terra promessa, si fermò a lungo a contemplarla sopra i monti di Moab, e in quella guisa medesima che un pittore non potendo studiare per minuto una fisonomia che gli fugge, cerca di cogliere in quell’apparizione fugace l’espressione generale e il tipo supremo sul qual è coniata. Ora questo concetto, questo giudizio generalissimo non sarem noi che il proporremo. Dopo tutte le cose anzidette,[416] dopo avervi tutta la mente mia fatta aperta, sulla consanguineità cabbalistica, troppo parrebbemi aver sembianza di giudice parziale e troppo quindi disdicevole a me stesso proporvi un giudizio.—Ve lo proporrà un filosofo, un libero pensatore—un francese del secolo XIX, ve lo proporrà il Frank. E ve lo proporrà a proposito di Filone e del suo sistema, del quale le intime attinenze conosciamo da lungo tempo colla scuola degli Esseni, tantochè, ciò che di Filone favella il Frank dovrà essere intesa quasi degli Esseni istessi ei favellasse, null’altro essendo, a veder bene, Filone, che il filosofo della setta, l’interprete dell’essennato al mondo pagano, e se così emmi lecito esprimermi, l’Apostolo dei Gentili. Ora udite come intende il Frank i rapporti tra Filone ed i Cabbalisti. Come si esprima reciso, e com’egli, d’altronde se riservato, non tema di usare niente meno che queste parole: Tous les principaux traits de la philosophie de Philon se retrouvent dans le Zohar avec moins d’éclat et de profondité.—Sì, se intende metodo ed arte—no, se intende splendore e altezza d’idee e di eloquio. Ma il signor Frank non è uomo da sentenziare senza un perchè, ed eccolo testuale: Comme Philon, le Zohar s’appuie sur les traditions juives interprétées symboliquement; comme lui, il est tout à la fois mystique et panthéiste. Cet Eusoph supérieur à l’Être et à l’intelligence, le mystère des mystères, l’inconnu, l’ineffable, rappelle le Theos Agnostos de Philon: le Juif Alexandrin et helléniste a dit en grec ce que les Juifs de Jérusalem ont dit en hébreu; e così via discorrendo, ponendo continuamente a riscontro i due sistemi. Ma il signor Franck non è solo a pensarla siffattamente. Il signor Frank che, per lo assunto da lui intrapreso, per quella specie di riabilitazione che tentava del Cabbalismo, potrebbe sembrare a taluno pregiudicato, e forte nonostante[417] di tutta la forza della scienza germanica contemporanea, ed ha per se il fiore, l’eletta dei più valenti e autorevoli critici dell’Alemagna. Il Nicolas, di cui udiste non ha guari menzione, e che compendiava quanto di meglio provato resulta dalle ricerche di quei dottissimi, usa parole che non la cedono certamente a quelle che udito avete del signor Frank, e che a parer mio anco più urgentemente concludono in favore dell’assunto, avendo preso il Nicolas a parlare non già di Filone singolarmente, ma di tutti gli Esseni, e della scuola direttamente. Della quale così si esprime: Deux philosophies, fort analogues, me paraissent être sorties de l’Essénisme: le Gnosticisme et la Kabbale. On peut supposer que les Esséniens qui embrassèrent le Christianisme, s’en firent une conception conforme à leurs principes antérieurs, et ce fut le Gnosticisme; et que ceux des Esséniens qui restèrent Juifs, continuèrent les spéculations de leur secte, et ce fut la Kabbale. Parole vere e belle, e che compensano con usura le pretese ingiuste, mel perdoni la sua amicizia, del nostro illustre Luzzatto.—Ma contro di questi non abbiamo solo i nomi ricordati;—abbiamo tale che, per quanto suoni nuovo per avventura ai vostri orecchi, si levò altissimo fra tutti i moderni filologi tedeschi, e questo è il Baur. M. Baur, continua il Nicolas, les regarde (riguarda Gnosticismo e Cabbalismo) comme deux productions semblables, qu’on est obligé de ramener à une source commune.
Ora chi potrebbe dubitarne più oltre? L’esame analitico da me intrapreso e in quella parte attuato che era possibile, l’idea generale che alla sua vista ci si ingerisce, le autorità più competenti, più spassionate, tutto prova la identità da noi propugnata. E questa identità fu da noi perpetuamente dimostrata nella sposizione delle[418] due prime parti di questa Storia, Istituzioni e Dottrine; e che qui hanno termine. La terza parte della storia dell’Essenato che ci rimane a vedere, ella è, e voi lo ricordate, la storia del culto, degli usi, delle pratiche del nostro istituto, ed alla quale colla successiva lezione daremo principio. Esaurita questa ultima parte, e spero tra breve, noi avremo terminato lo studio di una gran scuola, risoluto, quanto lungi si stesero le nostre forze, un problema difficilissimo; e con amore e studio grandissimo notomizzato il corpo venerandissimo, le cui istituzioni sono l’organismo, le cui dottrine sono il cervello e la mente, le cui pratiche sono il cuore e la volontà. Ma in questa autossia, ciò che abbiamo trovato, non fu tutto materia. Broussais, così narra la fama, sendo prossimo a finire, stupiva i circostanti con queste parole: Infiniti corpi notomizzando e di tutti le segrete parti collo scalpello ricercando, mai mi avvenne trovare l’anima dell’uomo. Infelice! che s’ei l’avesse trovata, l’anima non sarebbe. Noi però siamo più felici di Broussais.—Abbiamo trovato nelle indagini nostre l’anima dell’Essenato, il suo spirito, il suo genio, la carne delle sue carni, l’ossa delle sue ossa, il sangue delle sue vene, l’alito, come dice la Bibbia, delle sue nari, e questi è il genio, lo spirito cabbalistico.—L’Essenato è morto; ma il cabbalismo, intima essenza dell’ebraismo, per quanto a terra disteso e di sudario funebre rivestito, e le nenie li facciano intorno e mortorio stragrande gli avversarj di ogni colore, e i neri fraticel, e i bigi e i bianchi, ciononostante come il profeta sepolto, di cui si narra nei Re, non solo vive d’una vita interiore, ma ai grandi morti eziandio la comunica al solo contatto.—Noi abbiamo posto gli Esseni al contatto del grande sepolto; al contatto del cabbalismo; ed a quel contatto, oh miracolo! l’Essenato è risorto.
LEZIONE TRENTESIMAPRIMA.
S’egli è vero che ai sospirosi naviganti l’animo si rinfranca al pensiero della meta vicina, egli non è senza più celere fiducioso muovere il passo verso il termine desiato, che io tocco stasera la terza parte della Storia degli Esseni; dopo avere studiate le loro istituzioni e i loro dogmi, io chiamo a rassegna le loro pratiche, la loro vita. Ma la vita sociale come la vita dello individuo, gli atti dell’una come gli atti dell’altra, possono in tre grandi ordini e sommi capi dividersi secondo il triplice oggetto a cui la vita e gli atti si riferiscono; vi è la vita religiosa che comprende gli atti, le opere che hanno Dio e la Religione per obbietto; vi ha la vita privata che le opere inchiude che all’uomo istesso si riferiscono, i suoi abiti, le sue virtù, le regole che a sè medesimo s’imponeva, e che hanno per ultimo fine lo individuo, la persona medesima; vi ha infine la vita pubblica, la vita esteriore, quelle opere tutte abbraccia nel proprio seno, che al prossimo, alla città, al mondo intero si riferiscono. Egli è per questo che per amore di ordine, di chiarezza, di brevità, io ho in tre parti distinto lo studio della essenica vita. Vita religiosa, ossia culto: Vita privata, ossia abiti e virtù: Vita pubblica, ossia rapporti esteriori. Di queste tre parti, la prima, vuoi per l’argomento fecondo, vuoi per dignità, vuoi per logica preminenza, merita il primo posto, e volentieri glielo concedo.[420] La vita religiosa dell’Essenato si esamini dunque nelle sue parti. E perchè l’ordine si ramifichi nelle più minute parti eziandio del subbietto, si dica in primo del culto che a Dio si rendeva, e del culto istesso quella parte in prima si consideri che riguarda i luoghi religiosi, i tempi, gli oratorj.
Vi è una frase in Giuseppe, che per bene intendere ci conviene che vi riduciate a memoria i tempi in cui visse, in cui fiorì il grande istituto. Qual fu il secol d’oro dell’Essenato? fu quello, si può dire, che più famoso rimase per le calamità infinite che piovvero sul nostro popolo, il primo secolo dell’era volgare. Ei fu allora, nel precipite declinare del nostro sole all’occaso, nella dissoluzione estrema di ogni legame politico, all’ombra del tempio che minacciava rovina, che lo spirito, il pensiero, il genio dell’ebraismo, come fiamma che stia per ispegnersi, mandò pria di finire un ultimo raggio, e quel raggio fu l’Essenato. Ora tra gli Esseni che sopravvivono alla morte di ogni nobil cosa fra noi, e lo eccidio ultimo che minaccia la patria, vi è un testimone; testimone della grandezza degli uni e della miseria dell’altra, della vita possente, rigogliosa del primo, e della disperata e violenta agonia dell’ultima; e questo testimone è Giuseppe. E che cosa dice Giuseppe che dell’uno e dell’altro stato fa nei suoi libri fede continua? Dice parola che mi fece per non brev’ora meditabondo; e il cuore m’empiva di poi eziandio d’ogni indicibile melanconia. Quando Giuseppe, parlando delle pratiche esseniche, dice che gli Esseni non entravano nel tempio per timore di profanarsi al contatto della folla che ingombravalo, parevami nell’udirlo una cosa:—Mi pareva vedere nell’Essenato il genio irato dell’ebraismo trarsi in disparte dall’orribile scompiglio sopravvenuto; parevami trincierato nella sua solitudine imprecare alle passioni, ai peccati, al disordine[421] che infuriavano; parevami, preso in dispetto il tempio, fuggirsene lungi, come fuggita se n’era la gloria di Dio ai tempi di Ezechiele; e come fuggire accennava dal secondo tempio eziandio quando per entro alle sue mura, come narrano Ebrei e Pagani, udissi quel suono, quel calpestio, quella voce di partenza che disse: Esciamo da questo luogo. Io vel confesso ingenuamente. Il primo senso che io colsi nelle parole flaviane, non fu sì vero, sì profondo, non fu questo che io dico: parevami, e male parevami, che qui si trattasse di qualche cosa di ordinario, di normale; parevami volesse dirmi Giuseppe, non riconoscere gli Esseni, non ossequiare almeno in pratica, il culto pubblico, la casa di Dio, il tempio di Gerosolima. Ma quanto ingiustamente! E non solo perchè gli Esseni, Ebrei quanti altri mai, non potevano ragionevolmente disertare tempio ed altari; non solo perchè le cause da Giuseppe assegnate, accennano manifestamente a temporaneo ed eccezionale abbandono, per istudio eccessivo di purità, ma soprattutto perchè la storia parla eloquente, perchè troppo anzi giustifica il ritiro e la diserzione dell’Essenato. Bisogna leggere le storie per persuadersene. Bisogna leggere delle passioni che si scatenavano ignobili, brutte, furiose nel sacro recinto, del sacerdozio venale, ambizioso, intrigante, vendereccio, lussurioso; bisogna leggere degli eccidj commessi sui gradini del tempio, degli altari di Dio conversi in campo di battaglia dalle fazioni che laceravano la patria; delle bruttezze, delle enormità d’ogni maniera che un popolo, che un sacerdozio feroci, farneticanti commettevano all’ombra del tempio. È miracolo dunque se gli Esseni quando Giuseppe parlava, ch’è quanto a dire, allora appunto che le scene discorse si spiegavano in tutta la lor turpitudine, fuggissero lungi da quelle mura contaminate, dalle mura del tempio? È miracolo, quando sapremo[422] le regole rigorose inflessibili che avrebbero dovuto vegliare, e che avevano infatti in altri tempi vegliato alla purità di quel tempio, quando sapremo dalla tradizione che ce lo narra, che tante parti eranvi nel tempio quanti gradi vi erano nel popolo di purità, che altro per esempio era il luogo ai Gentili dischiuso, altro agli immondi per contatto di morti, altro ai Tebulè jom, altro ai Mehusserè caparà, altro alle donne, altro agli uomini riservato, ed altro infine ai sacerdoti? E quando pure queste regole comuni, per ognun doverose, non fossero state ad ogni istante manomesse dal disordine, dall’anarchia imperante, non avevano eglino, gli Esseni, specialissime regole di purità, che non essendo generalmente osservate avrebbero pericolo corso di violazione quando commisti alla folla dei devoti fossero entrati nel tempio? (Vedi Lezione XII.) Ma se Giuseppe accennava di porci in imbarazzo coll’asserzione che abbiamo adesso storicamente giustificata, non meno a prima vista riesce duro a comprendersi quanto egli aggiunge immediatamente. Quando Giuseppe dice apertissimo che gli Esseni sacrificavano nelle case loro, nei loro chiostri, nel loro ritiro, non vi par egli che osti, non solo al deposto della tradizione, ma eziandio ad un testo formale, ove s’interdice il sacrifizio fuori del recinto sacrato? E veramente all’uno e all’altro osterebbe Giuseppe, e non solo dalla legge ingiustificato, ma contraddetto parrebbe ancora dalla storia contemporanea, che non ci mostra in Palestina a fianco del tempio pubblico nazionale di Gerosolima, nè altri tempj, nè altro altare, nè altro culto. Che cosa dunque volle dire Giuseppe quando parlava dei privati, dei domestici sacrifizi dell’Essenato? Io ci ho lungo tempo riflettuto, e solo due possibili spiegazioni mi sovvenivano all’uopo opportuno. Voi lo avete udito più volte. Oltre gli Esseni di Palestina, oltre gli Essenici Chiostri di[423] Terrasanta, vi erano gli Esseni di Egitto, quelli che udito abbiamo chiamar Terapeuti, erano le case, i ritiri di Egitto. Or bene, la storia ci ha serbato un fatto, un gran fatto, per la storia degli Esseni, per la questione presente segnatamente. E questo fatto è la esistenza di un tempio in Egitto, foggiato appunto su quello che inalzavasi in Palestina, di esso contemporaneo e rivale, ed ove il sacerdozio, il culto e sacrifizj e le forme istesse architettoniche dell’edifizio porgevano imagine fedelissima del modello palestinese. Furono eglino al tutto estranei i Terapeuti di Egitto, se non altro alla elevazione, alla conservazione almeno dell’ossequio, che ivi riscoteva generalissimo il tempio egiziano, il tempio di Onia? Io non lo credo: non lo credo, perchè i Terapeuti avrebbero fatto allora scissura ai fratelli alessandrini, nè la storia ci autorizza a menar buono il supposto: nol credo, perchè l’Esegesi tradizionale del verso citato può non aver esercitata, a tanta distanza del centro ortodosso, l’azione sua proibitiva; non lo credo, perchè i Terapeuti di Egitto, per quanto a parer mio Esseni trapiantati in terra straniera, ciononostante come pianta divelta dal suolo natio, non lasciava di offrire sembianza alquanto degenere dall’originario sodalizio per la miscela di idee greche od egizie colà operatesi; e non lo credo infine per un curioso cenno che la mia stella propizia mi offriva in Maimonide. Maimonide, oltre la grand’opera rituaria che lo ha fatto sì celebre nel Rabbinato, è autore di un comento misnico che scrisse all’età di venti anni, e che dettava come altre sue opere, in purissimo arabo. Or bene, in questo comento che io dico, al 13º di Menahot, e là appunto ove nella Misnà si favella del tempio egiziano, del suo fondatore per nome Honiò, io trovo in Maimonide preziosissima indicazione. Quando dice della fuga di Honiò in Egitto, quando narra del favore trovato da esso nella[424] corte dei Tolomei, della grand’opera intrapresa, del nuovo tempio, dei seguaci, degli aderenti che secondaronlo, sapete chi egli annoveri tra i cooperatori e ajutatori del nuovo Esra? Egli annovera una sètta, sono sue parole, Kaptzar. Un pensiero mi sorrideva, mi tentava, e comecchè da principio non osassi confessare nemmeno a me stesso, pure a poco a poco presi coraggio, ed ora a voi lo espongo. Sarebbe egli possibile che nell’informe vocabolo si nascondano i Copti?[88] Ma io oso dire di più: oso dire che non al tutto sarebbe oggi stesso difficile seguire quello strano rivolgimento di casi per cui gli antichi Terapeuti di Egitto divennero in bocca a Maimonide la sètta dei Copti. E questo filo conduttore, questo filo d’Ariana nel nerissimo laberinto ce lo porge la storia. La quale ci addita nei Copti l’antichissima, la primitiva chiesa cristiana di Alessandria fondata da Marco; che ci narra la confusione sino ab antiquo avvenuta, e di cui vi tenni parola nelle prime lezioni, tra i Cristiani di Egitto e i Terapeuti colà stabiliti: le strane pretese d’identità spiegate sino ai nostri giorni dai dottori della Chiesa, e fondate unicamente sopra tale confusione; e infine il nome di Terapeuta usato positivamente nei primi secoli qual sinonimo di cristiano, di monaco, di solitario. Che cosa dunque avvenne a parer mio? Vi era una tradizione sino a Maimonide perpetuata, del concorso prestato ad Onio, al suo tempio, al suo culto, dai terapeuti di Egitto. Di questa tradizione Maimonide ebbe contezza. Maimonide che dimorava in Egitto, ch’è quanto dire nella patria stessa dei Terapeuti, nell’antica sede del tempio Onico, colse in Egitto stesso dalla storia, dalle tradizioni egiziane il fatto in discorso; ma lo colse corrotto, alterato, degenere, quale i secoli e la ignoranza lo avevan ridotto. E così alterato e degenere lo trasmise ai nipoti. Di Terapeuti ebrei si era fatto Terapeuti cristiani[425] di questi, con facile e legittimo transito, e solo l’antico nome traducendo con più moderno vocabolo, si era fatto i Copti.—E i Copti appunto disse Maimonide cooperatori di Onio. E i Copti, ch’è quanto dire i Terapeuti, gli Esseni d’Egitto, ebbe forse di mira Giuseppe quando parla dei privati, dei domestici sacrifizj da loro praticati. E questo è uno dei due sistemi possibili per ispiegare Giuseppe. L’altro è più breve, e non vi so dire se meglio persuasivo. I sacrifizj di cui parla Giuseppe sarebbero patrj, indigeni, palestinesi, sarebbero proprj degli Esseni di Gerosolima; e se la legge a tali sacrifici si opponeva non è tale nè sì generale il divieto che un caso solo non se ne eccettui, che non sia anzi permesso raccomandato, ed a cui potuto hanno dar opera i nostri Esseni secondo Giuseppe. E questo caso è quando non l’Ebreo, ma è il Gentile, ma è il Pagano che offre. Allora ogni barriera si abbassa; allora non più tempio, non più recinto, non più limiti che circoscrivino l’adorazione umanitaria; allora la natura quanto è vasta, un campo, una riva, la cima d’un colle, son tempio condegno al culto di Dio; allora, secondo nostra fede, non solo il gentile può scegliere luogo a sacrificarsi qual più gli talenta, ma ciò ch’è sovrammodo degno di nota, egli è il permesso all’Ebreo conceduto, di dirigerne, di regolarne l’esecuzione, di prescriverne i modi più accetti, di additarne il rito voluto, legittimo e già determinato dalle nostre leggi;[89] allora vediamo i Dottori Talmudisti sul fine di Zebahim, mettersi tutto cuore e tutta anima a secondare le pie vedute di nobili e signori pagani della madre di Sapore, monarca di Persia, insegnar loro il modo di sacrificar più accetto, ad assistere personalmente al sacrifizio, a predicarlo meritorio, e in certa guisa parzialmente antivenire quel ministerio sacerdotale che sarà proprio e naturale d’Israele, alla fine dei tempi.
Ma noi dei sacrifizj essenici ragionando, abbiamo trovato, se la congettura non erra, un loro tempio, il tempio di Onio in Egitto. È questi il solo che pretenda all’onore dell’Essenato? Io credo che di due altri tempj ragioni la storia che più o meno possan vantare essenica cittadinanza. È l’uno quella famosissima Proseuca o Sinagoga che sorgeva, non saprei dire se presso a Tebe o nelle mura di Alessandria, e di cui è menzione pomposissima nel Talmud di Succà, con qualche curiosa variante, tra il Babilonese e il Gerosolimitano, e che rovinò per ordine, dice il Babilonico, di Alessandro, per ordine, dice il Gerosolimitano, e dice meglio, di Trajano l’empio, Traghianos arasciah. Sono le altre quelle sinagoghe di cui udiste parlare in altre lezioni a proposito della vita campestre dell’Essenato, quelle Proseuche campestri, come le chiamano i dottori, ed in cui parevami e parmi ancora vedere memoria degli antichi oratorj dell’Essenato.
Ora una parola della Preghiera Essenica ed avremo finito. Pregavano gli Esseni, dice Giuseppe, al sorger del sole, gli è quanto dire in quell’ora istessa in cui pregavano i Vatichim del Talmud, altro nome dei nostri Esseni, e di cui videro i dottori nostri cenno in quel verso che dice Irauka im Sciamesc. Non basta: Giuseppe ci porge nuovo riscontro colla preghiera dei dottori. Gli Esseni, ei dice, non parlano di alcun affare prima del sorger del sole. E i Farisei pure, e lo dicono e lo raccomandano e lo osservano. Per essi, non solo gli affari, ma il conversare, ma il saluto istesso è interdetto pria che il sole risorto e l’anima ridesta mandino il saluto alla eterna fonte di ogni salute: tanto che vi furono e vi sono tanti Esseni senza saperlo, che imbattutisi per via prima di orare in un amico, usano frase che non è saluto ma è preghiera. Ma ciò che l’animo non ardiva sperare,[427] ciò che parrebbe superare ogni aspettazione, egli è la esistenza, la conservazione tuttavia nella Liturgia ortodossa di un Inno, di un Canto superstite dell’Essenato. E pure di questi miracoli, ed altri maggiori, è capace la bella e feconda per quanto ardita erudizione germanica. Se uomo vi è capace di dar credito e faccia di verità ad una ipotesi egli è senza meno il Nestore dei Rabbini tedeschi, il dotto e celebre Rapaport, gran Rabbino di Praga. Ora secondo il Rapaport vi è una preghiera tra quelle che si recitano nel sabato, che appartiene all’antica Liturgia degli Esseni; ed è quello un ordine alfabetico che incomincia El adon. Credo l’opinione del Rapaport assai verosimile, e ciò che vi parrà singolare, per quelle ragioni appunto che altri la osteggiò. E questi è un dotto e piissimo Rabbino Tedesco, tolto, non è molto, ai vivi, il Zebi Tro Haiot. Il Haiot nell’Imrè Binà trova la congetura del Rapaport inverosimile, e per quella ragione appunto la credo tale, che dovuto avrebbe persuadergli il contrario. Egli trova nel Fur una diversa lezione nella preghiera in discorso, trova che là ove leggiamo Raà veitkin, vide e formò, leggere si debba invece raà veictin, vide e impicciolì la forma lunare; e siccome tale lezione si fonda sopra un’Agadà del Talmud babilonico, ove si dice che la luna dicadde nella gerarchia degli astri, e di stella che era divenne satellite, egli crede che non si possa a buon diritto supporre nelle preghiere esseniche menzione di questa leggenda. Dico il vero, il raziocinio del Haiot, non dirò mi sorprese, sarebbe poco, mi empì di stupore. Possibile dissi fra me! Possibile che tanto abbia egli negletto ed obliato così scrivendo! che abbia obliato come alla perfine la lezione di cui favella non é la sola; ed ove l’altra, punto all’Agadà allusiva, si addottasse, resterebbe la congettura del Rapaport incrollata! Possibile che abbia posto in oblio, come l’Agadà[428] della degradazione lunare sia eminentemente Cabbalistica: e come tale, e come uno dei punti più culminanti del Cabbalismo talmudico, sia portata in trionfo dai teosofi antichi e moderni. Possibile che non siasi ricordato come appunto la lezione da lui proposta prevalga tra essi alla lezione contraria; possibile che abbia posto in non cale un fatto momentosissimo, e che solo basterebbe a dar ragione a Rapaport; voglio dire la importanza conceduta, i lunghi ragionamenti, le speculazioni Cabbalistiche che fa il Zoar su questa preghiera di El adon: è possibile infine come non abbia veduto che non altro essendo gli Esseni che i Cabbalisti antichissimi, se vi è scuola a cui s’acconci la preghiera in discorso che possa dire altamente vide e impicciolì ec.; eglino sono senza meno i nostri Esseni, a cui in verità e tanto meritamente l’attribuiva il rabbino di Praga. Ma se causa vi è di tanto oblio, ella è questa una: il non avere a bastanza il Haiot riconosciuto la identità da noi propugnata tra Esseni e Cabbalisti; l’aver trovato disdicevole ai primi ciò che avea trovato dicevolissimo ai secondi; e se il Haiot vivesse ancora, tanta era la sua pietà e la dottrina, che, oso dirlo, egli avrebbe plaudito ai nostri sforzi, e trovato avrebbe col Rapaport essenica per eccellenza la preghiera di El adon, perchè potuto non avrebbe negare essere la sua lezione per eccellenza cabbalistica.
LEZIONE TRENTESIMASECONDA.
I tempi, i sacrifizj, le preghiere dell’Essenato ci occuparono nelle passate Lezioni. Noi dobbiamo con passo misurato e rapido a un tempo procedere oltre; dobbiamo di quell’argomento favellare che più dappresso si attiene alle cose discorse; dobbiamo, a dir breve, ragionare delle Feste. E prima del Sabato Essenico, siccome quello che torna più di frequente e in cui più luminose spiccano le analogie farisaiche. E queste sono parecchie e di non lieve momento. È la prima quella che riguarda il Muczè. Che cosa è il Muczè? È quel divieto pel quale ogni uso e contatto eziandio ci è interdetto di quegli oggetti, che un officio adempiono proibito nel sabato.—Qual sarebbe a mo’ di esempio una vanga, una scure, delle legna, delle monete, divieto principalmente farisaico e tradizionale. E pure, gli Esseni il conobbero, e non solo conosciuto ma praticato era dal grande istituto, se stiamo a Giuseppe, il quale, con parole che più non si potrebbero esplicite, asserisce a dirittura non solo astenersi gli Esseni nel sabato da ogni opra servile, ma non osare cambiar nemmeno un utensile di posto, ch’è quanto dire il vero e preciso Muczè farisaico. Ma le cose che seguono non solo offrono nuova conferma alla identità favorita, ma anche solo da questa traggono la sola luce e intelligenza possibile; tanto senza la tradizione nostra tornerebbero incomprensibile. Quando[431] Giuseppe, dell’Essenico Riposo favellando, dice che da ogni necessità naturale si astenevano se non costretti, che cosa volle dire Giuseppe? Oso dire che le parole di Flavio riuscirebbero strane, ridicole eziandio, ove al contatto non siano poste della tradizione farisaica.—Ma poste di questa a riscontro, qual cambiamento! Non è dessa che l’uso interdiceva dei purganti nel sabato ove pericolo non corrasi della salute? non è dessa, che alludendo ad uso allor comunissimo, proibiva eziandio quegli emetici che non solo a ristoro della salute perduta, ma per istudio eziandio di crapula, d’intemperanza solevano prendere i parassiti romani? Certo che è dessa, è la tradizione che di tali cose ragiona, ed essa pertanto ci offre quella sola intelligenza possibile all’uso essenico che ricorda Giuseppe.—Ma il terzo punto che concerne il sabato essenico, non meno degli altri eloquente depone in favor nostro. Se gli Esseni, come attesta Giuseppe, portavano abiti distinti nel sabato, se onoravano anche nella loro persona il riposo sabbatico, che segno è? Egli è segno che gli usi, che le pratiche, che le interpretazioni eziandio adottavano dei Farisei, perchè appunto egli è da una interpretazione a Isaia, che trassero i Dottori l’obbligo di recare vesti distinte particolari nel sabato.
Per le Feste, non è questa la prima volta, che ne udite parlare.—Quando cercavamo la derivazione essenica dagli antichi Hasidim, voi lo ricordate. Noi parlavamo di una festa Terapeutica in cui mille spiccavano analogie colla festa della Scioabà; e noi lasciavamo allora indeciso se, salvo il ceremoniale e il solennizzare che era senza dubbio conforme, la stessa festa, lo stesso giorno fosse dagli uni e dagli altri in modo così conforme solennizzato. Ciò che allora mi pareva dubbioso, mi sembra oggi, non so se a torto, indubitato. Io credo che[432] salvo il Rito, e lo ripeto che era conforme, la Festa di cui parla Filone, quella non sia di cui parla il Talmud, non sia cioè la festa dell’autunno, la Scioabà, ma sia per contro la Festa delle Settimane del Pane terreno e del Pane celeste, della terra e del cielo fecondi, la festa di Sciabuot. Io oso dire che se avessi dovuto scegliere a libito mio, qual festa tornar potesse più acconcia al mio sistema, quale più di ragione mi fornisse nelle mie congetture, io non avrei altra festa potuto scegliere se non questa. E pure non l’arbitrio mio, ma le autorità irrecusabili degli antichi ce lo attestano.
E non solo attesta, come dissi, che quella festa era la festa delle Settimane, ma due grandi insegnamenti eziandio ne somministra nell’esporne in primo luogo la teoria e in secondo luogo nel narrarne la pratica. La teoria! Io oso dire che non potrebbe essere più consentanea al vero spirito della Bibbia, e alle più famigerate teorie cabbalistiche. Quando Filone espone le Dottrine terapeutiche sulla festa del Sciabuot, ci pare l’eco fedele delle idee più frequenti e più proprie dello Zoar; ci pare, ciò che è veramente, che uno sia l’insegnamento, una l’origine, una la scuola. Quando Filone fa dire ai Terapeuti il Sette numero santissimo, e quindi santissima la Settima Settimana dopo l’èra nazionale della Pasqua, quando lor fa dire la Settima Settimana casta e sempre vergine, dice cosa che inchiude un mondo d’idee cabbalistiche, che accenna in mille guise a quelle riposte dottrine, che riproduce in modo esattissimo, non solo i simboli e le espressioni più favorite, ma li produce in modo che più non si potrebbe opportuno. Perocchè egli è appunto intorno all’argomento del Sciabuot, che si accumulano, che si affollano nei libri teosofici le idee, i simboli uditi poc’anzi in nome dei Terapeuti, che tu odi, come udito abbiamo dagli Esseni preconizzare, glorificare[433] il Settenario, e quello venerare nella Settima settimana, che ricorrono, come ricorsero appo gli Esseni, i nomi, gli appellativi per la Settima settimana di casta e vergine Bat Scebah, Betulat israel; e che la festa del Sciabuot tu odi come intendevamo or ora dagli Esseni, chiamata il Settenario Sacro e solenne nel Ciclo Annuale.
Ma io dissi che non solo la teoria, ma anche la pratica da Filone narrata non riuscisse meno preziosa pel nostro assunto. Io vorrei avere tra i miei uditori coloro che tolsero a testo delle loro declamazioni l’uso prevalso tra noi di vegliare la notte intera in letture, in meditazioni devote, la notte di Pentecoste, la notte, dice il Zoar, in cui la Sposa s’apparecchia pel talamo nuziale; vorrei che fosse tra gli altri il nostro venerando Luzzatto, e ch’egli, a cui niuno può far da maestro, vedesse quanto giova lo studio dell’Ebraismo extrarabbinico, qual’è a mo’ d’esempio la storia delle sètte, per la rivendicazione di certi veri che non prendono faccia di menzogna se non quando sono isolati da tutte le manifestazioni contemporanee dell’idea religiosa. Egli che nel suo recente vicuah apriva la scena con un pio consesso, con una veglia religiosa per mostrarne, s’intende, la inanità e la fatale rovina col rovinare della base che è lo Zoar che la preconizza; egli così schietto e disinteressato cultore del vero, venga e veda. Veda i Terapeuti, che noi abbiamo sempre predicato antenati dei Cabbalisti, darsi in quella sera istessa in cui si danno i loro tardi nipoti, non già a quelle letture, a quelle pratiche istesse, a quel programma inalterato che vediamo oggigiorno seguito, perchè chi questo esigesse, esigerebbe l’assurdo; ma darsi a preci, a canti; e poichè nel recinto del Tempio di Gerosolima i Hasidim si davano pure alle danze, ed essi ancora i Terapeuti, come attesta Filone[434] medesimo, intrecciare parole, e poi all’alba, come udiste altra volta, di nuovo orare, e tutta insomma quella notte trascorrere in offici che se non hanno la forma istessa dei tempi moderni, ne hanno lo spirito. E poi, potrò io tacerlo per timor di sorprendervi? potrei negare che quella danza istessa, che urta tanto gli abiti, le idee, i pregiudizj contratti, che vi sembra, me lo figuro, sfidare tutti gli sforzi che io spendo a trovarne le vestigia fra noi, è tuttora visibile in qualche parte di mondo, ove si voglia frugare per entro ai costumi dell’universal ebraismo. E perchè dovrò tacere ciò che io ho veduto? Perchè non dirvi non solo che l’uso di danzare in Simhat torà è costume predominante tra gli Ebrei di Africa e di Oriente, ma che nella mia più tenera infanzia io stesso ne fui spettatore? E il santo e pio Coribante era un dottore che Livorno vide prima opulente e generoso sino alla prodigalità, e poi povero e anche più generoso, che amai fanciullo, e stimai e rispettai giovinetto siccome quello che mi parve di cuore e mente nobili elevatissimi, e che, a rovescio del ritratto di Petrarca che disse sotto biondi capei canuta mente, conservò già vecchio la candida, la fervida poesia del cuore: egli dotto, ingenuo, facondo, civilissimo familiare in Londra de’ lord John Russel e del Duca di Cambridge, cultore anzi adoratore di ogni sapere, ma più adoratore della patria nostra antichissima che sospirò negli anni suoi tardi, dove trasse, stanco dei favori e dei disfavori della fortuna, e dove pochi giorni dopo il suo arrivo morì di morte repente, per un bacio divino dicono sublimemente i dottori, Mitat Nescicà il giorno stesso di Sciabuot mentre compieva l’atto suo più favorito, mentre parlava. Ed ei danzava e nel suo privato oratorio con leggiadrissimo e piccolissimo Pentateuco alla mano, rinnovava la scena dei Terapeuti, ed io fanciullo stupefatto guardava, e poi risi, e più tardi[435] pensai, ed ora intendo.—E voi pure, ne son sicuro, intendeste. Intendeste come la danza dei Hasidim veossè Maasè nel tempio di Gerosolima, la danza dei Terapeuti che narra Filone, la danza del santo dottore che ora udiste, sia un atto solo ripetuto in luoghi e tempi diversi, l’espressione identica di un sol culto, di una sola scuola, che si chiama ora Hasidim, or Esseni, or Terapeuti, ora e proprio ora Cabbalisti sempre gli stessi e sempre diversi, sempre gli stessi nella sostanza, sempre diversi nella forma e nei nomi. E sopratutto intenderete il solenne insegnamento, ch’emerge dal soggetto principale del confronto presente, le veglie esseniche e cabbalistiche di Sciabuot in pari modo osservate dalle due scuole tra i primi, tra gli Esseni in alta e incontestabile antichità, tra i secondi in tempi a noi più vicini, ma che posti coi primi al contatto ne formano seguito e anella indivisibili, osservate da entrambi per le stesse ragioni, espresse da entrambi cogli stessi simboli, trascorse da entrambi in atti religiosi se non al tutto conformi.
E ciò che vi parrà, ne sono certo, aperto contrassegno di verità è il linguaggio che tiene lo Zoar a proposito delle veglie medesime. Non basta allo Zoar datare le veglie in discorso da R. Simone e dai suoi colleghi, ciò che bastato sarebbe a un impostore. Lo Zoar con uno sguardo retrospettivo, che non è comune troppo nelle sue pagine, ricorda tempi, uomini, esempj, più antichi come più antichi certo del Ben Johai furono gli uomini, i tempi, gli esempj dell’Essenato, nei quali e pei quali le veglie in discorso erano già state introdotte in Israel. E con quali parole ricorda lo Zoar quei tempi più antichi! Con frase che designa direttamente il grande Istituto, se le tante cose dette in queste lezioni sul vocabolo Hasidim non furono invano. E se nol furono, come non credo, chi non sarà di dolce sorpresa assalito leggendo[436] nello Zoar di Emor queste parole: E per ciò i Hasidim antichissimi non dormivano in questa notte: in cui la parola Hasidim non comune nello Zoar è acconcia propria speciale che nulla più all’epiteto Cadmaè antichi che segue dappresso, essendo, come dissi più volte, il nome di Hasid proprio ai Cadmaè cioè agli antichi progenitori dei Zoaristi, agli Esseni e Terapeuti, anteriori certo allo Zoar e allo stesso R. S. B. J. E non solo il passo citato favella dell’uso in discorso, ma la Prefazione eziandio dello Zoar a pagina 8 diffusamente ne parla. Parla dell’uso come da lungo tempo introdotto, degli uomini che si davano opera, e che sono evidentemente non già i Farisei indistintamente, ma quella parte più eletta che si chiamano habrajà dibnè ekalà deeallà. Si parla di nozze, di tripudj nuziali e quindi l’idea risveglia di danze e di canti; si parla di paraninfi, della mistica sposa che sono i dottori rammemorati; si parla nei libri posteriori della recitazione del Cantico dei Cantici mistico Epitalamio, e quindi sommamente consenziente alle idee preaccennate. Si parla di Tebilà nel mattino seguente di Sciabuot, come abbiamo veduto i Terapeuti di Filone dopo i riti notturni purificarsi con generale abluzione, e questo è notevolissimo riscontro come vedete. Infine uno dei punti delle pratiche stimate meno autorevoli dei Cabbalisti riesce così storicamente rivendicato.
LEZIONE TRENTESIMATERZA.
La prima parte della essenica vita, della essenica pratica, vuole essere qui terminata, la vita, la pratica religiosa.—Dopo i tempj, i sacrifizi, le preghiere studiate nella prima Lezione, dopo i sabati, le feste studiate nella successiva Lezione, vuolsi qui far menzione di due fatti che la storia degli Esseni ci ha tramandati, e che possono agevolmente in un fatto convertirsi. Riguardo al primo, l’essenico giuramento, non quello che lo iniziato pronunziava al suo ingresso, ma quello comune, ordinario, legale che si prestava innanzi ai giudici. Se stiamo a Giuseppe, gli Esseni reputavano spergiuro il giuramento istesso comunque veridico.—Giuseppe non si spiega di più, ma le analogie farisaiche, la legislazione ebraica del giuramento non solo spiegano, ma limitano e circoscrivono nei termini del vero, del verosimile l’asserzione di Giuseppe. Gli Esseni non possono avere considerato spergiuro quel sacramento prestato in modo legittimo pro tribunali, ed in quei casi, in cui non solo la legge il consente ma imperiosamente lo esige. Se questi pure avessero involto gli Esseni nella comune riprovazione, se detto avessero colpevole un atto chiarito da Moisè innocente, e talvolta altresì doveroso, potrebbero più dirsi veraci Ebrei, come pure lo erano eminentemente i nostri Esseni? potuto avrebbero al tempo stesso[438] tributare quella venerazione stragrande all’uomo divinissimo che pur tributavano a segno, come dice Giuseppe, di proclamare sacrilego chiunque meno che reverente favellasse dell’uomo di Dio.—Che se la ragione, la storia, i fatti più ovvj escludono questa lata, assurda interpretazione di Flavio, che cosa resta nella sua asserzione? Nulla a parer mio che mai sia, non solo in grado sommo conciliabile colla legge e le tradizioni farisaiche, ma anche che da esse e solo da esse tragga luce ed intelligenza adequata. Restano i giuramenti insulsi comunque veridici, lo affermare con sacramento fatti notorj incontestati, di colonna marmorea, come dice il Talmud, che è di marmo, di fatti pubblici incontesi che sono avvenuti, e quella insomma molto diversa dal falso giuramento che reca il nome di vano ed insulso e si dice legalmente Sebuat Sciav. Ma questo stesso quanto non giova al nostro assunto! Se ricusato avessero gli Esseni la tradizione farisaica, se dello spirito dei dottori non fossero pieni, se una sola scuola non avessero con essi formato, avrebbero eglino col solo, col nudo testo alla mano, il giuratore insulso dichiarato spergiuro? Io ne dubito, e tanto più esiterei ad ammetterlo quanto più i testi sembrano favorire l’equivoco tra il Sciav e il Sceker, e presentarle ambidue come identiche espressioni di un sol giuro. E se ogni altra prova mancasse, basterebbe questo fatto soltanto, basterebbe vedere la duplice versione del Decalogo servirsi sempre del vocabolo Sciav nel quale non potrebbe non vedersi il vero spergiuro, il falso giuramento. Che se la sola tradizione, il solo farisaico può avere agli Esseni amministrata la legale nozione del giuramento insulso, che sarà poi ove nello stesso giuramento vero legittimo, necessario vedeste le due scuole porgersi amica la mano, e se i Farisei non disdicendo, come disdir non potevano, il giuramento legale, pure li vedeste[439] ristringere nei limiti che più poterono angusti. Se ne circoscrissero l’applicazione, ed anco nei casi indispensabili lo infamarono? Vi è un luogo d’oro nel Tanchumà ove il prescritto del Deuteronomio «ad esso ti attaccherai e pel suo nome giurerai» ove l’autorevole, il legittimo giuramento è a tali e tante condizioni subordinato, di morale, di religione, di virtù pellegrine, che pochi sarebbero coloro che nei secoli più perfetti ne sarebbero degni.
E sono quelle che precedono il verso citato, il pel nome suo giurerai.—Il timore di Dio nella sua più vasta e nobile significazione—il culto perfetto—l’attaccamento, l’amore in cui i dottori pongono il colmo della perfezione religiosa. Ecco secondo i dottori chi può impunemente subire del giuramento la prova. Ma oltre i limiti e la repugnanza nell’applicazione, oltre le condizioni di morale squisito imposte al giuramento,—i dottori nostri ai litiganti che invocavano in causa il giuramento, imposero il titolo infamante di Resciaim, empj, e non solo tali li dissero sui loro libri, nel loro foro interiore, ma legale e pubblica sanzione dierono a questo titolo ingiurioso nel fôro esteriore, e lo dierono quando statuirono tra le formalità del giudizio civile, che dopo avere il giudice colla solenne formola del Scun o vuoi Monitorio, intimato alla coscienza del giurante le gravi pene dalla legge sancite, e la voce del Sinai minacciosa ripetuta ancor una volta al cospetto dei litiganti, che ove, dico, le parti insistessero nullaostante nelle loro pretese, che tutti ad una voce intuonassero i presenti quel verso con cui Mosè allontanava dalle tende ribelli turbe innocenti e: Lungi, dicessero, lungi dalle tende di cotesti malvagi; nè vi appressate a cosa che loro spetti, affinchè involti non siate nel loro sterminio, volendo alludere alla colpa presunta di ambo le parti, colpa d’insulso[440] o di falso giuro, nel debitore, colpa d’irregolare procedimento e d’imprudente fiducia nel reclamante, e tutti e due causa più o meno colpevole della invisa e dolorosa necessità di giurare.
E queste paionmi già abbastanza eloquenti antologie tra Farisei ed Esseni. Ma ciò che vado ad aggiungere è, oso dirlo, di bene altra importanza. Se ciò che prova la identità generica dell’Essenato colla scuola de’ Farisei, egli è, com’è veramente, di non lieve momento, che saranno quelle prove che distinguendo l’Essenato dal comune dei Farisei lo confondono, l’identificano specialmente con quella parte di essi che si dicono Cabbalisti? Se tra il silenzio del farisato talmudico e la formale e solenne asserzione del farisato cabbalistico, vedremo gli Esseni a questi ultimi associarsi e con essi alta e solenne levare la voce in favore di un principio, di un divieto, di una legge taciuta dei Farisei, non sarà egli il più bello, il più urgente, il più irrecusabile argomento in favor della identità propugnata? E che direste se questo singolare fenomeno si avverasse, se un divieto sconosciuto al Talmud, strano, paradossale eziandio secondo il Talmud, fosse dagli Esseni e insieme dai Cabbalisti, e da essi solo, solennemente affermato? E pure nulla di più vero, di più dimostrato. E pure, se ognuno volesse dire a sè stesso, tutto il valore della concordanza presente la identità essenico-cabbalistica, non sarebbe più un problema, e pure se questo fatto solo emergesse dal confronto delle due sètte, bastare dovrebbe a ingenerare grave sospetto d’identità, alla critica più severa. E questo fatto spicca luminoso in Giuseppe, in Filone e poi nel gran Codice Cabbalistico, nel libro del Zoar. In Giuseppe quando interpreta il verso dell’Esodo Eloim lò tekallel quando vi trova, singolare a dirsi! il divieto di maledire, di bestemmiare eziandio i numi gentili. In Filone quando il verso stesso[441] nel modo istesso interpretando, ci trova il rispetto dovuto eziandio alle straniere divinità. E nel Zoar infine, in quel luogo d’oro ove R. Abbà, il compilatore stesso della grand’opera, scrive parole memorandissime che nessuno sospetterebbe potere trovare in libro così ascetico; e che perciò stesso si può credere informato di uno spirito di gretta, di meschina, di esclusiva osservanza. E pure quanto vaste e grandi sono le idee! E non solo la teoria il fatto viene ivi stesso a confermare ed attuare il principio; e la conferma e l’attuazione per felicissima coincidenza, è opera non di uno, di sei dottori Cabbalisti, e tra questi più esplicito proclamator del principio, il dottore dei dottori, R. Simon Ben Johai. Io traduco e voi giudicate, e giudicando spero non troverete troppo enfatico il mio annunzio. Disse R. Abbà: «Ognuno che bestemmiato abbia lo suo Iddio, ricade sopr’esso il suo peccato. Vieni e vedi; quando furono gli Israeliti in Egitto, conobbero quei duci della natura che presiedono sopra i popoli universi, ed ognuno di essi fatto se n’era un Dio speciale. Quando furono a Dio stretti col vincolo della fede.—(vera etimologia di religione, come dice Cicerone, a ligando), ed appressolli Iddio al suo servigio, da quei numi si separarono ed avvicinaronsi alla fede suprema e santa. E perciò è scritto: Ognuno che bestemmiato abbia lo suo Iddio, ricade sovr’esso lo suo peccato; imperocchè comunque Iddii alieni siano cotesti, cionnonostante avendoli io costituiti a duci per governare la terra, chiunque bestemmi, o dispregi il nome loro, certo sovr’esso ricade il suo peccato, perciocchè miei servi e ministri sieno essi nel governo delle cose create: ma chiunque bestemmia il nome di Dio, non solo come gli altri iniquamente opera, ma la presente e la eterna morte sarà al suo fallir pena condegna. E questo è il principio ben chiaro, bene esplicito, bene eloquente, e[442] per eccellenza essenico, come vedete, senza che io spenda altre parole per comentarlo. Ma io vi dissi che, per non comune ventura, alla teoria seguiva nel Zoar immediatamente la pratica, ed il fatto viene in buon punto a dare il più bel comento al principio. Ed eccolo testualissimo. R. Simone procedeva per via, e con esso erano R. Eliazar, R. Abbà, R. Hijà, R. Josè e R. Jeudà. Giunti che furono ad un laghetto di acqua (notate che le parole testuali sono orribilmente oscure e i più grandi interpreti eziandio confessano di andarci a tentoni), stese la mano R. Josè per raccogliere nel pugno acqua per bere, sendo egli assetato, ma preso da impazienza, forse per l’acqua melmosa, o perchè stette, come vogliono altri, per sdrucciolare: O Lago! sclamò, deh tu non fossi!—Dissegli R. Simone: Reo è il tuo parlare; ministro è questo della natura, e rea cosa è il vilipendere i ministri di Dio, e tanto meno si dee farlo, per quelle creature veracissime ch’esistono per legge del supremo imperante. Nel quale passo per cogliere tutti i preziosi reconditi documenti, mestieri è molte cose ricordare; ricordare il culto paganico dei fiumi e dei laghi, e meglio dei genj che ai fiumi e ai laghi presiedevano e in grazia del qual culto proibirono i dottori macellare animali di ogni maniera in riva all’acqua, quasi fosse omaggio prestato alle Najadi, e ai Tritoni; ricordare poi il culto in genere all’acqua prestato dagli Arabi contemporanei che i dottori dicono Cadriim; ricordare il conto grandissimo che gli Esseni facevano delle rive, lo spirito profetico che si sviluppa secondo i dottori più agevolmente sull’acque correnti, e di cui a dilungo parlammo; ricordare le acque, simbolo veneratissimo, come dicemmo in non remote lezioni, presso i Talmudisti, i Cabbalisti in ispecie; e soprattutto notare quel bel pensiero di R. Simon Ben Johai, che non è persino i più vili oggetti della natura corporea, su cui un[443] raggio non si diffonda, benchè pallido e lontano, della gloria di Dio, nella quale tanto più davvicino si illustrano, si beatificano quelle che il Zoar dice Creature veraci, che vivono nella legge del Supremo Imperante, ch’è quanto dire gli Esseri Ideali, gli intelletti separati, come dicea la scolastica, i quali vivono in Dio come Paolo disse in Dio viviamo.
Noi abbiamo conchiuso quanto a dir avevamo sul culto religioso degli Esseni, o per dir meglio di quella parte delle loro pratiche, che a Dio si riferisce. Però mestieri è che io ricordi, quando nelle primissime lezioni favellavamo dell’origine dell’istituto, molte cose discorse abbiamo al culto di Dio attinenti, che per non menare troppo a lungo la nostra istoria, o furono qui per brevità trapassate, o solo un cenno ne fu dato a rinnovarne la rimembranza. Fra questi sono gli Inni religiosi che la storia narra posseduti dai Terapeuti, che dicevano redati dai loro antichissimi, che cantavano, come vedemmo, nelle feste e nei pranzj, e di cui trovammo corrispondenza tra i Cabbalisti antichi e moderni, e specialmente in uno dei grandi protagonisti del Zoar, nel figlio stesso di R. Simone Ben Johai che non il Zoar, sarebbe poco, ma il Jeruscialmi chiama Pajat e Carob. e Tannaj.
Fra queste le danze sacre, non quelle dei Terapeuti di cui discorso abbiamo anche troppo ora a dilungo, ma quelle dei Hasidim Veaosè Maasè, di cui favella la Misnà, che avevano a teatro le aule del tempio, quella di Illel che diceva danzando Im aní can accol can, parole pregne rigurgitanti di sensi cabbalistici siccome vorrei dimostrarvelo, se l’ora lo consentisse; quelle che dice il Talmud meneranno gli spiriti beati intorno all’Eterno, Sole della vita, come la Rosa dantesca si muove in giro danzando intorno il sole degli angioli, come Dante diceva, e se più oltre volessimo spingere lo[444] sguardo, le danze astronomiche degli antichi, siccome astronomiche erano quelle dei Terapeuti, quali raffigurano, dice Filone, nelle loro danze, udite bene una imagine dei cori e delle armonie celesti, lo che solo potremo intendere quando sapremo la Teoria dei Pitagorici, coi quali tanto confonde e assimila Ilario i nostri Esseni, e che vollero gli astri muoversi secondo le leggi della musica, e tra pianeta e pianeta viddero quelle stesse distanze musicali che Pitagora il fondatore si dicea avere trovato, tantochè il roteare degli astri formava, a detta dei Pitagorici, quella che essi chiamavano, e che restò celebre nella storia della filosofia, col nome di armonia delle sfere. Ora il nostro secolo—gli Arago, gli Herschell, i Leverrier non credono più all’armonia delle sfere. Ma l’armonia pitagorica, a cui niuno secolo potrà discredere se non è suicida, è quella che i pitagorici annunziarono al mondo quando dissero anche per l’anima umana essere l’Anima un’Armonia. Parola profonda che vorrebbe un volume per comentarla, e che basterebbe a provarla quella divina potenza che è in noi d’intendere, di cogliere ogni maniera di logica, di musica, di morali armonie. E voi ne date prova luminosissima comprendendo sì bene quelle che io tanto disarmonicamente vo proponendovi tra le grandi scuole del nostro popolo, tra gli Esseni, i Farisei e Cabbalisti, i quali sono i veri astri che si muovono nell’orbita eterna, che Dio loro ha segnato negli splendidi, nei sereni cieli del vero e del santo.[445][90]
LEZIONE TRENTESIMAQUARTA.
L’ultima parte della Storia degli Esseni, quella che riguarda il loro culto, la loro pratica, fu da noi in tre parti secondarie divisa, parte religiosa, parte privata, e parte pubblica. Della prima abbiamo parlato quanto meglio ci è stato concesso: ora diremo della seconda, di quella che ci narra i costumi e le virtù eziandio private dei nostri Esseni. Egli è d’uopo poi che d’una cosa io vi prevenga. Molti fatti vi sono alla privata vita appartenenti dei nostri Esseni, che in questa parte della loro storia non avranno menzione, e non l’avranno per la semplicissima ragione che per la natura loro organica fondamentale l’ebbero, e l’ebbero diffusissima, allorchè della prima parte ci occupavamo di questa storia della istituzione dell’Essenato. Allora, voi, lo ricordate, la tavola e i particolari tutti ad essa attinenti, gli abiti e le loro varietà, il celibato, e lavori, le occupazioni, gli studj furono subbietto, che a dilungo trattammo, ma che non lasciano per questo di essere vere e proprie esseniche pratiche. Per che allora piuttosto che adesso ne facemmo menzione? Perchè meglio tra gli istituti annoverati che tra le pratiche? Io già ve lo dissi, perchè non solo mere e nude pratiche son esse, ma vere e proprie istituzioni, ma elementi integrali della essenica esistenza, e perciò tra le istituzioni le abbiam collocate. Di queste[447] dunque più non si parli, e sol di quelle si faccia menzione che questo carattere non ci offrono organico, fondamentale.
E prima, la nettezza, la proprietà.—Era essa, dice Giuseppe, studio precipuo dei nostri Esseni; e ad essa particolarmente miravano nel sodisfare ai naturali bisogni. Noi siamo in pien Mosaismo, quando Moisè raccomanda di tener sgombro il campo di ogni immondizia, quando vuole che niuna traccia rimanga alla luce del sole, delle impurità corporali, quando, ciò che più monta, la scrittura designa l’atto vilissimo con una parola che dipinge l’attitudine stessa che prendevano i decentissimi Esseni, quando lo chiama Cuoprimento di piede, leassek et raglau, non fanno altro e Scrittura e Mosè che preludere alla rigida proprietà o decenza dei nostri Asceti. Ma che direte quando vedrete, siccome è proprio di ogni idea primitiva, radicarsi l’elogio, il dovere della proprietà, in una parlante e bellissima sinonimia? Vi è una parola nella lingua ebraica che attesta quale idea nobile elevatissima si formassero i primi suoi parlatori della proprietà corporale, e questa parola è Nachi. Nachi in ebraico vuol dir certo proprio, netto, decente, ma sapete che altra idea eziandio vi si acchiude? L’idea di una nettezza ben altrimenti superlativa, l’idea di purità, d’innocenza, di morale irreprensibilità. Avvi forse lingua che offra fenomeno così fatto? Or che diremo dei nostri dottori? I quali s’ebbero in pregio la proprietà corporale; lo dicano quei placiti infiniti che si leggono nei loro volumi, e per tutti lo dicano quei due eloquentissimi testi che vado ad esporvi.—È l’uno quel tratto curiosissimo del Medrasc ove traendo partito dagli usi contemporanei, dalla custodia gelosissima che si faceva su per le piazze, delle imagini, delle statue, dei ritratti dei Cesari, conclude a fortiori, quanto più ragionevolmente si debba[448] il corpo nostro serbare netto, proprio, decoroso, poichè il nome pure meritossi d’imagine e similitudine di benaltro Augusto, di Dio sempiterno. Ma se il passo, esso citato, è ammirabile per leggiadro confronto, per storiche allusioni, per un sapore di contemporaneità che solletica piacevolmente, quanto l’altro non sovrasta per più speciale attinenza coi nostri Esseni? Spero che non l’avrete obliato. Vi è in fondo al Talmud di Sotà un frammento preziosissimo per questa storia che porta il nome di Barraità, di R. Pinechas Ben Jair. In questa Barraità non è frase, non parola che non interessi, e grandemente, il nostro istituto. E in parte lo vedeste voi stessi quando vi additai in quella scala, che tale è veramente, di morale perfezione, il Hasidut (che è lo stato in cui vissero i nostri Esseni) occupare quasi la cima di quella morale gerarchia, e condurre immediatamente al Ruah acodes o Spirito Santo, che è quasi la transumanazione dell’anima umana, mentre vive nel corpo. Or bene: il primo grado di quella mistica scala, la porta quasi che mena alle aule celesti, è appunto la virtù che ora ci occupa, la proprietà. E se a questo aggiungete il nome che porta in fronte scritto la citata Barraità, quel nome che tanto dice di R. Pinechas Ben Jair, il suocero amatissimo di R. Simone Ben Johai principe dei Cabbalisti e Cabbalista egli stesso, e dei più insigni come si vede nello Zoar; se aggiungete le altre non meno belle analogie discorse in altre lezioni, ei non sarà senza grande ammaestramento che la proprietà, virtù tanto Essenica per eccellenza, forma quasi il vestibolo per cui si entra nelle più segrete parti del grande edifizio. Ma i dottori non si limitarono a predicare e celebrare la proprietà in modo generalissimo:—la loro mente così alta non sdegnò scendere basso, molto basso; e le più minute applicazioni studiare, e tutto prescrivere[449] determinare nella vita dell’uomo la proprietà consentanea.[91]
Ma Giuseppe un’altra minuzia ci ha pure conservata della essenica vita, che ha certo il suo pregio. Quando noi ragionavamo dei superstiti simboli dell’Essenato, di quelle forme a così dire oggi vuote di senso, ma ove il pensiero essenico si era una volta rinchiuso, voi lo ricordate certamente, noi facevamo allora menzione di quel principio di antagonismo, che gli Esseni esprimevano coi nomi di destra e sinistra, la prima chiamando fausta e buona, l’altra rea e veramente sinistra; nè posso qui tacere, giacchè l’omisi a suo luogo, che questo antagonismo venivano eziandio esprimendo talvolta coi nomi di giorno e di notte, simbolo se altro fu mai cabbalistico per eccellenza, come fa fede la celebre dualità o Sigezie che il nome reca appo i mistici di Giorno e di Notte, Middat iom umiddat lailà. Or bene: quando di Destra e Sinistra favellava, io vi dissi allora che una pratica essenica da quel principio s’ingenerava, e di cui a luogo suo ne avrei tenuto proposito. Questo luogo è il presente, e la pratica essenica, onde si parla, ci offre nuova occasione di ammirare lo spirito e gli atti uniformi di due scuole che furon sin’oggi credute diverse, e che l’esperienza e l’esame intrapreso perpetuamente identifica. Quando Giuseppe ci parla del rispetto che gli Esseni avevano per la destra, quando dice che si astenevano dallo sputare da quel lato, fu nessuno che sospettasse le analogie bibliche e farisaiche? Delle prime non dirò, che troppo più lungi ci condurrebbero che non vorremmo. Ma come tacere delle altre? E se pure tacere volessi di quei tanti infiniti casi, in cui negli atti di religione la destra vantò il primato, come tacere del caso in termini da Giuseppe accennato? Chè tale esiste veramente, e per perfetta medesimezza ammirabile[450] nelle pratiche farisaiche. Pei dottori, pei Farisei lo sputare, specialmente nella preghiera, se è concesso di dietro, se è concesso a sinistra non è concesso a destra; e il divieto più che non si crede antico muove non solo dai più antichi Trattatisti, quali sono Maran e Muram, ma vanta esplicita menzione nel Jeruscialmi, che è quanto dire nel più antico dei due Talmud. Ma il rispetto alla destra non finiva con questo e Giuseppe stesso ce lo ammonisce. Reputavasi, ei dice, grande increanza porsi in mezzo o a destra dei lor maggiori. E quest’uso, perpetuatosi fino a noi, ha antica e manifesta sanzione nel Galateo dei dottori. Per essi, tre che vadan per via, in mezzo si ponga il maestro, a destra il maggiore, a sinistra il minore. E non solo il consiglio non potrebb’essere più perentorio, ma il titolo con cui infamano chi lo prevarichi, conferma, se è possibile, l’indole essenica di tal prescritto.—Chi procede, dicono altrove, a diritta del suo maestro, è Bur. Ora che cosa è Bur? Noi il chiedemmo altra volta, e la risposta ci venne eloquente da un frammento d’Abot.—È l’opposto di Jerè ket; e Jerè ket, e questo non meno ci fu fatto palese, è il primo grado che all’altro più eccelso mena di Hassid.
Ma le cose discorse finora debbono cedere il luogo a considerazioni di gran lunga più rilevanti. Il silenzio essenico, il silenzio imposto ai suoi membri come dovere sociale, è più che un uso, più che una consuetudine; e non poco ristetti dubbioso se tra le istituzioni meglio che fra le pratiche non avessi dovuto annoverarlo. Dovunque però collocare si voglia, non si potrebbe disconoscerne la importanza; basta ricordarsi ciò che disse Giuseppe. Quando Flavio, porgendo ai Pagani una imagine delle sètte ebraiche, diceva gli Esseni i Pitagorici dell’Ebraismo, diceva una breve parola: ma quanto eloquente! Noi abbiamo le mille volte veduta l’asserzione[451] flaviana alla prova, noi la vediamo anch’oggi a proposito del silenzio, e sempre vera e sempre confermata dai fatti. L’istituto dei Pitagorici è celebre per la virtù del silenzio comandata ai suoi membri, ed a niuno meglio, a parer mio, se ne addice la pratica, siccome quello che, a somiglianza delle consorterie sacerdotali antiche di Oriente e di Occidente, serbò sempre inalterate le fattezze ieratiche tradizionali, religiose per eccellenza, che in parte ma meno profonde si trasfusero nei sistemi susseguenti dei Platonici, e degli Stoici antichi e moderni. Ma se Pitagorici erano gli Esseni, al dire di Giuseppe, Pitagorici, erano a detta sua, dell’Ebraismo, ed è in questo, ed è nelle viscere dell’Ebraismo, nella sua storia, nelle sue idee, nei suoi dottori che dobbiamo investigare le origini del lor silenzio, e tanto più imperiosamente a noi ne corre strettissimo l’obbligo, siccome quelli che abbiamo incessantemente proclamata la identità generale di Esseni e di Farisei, e quella specialissimamente di Esseni e di Cabbalisti.—La storia ebraica consta di tre grandi momenti—Bibbia, Dottori esoterici e Cabbalisti; ed è in tutti che noi dobbiamo cercare le segrete radici del Silenzio dell’Essenato. La Bibbia è il tesoro del pensiero antico nazionale dell’Ebraismo, ed è appunto siccome tesoro che solo nelle parti più ascose, nelle segrete profondità della lingua, nei misteri della grammatica, nella genesi ideologica delle idee nazionali, che tu trovi, ardisco dire, tutta la successiva esplicazione della dogmatica ebraica, e come mi è avvenuto non poche volte di avvertire, anche i riti e le leggi tradizionali. Ora la lingua ebraica porge colla sola denominazione del Silenzio una idea che si trova poi espressa, formulata nelle opere dei Rabbini; e cosa veramente ammirabile, senza che gli stessi Rabbini vadano minimamente consapevoli del possente ausilio; e[452] nemmeno che sappiano lo affratellarsi delle due idee in seno al vocabolo sinonimo; prova, se altra fu mai, della ingenuità e schiettezza e autorità della parola tradizionale. Io potrei sin da ora additare il vocabolo in discorso, ed insieme scendere come si fa negli scavi scientifici al lume di una critica sagace nelle più profonde sue viscere; ma a costo di stancare la pazienza, ne differisco l’enunciazione sino a tanto che le cose che ho a dire ne facciano più innegabile, e il senso e le conseguenze che ne deduco.
Ma oltre il vocabolo in discorso, Salomone celebra la virtù del Silenzio.—Oltre alcune idee, disseminate nei proverbi, l’Ecclesiastico par che preluda a quel dettato che corse famosissimo per le contrade di Europa, e che suona parum de Principe, nihil de Deo. Salomone però è più discreto, ei vuole che poco se ne favelli. Non ti affrettare a pronunciare sentenza intorno a Dio, perchè Dio è in cielo, e tu sei sulla terra; però sieno poche le tue parole. Ma quanto ingiusto sarebbe confondere il suo consiglio col proverbio rammemorato, e quanto più ingiusto confonderlo con quell’ipocrita e vile e codardo e irreligioso silenzio sulle cose divine, che molti predicano, non solo savio e prudente consiglio, ma anche per colmo di sacrilegio, religioso dovere! Questa specie spuria, vigliacca, degenere di Silenzio non è ebraica. Ella è propria di quelle Fedi le quali, inalzandosi sulle rovine della ragione, non trovano nè trovar possono salute che nel silenzio, che nel mutismo della ragione; di quei dogmi che esigono, che predicano la fede cieca, termine assurdo, contraditorio, sconosciuto nell’Ebraismo, il quale nè comprende, e nè pure il potrebbe, in qual modo la fede che vuol dire consenso dell’intelletto, e quindi razionale, possa essere al tempo istesso cieca, che è quanto dire irrazionale. Ella è propria di quei[453] tempi, di quelle età infelici in cui la ragione fuorviata dichiara guerra alla fonte d’ogni ragione, a Dio eterno; ai tempi di Voltaire, di Diderot, di Holback, e quindi scusabile in qualche modo, almeno nei timidi intelletti, nel secolo che ci ha preceduto; e quindi scusabile ancora nella bocca di quell’animo più intemerato che fu Salomone Fiorentino. Il quale ben fece ad essere così ricco come lo narra la fama di preziose virtù, di pietà ingenua semplice veracissima, di costumi specchiati, di probità senza pari, per fare almeno ai posteri obliare che ei fu autore di quell’assurda, vile, blasfematrice sentenza che suona, adora e taci. Ah! in quell’istante Fiorentino non fu ebreo, se pure non vuolsi a sua discolpa allegare che ei fece virtù in quell’istante di una dura necessità, non potendo libera, irrefrenata muovere la lingua contro di quello che lo spingea a battaglia. Ma ebreo, almeno nell’espressione, non fu. Non fu interprete veridico dell’Ecclesiastico, perchè solo le umane speculazioni l’Ecclesiastico interdice, e quelle temerarie e folli irruzioni nei campi del Divino, che la ragione tenta tal fiata senza guida, senza norma, senza la stella polare della parola rivelata; siccome appunto l’indole dell’opera e le idee tutte che entrano nell’Ecclesiaste mirano, com’è noto, a sfiduciare la mente umana nelle sue proprie ingenite forze, e ad ispirare uno scetticismo salutare che può senza fallo paragonarsi a quella specie di scetticismo religioso che professarono Biagio Pascal e Michele Montaigne. Non fu consentaneo allo spirito dei dottori che se il silenzio levano al cielo, e questo è il punto ove volevamo venire, egli è il silenzio delle cose vane, terrene, puramente mondane; egli è quello di cui intesero quando dissero: Mà ummanutò scel adem baolam azzè iassim azmò cheillem, non quello che eccettuarono in termini apertissimi quando aggiunsero: Jakol af ledibrè torà[454] chen, talmud lomar teddaberun; egli è quello a cui accennarono quando dissero ogni parola che esca dal labro dell’uomo un’eco avere nello eterno ed ogni pensiero aspirare, e come il fuoco secondo gli antichi, come vuole la sua natura alle cose del cielo, egli è quello che un dottore in Abot (notate luogo acconcissimo alle esseniche memorie, siccome quello che codice udimmo altravolta chiamato dei hasidim) proclama, dopo la lunga sua esperienza e conversazione farisaica, il farmaco più salutare, frase se altra fu mai opportuna al genio medico, terapeutico; come anche questo vedemmo dell’antico istituto, egli è il silenzio che nel medesimo Abot, notate indizio sopra indizio, un gran dottore R. Achibà, che per colmo di maraviglia è dottore insigne dei Cabbalisti, ed uno dei quattro visitatori del mistico giardino, egli è il silenzio che ivi è detto—siepe e riparo alla scienza—non antidoto e spegnitoio, come altri vorrebbe farne, e di cui bellamente interpretando, ce ne porge circoscrivendolo una idea adeguata il Bartenora, dicendolo silenzio sì ma solo delle cose mondane bedibrè aresciut; ed egli è quello infine che i dottori consigliavano agli esordienti, come appunto i Pitagorici lo consigliavano dicendo Asket, as veahar eah Kattet. Silenzio tutto, come vedeste, di cose, di bisogni, d’interessi, di avvenimenti, di pensieri mondani, non di bisogni, d’interessi, di pensieri comunque morali scientifici dottrinali teologici e per tutto dire religiosi. Nei quali beni lungi d’imporre un codardo mutismo, vuoi per raffinata superstizione, vuoi per timidezza di cuore, lasciarono libero il pensiero e libera la parola purchè i semiti non travalichi della rivelazione, e tanto liberi lasciarono e l’uno e l’altro, e tanto profondo scolpirono l’abito di libertà nell’animo del nostro popolo, che un bel giorno questo si è creduto potere in piena sicurtà di coscienza-dogmatizzare a sua[455] posta, e purchè il corpo assoggettasse ai precetti di Dio, scotere impunemente lo spirito, foggiarsi dogma come Parigi si foggia i suoi figurini; e questa libertà dissero non solo filosofica, ma religiosa e sopratutto, vedete pregio che ignoravamo! privilegio tutto proprio ed esclusivo di nostra fede. Noi abbiamo posto il dito sopra una cangrena terribile che consuma e rode la vita superstite in Israele, e se questo il luogo fosse di chiamare com’Elia i falsi Profeti alla prova, fossero presi costoro come gli antichi a centinaia, mandassero pure grida come gli antichi forsennate, il fuoco celeste non sarebbe per loro. Ma l’anarchia dogmatica, a cui pretendono costoro, prova una cosa, e i miseri non se n’addanno; prova che la libertà è passata per quella via.—Come le ceneri che attestano la preesistenza del fuoco,—come il corpo esanime fa fede che vi abitò uno spirto immortale, così l’anarchia presente fa fede dell’antica libertà. E quale libertà! Pei dottori, il dettato che udiste poc’anzi Parum de principe, nihil de Deo, se sarebbe stato nella prima sua parte un consiglio di prudenza, saria stato senza meno nella seconda un consiglio d’inferno—pel quale solo disse Dante luogo d’ogni luce muto, e la parola è luce del Mondo.—Per essi nella sfera vasta, vastissima della Bibbia e della tradizione, la parola umana, è giusta, legittima anzi regina e sovrana, e se gli imposero silenzio, come vedeste, nelle mondane faccende, ei fu fra le altre cagioni perchè non un atomo spendesse delle sue forze che non fosse per Dio, nè vollero che pel mondo molto tacesse se non per che di Dio e della fede sua molto parlasse.—In quella sfera se i dottori rifar dovessero il verso di Fiorentino, se crear dovessero un grido, una parola d’ordine, come si dice, non sarebbe adora e taci, ma adora e parla. In quella sfera la libertà è santa intangibile, anzi a Dio carissima anco nei suoi voli audaci,[456] anche allora che ignara, come dice Omero, della lingua degli Dei, ne strazia le forme e le locuzioni bellissime, vale a dire quando erra involontaria, quando merita di essere molto perdonata perchè molto ha amato. Allora dicono i dottori, Iddio non solo perdona, ma infinito amore lo prende per quell’anima che balbetta il suo verbo immortale in quella guisa che un padre non rifinisce di baciare e ribaciare il piccioletto figliuolo quando le prime voci emettendo sciupa le forme del linguaggio nativo. Vediglò alai aabà. Nè altrimenti avviene allora che agli spiriti audaci ai quali disse il mondo sorridere sempre benigna fortuna ed amore, ed a cui dicono i dottori sorridere non meno Dio verace fortuna e primo amore. Noi abbiamo veduto il Silenzio essenico approvato, predicato dai Farisei in teoria. In quest’altra Lezione lo vedremo in pratica.
LEZIONE TRENTESIMAQUINTA.
Trovare le idee, i costumi degli Esseni conformi alle idee bibliche e, ciò che più monta, ai costumi, alle idee farisaiche, trovare come trovato abbiamo nell’ultima Lezione il Silenzio essenico in quei Farisei d’onde trasse, a parer mio, l’Essenato l’origine, egli è certo assai per la storia dello Istituto, è poco per noi che nel Farisato medesimo abbiamo specialmente identificato i nostri Esseni con quella parte di Farisei che si chiamano Cabbalisti. Se il nostro sistema non è bugiardo, le analogie tra le due scuole dovrebbero, nè meno esplicite apparire nè men numerose. Se Esseni e Cabbalisti sono tutt’uno, gli ultimi non meno che i primi deono avere come squisita virtù proclamato il Silenzio. E proclamato l’hanno quanto basta a darci piena, assoluta ragione. E tanto iterati e diffusi ne sono gli elogi, i pregi, le utili conseguenze, che io farei opera interminabile se qui tutti volessi i testi riprodurre che negli antichi e nei moderni libri del Cabbalismo parlano in favor del Silenzio. Pegli uni come per gli altri due sono gli atti dell’umana generazione, corrispondenti alla doppia natura dell’uomo, la Parola ed il Coito, il germe spermatico ed il germe ideale, la concezione della carne e la concezione dello spirito, ambo unificati nelle lingue moderne, nella parola Concetto, ambo, e ciò che è più ammirabile, confusi, identificati[458] nelle parole Jadagh, Pensiero e Coito.—Generazione di carne e generazione di spirito e quindi dal seno istesso della lingua ebraica, intera e splendida sprigionasi la teoria cabbalistica.[92] Per essa due sono i segni dell’alleanza, due i patti, due gli organi fecondatori, il Berit allascion e il Berit amaor, ambi porgenti vana e colpevole ridondanza, ambi recanti da natura prepuzio, come stupendamente accenna la Scrittura medesima nel Aral Sefataim, ambi suscettibili di emendazione e circoncisione; anzi, notate meraviglioso riscontro, ambidue chiamati nel loro stato perfetto con una sola parola che suona milla, quasi dicesse la Corretta, la Circoncisa, nulla ostando la più lieve o più grave pronunzia, perchè ambidue unificati gramaticalmente in una sola radice, perchè d’ambi dicono i Lessici tedeschi Fortasse Malat idem facit quae mul abscindere: e noi possiam dire dopo le cose discorse senza forse, senza fortasse, e perchè finalmente l’organo della parola e l’organo della generazione oltre essere unificate nelle antiche pagane rappresentazioni del Fallo, parola generatrice, sono manifestamente adombrate nella prima Misnà dell’antichissimo Sefer Jezirà, ove sono posti in armonico contrapposto, il Milat alascion e il Milat amaor, nella quale iterazione della parola Milat volle senza meno l’antichissimo autore accennare a quella comunanza di espressione, quella di cui adesso parliamo. Ed ambi, sommessi a gelosa custodia, tanto che pei Cabbalisti non meno è colpevole chi la parola invano disperde, che chi spreca inutilmente il liquor seminale, ambi sendo egualmente colpevoli di fallita generazione, che è mira suprema di natura, nel mondo dei corpi come nel mondo delle idee; nè qui certo avrebbero fine le bellissime analogie se a talento mio potessi nell’argomento spaziare. Non tacerei di quell’aureo riscontro che ci porge tra le altre la Mitologia[459] dei Greci in Mercurio Dio della parola e del Fallo fecondatore, che Cicerone chiama per ciò stesso itifallico, e ch’era adorato in Samotracia, in Beozia, nell’Attica, e nel Peloponneso, identico all’Erme itifallico dei Pelasgi, rappresentato nell’Attica e nell’Arcadia col simbolo del Fallo che Creuzer crede identico a Pane suo figlio (di cui tutti sanno l’officio e i simboli fecondatori), e ch’egli chiama principe de fécondité et source de toute vie, de la vie physique et animale aussi bien que de la vie intellectuelle! (Religions des Antiq. Hermes, in Mercur. 676.) Ma perchè troppo è per sè l’argomento fecondo, di queste come di altri non men leggiadri relievi, si taccia per lo migliore.
Ma i Cabbalisti parlano di una virtù del Silenzio, che troppo parmi accennare al carattere dottrinale degli Esseni, dei Pitagorici, perchè io possa senza colpa tacerla. È l’efficacia che gli assegnano al conseguimento dei misteri divini; è l’economia delle forze intellettuali serbate tutte alla contemplazione di quegli altissimi veri; è lo accesso che forzano col loro concentramento nelle parti più recondite della scienza religiosa; è insomma una sublimazione straordinaria dell’Intelletto, parole son queste del R. Loria. Umittenaè assagat akokma scezarih lemaet beddiburò velistok col mà sceiuhal chedè scelò leozi sikà betelà. La quale virtù del Silenzio, dicono essi, può giungere sino alla fruizione dello Spirito Santo, sino a quel grado di Ispirazione che è Ruak Acodes, sino a rapire la mente in quella regione beatissima della scienza divina in cui la mente non ode, nè vede, nè sente più nulla, o per dir meglio sente ed ode il silenzio, la quiete, la pace, che sono proprie di quelle attitudini dove l’anima resta assorbita in estasi soavissima al santuario del silenzio della Mahasabà, della suprema Kokmà, dove tutta la scienza dell’uomo si risolve[460] in una grande ma soavissima interrogazione, e dove al Mi (chi?) infinito che l’anima manda in uno slancio d’amore, non s’ode che un’eco eterna che replica Mi, come l’unico obbietto omai conoscibile.[93]—Ed a chi vera e santa non credesse la teologia dei Cabbalisti e che pure nel giro si rimangono dell’Ebraismo, la Bibbia si leverebbe, e insegnando loro ciò che i Cabbalisti insegnano: Uomini, gli griderebbe, di poca fede, venite e vedete. Vedete il Silenzio indicatore della presenza di Dio.—Nella poeticissima e profondissima ad un tempo visione di Elia, in cui il vento, il fuoco, il tremoto, non sono che precursori del Nume che s’avvicina, che esteriori vestiboli del riposto Sacrario, e solo nel Silenzio, anzi per antitesi maravigliosa, nella voce del Silenzio col demama stare la maestà dell’Eterno, la essenza di Dio, appunto come il Silenzio dicono i Cabbalisti stare in cima alla scala delle cognizioni celesti. Vedete la intima identità, dai Cabbalisti ravvisata, fra la scienza ultima estatica, intuitiva e il Silenzio, sola condegna espressione di quella nella lingua stessa dei Profeti, nell’idioma antico d’Israel, siccome quello che è semenzajo, come non mi stanco di dire, delle antiche credenze dell’Ebraismo. Ora nell’idioma ebraico v’è una parola, e questa parola è Haras, e Haras, ammirate la forza del vero, è radice significante in pari modo Silenzio e saper magistrale, tacere e meditare. Pensiero e Silenzio, perchè il pensiero per eccellenza è tacito e silente, e perchè come udite dai Cabbalisti, la sede del Silenzio è altresì sede della Mahasciabà e della suprema Kokmà.
Ma la pratica farisaica, ed è tempo che ne parliamo, attesta in modo ben altrimenti eloquente la identità che non cessammo di propugnare tra le due scuole, e ciò che tornerà di gran lunga più rilevante, la identità specifica peculiare fra Cabbalisti ed Esseni. Obliamo per[461] un istante la Storia e domandiamo a noi stessi: Se il nostro sistema non è bugiardo, se i dottori Cabbalisti del Talmud sono veramente, come crediamo, i medesimi Esseni, che cosa dovrebbe mostrare la Storia? La Storia, in mezzo alla gran corrente del Farisato, dovrebbe mostrare, come ci mostra natura in alcuni vastissimi mari, una corrente secondaria, distinta, particolare, che segue inalterata sua via, in mezzo a mille correnti paralelle o traverse, e in questa corrente mostrar dovrebbe non solo i caratteri del Cabbalismo Talmudico, è questa impreteribile condizione, ma per finire di persuaderci, anche la pratica del Silenzio distinta, costante, particolare e pressochè esclusiva in questa istessa corrente. Noi abbiamo formato un voto, abbiamo detto ciò che la mente più esigente potrebbe chiedere al sistema che abbiamo adottato. I fatti ci daranno ragione? La Storia dei Farisei accenna a molti centri, a molte linee, a molte scuole di dottori diversi, e se tra questi ve ne sono tali che i caratteri, che i contrassegni ci porgan legittimi incontestabili della linea del centro, della scuola Farisaico-Cabbalistica, ella è quella senza meno, che incominciando coll’antichissima R. Johanan Ben Zaccai e poi con R. Eliezer Agadol, segue con R. Akibà suo discepolo, continua con R. Simone Ben Johai discepolo del medesimo Akibà, e ferma almeno, a quello che io ora mi sappia, con Rab o R. Abbà scolaro di R. Simone. Ora vi è un fatto luminoso a cui vano sarebbe chiudere gli occhi, e questo fatto è la celebrata e particolare virtù in questa serie di Farisei Cabbalisti, in queste cinque generazioni di Farisei nell’amore del Silenzio. E chi lo attesta non è lo Zoar, non è uno dei parziali a quella teosofia, è il Talmud, quel solo giudice competente fra noi e gli avversarj del Misticismo.—Egli è il Talmud in Succà che narra dello stipite della gran scuola di R. Johanan Ben[462] Zaccai non aver egli parlato mai parola profana; egli è il Talmud che pone in bocca al suo discepolo Eliezer la stessa lode; egli è il Talmud che chiama R. Akibà Ozar Balum; tesoro chiuso; egli è il Talmud che di R. Simone Ben Johai dice tohen arbé umozé chimhà, macina molto e poco espone, vale a dire, molto medita e poco parla, o come di sè medesimo ei dice nello stesso Talmud: Figli miei, imparate le mie regole perch’esse sono—prelevazione di prelevazione—vale a dire, le più elette delle regole di R. Akibà; e se non è il Talmud che narra la stessa pratica di Rab, perchè, della teoria niuno di esso più esplicito, è qualche cosa, oso dire, più del Talmud concludente.—Voi lo ricordate, per completare la serie ci manca un anello, ci manca Rab; e non narrandolo il Talmud, non ammettendo noi qual parte interessata la deposizione dei Cabbalisti, non ci resta che una sola possibile autorità, e questa, grandissima, irrecusabile, gli avversari del Cabbalismo. Ci accade in questa ricerca, come altre volte non poche ci era accaduto: che andando in cerca di una prova, ne abbiamo trovate altre ancora che non cercavamo.—Ei fu quando arrivammo alla persona di Rab che assistemmo al più singolare spettacolo che sin ora ci si fosse parato dinanzi.—Trovammo prima diffusa comune nei posteriori libri la memoria di Rab come celebre per la virtù del Silenzio, e volendo, siccome è mio stile, risalire alle fonti, ne chiesi vestigia ai libri talmudici, ma senza frutto. Allora tenendo una via opposta, scesi dal Talmud ai succedanei scrittori, e il primo in cui trovassi menzione del Silenzio di Rab, il primo che mi fornisse l’ultimo anello della serie farisaico-cabbalistica, ei fu il più grande avversario del cabbalismo, ei fu Maimonide. E non solo, come dissi, completa la genealogia cabbalistica col ritratto di Rab, ma il modo, le frasi con[463] cui ne favella sono sommamente eloquenti per chi le intende. Attesta in primo luogo il Silenzio di Rab, quando scrive nel Comento di Abot: E fu detto per Rab, discepolo di R. Hijà, che non profferì parola inutile tutti i giorni di vita sua. Il qual deposto formulato in Abot, ripetuto e destituito essendo nell’Opera Magna, nel 2º dei Morali (Deot), come dissi di ogni sanzione scritta nei libri talmudici, e parendo quindi inesplicabile al Caro, gli suggeriva ivi stesso queste parole di sorpresa, d’ignoranza: Ma per quello che a Rab si attiene, non saprei dire per adesso ove ne sia l’origine. Pure, Maimonide lo asserì formalmente non solo in due libri diversi, ma ciò che parrà ancor più rimarchevole, in due epoche non poco distanti di vita sua, avendo il Comento intrapreso all’età di 20 anni, e il testo Maimonico a quella dei trenta.
Ma tutto questo è poco, di fronte a quello che segue, malgrado la mancanza di sanzione talmudica, malgrado la rispettosa denegazione del Caro, un altro antico, meno certo antico di Maimonide, ma più antico del Caro, il luminare dell’Africa, Ribbi Semhon bar Zemak, nel Comento ad Abot ripete alla lettera le parole maimoniche riguardo a Rab, benchè suo stile non sia copiare servilmente il gran Cordovano, e benchè vada egli distinto per una solida e smisurata erudizione talmudica. Ma io dissi che non solo la tradizione estratalmudica rispetto a Rab si trova in Maimonide, ma che eziandio qualcosa trovato avremmo soprammercato. E questo è il preambolo che precede l’asserzione in discorso. E l’epiteto con cui qualifica gli antichi dottori distinti per la virtù del Silenzio, è lo appellativo che noi dicemmo storico antichissimo della scuola degli Esseni, l’appellativo di Hasidim allorchè non poteva tanto mostrarsi Maimonide avverso alle dottrine dei Mistici, che ei non soggiacesse[464] talvolta, come altre fiate eziandio, alla forza del vero, e non divenisse organo inconsapevole di una verità utile e preziosa alla causa loro. Noi potremmo dire qui terminato ciò che a dire avevamo intorno l’essenico silenzio, trovato, come vedeste, conforme in teoria e in pratica al silenzio dei Farisei, e dei Farisei Cabbalisti; pure vi è qualcosa di più, e di più concludente. E se delle cose dette una sola non resistesse alla prova, ciò che io vado a dire basterebbe non solo a provare la comun pratica del silenzio tra Esseni e Farisei, ma formerebbe prova bella, benchè indiretta, della somma omogeneità di pensieri e di genio fra il Ben Johai del Talmud, e il gran dottore del Misticismo. Se io mi illuda, giudicatelo voi. Voi sapete i dubbi suscitati sulla legittima figliolanza del Misticismo dalla sacra antica fonte Ben Johai. Sapete quindi qual valore immenso prezioso abbia per noi ogni tratto che nel Ben Johai del Talmud ci rivelavano somiglianza coll’ispiratore del Zoar. Sapete eziandio qual’opera bella, decisiva, per quanto erculea, sarebbe quella che facendo astrazione dal Zoar come se non esistesse, ricomponesse coi soli esclusivi elementi talmudici la gran figura di R. Simon Ben Johai, e da quel sacro capo sempre col martello talmudico facesse emergere, come Pallade bella e armata dalla testa di Giove, il sistema intero del Zoar, almeno nelle linee sue più preminenti, opra a cui vorrei volgesse qualcuno il pensiero, poichè le forze mie piegano non solo sotto il peso dell’opre, ma persino sotto il peso dei desiderj. Ora, questo desio generalissimo applicabile a tutte le parti, vuoi teoriche, vuoi pratiche, del gran sistema, ci è dato vedere adempiuto in due luoghi d’oro del Jeruscialmi, ove nell’uno si legge il pensiero, nell’altro la pratica di Ben Johai. Voi udiste come del santo dottore dicesse il Babilonese: molto egli meditare, poco favellare. Ora udite come egli[465] stesso della parola umana sentenziò nel Jeruscialmi. Se presente io fossi stato presso il Monte Sinai, avrei chiesto al Signore che altra fosse la bocca con cui uom parlasse delle cose del mondo—altra quella con cui delle cose di Dio. Qual idea della parola! E quanto feconda anche nelle minime sue parti l’enunciazione! In primo io veggo tutta la mente ardita taumaturgica del principe dei Cabbalisti in questo ardito consiglio—veggo la teoria massima dei Cabbalisti dell’officio di Concreazione all’uomo assegnato—il principio eminentemente farisaico e cabbalistico della rettificata natura, vale a dire della emendazione che all’uomo incombe nelle parti anormali imperfette delle cose create, e da cui trae origine l’Arte nella sua più lata significanza, la quale non sarebbe pertanto una semplice imitazione di natura, come vorrebbero i Realisti in Estetica; ma meglio un ritiramento della natura istessa alle eterne norme del bello ideale, come vogliono gli Idealisti, e veggo sopratutto l’idea ch’entro vi sta, come seme racchiusa, che il Silenzio è l’atto più nobile e naturale per tutto quel che concerne le cose mortali.
Ma queste cose basti lo accennare, ed il cenno già troppo grave ne offre materia a pensare perchè di soverchio ci estendiamo. Questo solo non tacerò; quando lessi il voto che formava R. Simone Ben Johai delle due bocche, sovvenivami in quel punto, non di un voto, ma di un presagio che fece Fourier. Fourier, che tante cose predisse in avvenire, diverse da quelle che oggi vediamo in natura, disse fra le altre, come natura avrebbe un giorno pagato un antichissimo debito che aveva coll’uomo contratto, dandogli un occhio di dietro come ben due ne aveva davanti, e che tanto dovrà tornargli in acconcio per cansare i pericoli che lo minacciano di dietro eziandio: io non so quanto valga il presagio di[466] Fourier, ma il voto, il rammarico di R. Simone Ben Johai suona ben altrimenti nobile e grande.
Ma io dissi come non solo la teoria ne porgesse del Silenzio il Jeruscialmi sulle labbra del gran Maestro, ma ben anco la pratica. E la pratica splendida emerge da quel fatto ivi stesso narrato, quando il signor Dottore considerando, specialmente nel sabato, quanto indegna e servil opra fosse ogni discorso profano, pregava silenzio ai domestici, e perfino alla madre sua, fatto più che non credesi significante, non solo per lo studio che ci preoccupa e con cui chiare si vedono le attinenze, ma ancora perchè mi offriva, già sono molti anni, l’unico mezzo che io trovassi a spiegarmi quel concetto, quella dipintura maninconiosa che del sabato ebraico fecero i Poeti latini, mentre tutto pare per contro spirare festa, spirare allegria. Ma anche questo è nuovo campo che noi rasentiamo e fuggiamo di volo.
Ciò che resta innegabile è la nuova e non meno parlante analogia, non solo fra la teoria, come veduto abbiamo nella passata Lezione, ma ancora nella pratica del Silenzio fra Esseni e Cabbalisti, come abbiamo veduto nella presente. E comunque questo nuovo amplesso fra le due scuole si operi in seno al Silenzio, e comunque per onorare il Silenzio essenico troppo più di parole abbiamo speso che il nome non tolleri, non meno provata però ne emerge la suprema identità tra Esseni e Farisei.
LEZIONE TRENTESIMASESTA.
Noi dobbiamo ora occuparci degli essenici libri, di quelli di cui usavano e di quelli da cui s’astenevano, del numero dei loro pasti, del regolato alternare del mangiare e digiunare, e infine del sistema dell’imbandire. Io sarò breve, non già perchè la materia scarseggi, ma piuttosto perchè troppo di soverchio ne abbonda, e quindi è mestieri riguadagnare in brevità e speditezza d’esposizione quel tempo che non si può senza ingiustizia fraudare ai fatti, ai rilievi interessantissimi onde avremo da favellare.—Ma la brevità perchè non torni pregiudicevole, due esige impreteribili condizioni. Bisogna che sia chiara, ed a questo m’ingegnerò provvedere. Bisogna poi che l’attenzione e la perspicacia, l’ingegno degli uditori ne colmi le lacune, ne svolga i germi, e intenda in un cenno un pensiero, in un pensiero un argomento, un raziocinio, in un raziocinio tutte le conseguenze potenzialmente in quello racchiuse. E questo è officio vostro, a cui non vorrete venir meno di certo quando più ne urge il bisogno. E prima dei cibi;—di quelli onde gli Esseni si guardavano come da cosa vietata.—È fama, e voi spesso l’avrete udito, ed io stesso ne reco ferma credenza, avere gli Esseni dalle loro mense bandita la carne ed il vino. E pure se le prove dirette si consultano, se le memorie e gli espliciti attestati, non vi è cosa forse meno provata[469] di questa. Se io non erro, egli è San Girolamo pel primo che favella di questo astenersi da carne e da vino. E Dio volesse che San Girolamo così parlando si facesse organo egli stesso di un’opinione, di una tradizione allora corrente. Avrebbe almeno tutta l’autorità e tutto il critico valore che può aver San Girolamo. Ma no; sventuratamente San Girolamo, parlando in questo caso degli Esseni, accenna a Giuseppe; a Giuseppe, il quale, a detta di lui, avrebbe quest’uso, quest’astinenza attribuita agli Esseni nel Trattato ch’ei scrisse contro Apione. Io vel confesso, non ebbi io stesso la pazienza di scorrere di nuovo da capo a fondo la non breve Apologia flaviana: ma autori, ma testimoni gravi, asseriscono formalmente che questo fatto, questa memoria nel Trattato contro di Apione, per quanto si cerchi, non si trova. Dovremo perciò negare e dubitare del fatto? Io credo che non lo dobbiamo. In primo luogo chi ne assicura che il Trattato contro di Apione non sia in qualche parte manchevole, che non sia stato in qualche parte mutilato, che le frasi insomma da San Girolamo accennate non esistessero, siccome egli asserisce, negli antichissimi manoscritti? E San Girolamo è per sè autorevole non poco, autorevole pel tempo in cui visse non tanto dagli Esseni remoto, che la contezza veridica se ne potesse alterare; autorevole per la dimora, il teatro stesso delle esseniche gesta, in Terra Santa; autorevole poi e in grado eminente per la familiarità, sto per dire, in cui visse quel Padre coi più dotti Rabbinici dei tempi suoi, tra i quali scelse maestro nelle Scritture: e tanto addentro entrò nei pensieri, nella conoscenza dei dottori contemporanei, che ebbe fama e meritossi rimproveri da Agostino di giudaizzante. Taccio poi della intima filosofica convenienza di quest’uso presso gli Esseni, perchè essendo questo argomento, come si dice, a priori, può parere a taluno[470] arbitrario, comunque sia stile dei più grandi storici dei sistemi supplire alle parti manchevoli coll’analogia dell’insieme, in quella guisa istessa che in una iscrizione a metà cancellata dal tempo, si suppliscono le lettere dileguate coll’ajuto di quelle che precedono e di quelle che seguono. Ma come tacere dei precedenti biblici tradizionali, d’onde l’essenico uso può aver germinato, e che servono eziandio fino a un certo punto di argomento in favor della sua esistenza? Biblico precedente io chiamo quell’implicito divieto ad Adamo imposto da ogni cibo animale, al quale solo si veggono conceduti i vegetabili, quale alimento, ed al quale primitivo sistema dietetico possono avere voluto gli Esseni restituirsi, siccome quello che anteriore al peccato, meglio pareva loro consentire a quel grado di perfezione a cui aspirava lo Essenato. Biblico precedente l’astinenza onde fa fede la tradizione, e fino a un certo segno confermata dal testo, e dagli Israeliti osservata per lo deserto da ogni cibo animale che non fosse stato all’altare appressato qual sacrifizio, attalchè per questo tempo poteva dirsi a rigore ogni banchetto essere un vero zebah, un sacrifizio. Biblico precedente l’astinenza da ogni inebriante licore imposta ai sacerdoti durante il servizio, imposto altresì, come ricordammo altre volte, a coloro che voti facevano di Nazirato e Nazirei si appellavano; e biblico precedente finalmente la storia grande interessante dei Recabiti di cui abbiamo, non ha guari, mostrato le intime attinenze col nostro istituto. Tra le quali primeggia l’astinenza, onde qui si favella; l’astinenza dal vino da Jonadab recabita imposta a tutta la sua discendenza. Che sarà poi se dagli esempj biblici trascorriamo ai tradizionali disposti? I quali il vino vietarono al giudice prima che sieda pro tribunali a pronunziare giudizio, non solo nelle criminali ma nelle civili e rituali cause eziandio;[471] il vino vietavano egualmente a quello che si accinge alla preghiera, e abominazione quella prece qualificarono che da una mente scaturisce conturbata dal vino. Ma i dottori ci offrono un documento ben altrimenti prezioso: ci offrono memoria non solo di leggi antiche che a certi offici, a certe situazioni interdicono l’uso del vino, come vedemmo, ma la memoria ci porgono eziandio di una sètta, di una scuola la quale, dice il Talmud, non appena colse al nostro popolo l’estremo esizio, crebbesi grandemente di seguaci, che l’uso s’interdicevano di carne e di vino. Misceharab bet ammicdas rabbù paruscim scellò ehol basar vescellò listot iain nitpal laem R. Jeosciua veaamar laem ec. E come si chiama questa sètta in bocca ai dottori? Mirabile a dirsi! Il nome ella reca appunto di Farisei, e la frase ebraica Rabbù paruscim, crebbero i Farisei, se bene la intendi, rivela abbastanza come la esistenza dello istituto risalga più oltre dell’epoca indicata, e quindi consuona anche per questo verso colla società degli Esseni la quale, come i Farisei del Talmud, si asteneva da carne e da vino, com’essa si reclutava cotidianamente di nuovi membri, e com’essa finalmente possono dirsi, siccome ad esuberanza fu per noi continuamente dimostrato, veri e proprj Farisei.
Ma i dotti indagatori delle sètte vi troveranno altra cosa eziandio. Vi troveranno ciò che finora fu creduto impossibile a trovarsi: una memoria, un vestigio, una abbastanza chiara e manifesta allusione a quell’Essenato che finora si disse dai talmudisti ignorato; a niuno allor che io sappia potendo meglio convenire che agli Esseni in discorso, i caratteri dal Talmud assegnati ai rigidi Farisei che da carne si astenevano e da vino, come appunto gli Esseni. E non solo la carne e il vino s’interdicevano, ma se prestiam fede a Filone che dei più rigidi[472] dei Terapeuti narra i costumi, un solo pasto facevano in tutto il giorno, e questo per lo più composto di radiche, e di pane e sale. E chi a queste parole non lo ricorda; chi non ricorda il pane, il sale e l’acqua colla misura, a cui ogni studioso deve starsi contento, secondo i morali di Abot? E come poi parlante, espressivo, e di nuova analogia fecondo, l’uso comune necessario del sale negli essenici prandi. Perocchè ei fu da lungo tempo notato come costoro tenessero quale inviolabile costumanza lo accompagnare la imbandigione, il loro pane in ispecie, con due condimenti indispensabili, il sale e l’issopo, attalchè la presenza di questi due ingredienti si può stimare a buon diritto qual pratica obbligatoria seguita sempre, ed allora segnatamente seguita che solenne si imbandiva la tavola nei giorni di festa. Ora la importanza rituaria del sale nelle pratiche nostre, non vi sarà chi neghi ove sentore abbia alcuno delle nostre leggi. Ricorderanvi il sale da Mosè comandato qual compagno indispensabile di ogni sacrifizio, sia pubblico sia privato, e col pomposo nome fregiato di patto ed alleanza del Signore. Che dico? a significare elevato quale acconcissimo simbolo l’alleanza eterna, la legge da Dio sancita, che appunto col nome vien designata di Patto di sale, Berit melah. E siccome non tanto quanto altri s’imagina, distà dalla legge di Dio la primitiva e semiortodossa gentilità, ricorderravvi altresì e con un senso di maraviglia a quelle grandi prove ripenserete, che in seno ai Pagani medesimi non solo l’uso istesso ti rivelano comune e rispettato, ma il concetto altresì te ne mostrano riprodotto nella sua interezza. Ripenserete alla così detta mola salsa, che Eustazio definisce farina di orzo mista con sale, e di cui si aspergeva la vittima intiera; cerimonia tanto essenziale ad ogni specie di sacrifizio, che di essa parlando non temeva Plinio di asserire: Maxime[473] in sacris intelligitur salis auctoritas; quando nulla conficiuntur sine mola salsa: parole che suonano quasi identiche a quelle del Levitico. Ripenserete a Omero, che non è quasi descrizione di sacrifizio che di questa salagione non favelli: a Virgilio che nelle Egloghe e nel 4º della Eneide ne fa esplicita menzione il testo, che da mola salsa deriva il vocabolo Immolatio, tanto stimavasi questa cerimonia essenziale, da qualificarne come qualifica Immolatio tutta l’azione del sacrifizio: a Ovidio nel 1º dei Fasti che alla cerimonia del salare attribuisce una particolare virtù a render i numi propizj
Ante deos homini quod conciliare valeret
Far erat, et puri lucida mica salis.
Ma ciò che è più, ma ciò che di molto maggior rilievo è per noi, ripensar ai Farisei ed ai Cabbalisti,—ai Farisei, che nel Talmud rammentano, consacrano l’uso di porre il sale a mensa; ai Tosafot nel trattato di Berahot, che sull’opinione raziocinando di alcuno dei talmudisti che la presenza del sale verrebbe omessa quando il pane bianco e sano non lo richiegga, voglion essi, i Tosafot, e concludono impreteribile la presenza del sale, che in termini apertissimi dicono Sacra e palladio di purità, leaabir ruach raà, e soprattutto ai Cabbalisti che alle tutte anzi dette cose lo soscrissero, e sulla necessaria presenza del sale rincararono eziandio. E non solo da questo lato si manifestano i Cabbalisti insieme ai Farisei parenti e consanguinei all’antico Essenato, ma tali pure per un altro verso si manifestano i Cabbalisti, e tanto più concludentemente quanto più soli ed esclusivi. E quando? Quando sul vegetabile presero a ragionare che insieme al sale udiste accompagnare il pane essenico, quando ragionarono sull’issopo. Del quale mentre tacciono, a quanto io mi sappia, i Talmudisti, nè si leggono[474] per contro certe parole nello Zoar, che non solo la lode ne contengono, e tale che a dirittura le stesse qualità purificanti gli comunicano che al sale furono attribuite, ma che eziandio, e per ciò stesso fanno grandemente dubitare non forse i Cabbalisti lo stesso uso ne facessero a mensa, che degli Esseni ci fu narrato, il sale, udiste, fugare ogni malefizio; e dell’issopo ecco che cosa si legge nel Zoar:—L’issopo rimuove ogni spirito malefico, e lungi ne caccia ogni influsso colla sua virtù salutare. Ma che dico lo Zoar? Doveva dire la Bibbia; doveva dire Mosè, che forse in niuno altro argomento più chiaramente ci apparisce informato dallo spirito medesimo dei Cabbalisti: nè meglio addimostra che il genio della Bibbia e dei dottori è unico, medesimo, indivisibile. E quanto nella Bibbia frequente, raccomandato, solenne l’uso, la virtù del vegetabile ricordato! Ecco il primo sacrifizio dagli Ebrei celebrato in Egitto, ed ecco l’Issopo, eccolo intinto nel sangue dell’agnello, e gli stipiti con esso contrassegnati ed i battenti delle israelitiche dimore. Ecco il sacrifizio del lebbroso, ed ecco egualmente l’Issopo. Ecco il rito della Vacca rossa, e non meno interessante ecco l’issopo. E non solo è vero che l’issopo spiccava qual principale disinfettante nei riti biblici, che di esso fu fatto nelle locuzioni poetiche il simbolo più espressivo della virtù purificativa, del lavacro spirituale, della morale disinfezione. Così David penitente quando esclamava: Purificami con issopo e diverrò mondo. Quando prova con questa sola eloquentissima allusione, e la virtù che a quel vegetabile s’attribuiva, sino al punto di farne simbolo del perdono di Dio, e nel tempo istesso la perpetuità, la continuazione ai tempi davidici dei riti, delle leggi mosaiche, in quella forma appunto in cui si leggono scritti oggi stesso nel Pentateuco.
Ma il pane onde cibavansi gli Esseni, almeno quelli[475] che abitavano l’Egitto e che si dicevano Terapeuti, merita che speciale considerazione gli si conceda, grazie a una singolare circostanza che lo distingueva. Il credereste? Gli Esseni, quelli in ispecie che si dicevano Terapeuti, si cibavano giornalmente, regolarmente, di quel pane stesso onde noi ci nutriamo otto giorni dell’anno, di pane senza lievito, in una parola, di pane azzimo.—Io non istarò a speculare filosofiche teorie: starò contento ai fatti, ed i fatti parleranno eloquenti abbastanza; sorgerà la storia patriarcale e dirà come comune alimento fosse tra i patriarchi il pane azzimo; sorgerà tutto il levitico, tutta la legislazione sacerdotale, e dirà come tutti i pani, tranne uno, che sotto qualunque forma e per qualunque oggetto si offrivano a Dio, e sull’altare e sulla mensa di preparazione, fossero tutti di pane azzimo; e il lievito qual abominato presente fosse bandito severamente dall’altare; dirà ancora come i sacerdoti in officio non d’altro pane si cibassero ogni giorno che di azzimo pane, sendo loro nutrimento i pani di proposizione che toglievansi ogni sabato dalla mensa di Dio; sorgerà la pratica secolare che ci fa vivere ogni anno per otto giorni della vita degli Esseni, della vita dei sacerdoti, e del pane esclusivamente ci nutrisce che stimavasi solo degno di essere a Dio presentato, del pane azzimo. E sorgerà in fine lo Zoar.—Dico il vero. Non fu senza qualche trepidazione, che io presi a svolgere le pagine di quel libro, temendo non dovesse nel maggior uopo venir meno lo storico raffronto, tanto più che niuna memoria sovvenivanci di simile pratica o teoria nella scuola dei Cabbalisti. E la pratica non vi era veramente, ma vi era la teoria. Non vi era la pratica, perciocchè, siccome ebbi luogo sin da principio di accennarvi, dividevansi gli Esseni in due ordini distinti, Pratici e Contemplativi, e i dottori nostri al primo dei due appartenevano, mentre[476] l’altro figura sì nel libro di Zoar, ma solo in distanza, e quale maggior raffinamento del medesimo sodalizio, di cui solo di tratto in tratto vediamo i membri entrare in scena, quando dal fondo delle loro solitudini passano qual ombra fugace in mezzo ai loro colleghi della città. E tra questi più rigidi probabilmente si praticava l’uso del pane azzimo per cotidiano alimento. Ma ciò che io non osava sperare, e che pure apparvemi luminoso nel libro Zoar, si è la teoria mercè la quale in termini apertissimi si conclude che dovriasi a rigore tutti i giorni invariabilmente imbandire sulle nostre tavole il pane azimo. Anzi lo Zoar stupisce, lo Zoar ricerca per qual motivo quel pane eletto non sia il pane giornaliero di ogni israelita, e la risposta è tale, che lascia intatto il principio, anzi che più e più lo conferma, ed oso dire ancora che il filo preziosissimo ci porge per cui dalla teoria zoaristica, la parte forse più ascetica dell’Essenato, scese alla pratica di cui si favella. Lo Zoar risponde, ma come? con una similitudine. Egli imagina un Re che un servo suo fedelissimo abbia insignito di un titolo onorando, e che a questo titolo, a quest’officio vadano annessi certi segni, certi fregi particolari. Quando dovrà il servo i gloriosi segni indossare? Certo, ripiglia lo Zoar, che per quanto a suo talento possa quandochessia rivestirsene, ciononostante ei non avviene per l’ordinario che la persona se ne adorni se non nelle grandissime e solennissime congiunture, quale sarebbe a mo’ di esempio il giorno anniversario della sua assunzione a tanta dignità. E pongasi pure, secondo lo Zoar, che il pane azimo, segno distintivo della nostra elezione, non debbasi, appunto qual abito peculiare e distinto, indossare se non nelle grandi, nelle grandissime occasioni. Ma siamo coerenti, e dal principio deduciamo, se vi piace, sino all’ultima conseguenza. Chi potrà negare al servo premiato di[477] recare, se così gli piace, indosso i segni continuamente della sua dignità? chi potrà negare uno stato di perfezione religiosa in cui ciò che per altri si fa per breve tratto di tempo ed a lungo intervallo, si faccia per contro da chi vive in quello stato, in modo continuo, regolare, abituale; e ciò ch’è stato eccezionale pegli uni, sia normale pegli altri? Certo che la conseguenza emerge chiara e legittima dalla teoria stabilita, e chiara quindi e legittima emergeva pei più spirituali tra gli Esseni, quel cibo cotidiano di pane azzimo a cui il resto dei fedeli non è astretto che per pochissimi giorni.
LEZIONE TRENTESIMASETTIMA.
Che più? Una religione che secondo ogni probabilità trasse le sue prime ispirazioni dalla società degli Esseni, che stende oggi i suoi influssi sul mondo civilizzato, il Cristianesimo, ci offre il più illustre vestigio dell’antica essenica costumanza esaltata, divinizzata, ed al grado assunta del più sublime dei sacramenti, nel sacrifizio dell’Eucaristia. Il pane eucaristico è pane azzimo, nè potrebbe essere da questo diviso; e per quanto la storia delle Eresie ci offra memoria delle quistioni a questo proposito suscitate, ciononstante, l’uso prevalse sempre conforme alla vetusta pratica degli Esseni.
Tra essi i più austeri tutti i loro giorni trascorrevano in digiuno, e solo a sera prendevano il loro parchissimo pasto. Nella quale rigorosa astinenza ebbero a compagni non solo i più austeri dei Farisei talmudisti, ma quelli eziandio che del Zoar sono autori od attori. L’ebbero nei Talmudisti a cui ci si offre ad esempio un figlio di Rabbinà, del quale si narrano i giorni tutti trascorsi in digiuno, salvo il giorno della Pentecoste e la vigilia del giorno d’espiazione. L’ebbero nel Zoar e più illustri e più numerosi, in tutti quei dottori che si veggono passare parecchi giorni senza prendere alcun nutrimento, assorti com’erano in profonde meditazioni, di cui la storia dell’antica filosofia ci porge esempi non pochi[479] e tra gli altri di Socrate. Del quale si narra che non solo, mentre assisteva ad un banchetto, era sì vivamente colpito da un pensiero che ogni moto perdeva e lungo tempo immobile perdurava, ma che in mezzo eziandio al romore dei campi restava dall’uno all’altro mattino immobile al luogo istesso, e solo i raggi solari gli ricordavan l’ora della preghiera. Nè qui vuolsi due circostanze della essenica vita pretermettere perchè più o meno all’ordine, alle regole della mensa si riferiscono. È la prima quel divieto che interdiceva agli Esseni ogni specie di unzione dalla quale si riguardavano come d’abominevole cosa. Nè la menzione volli di questo divieto disgiunta dall’argomento presente per una semplicissima ragione, perchè appunto le unzioni odorifere entravano tra le generali costumanze dei tempi dopo il pasto conchiuso, come fra poco vedremo. Ora dobbiamo domandare a noi stessi. D’onde e perchè questa interdizione fra gli Esseni?—Quale l’origine e quale lo spirito; e quest’ultimo costatato, più agevole, cred’io, scuopriremo la prima. Lo spirito è l’orrore di ogni mollezza, di ogni effeminato costume, è quel medesimo che non pochi precetti informa della legge di Dio, quello che la interdizione suggeriva onde all’uomo si fa divieto indossare femminile costume, di radersi i segni della virilità, l’onor del mento; e non solo come udiste di avvolgersi in ammanto donnesco, ma di addottare eziandio modi, ed usi, ed acconciature di donna. Testimone lo specchio proibito dai Talmudisti, perchè lo specchio a quei tempi era peculiare costume di femmina, siccome la pagana letteratura lo attesta, e come in ispecie si vede da Apuleio. Al quale un suo censore rinfacciando l’uso di quel arnese troppo a filosofo disdicevole, sclamava meravigliato: habet speculum philosophus; possedit speculum philosophus. Ma ciò che più interessa a sapersi, egli è in qual[480] guisa la pensarono i dottori intorno all’argomento presente, intorno all’unzione. Si può dire generalmente come i dottori distinsero in fatto di unzione quelle che dalla nettezza sono richieste, dalle altre che hanno la mollezza per consigliera. Le prime ammisero; nè forse, se il tempo lo concedesse, tornerebbe ingrato rammemorare come tra queste noverare si debba l’uso dagli stessi Romani adottato di ungersi dopo il pasto con olj odoriferi, e che ripetutamente vediamo ricordato nei libri Talmudici. Le altre che mirano, come dissi, a semplice diletto carnale interdirono specialmente a coloro che professione fanno dei sacri studj, pei quali reputarono abominevole il mostrarsi per le pubbliche vie per profumi olezzanti e per olj odoriferi, consentendo in questo come in infinite altre cose colle esseniche osservanze.
Ma io dissi di un’altra circostanza, alla mensa attinente, e di cui vado a darvi immediatamente contezza, singolare a dirsi!—Non vi è pratica dell’essenico istituto, non è parte della loro istoria che meglio la consanguineità manifesti tra esso e lo antico istituto dei Cabbalisti. Egli è quì che si vede ad un tempo come l’ultimo spinga le sue radici sino alla più alta e profonda antichità, ed egli è quì egualmente che i due istituti si porgono sul capo ai semplici Farisei amica la mano, e ciò che il comune dei Farisei rigettava e rigetta ammettersi, sanzionarsi, e con ogni possa difendersi da Esseni e da Cabbalisti, prova manifesta come gli Esseni non siano Farisei se non in quella misura, e sino a quel punto che i Cabbalisti lo sono, nè temano da quelli dissentire quando nè dissentano i Cabbalisti, nè separarsene quando i medesimi se ne separano. Io non ne chieggo ad esempio che il fatto presente ove vediamo i Cabbalisti permettere, anzi comandare ciò che i Farisei interdicono, e gli Esseni ad imitazione dei primi egualmente permettere[481] e comandare. Vietarono i Farisei tenere la tavola con pane imbandita dopo il pasto conchiuso, temendo non forse potesse cotesto uso precipitare in una pratica idolatrica, di cui si fa veramente menzione nel culto di Roma, e di cui le traccie risalgono sino ai Profeti che simil pratica rinfacciano ai coetanei loro, che la tavola, dicono essi, imbandivano oziosa in onore di Gad, Ahorekin laggad sciulkan. Ora, sia diversa tradizione, sia interpretazione più larga dello antico divieto, sia meno timore di trascorsi idolatrici; fatto è che i Cabbalisti a quest’uso non si oppongono. E non che opporvisi, instantemente lo raccomandano per la sera e pel giorno di sabato, volendo la mensa in quel giorno continuamente imbandita con pane dopo il pasto rinnovato: d’onde un disputare infinito tra i semplici Farisei e i Farisei Cabbalisti, e d’onde in fino nuova arme portai ai nemici dello Zoar a osteggiarne la santità e il valore. Ma io vorrei invitare amici e nemici a legger Filone. Il quale nè più nè meno una eguale identica pratica narra dei nostri Esseni, la cui mensa, egli dice, vedevasi specialmente nei dì festivi perpetuamente imbandita, e pane vedevasi sopra ordinato a somiglianza della mensa ch’era nel Tempio, e ch’è tipo che i Cabbalisti stessi tolgono ad imitare nella mensa loro.—Se gli avversarj dello Zoar hanno imparzialità ed amor del vero, come hanno scienza ed erudizione insigne, riflettano a questo fatto, a questo gran fatto. Pensino allo Zoar che in onta al Talmud, in onta alle sue esplicite interdizioni, in onta agli interpreti, ai ritualisti antichi e moderni, proclama innocente, pia, autorevole una costumanza che gli altri dicono vana, perniciosa, paganizzante. Pensino alla ignoranza certa, provata in cui vissero i nostri dottori di questo inaspettato ausiliare, cioè della società degli Esseni. Pensino all’esplicita menzione che veggiamo in Filone dell’uso[482] contrastato; alla indubitata antichità, al potentissimo ausilio che questa conformità reca ad un tempo ed all’antichità delle teorie zoaristiche ed alla loro identità, colle dottrine e colle pratiche esseniche: pensino a tutto questo, e poi ci dicano se le stesse anomalie che a suo danno impugnarono, non riescano a prova maggior dell’antichità di quel libro, e se di esso, come Dante di San Domenico, dire non si potrebbe acconciamente che percosse
L’impeto suo più vivamente quivi
Dove le resistenze eran più grosse.
Parad. XII.
LEZIONE TRENTESIMOTTAVA.
La seconda parte della Storia dell’essenico culto, quella che riguarda gli abiti e le virtù della setta, ci occupava nelle precedenti lezioni, e ci occuperà eziandio nella presente. E particolarmente diremo delle virtù per cui andavan distinti.—Quando parlammo delle dottrine degli Esseni, toccammo altresì della loro morale, e i principj indicammo speculativi dei loro costumi.—Ora dobbiamo dire in ispecie di quelli che a se medesimi si riferiscono, e che hanno principio e termine nell’uomo interiore.—Quando vollero gli Esseni insegnare la legge generale di ogni virtù personale, dissero che la maggiore tra esse virtù, la più generale, la più comprensiva consista nel domare le proprie passioni, nell’imperio di se medesimo. E se l’illustre signor Munk, il quale ci narra degli Esseni la morale suprema, si fosse dei Farisei ricordato, e delle sentenze in ispecie consegnate in Abot, trovato avrebbe la formula essenica in quel dettato degli antichi padri, ezeu ghibbor accobes et izrò, come in altri moltissimi forse anco più espressivi, che qui lungo saria ricordare.
Ma se ogni rea passione volevano domata, ve n’era una che più ispirava orrore agli Esseni, e che credevano il più grande nemico da superare; e questa era la collera. Nè potrebbe essere diversamente, se i Pitagorici[484] sono gli Esseni del Gentilesimo, come gli Esseni i Pitagorici dell’Ebraismo, al dir di Giuseppe, niuna passione più della collera doveva essere da loro abominata. La quale vincere era còmpito particolare di ogni buon Pitagorico; e tanto innanzi vennero i seguaci di Pitagora nel conseguimento di questa virtù, che la memoria restonne celebre nei filosofici annali, e che Carlo Ritter non temeva di asserire: Le triomphe des Pythagoriciens sur la colère est célèbre.
Mostrato abbiamo la verità dell’asserto flaviano, la pitagorica parentela; sarà d’uopo che la bontà proviamo ora del nostro sistema? Secondo il quale, e voi il sapete, oltre l’origine che con tutte le ebraiche scuole vanta l’Essenato, comune nell’epoche e nelle opere della Bibbia, più specialmente s’identifica, a parer mio, colla grande scuola dei Farisei, e in questa stessa segnatamente, colla frazione più eletta dei Teosofi o Cabbalisti. Or bene, se il nostro sistema non è erroneo, la collera dovrà apparirci esecrata non solo nei libri biblici, ma nei farisaici e cabbalisti eziandio; anzi in quest’ultimi specialmente un carattere particolare dovrà assumere, che meglio consuoni col genio e colle virtù degli Esseni, mostrandoci l’ira avversa specialmente a quella eccellenza contemplativa, a quella santità e purezza di speculazione ch’era il più proprio e più grato officio dei gran solitarj. Io oso dire che tutti i tratti anzidetti escogitati soltanto in desiderio si verificano storicamente a cappello. Non dirò lungamente della Bibbia, la quale siccome libro popolare e soterico non mira, almeno esteriormente, che alla morale o sociale pervezione dello individuo, e solo per via di accenni allude, di tratto in tratto, ai lati più nobili e segreti della umana coscienza, all’intelletto, alle sue leggi, al suo culto, alle dottrine che ne formano lo alimento. Pure[485] la Bibbia, i Proverbi in particolare ci presentano la collera, non certo sotto quei varj, moltiformi e veracissimi punti di vista, sotto cui i dottori la presentano nei loro libri, ma sempre quale passione esiziale all’uomo sociale, al suo corpo, ai suoi amici, ai suoi interessi, al suo onore. Ma i dottori vengono, e le parole bibliche, e i fatti stessi, come quadri, dalle tenebre sottratte, acquistano luce colore verità e merenza. Vengono i dottori, e la collera non solo è predicata micidialissima all’uomo corporeo, come la Bibbia stessa pareva indicarlo, come la Storia e la Medicina concordi lo attestano, ma, siccome non è vero scientifico che non abbia il suo limite in un vero contrario, così non tardarono a trovare nella collera stessa un farmaco alla salute, quando la fiamma onde l’anima s’avvampa, è accesa, dicono essi, non già nel fuoco d’inferno, ultima e vile teoria, Zoamà dell’igneo torrente, Near di Nur che traversa il Creato, ma in quello puro della celeste scaturigine, vale a dire nello sdegno generoso a difesa del vero, dacchè, per un concetto bellissimo, l’Inferno stesso pigli origine dal Cielo, e il fuoco che vi consuona non sia altro che il sudore delle Hajot ch’estollono il trono di Dio, vale a dire la Cloaca massima dell’Universo.—Or quest’effetto terapico di una collera nobile generosa, la Medicina lo ha notato, e molte cure si notano, come asseriva il medico Dementi, conseguite di vecchie e croniche malattie per l’effetto subitaneo salutare di un accesso di collera. Ma la collera non meno all’anima, secondo i dottori, che al corpo è nociva, e non meno alla morale che alla intellettuale perfezione. Alla morale, quando dissero: Dio stesso è preso a vile dall’iracondo, Afillù schehinà ena hasciubà chenegdò; quando aggiunsero tanto empio essere lo iracondo quanto lo idolatra; quando insegnarono sommo antidoto al peccato il non adirarsi. Che diremo[486] degli effetti sull’intelletto? Per essi l’iracondo non potrà mai istruire, e questo notate trovarsi in Abot, vale a dire nel Codice dei Hasidim, e sommamente confacente al genio studioso e contemplativo degli Esseni. Per essi la collera mette in bando la scienza, e intorpidisce lo intelletto.—Per essi Mosè stesso non si sottrasse da questi effetti della collera e vide venir meno il suo saper rivelato dopo un moto di sdegno.—Per essi, e ciò più davvicino s’attiene alla società degli Esseni, se tra le due scuole rivali di Sciammai ed Illel la seconda prevalse qual norma suprema in Israel, egli è perchè tra le altre virtù della scuola Illeliana, quella splendeva massimamente di una mansuetudine a tutta prova; fatto di gran rilievo, se ponete mente come la mansuetudine degli Illeliani e il carattere opposto dei Sciammaiti non siano, a ciò che pare, un fenomeno accidentale, ed uno scherzo del caso, ma parte integrale del loro genio speciale, poichè rimonta ai due grandi fondatori di ambo le scuole; e la docile natura degli Illeliani come il genio severo e sdegnoso dei Sciammaiti si vedono già spuntare in tutta la loro interezza nel docilissimo e mansuetissimo Illel come nello sdegnoso e severo Sciammai.—Ma se ciò è già molto per condurci bel bello dalle idee farisaiche alla società, alle leggi dell’Essenato, un passo più grande avrem compito quando ricordato avremo ciò che si legge in Sciabbat a proposito della mansuetudine Illeliana. Fra poco, quando toccheremo della collera qual aborrita passione dai Cabbalisti, vedremo le prove che i più venerandi tra essi imponevano ai nuovi venuti, contro la passione odiatissima in tempi in cui le dottrine loro erano chiuse ancora in istrettissimo cerchio, e che di uno o due secoli precedono il Mille dell’Èra Volgare. Ma dall’8 o 900 dell’Era Cristiana ai giorni dell’antico Illel corrono più di mille anni,[487] e nonostante vi è un fatto narrato nel Talmud Babilonico nel 2º di Sciabbat in cui, ove tu guardi con occhio fermo penetrante e scevro di pregiudizj, non potrai non ravvisare le fattezze comuni, alle posteriori prove dei Cabbalisti, alle prove più antiche che imposero certo gli Esseni ai loro seguaci.—Ma io però lo confesso, il mio modo d’intendere il fatto in discorso immensamente si dilunga da quello che fu ammesso sin’ora dai chiosatori; e s’egli è vero, com’è verissimo, che a niuno sia interdetto proporre nuovi e più acconci sensi alla parola tradizionale, altro non resta, per assicurare il trionfo del vero, se non vedere ove più sia di ragione, di critica, di plausibilità, di carattere storico. Il fatto in discorso è ovvio e trito fatto tra i Talmudisti. Sono due uomini, dice la Barraità, che scommettono di venire a capo della pazienza e mansuetudini Illeliane; che prendono tutte le loro misure per riuscirgli in mille modi importuni, che scelgono un giorno di venerdì mentre Illel si radeva i capelli, che bussano alla porta sua e con gran pressa chiedono se a caso vi fosse Illel. E Illel, che ricompostosi in fretta gli esce incontro festoso, che chiede a loro che cosa desiino; sono essi che gli propongono una serie di domande degnissime di nota, in quanto preludono alla bellissima moderna scienza etnografica, vale a dire allo studio dei popoli in relazione alla regione da essi abitata, e di cui, se io non erro, solo in Aristotile si vede tra gli antichi un primo albore.—Ma queste domande sono fatte ad Illel in guisa che un moto ne provochino d’impazienza, una parola, un accento; perchè fatte dopo iterato congedo, con intervallo dall’una all’altra, e coi ripetuti preamboli ad ogni novella domanda. Ma nè moto, nè accento, nè segno alcuno dà a divedere Illel d’animo concitato, ma sempre a metà raso accorse alla porta, sempre dolce favella, col nome[488] di figlio sempre li chiama, sempre cortese risponde, e non solo cortese, ma ragionevole e sapiente, come mi fu dato osservare non so se più lieto o sorpreso, in guisa che mille offre analogie colle soluzioni che Aristotele stesso, se non erro, nella Politica, propone agli stessi problemi.—Lo dissi e lo ripeto, il senso storico ch’io veggo nel fatto di Sciabbat, non è quello che tutti intesero i chiosatori finoggi, e forse gli ultimi compilatori del Talmud che tanto vissero lontani e dai luoghi e dai tempi dell’antico Illel, non si addarono o poco del carattere verace del fatto narrato, ed in guisa lo presentarono che nè mostra in essi una coscienza chiara luminosa del suo vero senso, nè è capace nemmeno d’ingenerarla ad una lettura superficiale, e senza il concorso di dati, di elementi estratalmudici. Pure io non m’astenni nè mi astengo dal proporvelo, sì perchè è principio di critica liberalissimo nei nostri studj—potere ognuno liberamente discutere sul senso talmudico—, sì perchè se non al tutto andava errato Ernesto Renan, quando disse potere la ebraica filologia moderna più e meglio penetrare la biblica intelligenza che non i secoli per avventura men dall’origine discosti, egli è certo però che, vuoi nella Bibbia, vuoi nei Dottori, questo fatto si verifica allora, e solo allora che il nuovo senso è tratto dall’Emporio tradizionale che è la corrente perenne ed il pensiero intimo nazionale, che precede, accompagna e segue tutte le opere scritte, l’atmosfera in cui nuotano, la luce in cui sono rischiarate. Nel giro tradizionale la ragione ha libero il moto, libera scelta, libera adozione, e mentre gli è dato produrre ivi quel giro con quei dati, con quegli elementi, tutte le combinazioni, tutte le forme, le figure possibili, che sono Scibghim Panim, e l’immenso Poligono di cui favellano i Dottori, non può a buon diritto creare nè nuovi dati, nè nuovi elementi appunto[489] come nella materia, ove libero s’esercita nel combinare incessante l’ingegno del chimico, ma in cui vano sarebbe tentare la creazione eziandio di un atomo.—Sendo il corpo e l’idea, la materia fisica e la materia ideale campo e limite nel tempo stesso alla ragione dell’uomo,—campo ove libero si muove—limite ove libero si ferma, e campo e limite adombrati nel bel vocabolo Ghebul, che con mirabile sinonimia significa a un tempo limite e campo.
Noi però siamo ancora nei confini del puro e semplice farisaismo talmudico. Prima di passare alla più speciale considerazione del farisaismo cabbalistico, che è quello con cui in ispecial modo s’identifica la società degli Esseni, mestieri è che di due altri rilevantissimi cenni favelliamo altresì, tratti dal seno del farisato talmudico, e che serviranno di naturalissima transizione al campo alla scuola più speciali del farisato cabbalistico. Questi cenni non sono di eguale significanza, troppo il secondo sovrastando, come agevole comprenderete. È il primo una frase che precede una sentenza, che non ha guari udivate quando per sommo preservativo al peccato additavano i dottori l’allontanamento dall’Ira, Lò tirtah velò tehetà. E il nome del dottore, a cui si dirige l’insegnamento e il titolo di Hasid che reca manifesto e che non troppo frequente ritorna nelle pagine talmudiche, Rab Sallà Hasida. Ma che cosa è il nome del dottore ammonito di fronte a quello di chi ammonisce;—che cosa è Rab Sallà Hasida di fronte al nome di Elia, del profeta immortale che di un balzo leva la mente a una visione semiprofetica, che ci rapisce di un tratto nel vero e naturale orizzonte dell’Essenato, delle sue visioni, della sua vita contemplativa, che un nuovo anello ci porge tra i due istituti, tra Esseni e Cabbalisti, nelle comuni visioni, nelle comuni apparizioni di[490] Elia profeta; e che dopo avere insieme stretti Esseni e Cabbalisti, insieme poi gli radica, li riappicca nelle più vive e pure fonti del farisato antichissimo. Oso dire che lo incontro di questi nomi di Elia e Rab Sallà Hasida, è lo incontro di due idee che insieme si spiegano, s’illustrano di bellissima luce, la quale poi è levata a grado ancor maggior di potenza dall’oggetto istesso che pone a fronte i due individui; oggetto, legge, precetto essenico per eccellenza, l’orrore, l’esecrazione della collera. E questo, come vedete, è già transito facilissimo dal puro e semplice farisato al farisato cabbalistico, in quanto ne porge nel titolo di Hasid nell’incontro dello Essena con Elia, e sopratutto nell’idea che li pone a contatto, altrettanti sbocchi e riuscite naturalissime alla più speciale scuola dei Cabbalisti.
Ma che parlare di questi transiti, quando una via regia ci si para dinanzi nello stesso Talmud? Formiamo secondo il solito un voto, e vediamo se sarà adempito. Imaginiamo che cosa di più preciso, di più parlante potremmo desiderare nel Talmud, che nell’odio stesso alla passione dell’ira ci offrisse un mezzo nuovo d’identificare Cabbalisti ed Esseni.—Diciamo a noi stessi: Se il Talmud suppone, come non è dubbio, una scienza segreta acroamatica che si chiama ora Sitrè torà, ora Maase Mercabà, ora Pardes, ora la trasmissione del nome Mesirat ascem; s’egli è vero, come dicemmo le tante fiate, che quella scienza, quella scuola segreta, è la scienza e la scuola dell’Essenato; se è provato come gli Esseni imponessero la fuga dell’ira qual morale apparecchio indispensabile alle dottrine gelose; se in pari modo l’imposero i Cabbalisti; se l’uno e l’altro sono quegli stessi nel Talmud designati, come cultori del Pardes, della Mercabà, dei Sitrètòrà o qual altro nome si abbia la riposta teologia; in una parola se il sistema[491] nostro non è bugiardo, che cosa dovrà trovarsi nel Talmud? Dovrà trovarsi, se non erro, la fuga, l’astensione, l’orrore della collera qual condizione impreteribile alla comunicazione della Mercabà, dei Sitrè torà e sopratutti dei Nomi sacrosanti che tanto gelosamente vedemmo custoditi eziandio dagli Esseni. Questo, nulla di più nulla di meno, dovremo trovare nel Talmud, ed ove realmente si trovi, ed ove l’ira vi sia additata qual sommo ostacolo da superare nello ingresso del Pardès, o la logica e la critica non sono più che nomi privi di senso, o il sistema nostro riluce di nuovo, d’inusitato fulgore. Ora l’ipotesi escogitata in desiderio è una bella e preziosa realità. È un testo chiarissimo e luminosissimo in Kedduscin ove aperto s’impongono fra le altre, qual condizione indispensabile alla comunicazione dei nomi divini, l’età virile, e poi la fuga dell’ira. Queste parole non hanno bisogno di chiose perchè troppo eloquenti depongono in favor nostro. Egli è per ciò che per la porta che dischiudono, pel passaggio che ci offrono alle idee cabbalistiche, noi entreremo difilati ad udire dalle costoro labbra non meno solenne ed esplicita la condanna dell’Ira. Ora del Zoar e del suo attestato. Chiede il Zoar a qual segno si debba cercare o fuggire la compagnia di un uomo, e risponde: nell’ira. Se l’anima santa ei dice, custodisce illesa nell’ira, se non la divelle dal suo riposo, se in luogo suo non vi pone un Dio alieno, un idolo, questi è l’uomo perfetto, questi è il servo fido al suo Signore, ma ove fosse al contrario, ci sarà l’uomo ribelle al suo Signore, ed a cui (notate le seguenti parole che l’idea ci destano dei Habrajà Zoaristici che rispondono, come dissi altra volta, ai socj dell’Essenato), ed a cui è interdetto avvicinarsi nè con esso associarsi. Ma ciò che altrove dice lo Zoar merita più attenzione.—Dopo aver chiamato, come udiste, la collera[492] vera idolatria, Èl Zar, Sitrà okarà, conclude con parole che, oso dire, sono a parer mio un lampo vivissimo di luce che progettandosi a traverso i secoli frapposti sulle antiche linee del grand’Essenato, ce ne fa cogliere in un amplesso istantaneo di luce le vere fattezze e i fili segreti che lo congiungono agli uomini, alle teorie del Zoar. E per comprendere questo tratto di luce, due parole d’indispensabile prefazione. Ricordatevi di un fatto, e questo fatto sarà la chiave con cui potrete penetrare nell’intelligenza del Zoar. Il fatto e l’uso che abbiam veduto presso gli Esseni di cibarsi cotidianamente di pane azzimo, e questo è il punto di partenza.—Ma ciò non basterebbe senza che una idea intermedia non venisse a stringere, a legare tra essi l’uso essenico del pane azzimo e parole che udirete del Zoar, e questa idea è idea farisaica per eccellenza, è il lievito preso, considerato qual simbolo naturalissimo di ogni passione che suoni tumore, gonfiezza, la collera, la superbia particolarmente.—Da questo punto di vista, con questo duplice filo alla mano, udite le parole dello Zoar a cui accennava. La fuga dell’ira era l’oggetto delle più calde sue esortazioni. Per mostrare l’Ira qual vera e propria idolatria, il Zoar invoca l’autorità della Bibbia, e per ciò, ei dice, egli è scritto: Eloè Massehà lò taase lah, e poi si legge immediatamente: Et kag amazzot tismor. Ma che intenda lo Zoar con queste parole, qual rapporto abbia l’idolatria col kag amazot, qual rapporto abbiano ambedue col soggetto in discorso, coll’Ira; nè il Zoar lo dice, nè i più autorevoli commentatori lo spiegano, nè troppo parmi suoni agevole a comprendersi.—Solo ha un senso se ci torniamo alla mente e l’uso essenico di cibarsi di pane azzimo, e il simbolo del lievito qual espressione di collera e superbia. Premessi i due fatti ricordati, quanto non riesce piano e naturale il ragionamento dello[493] Zoar! Ei vede nella Contiguità ossia Semikut dei due comandi il cenno del principio suo favorito.—L’iroso essere idolatra—; egli vede il testo esordire colla idolatria materiale esteriore, sensibile nell’Eloè masseha, e senza sbalzo e senza lacuna proseguire nella idea stessa d’idolatria, non più fisica certo ed esteriore, ma morale e interna nel divieto di ogni lievito, Et kag amazot; ch’è quanto dire, oltre il suo senso positivo e letterale, lo schifo, la fuga della collera, della superbia da cui gli Esseni si guardavano, e in figura e in realtà; in figura coll’odio che ispiravano per la passione dell’ira, in realtà colla massima estensione che davano al precetto in discorso, cibandosi, come vedemmo in fatto che si cibavano, cotidianamente di pane azzimo. Il Zoar con una frase suppone, e la significanza simbolica del lievito qual simbolo di collera, e ci addita al tempo stesso la via per la quale poterono gli Esseni allargare il precetto in discorso sino a formarne regola comune ordinaria di loro vita. Ora dagli antichi ai più moderni Cabbalisti trapassando, seguiamo di queste idee le vestigia sempre più manifeste. Non solo per essi le virtù alla collera opposte, la dolcezza, la mansuetudine, la sopportazione delle ingiurie, sono apparecchio a ricevere lo spirito divino, sono anzi i più eloquenti maestri della scienza riposta; non solo si legge in nome dei più antichi Cabbalisti quai furono i Cichittilia spagnuoli; non solo eglino stessi dicono averlo trovato scritto nei libri dei Cabbalisti, che meritarono di pervenire alla scienza divina; non solo, dico, per essi uno dei preliminari più grandi e più necessarj è la sopportazione delle ingiurie, è la fuga della collera ma ciò che più monta, è quello che segue, ove risalendo a un’epoca antichissima, al mille dell’Era volgare, vediamo la prova contro la collera prevaler qual uso tra i più grandi dei Cabbalisti. E grandi invero sono per esempio[494] Rabbi Jeuda chasid, più antico di Rasci, e grande non meno il maestro suo Rabbi Jaacob Eschenazi. E dell’uno e dell’altro ecco ciò che si legge nel Rescit Kokmà, libro prezioso non solo per la dottrina morale, ma per i frammenti e le memorie di gran lunga più antiche che di frequente racchiude:—«Avvenne che il hasid Rabbi Jacob Eschenazi, che era straordinariamente erudito nella scienza (intendi la Teosofia o scienza per antonomasia), volendo insegnare la sua dottrina a Rabbi Jeudà chasid, provollo prima riguardo alla collera.—» Ma ciò è poco rispetto a quello che segue: «Ed era tradizionale costume appo loro (intendi Teosofi) di non trasmettere la scienza, se non a chi provato essendo negli effetti dell’ira, non s’adirasse. Ora fu provato pertanto R. Jeudà chasid il quale, per molte volte riuscito vittorioso, la settima però restò soccombente.» Queste parole brillano di una luce propria innegabile, nè bisogno hanno di venire illustrate, ogni parola o comento non facendo che oscurarle. Solo piacemi additarvi un punto, non men bello nè luminoso, ma che nel fulgore dell’insieme potrebbe sfuggirvi, come le stelle si ecclissano alla luce del sole. Ed è l’epiteto Hasid invariabilmente appiccato al nome dei due Cabbalisti, del dottore e dell’addottrinato del Hasid R. Jacob Eschenazi, il maestro; e del hasid R. Jeudà suo discepolo. Se tutte queste cose sono a caso, io mi taccio; e solo dirò che se ciò è a caso, non è più assurda quella ipotesi che altri mise in campo per provare la necessità di un ordinatore del mondo, e che non è più impossibile che imborsando tutte le parole del vocabolario latino ed estraendole ad una ad una, ne venga fuori il capo d’opera della letteratura latina, L’Eneide di Virgilio.—Se il caso può partorire le armonie che vediamo nello studio degli Esseni, non v’è nulla di assurdo che possa fare ancora il prodigio indicato.
LEZIONE TRENTESIMANONA.
La storia della vita essenica costava di tre parti distinte. La vita religiosa, la vita interna, la vita pubblica esteriore. Delle prime due parti abbiamo ragionato abbastanza, rimane a vedere della terza ed ultima che dicemmo vita pubblica ed esteriore. Vi ha però un tratto della vita loro, intima privata, che serve quasi di ponte e di transito naturalissimo allo studio, dei loro rapporti esteriori, ed è il rispetto reciproco che professavan tra essi i membri dell’Essenato. Questo rispetto fu sì grande, sì costante, così proprio all’Essenato, che un tratto forma sensibilissimo della essenica fisonomia, che menzione segnalatissima meritava dallo storico della setta, Flavio Giuseppe. Giuseppe vide il rispetto, la deferenza che usavansi tra essi i membri dell’Essenato, ed ai posteri lo trasmise, e trasmettendolo, nuovo e parlante argomento ci porse della identità tra Farisei ed Esseni, da noi propugnata. Se v’ha carattere deciso spiccato prominentissimo nella scuola dei Farisei; egli è questo senza meno, egli è il rispetto che la scuola imponeva tra colleghi e compagni; egli è il precetto che si legge in Abot, il Codice dei Hasidem, di amare, riputare qual proprio l’onor del compagno; egli è l’onoranza dovuta al compagno qual duce e maestro per quello inevitabile incremento di scienza che si consegue negli studj, nelle disputazioni[496] comuni; egli è il titolo di familiare all’Esterno conceduto in Pesahim a quelli che tributano lode e dimostrazioni onorevoli ai compagni loro nei dotti, consessi; egli è il vanto che menavano i più grandi tra i Tanaiti, di non aver mai tolto a vile l’opinione dei colleghi, sino al punto, dice alcuno tra essi, di officiare qual sacerdote abbenchè sacerdote non fosse; egli è il flagello che dicesi menò strage nella immensa scolaresca di Akibà, sol per aver un solo istante obliato il dover sommo del Farisato, il rispetto reciproco e per cui dura tuttavia un vestigio di lutto tra la Pasqua e la Pentecoste; ei sono infine gli esempj grandi cospicui che ci offrono del reciproco rispetto i lumi più grandi del Farisato, e ciò che più monta, per eloquentissima coincidenza, i dottori più celebri del Cabbalismo, Rabbi Akibà quando profonde in carcere la scarsa misura d’acqua per bere, ad uso di un lavacro doveroso soltanto, a detta dei suoi colleghi, perchè, com’egli disse, meglio era subire le torture della sete che dar pubblico segno di indisciplina e disobbedienza; R. Simon, il corifeo del cabbalismo, quando sgrida, non appena uscito dal suo più che decenne nascondiglio, colui che contro la volontà dei colleghi, e ciò che più monta, in coerenza alla sua propria opinione, raccoglieva poche spiche spontaneamente cresciute nell’anno sabbatico. Ma tal rispetto, comunque osservato universalmente tra i nostri Esseni, non era tuttavia in pari modo distribuito tra loro. Fra gli Esseni d’Egitto, che la Storia conosce col nome di Terapeuti, v’era una classe che forse non differisce dai sacerdoti stessi che ministrarono nel Tempio di Onia, di cui ebbi luogo non è molto di favellare e che il nome reca appo Filone di Presbiteroi, d’onde, come dissi altra volta, il prete cristiano. Ora i Presbiteroi di Filone erano i più degni e più meritanti di tutta la scuola, certo i più dotti, e ciò che più monta[497] è ciò che aggiunge Filone, concedersi quel titolo al merito senza riguardo di età. E questo è pretto e puro farisaismo. Presso i quali se la vecchiezza è in somma onoranza, come presso la Bibbia, come appresso i più civili e più nobili popoli dei tempi antichi, non è sì che la scienza non faccia venerando per prematura canizie anche l’uom giovanissimo, che non lo anteponga al vecchio ignorante, e che per tutto ciò che s’attiene ai consessi studiosi, unico criterio di preminenza non sia la scienza maggiore, e solo nei mondani convegni si accordi alla vecchiezza, comunque indòtta, la preminenza.
Ora lo studio della vita esteriore ci dee le soglie far varcare del grande Istituto, e dall’esame dei rapporti reciproci dobbiamo procedere a quelli che gli Esseni legavano cogli uomini, col mondo, colla Società esteriore. La storia ci ha conservato memoria di due rapporti, che due Stati contrassegnano opposti, estremi nelle sorti dell’Essenato, la libertà, la grandezza, il potere da una parte, la sventura, la persecuzione, il martirio dall’altra. Nell’uno come nell’altro, nella trista e nella lieta fortuna, uno è il volto, uno il carattere, uno il tipo, quello dei Farisei. Come gli Esseni, dei quali chiaro attesta Giuseppe le civiche e governative dignità, le città governate, come Giovanni Essena governatore di Jamna, come gli Esseni ebbero i Farisei onori, potenza, impieghi, uffici pubblici, edilizj politici eziandio dal governo romano, o dagli efimeri principati della Giudea; e senza ripetere ciò che fu detto di Menahem, chiamato, dice il Talmud, insieme ai discepoli al servigio di Erode, parecchi esempj si potrebbero fra i dottori citare non solo di regie e imperiali amicizie, ma di offici pubblici sostenuti, e di cui lo esempio non è raro vedersi anco nella storia moderna, nelle corti d’Europa, nei ministri dei Re di Francia, nei tesorieri e medici della corte[498] papale, tra i quali splende qual vivido astro, Rabbenu Iehiel del 9º secolo dell’Era Volgare, tesoriere del Papa allora regnante. Ma le cariche, di cui parla Giuseppe, datano da tempi più antichi, da quando ogni barlume d’indipendenza non era svanito, dai primi tempi del dottorato talmudico, e forse dai tempi gloriosi della guerra d’indipendenza. Di tempi così antichi, scarsi sono ed incerti le memorie talmudiche, e quindi scarse ed incerte le analogie che andiamo cercando. Non sì però che qualche vestigio non ne rimanga. Testimoni Menahem e la sua scuola di cui abbiamo parlato, e testimoni quei primi venerandissimi Tanaim che aprono la serie del dottorato in Abot, un Antignos Is soho, vale a dire Signore rettore di Sohò, un Joseben soezer rettore di Zeredà, un Rabb Halafta rettore di Chefarhanama, un Rabb Eliezer rettore di Bartota, un Rabb Levitas rettore di Jabuc, un Nehunià capo di Chefarabatli; tutti, come concordi attestano i chiosatori, investiti di pubblico, di civile officio, indicato nel vocabolo Is, Signore e Duce. Ma gli esempj e la pratica non solo all’uopo soccorrono, vi è anco il principio, il costume, l’enunciazione generalissima del fatto dai dottori proclamato. Il fatto voglio dire di Dottori, di Farisei, di Esseni, che son tutt’uno per noi, preposti al governo, al maneggio de’ pubblici affari. E non solo una volta, ma bene tre esplicite e chiarissime menzioni ne ricorrono nei libri talmudici, e non solo i Farisei in generale ne sono, come dissi, gli enunciatori, ma quelli in specie che recano manifesti i segni dell’affiliazione cabbalistica, e di cui udito abbiamo altra volta la voce e veduto gli esempj preziosi, autorevoli. Ma uno poi di questi luoghi accennati brilla di una luce tutta propria, speciale, sfolgorantissima, ed al novero appartiene di quei pochi, ma salienti tratti di luce che ci rivelano nel Talmud le traccie[499] dell’Essenato, e che se non soli perchè corredati, accompagnati da quelle costanti e perpetue analogie da noi additate, sono però come soli in mezzo agli astri minori, come i visceri vitali, come i centri organici nervosi in mezzo al continuato organismo, come i nuclei stellari nella materia delle nebulose, come i grandi avvenimenti nella istorica successione, come le epoche organiche genesiache nella formazione della terra; un concentramento di luce, di forza, di vita, di azione e di pensiero. Io dissi che tre sono i luoghi in discorso. Ma se tre sono i luoghi e tre le forme, uno solo è il pensiero, uno solo il fatto che sotto vi giace, ed a cui si allude; il fatto della presenza dei Dottori, dei Farisei al governo della città, il pensiero di fuggire la città da essi governata. Io non starò a notare le grandi riflessioni che questo pensiero ci suggerisce, le vere cause che condussero i più grandi tra i Farisei ad abdicare ogni politica superioranza, ma il fatto resta, ed il fatto ci basta. Quando Rabbi Akibà volle lasciare al figlio alcune regole di condotta per bene vivere nel mondo, fralle altre cose che raccomandògli sì è quella di non abitare un luogo al cui governo siano Talmide hahamim, vale a dire veri e proprj Farisei. Quando Rab volle fare nel Talmud di Sciabbat una scala, una gradazione di merito fra le umane signorie, pose in primo luogo l’araba signoria, dopo l’araba la romana, dopo questa la persiana o cabaritica, e dopo questa la farisaica. Ma il terzo luogo vince di gran lunga i due ricordati; ed è, come dissi, un dei fari, dei punti luminosi che guida chiunque si faccia a cercare nel mare talmudico l’antica scuola degli Esseni. L’autore è quel medesimo della scala politica testè udita, è il medesimo Rab, il pensiero è il medesimo, ma l’espressione, ma la forma, quanto più eloquente! Esorta egli com’esortava Akibà il figlio suo, ma invece[500] del vocabolo Talmid Haham un altro è posto in luogo suo, e questo è il nome di Assè. Non abitare città alla cui testa sia un Assè. Parola grande storica che suona rarissima in tutto il Talmud, e che doveva quindi tornare strana, bizzarra all’orecchio dei chiosatori ignari o incuranti della esistenza stessa di una scuola per nome Essenato. Quindi in Rasci e nel Karuh, un linguaggio perplesso e come a tentoni: ma poi la mente loro dopo breve bagliore, mirate forza del vero! si fissa come aquila nel sole, nella contemplazione dell’unico senso, vero, storico, razionale, e la gran parola pronunziano d’identità fra Talmid haham e Assè, e nell’Assé del Talmud non altro veggono che lo stesso Talmid haham, vale a dire veri e proprj Farisei. Ei fu per me un conforto, un diletto che non saprei dirvi. Oltre il passo talmudico che ha un’importanza senza pari per la storia dell’Essenato, e che è come il suggello posto al nostro sistema d’identità, e che niuna umana potenza ci può rapire, mi doleva non poco dover anch’oggi scostarmi da quegli uomini santi e venerandi che sono Rasci, e l’autore del Lessico Aruh e in genere i Rabbini del Medio-evo. Da oggi in poi potremo dire senza che niuno sia oso di contraddirci, che per l’uno come per l’altro Assè vuol dire e può voler dire ch’egli è uno dei nomi con cui il Fariseo si distingue, ch’è quanto dire, per assumere un linguaggio storico, che gli Esseni non sono che parte nobile sì, ma pur parte del gran corpo dei Farisei.
Ma la considerazione di questo gran fatto non vorrei ci togliesse vaghezza di volger il pensiero a cose men grandi; la beltà delle forme si vede nelle grandi come nelle piccolissime linee, e ciò che è vero, è vero in tutto, nelle massime come nelle minime parti. Se il fatto che ci narra il Talmud, se il nome nuovo che accampa, quale denominazione dei Farisei, sono, più che dir si può,[501] eloquenti, non lo è meno il nome degli uomini che il fatto proclamano. L’uno è R. Achibà, il maestro del Ben Iohai, grande e felice visitatore del Pardes, ed egli stesso vivente esempio della ingerenza politica dei Farisei, nella parte grandissima che prese, nel supremo ed infelice conato d’indipendenza, in cui Ben Cozibà fu il braccio glorioso, in cui Achibà fu il capo, il pensiero, il profeta, l’ispiratore, e che soleva dire per l’infelice Barcocheba avere di esso pronosticato Balaamo quando disse: Ecco spunta una stella (Cokab) da Giacobbe. L’altro che abdica il valore politico è Rab, vale a dire R. Abbà lo scriba, il redattore, il collaboratore anzi dello Zoar, il discepolo prediletto di R. Simon, il Beniamino della scuola, il portavoce del gran maestro tanto nella tradizione comune, quanto nella recondita, tanto nel Rito come nel Dogma, nel rito colla redazione del Sifrè, opera di Rab, pensiero del Ben Johai Setam Sifré R. Simon Ben Johai, nel dogma colla redazione dello Zoar, opera egualmente di R. Abba o Rab che è pensiero egualmente del Ben Johai. E ambidue eloquentissimi nomi perchè appartenenti al maestrato supremo del cabbalismo, i quali uniti all’idea che esprimono, essenica per eccellenza perchè allusiva agli storici esteriori rapporti dell’Essenato, formano un concorso di prove, di memorie innegabili in primo luogo della identità tra Esseni e Farisei cabbalisti, e in secondo luogo delle vestigia tuttavia sussistenti nei libri talmudici del grande Istituto. Vedremo nella seguente lezione quanto gli Esseni abbiano comuni coi Pitagorici, il genio, gli uffici, la vita politica, e come grandi si mostrino nella sventura e nel martirio, non meno che nella prosperità e nella gloria.
LEZIONE QUARANTESIMA.
Se gli Esseni prendevano parte al governo dello Stato, se molti offici sostennero, come disse Giuseppe, non fecero, come veduto abbiamo nella passata Lezione, nulla di cui esempio illustre non c’offrano i Farisei, e nulla altresì, come vedremo in questa lezione, che non facesse il grande istituto dei Pitagorici, ai quali paragonavali Flavio. Voi lo ricordate, Giuseppe disse gli Esseni i Pitagorici dell’Ebraismo, e quanto bene si apponesse così dicendo, voi lo vedeste in quei casi infiniti in cui le leggi, i costumi, il genio delle due scuole s’incontrano nel corso di queste lezioni, e lo vedrete eziandio nell’argomento presente, sol che vi piaccia invocare le più accertate e comunali nozioni intorno la storia antica dei Pitagorici. Se v’ha punto incontroverso nelle vicende di quella scuola, se v’ha cosa che costituisca profondo reciso, divario tra gli antichi e i moderni Cenobj, egli è il genio pratico, attivo, sociale, politico dei Pitagorici; la parte grande, eminente che presero sino dall’origine nelle sorti, nelle costituzioni della patria loro; delle città in ispecie di Magna Grecia, ove ebbero sede famosa e illustre. Basta dire di Pitagora stesso, tra i cui caratteri splende quello di legislatore degli Italioti; di Archita, di Eudosso, pitagorici antichi essi pure, i quali, al dire di Diogene Laerzio, dierono leggi a parecchie città che abitarono.[503] Il quale genio ed officio politici perpetuaronsi nella scuola sino agli ultimi giorni della sua esistenza. Se v’ha scuola antica che meglio le fattezze riproduca dei Pitagorici, che più abbia di somiglianza, d’affinità coll’Essenato e col Cabbalismo, ella è senza meno la scuola dei Platonici. Ed a Platone non è niuno che negar possa il carattere, il genio e la scienza di statista, di cui fece studio precipuo nelle Leggi, nella Repubblica, ed è a Platone che il gran placito si attribuisce: Non potersi dare stato perfetto se non dove il principe è filosofo o il filosofo principe; ed è di Platone che il Ritter, dopo costatato il pregio e la inclinazione politica, conchiude in questa guisa: On voit donc que Platon considère la société civile comme quelque chose d’utile au particulier, et qu’il croit que c’est une œuvre louable que de prendre part aux affaires de l’État. Queste cose ci diano una idea più adequata dell’Essenato, se frainteso avessimo sino adesso il suo genio, se creduto avessimo gli Esseni non dissimili da quegli asceti antichi e moderni, che maledicendo il mondo e la vita mondana, fuggono lungi dall’umano consorzio solo per piangerne e imprecarne i vizj, i delitti; che non dànno niun valore alla vita politica, che stillano nei cuori l’indifferenza, l’apatia, lo scetticismo politico, che aprono quindi il varco a sensi abbietti e servili, e quindi operando contro il proprio scopo, non offrono più per cibo alle menti che il più vile materialismo; oh quanto non saremmo andati, così giudicando, lungi dal vero! L’Ebraismo, che è il più perfetto e sublime connubio tra la politica e la religione, era là per evitarne gli eccessi; e gli Esseni e i Terapeuti e qualunque altra scuola che nel suo seno sorgesse, non poteva a meno di essere ebrea, e quindi eminentemente pratica e politica per eccellenza. Perchè non lo fosse, perchè facesse divorzio dalla vita esteriore, bisognava che[504] prima facesse divorzio dallo stesso ebraismo, che si separasse dal suo grembo, che ne rompesse la possente unità; e, mirabile a dirsi! la storia ci conferma il dettato della ragione, e ci mostra nel cristianesimo la prima setta che fatto abbia divorzio dall’ebraismo, e nello stesso tempo che abbia fatto divorzio dalla vita politica.
Ma la ingerenza politica che la storia ci mostra nella società degli Esseni, mise in luce quella virtù più preziosa che gli fece magnanimi, eroici, tetragoni nelle persecuzioni, e che nuovo e bel riscontro ci offre colla setta madre dei Farisei. Se Farisei ed Esseni vedemmo confusi, immedesimati nelle opere del pensiero, delle leggi, delle pratiche, della morale, delle storiche vicende, confusi ancora e immedesimati li vedremo nella sventura; e se comuni ebbero gioje, sapienza e virtù, comuni avranno ancora dolori e martirio. Giuseppe che ci narrava le prime, ci narra i secondi; e in seno alla sventura, in mezzo ai roghi e sotto le crudi bipenni, ci fa vedere gli Esseni e’ Farisei stringersi ancora una volta, unificarsi in un amplesso di amore. E non solo il fatto principale da Giuseppe narrato lo attesta ad evidenza, ma le circostanze tutte eziandio che ne costituiscono l’epoca, i caratteri, le cause dei gloriosi martirj. E se io vado errato così giudicandolo, ditelo voi, quando udito avrete le parole di Flavio che io tolgo testuali dal traduttore francese. «La guerre que nous avons eue contre les Romains a fait voir en mille manières que leur courage est invincible. Ils ont souffert le fer et le feu, et vu briser tous leurs membres plutôt que vouloir dire la moindre parole contre leur Législateur, ni manger de viande que le Seigneur défend, sans verser une larme pour tâcher d’adoucir la cruauté de leurs bourreaux.» Qual ritratto, e quale più proprio e conveniente ai Farisei! Se ad una ad una tu togli ad esame[505] le circostanze da Giuseppe narrate, non una vedrai che non si attagli mirabilmente al lungo e glorioso martirio dei Farisei. Se all’epoca tu guardi, ed è la guerra d’indipendenza, egli è appunto nelle nazionali riscosse, nelle crude rappresaglie dei vincitori, che il più puro e sacro sangue si versava dei Farisei; se al genere guardiamo di morte, al ferro, al fuoco, ai membri lacerati, ove è strazio che meglio lo strazio riproduca dei Farisei? se la costanza religiosa nell’indurarlo, ove è, non dico costanza, ma sereno, ilare e quasi esultante coraggio che quello superi dei Dottori farisei menati al supplizio? se al ciglio asciutto, all’orrore di ogni supplica, di ogni bassezza, ei furono tali nei Farisei, fu sì grande l’animo impavido, ei fu tale il prestigio del sovrumano contegno che il cuore ammolliva eziandio dei manigoldi; e non pochi casi si leggono nella storia del martirio, di Dottori che vinsero i loro carnefici, che ricevendone la morte del corpo, li ripagarono colla vita dell’anima, e di pagani carnefici ne fecero, per prodigio di fede, martiri pur essi alla volta loro, e martiri israeliti.
Un’altra storica indicazione della scuola, e avrà termine l’esame del grande Istituto. Come tutti gli uomini sobri, temperanti e viventi di una vita spirituale, come tutti i Cenobj antichi e moderni, l’Essenato esso pure andò famoso per la vita singolarmente longeva dei suoi seguaci. E chi lo attesta è lo stesso Giuseppe, quando dice che la maggior parte degli Esseni perveniva all’età di cento anni; e così dicendo non fa che preludere ai cenni, agli attestati talmudici sui Farisei. Chi volse solo per poco lo sguardo al Talmud, sa quanto suoni preziosa pel nostro sistema la deposizione di Flavio; chi lesse nel Talmud quant’oltre giunse per l’ordinario la vita dei Farisei; chi reca ancora l’eco distinto di quella frase così ripetuta nei due Talmud: Per qual merito vissuto hai vita[506] così longeva; chi vide quella straordinaria durata attribuita ai più celebri tra i farisei, e innanzi a cui resta sgomenta e perplessa la critica istessa; chi queste cose ebbe per un istante considerato, vedrà nella longevità essenica narrata da Flavio un nuovo e non lieve riscontro colla scuola madre dei farisei.
E qui ha termine l’esame intorno dell’Essenato. Nell’ufficio da noi assunto duplice fu il nostro scopo. Esporre la storia tutta dell’Essenato, e al tempo stesso trarre a mano a mano dalle viscere stesse di essa storia le prove, i titoli, gli argomenti di quella identità da me propugnata tra Farisei ed Esseni, e più specialmente tra gli Esseni medesimi e quella classe di Farisei che si dicono Cabbalisti. Quanto lungi si stese l’esame dell’Essenato, quanto profondo s’addentrava l’occhio nella contemplazione della sua origine, delle sue istituzioni, dei suoi dogmi, delle sue pratiche, nelle grandi come nelle piccole parti del grande edifizio, nelle sue piccole e minute ramificazioni, continuo, splendido, eloquentissimo risultava il fatto, il gran fatto da noi proclamato, la identità essenico-cabbalistica. Io non presumo avere il grande subietto esaurito; credo però avere la buona via additata a chi più pronto l’ingegno, più propizie le occasioni da natura abbia sortito. Però, coll’esame interno, colle prove intrinseche dell’Essenato non finisce la dimostrazione della identità essenico-cabbalistica da noi proclamata. Conclusa eziandio la storia loro, resta un ordine di prove, che non ha nè può avere attinenza coll’esame interno del grande Istituto, e che si fonda sempre sopra poche ma momentose circostanze, che solo esteriormente all’Essenato si riferiscono. Si possono queste prove dividere in tre capi distinti. Si fondano le prime sopra il silenzio di antichi autori e monumenti intorno l’Essenato, silenzio che torna eloquentissimo in favore[507] della identità in discorso, come vedremo tra breve. Consistono le seconde in alcune frasi preziosissime degli antichi storici delle nostre sètte, le quali depongono, come vedremo, non meno in favore del nostro assunto. L’ultima e terza prova è tutta cronologica, ch’è quanto dire, si fonda sopra la durata che narra la storia delle due scuole, e mostra un sincronismo significantissimo tra Esseni e Cabbalisti, un sorgere, un declinare o piuttosto un ascondersi simultaneo che depone altamente in favor nostro. E prima del silenzio: del quale vorrei che comprendeste pienamente il valore. Che vuol dire un argomento tratto dal silenzio semplicissimo dei monumenti? Vuol dire consultare gli storici, i monumenti contemporanei, interrogare coloro che per officio storico, per posizione, per carattere, per rapporti necessari, sono i naturali e proprj narratori delle sètte contemporanee; vuol dire cercare tra le scuole, di cui v’è menzione, la scuola degli Esseni, ed ove solo degli Esseni si serbi un singolare silenzio, ove ogni altro motivo di questo tacere sia eliminato, concludere logicamente, trionfalmente la identità della setta della scuola taciuta, con quella fra le scuole rammemorate colla quale maggiori e più sentite corrono le somiglianze, le analogie. Determinato così il valor teorico dell’argomento in discorso, vediamolo alla prova nel presente subietto. Due sono i libri ove a buon diritto ci dovremmo attendere una esplicita e diffusa menzione della società degli Esseni, per i tempi, per le lotte, per il subbietto istesso che evocare dovrebbero ad ogni istante la presenza, la memoria dell’Essenato. E questi due libri sono i monumenti ebraici e cristiani contemporanei, il Vangelo e il Talmud; e per Vangelo intendiamo tutti gli scritti evangelici, e per Talmud le opere tutte della Enciclopedia Rabbinica dei primi secoli dell’E. V. Parlano eglino i Vangelisti, parlano eglino i[508] Dottori nostri del grande Istituto? Sì certo che ne favellano ove il nostro sistema si adotti; quando si vegga cioè in tutti quei luoghi ove è menzione degli asceti talmudici, un vestigio dell’Essenato; ma ciò che chiediamo, è diretto agli avversarj; a coloro che tentati fossero di ricusare la identità da noi proclamata, ove chiariti fossero inefficaci gli argomenti sin qui allegati, egli è a costoro che noi chiediamo, se il nome essenico vi è pronunziato, se diretta propriissima rimembranza ricorre nei libri citati, e la risposta non potria essere dubbiosa. Tacciono i Vangelisti tutti della società degli Esseni; tacciono gli immensi volumi talmudici; e se il silenzio loro è rotto tal fiata da quei brevi comunque parlanti accenti in cui il nome si ode, per un istante, del nostro istituto, egli è da una parte troppo scarsa memoria di tanta scuola, egli è dall’altra così spiccante il carattere farisaico in tal menzione, che anzichè rivocare in dubbio la identità tra le due scuole ne formano invece la più bella conferma. In una parola: il silenzio è generale e costante nei Vangeli, presso che generale eziandio e costante nei libri talmudici. Donde questo fenomeno singolarissimo, d’onde quest’anomalia storica, questa lacuna nella schiera numerosa, illustre delle sètte che intervengono, che parlano, che agiscono, che disputano, che si laudano, che s’infamano scambievolmente, nei Vangeli, nei libri talmudici? Grande è il problema e tale che l’attenzione si meritò dei più grandi scrittori. Non dirò che del Basnage, il quale, siccome noi, chiedeva a sè stesso in qual guisa si tacesse il Vangelo, della società degli Esseni. Come rispose il Basnage alla grave domanda? In modo, è uopo dirlo, ch’è ben lungi dal sodisfare, benchè duplice soluzione abbia proposto alla presente ricerca. Disse in primo luogo come gli Esseni non uscendo dai loro ritiri per disputare con Gesù, non fossevi quindi occasione di rammentarli[509] nelle dispute evangeliche. S’appose egli il Basnage così sentenziando? Io forte ne dubito. Che gli Esseni amassero la vita contemplativa non si nega, ma quanto andrebbe errato chiunque far ne volesse altrettanti solitarj e anacoreti della Tebaide! Lungi dal separarsi dal consorzio sociale, lungi da fuggire il mondo e la sua vita, niuno meglio di essi conciliar seppe la vita attiva e la vita contemplativa, niuno più volontario si sobbarcò ai doveri, agli offici politici, sociali; e se v’è carattere che più distingua gli Esseni di Palestina dai Terapeuti d’Egitto, egli è appunto quel genio, più spiccato nei primi, quella speciale predilezione per la vita pratica, esteriore ed attiva. D’onde dunque il silenzio degli evangelici? Dallo scarso insignificante numero degli Esseni, dice in secondo luogo il Basnage. Ma quanto inconsideratamente! Non vide il Basnage come menzione vi sia negli scritti evangelici di sètte ben altrimenti oscure che non gli Esseni, qual fu a mo’ di esempio quella degli Erodiani ivi rammemorata: non vide, come l’Essenato sia, a detta di Flavio, insieme ai Farisei ed ai Sadducei, una delle tre grandi divisioni in cui si partiva l’Ebraismo contemporaneo: non vide come le sètte non si contino ma si pesino; e non vide infine come l’Essenato, sendo per sua natura ascetico superlativo, non poteva non offrirsi numericamente inferiore alle altre sètte, perchè non molti sono gli uomini i quali aspirano a una vita, a una perfezione straordinaria.
Ma per tacere del Basnage, io lessi del silenzio degli Evangeli una ragione che, se non è certo più solida di quelle esposte sin ora, è certo più di esse speciosa, e poco manca che a prima giunta non ti seduca.—Ad udire certuni, se gli Evangeli non favellano degli Esseni, egli è perchè mentre il Cristianesimo pugnava colle altre scuole, mentre dichiarava la guerra agli Scribi,[510] ai Farisei ed ai Sadducei, fu tutto stima, amore, concordia colla società degli Esseni, da cui nacque, con cui ebbe comuni e la sostanza e la forma esteriore, il dogma, il culto, le istituzioni.—Non è ella cotesta la parodia, e la contraffazione del vero? Noi diciamo tutto questo dei Farisei, noi spieghiamo il silenzio farisaico colla identità essenico-farisaica, come il sistema che combattiamo spiega il silenzio evangelico colla identità fra Cristiani ed Esseni, e forse potrebbe credersi che non possiamo combattere la identità essenico-cristiana senza per ciò stesso ferire la identità essenico-farisaica, ambe poggiando sullo stesso argomento, il silenzio talmudico e il silenzio evangelico. Se così fosse, io mi troverei in un bivio pericoloso: non potrei impugnare l’arme contro il nemico senza ferire me stesso, senza soffocare prima di nascere uno degli argomenti più concludenti del mio sistema. Saremo noi condannati a rinunciarvi? Io non lo credo, purchè si voglia mirare a una radicale differenza che corre tra i due casi. S’egli è vero che il Cristianesimo ebbe rapporti strettissimi coll’antico Essenato, se s’inspirò in quella scuola, se ne trasse i caratteri più prominenti, se tutto questo e anco più concedessimo agli avversarj, ci rimarebbe sempre un punto di divergenza che eglino stessi non ci potrebber negare. Che dico? che non potrebbero contestare senza moralmente suicidarsi, senz’abdicare a ogni titolo di storica, di religiosa considerazione; vale a dire la rottura, lo scisma dall’antico ebraismo. Se il Cristianesimo non si separò dagli Esseni, se rimase una sol cosa con essi, se non dilungossi dal grembo ortodosso, e se per questo ne tacciono gli Evangeli, ch’ei rifaccia tutta la via che da noi lo divide, che risalga la corrente che lo ha recato da noi sì lontano, che si riduca infine nella ebraica periferia, se pure la pretensione ei vuol mantenere di essere[511] lo stesso Essenato.—Ma se nuova è la legge, nuovo il testamento, se proclamò sino dal nascere falso ciò che vero confessavano gli Esseni, e vero quello che falso, se rigettò la tradizione ch’era l’anima dell’Essenato, se dichiarò irrite le leggi cerimoniali, se annunciò l’umanazione del verbo incognita e blasfematoria agli Esseni, perchè dunque degli Esseni non si favella, perchè non si veggono con essi quelle dispute, quelle lotte che cogli altri si vedono così frequenti?
Ma su, pognamo che vero sia tutto quello che dagli avversarj si chiede, che nulla ci corra tra Cristiani ed Esseni, che il Cristianesimo sia lo stesso che l’Essenato, e che per questo non vi fosse luogo di farne menzione negli Evangeli. È egli per questo a bastanza spiegato il silenzio evangelico? Non dovrebbe anzi per ciò stesso invocare a ogni tratto gli Esseni? Non dovrebbe fondarsi sopra un passato venerabile, ammesso ortodossissimo, qual fu l’essenico Istituto? Non dovrebbe cuoprirsi colla sua egida? Non dovrebbe valersi del loro nome per mostrare com’ei fosse meno novatore di quel che lo reputavano?
Che se le ragioni allegate dal Basnage non valgono a spiegare il silenzio evangelico, se tutte le ragioni anzi avrebbero dovuto indurre gli Evangelisti a parlarne, se nonostante niuna menzione se ne legge, non resta che una possibile spiegazione, ed è quella che si fonda sulla identità degli Esseni con una di quelle scuole di cui è veramente menzione negli Evangeli. Tra le quali niuna più offre caratteri innegabili d’identità col nostro Istituto di quella dei Farisei. Il nostro sistema dunque non ha soltanto i caratteri intrinseci di verità; ma giova ancora a spiegare alcuni problemi storici finora insoluti.
LEZIONE QUARANTESIMAPRIMA.
Nella passata Lezione veduto abbiamo il silenzio degli Evangeli intorno la società degli Esseni e la sua spiegazione. Ma il silenzio evangelico non è il solo a deporre in favor nostro. I libri talmudici, noi lo abbiamo veduto, non sono certo così sterili di dati, di cenni più o meno diretti della società degli Esseni, come sinor fu creduto, ma non ci porgono però le esseniche allusioni che ove siano secondati dal nostro sistema, e pertanto ne suppongono fino a un certo segno la verità. Possiamo però supporre per un istante che tutti i cenni, le allusioni talmudiche siano come non fossero; possiamo dire che il silenzio talmudico sia così profondo, così completo come finora fu ammesso. In questa ipotesi stessa, come spiegarne il silenzio? Come avvenne che il Talmud così pieno di allusioni alle sètte contemporanee, ai Sadducei, ai Minei, ai Galilei, alle divisioni e suddivisioni dei Farisei, ai Cuttei o Samaritani, ai Dualisti, alle sètte primitive del Cristianesimo, niuna ci offra menzione di quella ben altrimenti nobile illustre famosissima dell’Essenato? Il nostro sistema ha già risposto al grande problema. Ma ove pure negar si volessero i resultati, in qual guisa spiegarne il silenzio? O io erro, o l’unica possibile soluzione è la identità degli Esseni con una delle scuole del Talmud rammentate, per cui di questa favellando, di quella[513] pure implicitamente si favelli. Ed ove tra quelle di cui si parla nei libri talmudici discernere si voglia quella che meglio ai caratteri risponde dell’Essenato, io credo che ogni critico di buona fede non esiterà a rispondere; e nella eletta parte dei Farisei, nei Teologi della scuola, vedrà i fedeli rappresentanti dell’Essenato nei libri talmudici. Ed ecco come per due vie opposte si giunga alla mèta medesima, come tanto nell’ipotesi del silenzio talmudico, quanto in quella della esistenza, ivi stesso di parlantissimi cenni giungere si debba inevitabilmente al medesimo resultato, vale a dire alla identità degli Esseni colla più eletta parte dei Farisei.
Ma il Vangelo e il Talmud non sono i soli ad attestare col loro silenzio la identità da noi propugnata. Vi è un altro non meno significante documento in proposito che col suo silenzio egualmente depone in favor nostro, e questi è Giustino. S. Giustino, da cui molto si può imparare intorno la polemica ebraico-cristiana dei primi secoli, ci offre un elenco delle sètte allora esistenti nell’Ebraismo. S. Giustino conosceva gli Esseni; non basta; ei fa l’onore di annoverare tralle sètte dell’ebraismo quelle eziandio che infinitamente più oscure dell’Essenato non lasciarono, si può dire, di sè memoria se non il nome; e pure gli Esseni soltanto sono quelli di cui si tace assolutamente da Giustino. Questo silenzio non può avere altra causa tranne quella da noi accennata; vale a dire l’identità degli Esseni con alcuna delle sètte ivi stesso da Giustino rammemorate, e pei caratteri innegabili di strettissima affinità con quella dei Farisei, di cui sono gli Esseni la parte più nobile e più illustre.
Ma oltre le prove tratte dal silenzio degli Evangeli, del Talmud e di Giustino, vi è un passo nel nostro Giuseppe che, per chi ben lo intenda, depone altamente in favor della identità da noi propugnata. Ed è quello[514] nelle Guerre Giudaiche al Cap. XII, ove narra Giuseppe il nascimento di una quarta setta creata da un Giuda, del quale egli narra le gesta e la vita. Giuseppe così si esprime: Questo Giuda fu autore di una quarta setta di cui la prima è quella dei Farisei; la seconda dei Sadducei; la terza degli Esseni, ch’è di tutte la più perfetta. Giuseppe, voi lo udite, chiama la setta degli Esseni, di tutte quante la più perfetta. Giuseppe ne loda, ne esalta i pregi singolarissimi; Giuseppe, il Fariseo confessato, il Fariseo illustre, l’apologista eziandio dei Farisei. Io lo chieggo agli uomini di buona fede: avrebbe egli così parlato Giuseppe, avrebb’egli chiamato la setta essenica di tutte la più perfetta, se gli Esseni come i Sadducei dissentito avessero profondamente dai Farisei, se formato avessero una scuola nemica, se la parte anzi non fossero stata più eletta, più illustre del farisato medesimo?
Noi abbiamo finora veduto quanto valga il silenzio degli Evangeli, del Talmud, di S. Giustino, e quanto le parole stesse di Giuseppe in favore della identità da noi propugnata. Qui non hanno però termine gli argomenti estrinseci che formano di questa lezione il subbietto. Vi sono quelli che abbiamo detto cronologici e storici, e di cui vado adesso a darvi contezza. E sono a due punti riferibili, i più prominenti della essenica esistenza, a due momenti principali di loro vita, a quelli che contrassegnano l’apogeo e il perigeo, lo stato più florido e la decadenza, o per dir meglio la scomparsa dello istituto dalla scena del mondo. Ed ambi ci forniscono novello argomento in favore del nostro sistema. Il momento più bello della esistenza dell’Essenato egli è quello senza meno, in cui scrisse Filone, vale a dire il primo secolo dell’Era Volgare. Allora l’Egitto e la Palestina offrivano, nel duplice ramo di Terapeuti ed Esseni, tutte quelle istituzioni, dottrine, tutti i costumi di cui si fecero[515] storici Giuseppe e Filone, e le offrivano in tutta la pompa e la forza del loro sviluppo. Allora Esseni e Terapeuti avevano e studiavano, al dire dei medesimi, libri speciali, veneratissimi trasmessigli dai loro maggiori. Ma che dico? Scorrono già due secoli: siamo ai tempi di Alessandro Severo, e di Porfirio filosofo; e Porfirio non rifinisce di laudare l’istituto degli Esseni, e tante sono le lodi che gli profonde, che il cardinale Baronio non esitava di asserire, confortato eziandio da altri indizj, non potere non essere esso Porfirio di origine, di nazione israelitica. Tanto che non si può muover dubbio che sino nel terzo secolo dell’Era Volgare vi era l’Essenato, pieno di vita ed in perfetta possessione delle sue istituzioni e dei suoi libri. In qual guisa sì repentina scomparsa? In qual guisa si ecclissò il sole essenico, si può dire in sul meriggio? In qual guisa scomparvero ad un tratto le sue istituzioni ed i suoi libri? Che lo istituto siasi spento senza seguire le leggi regolari, ordinarie di ogni vita sociale, senza percorrerne le fasi tutte di declinazione e di decadenza, è già tal supposto che nulla può darsi di più strano, di più inverosimile, è già per se stesso uno dei più parlanti riscontri colla parte più eletta, superlativa, teologica, della scuola dei Farisei. La quale presente nei libri più antichi del Rabbinato talmudico, presente nella Misna, nei Medrascim, nell’uno e nell’altro Talmud, sparisce poi dalle scritture rabbiniche posteriori, sparisce collo sparire del Dottorato talmudico, e sparisce, lo che più monta, in quel punto istesso in cui sparisce dalla storia la società degli Esseni, e col simultaneo suo sparire giova mirabilmente ed al sistema d’identità da noi propugnato, ed a rispondere trionfalmente allo argomento degli avversarj i quali trar vorrebbero dal silenzio del Rabbinato postalmudico nuovo pretesto a negare l’antichità, l’autenticità cabbalistica.[516] Noi torneremo sull’argomento presente quando il secondo punto toccheremo della loro scomparsa. Noi dobbiamo notare adesso un nuov’assurdo ch’emergerebbe dal rifiuto del nostro sistema. Se gli Esseni e i Terapeuti non sono i medesimi Cabbalisti; se la scuola non si è perpetuata sott’altro nome nella scuola dei Cabbalisti; se i loro libri, le loro opere, i loro scritti, che redato avevano, come dice Filone, dai loro maggiori, che formavano, come attesta egli stesso, oggetto precipuo, amatissimo dei loro studj, non si perpetuarono, non si trasfusero in quelle opere che la scuola serbò gelosamente dei Cabbalisti; se questi libri ai tempi di Filone, ai tempi eziandio di Porfirio, erano in fama grandissima, e oltremodo studiati e venerati presso gli Esseni, in qual guisa spiegare la loro subitanea e completa scomparsa dalla superficie del mondo; in qual guisa libri diffusi, meditati, venerati non lasciarono di sè traccia veruna? Io comprendo che libri preziosi celebratissimi siensi in breve ora perduti, che sieno stati anzi distrutti, o per scarsezza di esemplari svanissero dalla faccia del globo; ma che libri, non solo religiosi, non solo autorevoli, ma libri eziandio incarnati colla esistenza stessa di un istituto vivacissimo, anzi, colla fede, colle dottrine di un popolo tuttavia vivente; che libri i quali esprimono, senza meno, il grado più eccelso del suo intellettuale sviluppo, siensi perduti in modo sì intero, sì assoluto, sì irreparabile, egli è tal fenomeno bizzarrissimo ch’io non riesco a comprendere. Ma se i libri essenici sono quei medesimi che compongono la Biblioteca cabbalistica, o almeno se le idee, se le dottrine che li contessevano, si travasarono sott’altra forma nelle opere e negli scritti dei teosofi; in fine se il nostro sistema non è bugiardo, l’asserzione di Filone non è più contraddetta dai fatti, e il più strano fenomeno che siasi mai dato nella istoria cede il luogo al più normale[517] e verosimile andamento nella seguenza dei fatti.
Ora diremo del secondo punto di contatto che ci offre la Storia tra le due scuole nel momento in cui spariscono dalla scena del mondo; gli uni, i Cabbalisti, dai libri posteriori al Talmud; gli altri, gli Esseni, dagli storici, dai cronisti posteriori a Giuseppe e Filone, ai primi Padri della Chiesa e Porfirio. Io dissi, non ha guari, che meglio che scomparsa, meglio che estinzione, si dovrebbe chiamare questo sottrarsi degli Esseni cabbalisti dalla scena del mondo un’ecclissi temporaria, un ritiramento nelle più segrete latebre dell’Ebraismo, uno ascondimento precario a guisa di quei fiumi che ad un tratto avvallando e sprofondandosi nelle viscere della terra, si aprono una via sotterranea per miglia non poche, onde erompere di nuovo alla superficie del globo e lo antico corso seguire alla luce del sole. Due cose sono da notarsi in questo fatto importante: la causa che lo ha prodotto; lo insegnamento prezioso che ci porge, e i nuovi riscontri in favore della identità da noi sostenuta. Della causa si vorrebbe discorrere con ampiezza maggiore di quella che qui è concessa, tanto parmi rilevante e connessa coi più grandiosi problemi della storia contemporanea. Pure è bene che qui ne abbiate almeno un cenno. E per averlo meno inadeguato che è possibile, mestieri è che vi riduciate a memoria come tre grandi avvenimenti segni la Storia circa all’epoca istessa, vale a dire, nel terzo o quarto secolo dell’èra volgare. Il primo è il trionfo definitivo del Cristianesimo. Il secondo è la formulazione definitiva della tradizione nei libri talmudici. Il terzo è la scomparsa, è l’eclissi di una dottrina che fatto aveva per lo mondo romore stragrande sotto tre forme particolari, ma una sempre, e la stessa nella sostanza; e le tre forme sono l’Essenato, il Cabbalismo e la Filosofia alessandrina rappresentata da Ammonio[518] Sacca, da Platino, da Porfirio, da Samblico e da Proclo. Questo sincronismo, questa contemporaneità dei tre grandissimi eventi, non è a caso. In gran parte, si può dirlo arditamente, i due ultimi fatti, la formulazione della tradizione, e la scomparsa dell’Essenato, del Cabbalismo e dell’Alessandrinismo, essere conseguenza più o meno diretta del primo e momentosissimo fatto, voglio dire il trionfo del Cristianesimo. Il quale dopo avere a lungo lottato coll’Ebraismo da cui tratto avea il nascimento, colla civiltà e colla filosofia alessandrina con cui ebbe più di un tratto di somiglianza, finì col prevalere sulle due forme rivali, sulla forma religiosa trionfando dell’opposizione del Giudaismo, sulla forma civile e filosofica trionfando della opposizione dell’Essenismo. Vinti nel mondo esteriore, spodestati dal Cristianesimo trionfante, Essenismo e Giudaismo, disperando oggimai di lottare e di vincere, pensarono almeno a conservarsi, a custodire pei tempi avvenire il pensiero, l’idea di cui erano depositari. Ambi lo fecero, ma ognuno in quel modo che più tornava acconcio al suo genio, ai suoi destini: l’Essenismo depose la stola di sacerdote e ispirò le lettere, le scienze, la filosofia della società riformata per comparire di nuovo ed invadere, ad èra meglio opportuna, il dominio istesso della religione e del culto. L’Ebraismo, che il trionfo veduto aveva della forma sorella, ma non meno per questo rivale, che appunto per le affinità che tra esse correvano, doveva ragionevolmente temere di essere da quella avvolto, circonfuso, assorbito, che vedeva il mondo confonderli, immedesimarli nella stessa esecrazione o nello stesso rispetto; l’Ebraismo avendo invano combattuto, osteggiato ciò che dal Cristianesimo lo divideva, pensò a difendersi, a premunirsi contro di quello che al Cristianesimo il congiungeva. Se durante le lotte ci furono le discrepanze a temere, ci furono[519] per contro dopo il trionfo le somiglianze. Quell’ombra vana, quel ricordo lontano, quel simulacro di Ebraismo che la Chiesa ostentava, era il pericolo massimo per la esistenza del nome ebraico. Quel centro possente di Pseudo-Ebraismo che si andava formando in Costantinopoli e in Roma, era un’aperta voragine dove precipitate sarebbero il nome e la fede ebraica, dove gli animi ebraici inquieti, perplessi in quell’istante critico di rottura fra le due forme, e non sapendo da qual parte fosse il vero, l’antico Ebraismo avrebbe con facile apostasia disertato gli antichi vessilli. Quindi nei Dottori, nei Padri del popolo, il grande studio di definirsi, quando quello spettacolo grande che somiglia ad un esercito avvolto nelle tenebre per vie nuove e inesplorate, che per riconoscersi, per distinguersi dagli inimici, moltiplica i contrassegni con assise, con motti, con armi diverse; quindi in una parola lo studio, come dissi, di definirsi: definirsi nelle leggi, negli usi, nelle credenze colle più precise e formulate sanzioni dell’opere scritte, e al tempo istesso con concentramento, con ritiramento della vita e del pensiero ebraico nelle più segrete latèbre del popolo nostro. A quel moto di espansione che prodotto aveva i Filoni, gli Aristobuli, i Flavii e le lotte rabbiniche colle sètte contemporanee, sottentrò un moto contrario di ripiegamento sopra se stessi, e per meglio conservarsi, e per meglio serbarsi intatti e possenti per l’avvenire. Ma questo internamento del pensiero ebraico si verificò in quella misura che più si richiedeva, secondo l’importanza e la gelosia delle dottrine. S’egli è sensibile in tutte le parti dello scibile ebraico, egli è sommo e cospicuo per ciò che riguarda la parte più riservata di quelle dottrine, la riposta teologia che si chiama Essenato nella Storia, che ha nome tra i Rabbini di Cabbalismo. Dopo il trionfo del Cristianesimo il silenzio è completo[520] intorno gli Esseni, non meno completo intorno la scuola i cui fasti sono contenuti nel Talmud sotto il nome di Pardes, Sitre tora Maase Mercaba. Se questo è il fatto, e fatto accertato, non meno ovvia riesce la spiegazione dopo le cose discorse. Ambi, Essenato e Cabbalismo, o per dir meglio il Cabbalismo sotto il duplice nome, non appena fatto avevano di sè mostra nel mondo, non appena ne furono alquanto divulgati i misterj, non appena si fe segno di voler deporre i veli opacissimi che il nascondevano, che il romore si levò grande tra gli Ebrei e fuori, che i dogmi ne furono fraintesi, che gli insegnamenti abusati, che le teorie mischiate a teorie sconosciute e straniere, e che dallo strano mescuglio sorse un Pseudo-Essenato, un Pseudo-Cabbalismo che si disse Cristianesimo, e che non fu altro in origine che un Cabbalismo equivocato. Quando la lotta pubblica esteriore finì col trionfo del Cristianesimo, videro i Dottori nostri quali amari frutti raccolto avevano dalla non troppo gelosa custodia dei loro misteri, dalla non troppo gelosa scelta dei loro cultori. Quindi l’antico e vero Cabbalismo si ritira innanzi il più fortunato rivale, quindi un silenzio, un segreto più assoluto, e per cansare ogni contatto col Cristianesimo vittorioso, e per togliere ogni causa di nuovo abuso, di nuovi errori, di nuovi scismi e quindi quell’ecclissarsi instantaneo dal mondo rabbinico del Cabbalismo talmudico, che sarebbe il più difficile e insolubile problema se non avesse la più ovvia e natural spiegazione nei fatti e nei pensieri discorsi.
Ma non solo perdiamo il Cabbalismo di vista col trionfo del Cristianesimo, ma l’Essenato eziandio cessa di comparire sulla scena del mondo, nell’epoca istessa in cui l’altro scompare; grande insegnamento, e che sarebbe già per sè stesso fecondo, ove ancora ogni altra circostanza mancasse che nel tramontare delle due scuole[521] nuovo segno non ci additasse d’identità. Ma questa circostanza esiste, ed esiste troppo eloquente perchè qui non si accenni. È il nome che narra la Storia aver recato gli Esseni sul declinare di loro esistenza, è il nome che unanimi gli assegnano gli ultimi storici della scuola, il nome di abitanti del cielo. Se gli Esseni si dissero abitanti del Cielo, se la Storia fedele registrava questo epiteto, ci pare che abbia voluto fornirci la più bella gemma con cui suggellare possiamo questo monumento di amore, di studio, di ammirazione ch’elevato abbiamo in onore della gran scuola. Non dirò del nome già abbastanza parlante di Angioli, Malahe Asciaret, recato indistintamente dai più dotti dei Farisei, e che veduto abbiamo usato eziandio dal Cristianesimo nascente, quando i suoi vescovi chiamavansi col nome di Angioli. Ma tacere non si deve di una più propria, più speciale, più decisiva appellazione; e più decisiva perchè unica in tutta la Biblioteca talmudica, e sopratutto perchè quell’unica volta è posta in bocca di quello, che se Esseni v’ha tra i Dottori, è l’Esseno per eccellenza, voglio dire R. Simone Ben Johai. Egli è là ove, deplorando lo scarso numero dei seguaci, le fila diradate del Pardes, il declinare sempre più sensibile della scuola, pronunziava la grande, la eloquente parola. Diceva R. Simone Ben Johai: Veggo gli abitanti del cielo in numero scarso. Se dieci sono, io e il figlio mio siamo tra i dieci. Se due sono, io e il figlio mio, siamo quei due. E questo nome di abitanti del cielo l’usa Ben Johai, l’Essena per eccellenza, l’usa allora appunto che vuol accennare alla decadenza della scuola, vale a dire allora appunto quando la Storia accenna averlo assunto lo Essenato, e l’usa nel Talmud, libro non dubbio, non controverso, e che autorevole favella agli amici come agli avversari della verità cabbalistica.
Ah! dopo questo prezioso trovato, possiamo chiudere[522] contenti questa Storia dell’illustre Istituto; possiamo dire addio contenti a quegli spiriti beatissimi; possiamo togliere commiato da costoro che nel dipartirsi ci invitano a salutarli col titolo di abitanti del cielo; possiamo riconoscere in essi, i nostri Dottori più illustri e più santi; e col dolce nome salutarli di Padri e maestri del nostro popolo.
Ed a voi una parola ancora pria di separarci. Se fu bello ed onorevole, se fu soave all’animo mio il vedere i miei esordj incoraggiti con tanta affluenza di uditori; se titolo giusto si acquistarono pur essi alla mia gratitudine, egli è certo che l’onore più grande, che l’affetto più sentito spetta a coloro che perseverarono. Grazie vi sien rese, e grazie sincere. Voi muoveste costanti nella via in cui m’inoltrava; voi porgeste assidui l’orecchio alle mie Lezioni; voi comprendeste quanta importanza si nascondesse per entro a certi studj, che ai frivoli, ai semidotti, agli ameni anco nelle lettere e negli studj, potrebbero sembrare per avventura destituiti di ogni momento; voi toglieste a cuore l’onore di questa città che dopo essersi annunziata al mondo iniziatrice di nuovi studj, imitatrice della seria letteratura germanica, riscuotitrice del sonno che ne gravava le ciglia, sarebbe caduta senza di voi, in onta e in deriso presso l’Ebraismo universale. Imperciocchè, s’ella è vera sentenza per ogni culto, ella è verissima e santissima pel culto ebraico. Il vero Tempio, le vere glorie, le vere bellezze, il vero decoro meglio che nei marmi e nei fregi esteriori, sono nell’uomo interno, nel suo sapere, nella sua cultura, negli studj in cui si adopera, nel Tempio, a tutto dire, dell’animo suo, senza di cui ogni pompa esteriore è vana e ridicola ostentazione di Fede, di Religione bugiarda.
FINE.
NOTE:
[1] Sicarj si chiamavano i terroristi ebrei che volevano spinger la resistenza alla signoria straniera sino all’estremo e con tutti i mezzi. I Vangeli, se non erro, vi alludono.
[2] Udremo fra non molto Plinio, qualificare gli Esseni col nome di gente che non muore mai, e tra cui niuno nasce.
[3] A quai paesi corrisponde la nordica regione del Caucaso? Se io non vado errato, ai paesi anticamente conosciuti sotto i nomi di Frigia e Bitinia. E questi paesi che nomi recano nella Santa Scrittura? Null’altro, dice il Bochart, e dopo di esso autori parecchi, che quello di Aschenaz. E per quanto Askenaz suoni diverso nella lingua ultima dei Rabbini, e nel valore che l’uso da lungo tempo gli annette, quello cioè di Germania; nonostante, ai Dottori, organi veri, legittimi di tradizione, non mai avvenne usare per Germania Askenaz. Che dico? Sono essi per contro che il suggello appongono alla Interpretrazione del Bochart, e tutto il peso vi aggiungono del numero e della tradizione. Abbiamo detto, non è molto, il Parafrasta di Gerusalemme tradurre Aschenaz per Asia: ora non è egli solo che all’uopo ci ajuti. Egli è il Rabba, che l’Askenaz della Scrittura ci presenta in Asia. Egli è altresì il Talmud di Gerusalemme, che Asia egualmente sostituisce ad Askenaz. Non basta: ma, cosa più sorprendente, vi ha un nome d’un popolo tra i figli di Jafet e tra i popoli Giapetidi, che il nome reca di Tubal. Ora, o signori, che cosa è Tubal? Bitinia, vi risponde aperto il Talmud Jerosolimitano; Essenia, vi risponde aperto egualmente il Medras. Duplice asserzione che a vicenda si rischiara, che a vicenda s’illustra, che ci rimena col pensiero alla Bitinia, che, secondo Tolomeo, il Klaproth e il Dubois, fu specialmente contrassegnata col nome di Asia. Egli è, insomma, quel cumulo maggiore di prove che sia lecito desiderare onde mettere in sodo la esistenza di una particolare regione denominata Asia, e per giustificare il Talmud.
[4] Si dice, è vero, Scuola eleatica, cirenaica ed itala; ma non si dice, od appena, eleati, cirenaici ed itali.
[5] Vi sono alcuni testi rabbinici antichi, che farebbero credere essere stati piuttosto i discepoli di Zadoc e Baitos, ch’eglino medesimi, i fondatori delle sètte di questo nome. Ma posto ciò eziandio, riman ferma la esistenza storica di Baitos, e la derivazione da esso del nome della setta. Quanto ai Sadducei, setta a questa collaterale, la critica moderna si è permessa da poco in qua un congetturare senza limiti e senza freno. Lo spirito caraitico e antitradizionale che informa alcuni distinti suoi corifei, fece trovare nel nome di Sadducei un senso eminentemente encomiastico, facendolo derivare da Zaddik, giusto. Altri fece risalire i Sadducei a Zadok, antico sacerdote a’ tempi di Salomone, e vide per conseguenza in essi un partito sacerdotale. Il Sig. Renan, nella recente sua opera Vie de Jesus, fece altrettanto rispetto al Baitusei, che volle derivati da un Böethus pontefice di questo nome. Sarebbero, dunque, e Sadducei e Baitusei della famiglia sacerdotale. Qualunque sia il fondamento di questa congettura, egli è certo che il sacerdozio costituiva ai tempi di G. C. un partito ostile ai Farisei, tanto per le tendenze politiche, quanto per le dottrine religiose. E di ciò abbiamo autorevoli documenti nel Talmud, nè il sig. Renan ne dissente minimamente. Solo ci pare ch’ei non tragga tutte le conseguenze che da questo fatto derivano, nella discussione dei grandi problemi ch’ei si è proposto. Ma qui non è luogo a parlarne.
[6] Il nome talmudico Baitos è identico al Bœthus pagano. Vi fu un Bœthus stoico, contro cui scrisse Porfirio un Trattato sull’Anima. V. Enneades de Plotin, trad. par Bouillet: Paris. Vol. II, p. 68.
[7] Il Talmud è pieno di allusioni alla setta dei Baitusei; e quanto di essa si legge, delle dottrine e costumanze, nulla offre di analogo a quanto sappiamo d’altronde di certa scienza intorno la società degli Esseni.
[8] L’illustre sig. Frank, autore della Kabbale, notò a buon diritto come nella identificazione suprema dell’Essere e del Pensiero precorresse la Teologia ebraica alle ultime dottrine prevalse in Germania. Ciò che ci reca ad una più alta antichità, che ne fa risalire alle Bibliche sorgenti, e che perciò stesso rivela nelle viscere dell’idioma biblico l’arcana dottrina teosofica che per entro vi circola, è questa sinonimia profonda di Essere e Pensiero nella radice Ies, onde qui si discorre. In un ordine poco diverso d’idee abbiamo, nel verbo Iadah, conoscere, un’altra non meno ammirabile sinonimia di Conoscenza e Amore. Noi renunciamo a citare il nome di Benedetto Spinosa, e ciò che nella sua Etica pertratta. È noto come i due attributi della Sostanza sieno per esso il pensiero e la estensione; e ciò che vi ha di acroamatismo ebraico nelle dottrine di Spinosa, ciò che costituisce la sua deviazione dall’acroamatismo ortodosso, ci studiammo di porre in luce in un articolo in idioma francese dettato, nel quale prendemmo a rilevare alcune mende nelle quali ci sembrò incorrere l’illustre sig. Emilio Saisset, nell’egregio suo lavoro pubblicato dalla Revue de deux Mondes intorno a Maïmonide et Spinosa.
[9] Solo nel secolo scorso, e tra gli Enciclopedisti sarebbe suonata una eresia filologica l’additare nell’Ebraico l’origine di un vocabolo greco. Erano costoro così lungi dall’immaginarne perfino la possibilità, che tra le più speciose obbiezioni che mossero contro la originalità e santità delle sacre scritture, sì fu il nome di Giove pagano, che dissero origine e modello del nome ineffabile del Dio d’Israel, senza riflettere che gli Ebrei avrebbero dovuto andare a cercare il tipo immaginario non già in Grecia ove Giove ebbe nome Zeus, ma in Roma, anzi in Etruria, sin dove lo raggiungono gli studj moderni. Per essi, il Sole delle origini non sorgeva più dall’oriente; e bene stava cotesto ragionare in bocca di chi cantò per Caterina Seconda:—
C’est du nord qu’aujourd’hui nous vient la lumière.
I progressi della scienza hanno ricollocato nell’oriente la sorgente della luce morale, siccome non cessò mai di essere il fonte della luce che ci rischiara; e basta aprire un lessico moderno per comprendere ad un solo sguardo qual parte segnalatissima sostenga l’idioma ebraico, e in generale sostengono le lingue semitiche, nella formazione delle lingue occidentali; comecchè si collochino nella famiglia delle indo-germaniche, e se ne cerchi la prima derivazione o almeno la forma loro più antica, nella lingua sanscrita.
[10] Quanto volentieri rendiamo omaggio alla non infelice interpretazione del nome Esseni dal greco Isos amici, confidenti; altrettanto ci ripugna il credere, come vorrebbe persuadercene l’illustre Rabbino, che lo stesso vocabolo greco abbia derivazione ebraica, e tragga origine dall’incertissimo Hoze o Hazut d’Isaia, XXVIII, 15, 18, spiegato nel senso greco di Amicizia e Confidenza. Basti dire che l’esempio ebraico è unico in tutta la Bibbia in questo senso, mentre appena un uso frequente, quasi universale, basterebbe ad autorizzare il supposto di un passaggio dall’ebraico al greco; che questo senso stesso è almeno problematico, stando il Gesenius per altro, il quale non tollera questa assimilazione coll’Isos greco; e che infine meglio che la interpretazione dell’uno o dell’altro a noi arriderebbe l’ipotesi che qui non si tratta, nel Hoze o Hazut d’Isaia, che di un sinonimo assai più antico, più nobile e più puro del Galui di Geremia, Cap. XXXII, 11, che vale probabilmente quanto attestato, o almeno documento pubblico che accerti la esistenza di un contratto: e vale alla lettera, Scuoperto o Aperto, come Hoze o Hazut suona pure alla lettera, quello per cui si vede, o veduta. Ove non si voglia dire piuttosto che il patto per eccellenza, l’alleanza con Dio, essendo sancita per opera di una rivelazione, questa viene usata come sinonimo di patto nella parola Hoze o Hazut, per indicare l’alleanza col genio della Morte o dell’Inferno. Inoltre, parci l’illustre Rapoport caduto in una strana illusione quando trova affine al Hoze d’Isaia, l’arabo Haz, stringere patto, unirsi; mentre è evidente che questo verbo arabo non ha rapporto che coll’ahaz ebraico e coll’ahad arameo, stringere, unire.
[11] Esodo, cap. XV, v. 26.
[12] Proverbi, cap. III, v. 8.
[13] Vi fu tra i Dottori chi intese in questo senso la signoria predetta dal Genesi all’uomo sopra le altre creature. Non si può negare che la frase nulla scapita, così intesa, della sua sublimità.
[14] Salmo XXXXI, v. 5.
[15] Isaia, VI, v. 10.
[16] Isaia, LVII, v. 18.
[17] Geremia, VIII, v. 22.
[18] Opera infinita e certo non capace di stringersi in una nota noi faremmo, ove volessimo tutte riandare le analogie che la predicazione evangelica, il primitivo cristianesimo, ci offrono colla società degli Esseni. Forse ne sarà dato accennarne alcune, e solo di volo nel seguito di questa istoria. Ciò che possiamo sino da ora additare al lettore istruito, sono le numerose figure, imagini, locuzioni tratte dall’esercizio della medicina che ricorrono in bocca al Fondatore del Cristianesimo, le cure ch’egli prodiga agli infermi, la Salute onde s’intitola la nuova dottrina; indizj tra altri infiniti, che persuasero gravissimi autori antichi e moderni a vedere nell’Essenato la prima origine d’onde uscì il Cristianesimo evangelico. Nello scorso secolo, Bahrdtt e Venturini furono i più eminenti rappresentanti di questo sistema; e gli studj susseguenti nulla valsero a renderlo meno probabile.
[19] Amici solo del vero, e rinunziando alla spuria gloria di aver ammaestrato Platone e Pitagora che alcuni Padri sognarono in favore dell’Ebraismo, ci acquistiamo il diritto di ripudiare egualmente una non meno falsa sentenza; cioè che l’Oriente semitico sia andato a scuola dei Greci, dei Romani, e anche degli Etruschi e antichi Italiani. Sistema dismesso dopo i tentativi invano assaggiati dal Biscioni, dal Mazzoldi, in favore delle origini italiche; ma che il sig. Gherardi tentò d’inverdire in un’opera recente, che ha, se non altro, il merito dell’eleganza e della erudizione. Ci duole aggiungere che non ne ha altri, e che vi manca quella nota impreteribile in ogni storica pertrattazione non solo, ma anche di un buon romanzo, la verosimiglianza. L’ebraismo ha una gloria più legittima e non men bella da vantare; quella di aver ammaestrato per mezzo della primitiva rivelazione i maestri stessi di Pitagora e di Platone, i legislatori, i Tesmofori e i poeti-teologi di Grecia e d’Italia: e questa e la Grecia a loro posta hanno titoli più legittimi che non il primato sull’oriente semitico; quello di avere sviluppato quei germi che l’Oriente vi dispose, in guisa che invano sariasi desiderato da popoli diversamente temprati, conciossiachè, nella guisa stessa che non ogni terreno è capace di fare allignare ogni sorta di pianta, così non ogni popolo è capace di fare fruttificare certi principj. I Dottori nostri, colla teoria loro dei Sarim o genj de’ popoli tutti necessarii e che nel loro insieme costituiscono la vera e completa Mercabà, cioè il carro che Dio stesso conduce e guida, gittarono le basi della più alta filosofia della storia che capir possa in mente mortale.
[20] Il dotto signor Munk è sventuratamente afflitto da quasi completa cecità.
[21] I fatti dall’illustre sig. Frank allegati, se provano improbabilissima un’influenza decisiva tra le due capitali e le due civiltà, non bastano però ad escludere ogni qualsiasi ascendente. Questo anzi è provato da quelle non scarse nozioni che di Alessandria e del suo ebraismo tralucono negli scritti dei dottori, e da quelle comunicazioni che la mercè dei viaggi intrapresi da varj cospicui dottori, non cessarono di rinnovarsi di tratto in tratto tra i due paesi. Il Talmud è ricco di notizie intorno all’organamento dell’ebraismo nella capitale dei Tolomei. Si rende ragione dei tribunali ebraici di Alessandria (Talmud Ketubot 25, 1), si magnifica la ricchezza delle sue Basiliche e delle Cattedre su cui siedevano pro-tribunali settanta dei più cospicui fra i cittadini; si descrive la magnificenza e le forme del culto, sino ai più minuti particolari della costruzione di quel tempio (Talmud Succa Babilonico e Gerosolomitano). Si mostra contezza delle loro arti (Moed Katan 26), degli abusi, delle prepotenze che si usavano sulle fidanzate altrui (Mezihà 104, 1), dei loro costumi dissoluti (Medras Ester in principio), della loro propensione alla magia (Ibidem e Kidduscin 49, 2). Ma ciò che più monta, sono i viaggi che si narrano dal Talmud colà intrapresi in varie epoche dai dottori Palestinesi. Non parleremo di Onia, che sugli esordj del secondo tempio, si recò dalla Palestina in Egitto, e vi fondò quel tempio che ne porta il nome. Si disputa nel Talmud se il tempio elevato da Onia in Egitto fu tempio dedicato al culto del vero Dio, o a un culto idolatrico. La prima opinione sembra prevalere. Ciò che importa non meno sapere, è una curiosa aggiunta che il Maimonide si permette fare nella storia del soggiorno di quest’Onia in Egitto, della quale, a quanto io mi sappia, non vi ha memoria negli antichi monumenti rabbinici. Il Maimonide, nel suo comento alla Miscnà (Trattato Menahot), ragionando di Onia, ne fa sapere che trovato avendo costui in Egitto una setta per nome Kabtazar, con essa si accontò o per dir meglio si fece suo capo. Kabtazar è invero il nome che si legge almeno nel comento stesso voltato dall’arabo all’ebraico. Però era naturale in me il dubbio che qualche altro nome ben altramente storico, sotto queste mentite sembianze si nascondesse. Infatti, la idea mi occorse che per questo nome guasto e corrotto di Kabtazar, si volesse significare per avventura i Copti; e per quanto la congettura mi sembrasse non infelice, pure non mi attentai a soscrivervi seriamente se prima non ebbi e l’attestato di antico documento e l’adesione di uomo competentissimo. Questo è l’illustre amico mio sig. Salomone Munk, socio dell’accademia delle Iscrizioni e belle lettere di Parigi, al quale m’indirizzai in cerca di notizie; e che con isquisita benevolenza risposemi nei termini seguenti: «Quant au mot Kabtazar, sur le quel vous me faites l’honneur de m’interroger, c’est tout simplement une faute d’impression, ou une faute de copiste dans la version hébraïque de commentaire de Maïmonide. La véritable leçon est Kobt Masr, et comme vous l’avez bien deviné dans un premier moment il s’agit ici des Coptes anciens ou des Egyptiens indigènes, par opposition aux Grecs qui depuis Alexandre s’étaient établis en grand nombre en Egypte. Maïmonide veut dire qu’Onia gagna un grand nombre d’Egyptiens indigènes, qu’il convertit au Judaisme. (È questo fatto principalmente che Maimonide introduce nella istoria, senza che si possa scuoprire d’onde derivato). Les mots Kobt Masr, sont généralement employés par les auteurs arabes pour désigner les anciens Egyptiens sous les Pharaons ou leurs déscendants à l’époque des Grecs et celle des Arabes. Encore aujourd’hui on appelle ainsi les chrétiens d’Egypte que nous designons ordinairement par le nom de coptes, et que descendent d’une race mêlée d’anciens Egyptiens et de Grecs. (Qui il dotto sig. Munk trascrive il testo arabo, e aggiunge.) J’ai fait copier ces mots arabes d’un manuscrit de la Bibliotheque imperiale que j’ai apporté moi même d’Egypte en 1810.» Senza più oltre aggiungere di Onia, è celebre il viaggio di Jeosciuah Ben Perahia, quegli stesso che a detto del Talmud fu precettore di Gesù, il quale insieme al maestro si sarebbe recato pur esso in Alessandria. Il Talmud ci conservò la Epistola che da Gerusalemme fu spedita alla Sinagoga d’Egitto per affrettare il ritorno del prenominato dottore. Ella è così concepita: Da me, Gerusalemme città santa, a te Alessandria. Lo Sposo mio dimora presso di te, ed io me ne sto in solitudine. Il dotto sig. rabbino Rapoport, nel suo Erech Millin altra volta citato (pag. 101), pare volere confermare questo viaggio di Gesù in Egitto con quanto narrano i Vangeli della fuga in quel paese. È noto però come questa avvenisse nella più tenera infanzia del fondatore del Cristianesimo; mentre il viaggio onde si narra nel Talmud sarebbe stato eseguito nella sua gioventù, anzi poco prima della sua rottura colla Sinagoga. Tuttavia non è a tacersi che di questo viaggio eseguito da Gesù nella età virile, narravano i Carpocraziani, antichissimi eretici, quando dicevano: «Que J. C. avait choisi dans ses 12 disciples, quelque fidèles amis, auxquels il avait confié toutes les connaissances qu’il avait acquises dans le Temple d’Isis, ou il etait resté près de treize ans a s’exercer à une étude pratique, dont on lui avait donnée la théorie pendant son enfance instruite et formée par les Prètres egyptiens.» (La Maçonnerie considerée comme le resultat de la Relig. egypt. juive et chrét., par R. D. S.; vol. I, pag. 289). Ciò pone almeno in salvo la buona fede dei Talmudisti, e l’antichità della tradizione di cui si fecero interpreti. Ella è attestata da un documento non meno antico, l’Evangelo di Nicodemo. In questo, tra le altre cose, gli Ebrei accusano Gesù che «arrivé à certain âge fut contraint de chercher fortune en Egypte, ou il apprit quelque secret; qu’il retourna dans son pays en Judée, et que par ce moyen il fit de la magie» (Ibid. vol. I, pag. 445). Il Talmud Gerosolimitano racconta di un altro viaggio posteriore, che Jehouda Ben Tabai ed un suo discepolo intrapresero nell’Egitto. Simone Ben Sciattah, capo dei Farisei, fuggì in Egitto per torsi alla persecuzione del cognato suo, il Re Janneo, amico dei Sadducei. Quindi R. Jeosciuah Ben Hanania, soprannominato lo Scolastico, visitò pur esso l’Egitto; e il Talmud racconta dei colloqui avvenuti colà tra il dottore Palestinese e gli Ebrei ivi stabiliti. Un altro dei più illustri Tanaiti, R. Johanan Asandellar, era di Alessandria (Talmud Gerosolomitano, Haghiga cap. III). Più tardi, troviamo domande in fatto di riti, dirette da Alessandria ai dottori di Palestina (Talmud Gerosolomitano, Kidduscin cap. III), e circolari da questi alle Sinagoghe di Alessandria (Talmud, Irrubin cap. III). R. Abhu, familiare nella Corte di Cesare, vi si recò esso pure e v’introdusse l’uso delle Palme nel primo giorno dei Tabernacoli caduto in Sabato (Ibidem). Tutti questi viaggi, dei quali il più antico è appena contemporaneo a Filone, non possono avere esercitato un’influenza decisiva nè sopra la di lui filosofia, nè sulla istituzione dei Terapeuti, che Filone descrive come da lungo tempo ivi stanziati e stretti in consorteria; e la ignoranza almeno parziale di quanto accadeva in Palestina, è prova in Filone di non aver subìto se non indirettamente l’ascendente palestinese. Forse anche meno probabile è l’altra ipotesi di un’azione qualunque esercitata dalle dottrine alessandrine sulle idee in Palestina, e quindi nella formazione della dottrina cabbalistica e dell’Essenato. Chi rifletta alle rare occasioni di contatto tra i pensatori delle due sinagoghe; all’autorità e preminenza che dovevano avere necessariamente i dottori di Palestina sulle sinagoghe straniere; alle antichissime menzioni che vengono fatte di una scienza acroamatica nei libri talmudici, rappresentandola come già esistente fin dai tempi d’Illel; soprattutto alle antichissime tracce dell’Essenato non solo in Giuseppe Flavio e in Plinio, ma, ciò che più monta, in Filone e forse anco nei Maccabei; agevolmente andrà convinto, che se molte strettissime attinenze, se molte somiglianze parlantissime si rinvengono tra Filone e i Cabbalisti da una parte, e tra Terapeuti ed Esseni dall’altra, si debbono fare risalire a quell’epoca più antica in cui gli Ebrei si staccarono dal centro palestinese per andare ad abitare le sponde del Nilo, ove recarono seco, insieme al Testo della Legge, i germi di quelle tradizioni, che subirono poi sì ricca e rigogliosa vegetazione sul patrio suolo di Palestina.
[22] La identità suprema di Esseni e Farisei che la storia presente contribuirà spero in parte a mettere in sodo, e che antichi e moderni autori di buon grado consentirono, non ne toglie di considerare la prima di queste scuole siccome quella parte che per le sue dottrine e le sue tendenze, diede più particolarmente origine alle istituzioni e ai dogmi cristiani; ed anche di questo sembra che la critica indipendente vada sempre più convincendosi. Questa prerogativa degli Esseni-Kabbalisti di aver generato il Cristianesimo da ma diffusamente trattata nel mio Essai sur l’origine des dogmes et de la morale du Christianisme ci porge una naturalissima spiegazione di questi due fatti accennati nel testo; il primo è il nome di Terapeuti preso dai primi Cristiani, il secondo molto più momentoso è il silenzio degli Evangeli intorno la Società degli Esseni, silenzio non altrimenti esplicabile. Ma agevole torna il comprenderlo purchè si ammetta ad un lato che gli Esseni non erano che la parte più eletta, la frazione speculativa del Farisato, e che era quella da cui meno dessentiva la nuova dottrina. Non è nemmeno improbabile che i Dottori della Legge di cui si parla ripetutamente nei Vangeli siano la indicazione di questa parte del Farisato. Nel Saggio sopra rammentato mi sono ingegnato di porgere di questa congettura non pochi nè lievi indizi, tratti dai Vangeli e dai libri rabbinici.
[23] Opera infinita, certo non capace di stringersi in una nota noi faremmo, ove noi volessimo tutte riandare le analogie che la Predicazione evangelica e il primitivo cristianesimo ci offrono colla società degli Esseni. Forse ne sarà dato accennarne alcune, e solo di volo nel seguito di questa istoria. Ciò che possiamo sino da ora additare al lettore istruito, sono le numerose figure, immagini, locuzioni, tratte dall’esercizio della Medicina, che ricorrono in bocca al Fondatore del Cristianesimo; le cure che egli prodiga agli infermi, la Salute onde s’intitola la nuova dottrina, indizj tra altri infiniti che persuasero gravissimi autori antichi e moderni a vedere nello Essenato la prima origine d’onde uscì il Cristianesimo Evangelico. Nello scorso secolo Bahrdt e Venturini furono i più eminenti rappresentanti di questo sistema, e gli studi susseguenti nulla valsero a renderlo meno probabile.
[24] Questo fatto, segnatamente per ciò che s’attiene a Filone, torna tanto più ammirabile quanto più erano tempi i suoi di gravi dissidenze religiose in Palestina. L’essersi serbato puro il nostro Filone di ogni labe eretica, non è ella nobilissima testimonianza dell’antichità e verità dell’ortodossia farisaica che Filone redò dai suoi maggiori trasportata in tempi più antichi in Egitto? Quanto al fatto stesso, vale a dire l’ortodossia di Filone, ci sembra indisputabile. Può trovarsi qua e colà nelle sue opere alcune, vuoi dottrine o interpretazioni che dissentono dalle dottrine e chiose prevalenti tra i Farisei; ma in primo non si può negare che il Farisaismo stesso era a quei tempi scisso in cento diverse frazioni le quali, tenendosi fra loro in bilico creavano in seno all’uniformità generale una varietà così pronunziata nei particolari, che avrebbe oggi faccia di paradosso e di eresia. In secondo luogo non è lecito pretermettere che Filone vivendo lontano, e ciò ch’è più, sequestrato dal centro religioso di Palestina, non poteva a meno di offrirci nelle opere sue qualche dissonanza colle idee colà dominanti. Nè faremo caso di altre cagioni non meno urgenti che produssero questo cotal disaccordo; la traduzione greca dei sacri libri diversa in gran parte dal Testo ebraico e sola conosciuta da Filone, lo scopo da esso propostosi nel dettare le opere sue, quello cioè da far conoscere le dottrine e la storia ebraica ai Pagani e che ispiravagli tal volta un linguaggio più acconcio a persuadere i suoi lettori pagani, che fedele alle vetuste dottrine degli avi suoi. Nonostante è innegabile che il genio, la sostanza, le tendenze di Filone e delle sue opere sono a dirittura farisaiche. Opera immensa sarebbe il raffronto tra le dottrine dell’uno e quelle degli altri. Momentosissima poi quella che si assumesse l’officio di trovare nelle costui dottrine i principali lineamenti, e non poche volte le formule istesse della teologia farisaica, o acroamatismo (Cabbalà) impresa che il signor Frank tentò in parte nella sua Kabbale, éd. de Paris. Basterà qui che noi facciamo un breve assaggio delle strettissime attinenze che corrono fra Filone, e i Farisei o la tradizione in generale e ciò in una delle meno illustri delle opere filoniane la vita di Moisè che noi preferiamo, trovandosi più agevolmente in mano ad ognuno per le recenti edizioni che ne vennero fatte. Ora noi mostreremo in brevissime note ciò che di singolarmente somigliante si trova in quest’opera tra le nozioni storiche, i giudicj, le dottrine eziandio di Filone, e quelle che suonarono famose tra i Farisei e che solo i loro libri, posteriori di gran lunga a Filone, ci attestano; prova se altra fu mai che la loro data risale molto più alto dei libri che le contengono, e che la lealtà dottrinale e religiosa dei Farisei repugna al supposto di una invenzione e alterazione per parte loro.—Divideremo i nostri rilievi in due parti—prima tutti quelli che si riferiscono a storia—poi quelli che si attengono a dottrine.
A pag. 3. Dice di Moisè «Allora nato questo bambino pareva che dallo aspetto promettesse non so che più dell’ordinario.» Non si dee tacere che idee conformi si leggono nei monumenti tradizionali sul testo che dice E vide, (la madre) ch’egli era bello. Ora si dice, che nacque circonciso; ora che al suo nascere un gran splendore invase la stanza; ora che fu veduta con esso la Schehina. Tob che qui significa probabilmente bello, ha pure il senso di buono, e buono è nome che Dio ha nella teologia riposta dei Farisei, come il Primo e l’uno di Plotino corrispondente al Padre del Cristianesimo, e alla Sapienza o Sofia dei Teosofi ebrei (Kabbalisti) ha esso non meno il nome di Buono (Agathos).
A pag. 18 «Dopo le quali nozze egli incominciò ad essere pastore preparandosi in cotal guisa al principato, perciocchè l’arte pastorale ci dispone al regno, cioè al regime di uomini, greggia mansuetissima; siccome quelli che hanno i loro animi inchinati alle cose della guerra prima si esercitano nella cacciagione.... onde il Pastore ha certa somiglianza col Re. Anzi, per quanto io ne sento, non seguendo la comune opinione ma ricercando la verità, e rida chi vuole, solo colui può essere perfetto Re che ottimamente sa quello che si richiede a governare un gregge. Ora chi non resterà sorpreso leggendo nel Scemot Rabbà le parole seguenti. Come fu provato Moisè? Nell’arte sua di Pastore. Così pure fu provato David e fu trovato egregio pastore conciossiachè egli traesse addietro i più forti tra il gregge per dar luogo a’ più deboli di cibarsi; mandava pure innanzi al pascolo le più tenere pecorelle perchè trovassero l’erba più delicata; quindi le vecchie a pascere l’erba mezzana, infine le giovani e forti a cibarsi della parte più dura. Ciò vedendo disse Iddio; questi che sì bene sa appropriare ad ogni età e temperamento il suo cibo sarà pastore del mio popolo. Così Mosè non fu altramente esperimentato. Dissero i nostri maestri: mentre stava Mosè pascolando la gregge di Ietro per i campi, fuggigli un agnello, ed avendolo rincorso lo trovò mentre si dessetava in un laghetto d’acqua. Disse allora Moisè: Non sapeva che tu corressi per la sete che ti molestava. Sei tu stanco? e così detto, lo prese, e messoselo sulle spalle se ne ritornava. Lo che veduto Dio, disse: Poichè tanto hai di pietà nel governo del gregge degli uomini, tu sarai pastore del mio popolo Israel.» e più oltre, «Dio non concede agli uomini grandezze se prima non sono provati nell’infime cose. Così due grandi uomini furono in vili offici esperimentati, e trovati fedeli, salirono a’ più magnifici stati. Fu David esperimentato nella pastorizia, e vedendo come ad ogni poter suo evitasse i colti onde di rapina non si cibassero le sue pecore, fu fatto pastore di popoli. Moisè pur esso, dice il Testo, pascolava le gregge dietro il deserto perchè le pecore sue non vivessero sugli altrui campi; quindi fu chiamato a pascere Israel, essendo scritto: Tu guidasti qual gregge il tuo popolo per mezzo di Mosè e Aaron.» I fenomeni portentosi che accompagnarono il nascimento di Mosè possono essere suggeriti dal desio comune di dare una tinta maravigliosa all’origine di uomini comunemente venerati. Ma il presente raffronto ci sembra ancor più significante.
A pag. 41. Era l’acqua del fiume mutata in sangue, ma non agli Ebrei perciocchè attingendovi questi, diventava buona da bere. Quest’ultima circostanza taciuta dal Testo si trova solo nella Tradizione.
A pag. 78. Perciocchè allora più mostrava di veder la bestia che l’uomo, il quale si dava vanto di vedere non pure le cose mondane, ma esso rettore e creatore dell’universo. Al vanto dl Balamo che si dice conoscitore della Mente di Dio (Veiodea daat Elion) i Dottori domandano or come conosce la Mente di Dio colui che nè anco sa cosa voglia la sua giumenta?
A pag. 108. Quivi (I Dottori interpetri della legge per ordine di Filadelfo) rapiti dallo spirito, profetavano non diversamente, ma tutte colle medesime parole non altrimenti che se alcuno avesse dettato a ciascheduno invisibilmente. Il Talmud parecchi secoli dopo Filone, e ignaro certamente dell’attestato di questi, ripete le stesse cose. Non è prova il deposto di Filone della preesistenza delle medesime tradizioni ai Dottori talmudici e non pone suggello alla loro veracità? Questa esattezza nel riferire le tradizioni storiche ci è arra della dote medesima nel riferire le tradizioni dottrinali. Ognuno comprende come la verità del fatto sia considerazione estranea alle conclusioni che qui si traggono, perocchè la lealtà farisaica rimarrà dimostrata ogni qualvolta le loro narrazioni si palesino concordate dai più valenti scrittori, non pochi secoli vissuti innanzi a loro.
A pag. 119. Di tale affetto di conversar con donna erasi spogliato Mosè già molto innanzi, quasi infin da quel tempo che incominciò a ricevere lo Spirito Divino, per esser sempre apparecchiato ad ascoltare gli oracoli della voce divina. Circostanza taciuta assolutamente nel Testo mosaico, nè vi ha frase che l’autorizzi. I soli a parlarne, a giovarsene eziandio per ispiegare non pochi passi del Pentateuco sono i Dottori. Donde tolse Filone questa circostanza? Io non so imaginare altra fonte che quella d’una tradizione nazionale anteriore alla emigrazione degli Ebrei in Egitto. Avesse anco attinto Filone nel centro Palestinese, rimarrebbe tuttavia verissimo che i Dottori talmudici nulla dissero che non corresse per le bocche ad ognuno, parecchi secoli innanzi; e che non pochi dettati i quali sembrano appartenere al patrimonio letterario dell’epoca loro, hanno radici in un’antichità che non eravamo usi sospettare. Alla pagina istessa Mosè è dichiarato, bello e forte di corpo. Ed anco di questo, solo la tradizione è maestra che appunto in Mosè trova il prototipo di tutti i Profeti siccome quello che era forte ricco e sapiente.
A pag. 120. In quei giorni ch’egli (Moisè) nel monte dimorò, imparava tutti i misteri del Sacerdozio. E questo è purissimo farisaismo, che vuole la Legge e i misteri della Legge imparati da Moisè nei giorni ch’ei stette sul monte.
A pag. 137. Esse dunque (le Donne) avevano dedicati a Dio spontaneamente gli specchi avanti i quali erano avvezze ad abbellire la faccia come primizie dell’onestà del matrimonio. Che dal Testo apparisca essere veramente specchi cotesti, e dalle donne offerti, può darsi, ma l’intenzione e il pregio di tale offerta quali si descrivono qui da Filone, non si leggono che nei Dottori i quali vi veggono come Filone il simbolo e lo Stromento dell’amor coniugale onde tanto crebbe il popolo di Dio in Egitto.
A pag. 161. Insegnando (nel sabato) il principe (Moisè) a guisa di Dottore ammaestrando e dimostrando a ciascuno l’officio suo il quale uso dura anche al dì d’oggi presso i Giudei. Nessun vestigio nella Bibbia di questa pratica; sibbene nella tradizione la quale fa risalire a Mosè la istituzione di cui si tratta e l’insegnamento al popolo nei Sabati e nelle Feste dei Riti odierni.
A pag. 162. Stando Moisè sospeso nè sapendo con qual maniera di morte che a lui si convenisse, dovesse punirlo. Il Testo dice semplicemente che non sapeva qual pena dovesse infliggergli. Ella è solo la tradizione che ponendo in Mosè la certezza della pena di morte, gli fa sol dubitare in qual maniera dovesse essere eseguita. Le parole di Filone consuonano quindi perfettamente colla tradizione, meglio assai che col Testo il quale tollera che si supponga in Mosè il dubbio piuttosto, se fosse o no reo di morte. Ma la mèsse che noi andiamo a raccogliere del raffronto fra dottrine e dottrine è di gran lunga maggiore e più importante.
A pag. 3. Filone fa notare come Mosè fu il settimo per ordine dal primo il quale venuto da straniere contrade diede principio al popolo ebraico. Qui tutto è farisaico 1º L’importanza conceduta ai Numeri. 2º La Santità del numero Sette. 3º L’osservazione medesima per ciò che riguarda Mosè è non meno esplicita nei Dottori, i quali adducono qual prova della stima in cui questo numero è tenuto, la elezione di Mosè settimo nella serie dei Patriarchi.
A pag. 20. Filone trova nella visione del pruno che arde senza consumarsi un senso allegorico «il fuoco che non consumava la materia, dimostrava che coloro non dovevano morire i quali dalla violenza dei nemici erano calcati.» Questa interpetrazione è proposta e autorizzata dai Dottori.
A pag. 22. Dirai primieramente loro, che Io sono colui che è, acciocchè imparino la differenza tra colui che è, e quello che non è; nè verun nome potersi convenevolmente dire di me del quale solo è l’Essere. E se egli avvenisse che per essere essi d’ingegno tardo, volessero sapere come io mi chiamo, mostra loro non solamente me esser Dio, ma Dio ancora di tre personaggi ec. Qui si noti:
1º Filone dà perfettamente ragione alla più antica sentenza che vide nei due nomi più augusti di Dio—Ehie—Avajà—il concetto dell’Essere; e vince colla sua luce il falso bagliore di interpretazioni quali sono quelle proposte dal Prof. Luzzatto vuote di ogni merito, tranne quello, di essere da lui derivate.
2º L’Essere, qual nome di Dio e superiore a quello stesso quadrilettere, consuona mirabilmente con quanto insegnano i Teosofi ebrei (Kabbalisti) i quali veggono nell’Ehie o Essere, la denominazione di una Sefirà o Emanazione superiore a quella che reca il secondo di questi nomi.
3º Tanto conferma Filone aggiungendo che ove per ingegno tardo volessero saper come Io mi chiamo mostra ec., dove si allude manifestamente al quadrilettere usato dal Testo in quella circostanza e chiamato Dio d’Abramo ec.
A pag. 28. Dieci afflizioni caddero sopra il paese, acciocchè quelli che avevano commesso ogni scelleraggine con perfetto numero di flagelli fossero battuti. Qui non solamente torna in campo il valore dei numeri, non solo il numero dieci è il prediletto dai Dottori e dalla Bibbia eziandio, ma ciò ch’è più, la teosofia recondita degli Ebrei trova nei dieci flagelli d’Egitto, l’espressione, la imagine delle dieci emanazioni impure, specie di Antischemi ch’essi oppongono alle divine emanazioni.
A pag. 29. Cotali (flagelli) però in tre ordini furono divisi. Ogni Israelita legge nei vespri pasquali l’antica sentenza di R. Iehuda che divide i dieci flagelli in tre serie, Dezah, Adas, Beahab. Questa gratuita partizione diventa così, più vecchia di circa due secoli.
A pag 54. La vitale virtù della palma non come le altre piante e riposta nelle radici ma nel sommo messa, come ii cuore nel mezzo dei Rami la quale intorno intorno è custodita, come un Re dalle sue genti. Osservazioni dei Dottori a proposito della Palma festiva i quali aggiungono volere essa per questo significare l’unità d’aspirazione d’Isdrael verso l’Altissimo. Quanto alla Palma, ecco come si esprime il Sharon Turner I, 122, nota: «Vi è una tribù di piante chiamate monocotiledone dove dall’avere un solo lobo per seme, appartiene a questo, l’ordine naturale delle Palme.»
A pag. 82. È sensibile in Filone una interpretazione farisaica di un locuzione di Balaam. Questi aveva detto per Israele «popolo che qual lione si alza, nè riposa finchè abbia divorato la preda. I Dottori spiritualizzando il verso lo applicarono alle preghiere, alla Confessione di Dio che l’Israelita ripete, nel levarsi e nel coricarsi. Si oda ora Filone: nè ciò fatto anderà a riposare, ma vigilando canterà versi che significheranno la sua vittoria.» Ecco altri tre secoli di antichità alle più umili o neglette tradizioni farisaiche.
A pag. 104. Il Testo Biblico vieta le opere nel giorno di Sabato. Una esegesi razionalistica potrebbe non vedervi, che le opere le quali affaticano il corpo, non atti che si compiono quasi per trastullo, quale sarebbe cogliere un frutto, strappare una fronda ec. Filone però non è tra questi. Concede ancora il settimo giorno agli alberi e a tutte le piante qualche alleggiamento, perciocchè in tal dì è vietato levarne le frondi e le foglie e raccorre alcun frutto.
A pag. 120. Filone traduce il Micdas di Mosè (Tempio) per città sacra. Donde ciò? Una delle tradizioni farisaiche nella Misna vuole appunto che tutta la città di Gerusalemme sia detta Micdas e ne abbia a certi effetti le prerogative.
A pag. 122. Il numero Cinquanta santissimo. Eccolo dunque col sette e col dieci, terzo tra i più venerati numeri nella teosofia tradizionale: degno pure è di nota l’epiteto di santissimo. Infatti il numero cinquanta appartiene alla emanazione Bina che ha per distintivo la santità Kodes, come altre, la verità (Emet), la carità (Hesed) e via discorrendo.
A pag. 124. Il giacinto rassembra nel colore l’Aere. E questo è il Tehelet del Pentateuco e appunto come Filone dissero i Dottori, il Tehelet somiglia all’Aere. Pare dunque che a questa doppia autorità dobbiamo starcene, piuttosto che a problematiche analogie tratte dall’Etiopico come vorrebbe un Filologo scrittore del giornale Ebraico. Maghid. Anno 7º 13 e 14.
A pag. 127. In tali figure (dei Cherubini sovrapposti all’arca) crederò che dimostrino le due antichissime ed incomprensibili potenze di colui che è la vera essenza, una delle quali crea, l’altra governa; per quella vien chiamato Dio, con cui tutto l’universale fabbricò ed adornò ma per la regale è chiamato Signore. Testo preziosissimo perchè informato senza meno delle idee teosofiche farisaiche. Basti dire (senza grandi sviluppi che il luogo non consente) che della sacra decade o dieci Emanazioni divine, la sapienza ch’è la vera essenza, come dice Filone, e appunto per ciò chiamata Ies, Essenza, si parte nei suoi due attributi, o in un figlio ed una figlia come si esprime il linguaggio simbolico di essa teosofia, e questi figli appunto sono in quella scienza stessa rappresentati dai due Cherubini che poggiavano sul arca del Patto. Or quali idee esprimono essi? Tali osiam dirlo, che concordano mirabilmente con quanto Filone va significando. Il primo portato o figlio, è appunto la potenza creatrice che l’universo fabbricò ed adornò il Demiurgo dei Platonici e come Creatore è pur anco Rivelatore e fonte dei prodigii, conciossiachè egli abbia dato le leggi al mondo; anzi che per esse leggi lo governi; ed è rappresentato dal nome tetragramma di Avoja, il secondo attributo o figlia, è alla lettera la potenza regale, come dice Filone il Regno, Malhut, e come il nome lo significa, presiede al governo del mondo. Per questo officio lo chiama Filone Signore e appunto per ciò ha per suo distintivo in quella Teosofia il Nome d’Adonai o Adon, e per far più mirabile l’analogia, il nome persino onde nel Testo Greco si vale Filone il greco titolo di Kirie Signore, e appunto nel suo senso greco di Signore, conciossiachè sia cotesto uno dei residui della lingua greca di cui si giovò lo stile familiare e la teosofia dei Farisei.
A pag. 130. Aveva (il sommo Pontefice) una piastra d’oro a guisa di corona scolpita di quattro lettere, di quel nome il quale è lecito d’udire e nominare nel sacrificio, solamente a quelli che gli orecchi e la lingua hanno colla sapienza purificato. Da cui tolse Filone questo divieto di profferire il nome quadrilettere se non nel Tempio? Non certo nella Bibbia che di ciò non favella; sibbene nella tradizione farisaica che appunto dispone doversi nel Tempio invocare Dio col nome suo quale si scrive, e fuor del tempio con quel di Signore e che per l’autorità di Filone si palesa veridica e più antica di parecchi secoli.
A pag. 131. Ciò che segue è d’importanza ancor maggiore. «Tal nome dicono i Teologi essere di 4 lettere forse perchè significa i primi numeri, uno, due, tre, quattro, perciocchè nel quaternario tutto si contiene, e punto, e linea, e superficie, e solidità.» Si noti in primo luogo come Filone non sia tanto qui originale spositore, ma si faccia bensì interprete di ciò che dicono i teologi. Non sembra con queste parole mostrarci a dito la sorgente a cui attinse? Che sarà se troveremo pure gli insegnamenti conformi? In fatti i Teologi ebrei veggono nelle quattro lettere del nome divino, nè più nè meno di ciò che vi trova Filone, o per dir meglio, ciò che vi trovano i Teologi a cui accenna. Queste lettere sono la Iod, la E, la Vau e la E. Ora per la prima intendono la emanazione Sapienza detta ora, Uno (ed in ciò consuona coll’Uno, o Buono di Plotino e dei Neoplatonici) ora, punto, (Nekudda;) per la seconda, vogliono significare la emanazione Bina o intendimento, chiamata per la stessa simbologia matematica ora due ora linea (Kau;) per la terza accennano alla sesta emanazione il Logo, Daat o Bellezza, Tifheret, che è detto il terzo patriarca, Israel a cui è promessa larghezza senza confini (Nahala Beli Mesarim) la quarta lettera, raffigura il Regno ultima emanazione, (Malhut) chiamata Guf.... Corpo Solido, Profondità (Omek) ed anche quarto sostegno del trono, reghel rebihi. Aggiungiamo per i dotti, che qui in Filone come nelle prime evoluzioni del domma cristiano le due triadi principali della serie emanativa, Corona, Sapienza, Intendimento da un lato, e Sapienza, Logo e Regno dall’altro, si compenetrarono e confusero in guisa da sostenere talvolta l’officio gli uni degli altri.
A pag. 136. Parimente nel Razionale, il quale alla regione (Logos) ogni cosa disponente, si rassomiglia, perciocchè faceva mestieri che il sacerdote che all’universal Padre porta preghi, adoperasse per avvocato il perfettissimo suo figliuolo, ad ottenere degli errori perdono. Il razionale è come ognuno sa un quadrato di porpora giacinto ec., che il sommo pontefice recava sul petto. Questo come tutte le altre parti del culto ha un senso simbolico, teosofico nella scienza recondita e nel suo gran codice il Zohar. Qual è questo senso nel razionale? Non so se m’illuda, ma parmi l’identità e non solo l’analogia d’idee, evidentissima. L’emanazione Tifheret, o Logos è per i Teosofi la ragione (Daat, Logos) il figlio, e per aggiunta perfettissimo (Ben, Tam, Tamim.) Chi direbbe che ciò appunto significa il Razionale per i Teosofi? Eppure nulla di più dimostrato per chi legga nel Zohar, vol 2, pag. 230 e nel Meore Or. Di fronte a questa splendida conformità non insisteremo sull’officio di Difensore e per dirla nel linguaggio cristiano e che probabilmente Filone adoperò, di Paracleto attribuito a esso figlio, Ragione. Diremo solo che neppur esso manca per completare la rassomiglianza fra il Logos o Ragione di Filone e il figlio o Ragione dei Teosofi Ebrei. Notiamo ancora di fuga che il nome di Razionale derivò, a quanto pare, a questa veste dall’epitetto Mispat di giustizia che porta nel Pentateuco.
A pag. 145. Nè potendo fare di non credere all’oracolo, come mezzano e arbitro del divino concetto. Fraseologia incomprensibile se non si raffronti allo stile ed ai simboli teosofici dei Farisei, pei quali l’oracolo o l’eco, è lo Spirito Santo il Regno, chiamato appunto Mezzano (Sirsur, emzahi, Malah) Interprete, Turcimanno (Torgheman) del divino concetto, cioè dell’Idea del Logo, della Ragione.
A pag. 157. Più oltre passando ed il tutto bestemiando, niente addietro lasciò. Bestemmiare il tutto è frase che vuole spiegazione. Se la traduzione del greco è esatta, non è possibile astenersi dal vedere in questo tutto o Pan, uno dei nomi più legittimi di parecchie tralle emanazioni farisaiche col tutto.
Ibid. La legge del Sacrilegio interpretata dai Dottori esige che il bestemmiatore si faccia ad esecrare il nome dl Dio, col nome di Dio stesso, Dio invocando contro Dio medesimo; e come dice il Talmud (Iacchè Iosà et Iosè) forma che altra non fu mai non so se più mostruosa o paradossale. Ma tanto più concludente se si troverà in Filone. Si oda lo stesso, a pag. 157.... la sfrenata bocca obbedendo ec., sogliono senza dubbio bene spesso, o uomo, qualche mostruosa sceleraggine commettere. Or dimmi saravvi chi esecrerà Dio? Quale altro Dio a questa esecrazione chiamerà? Non chiamerà egli stesso contro lui stesso? Queste parole non han bisogno comento. Offrono un eloquentissimo indizio di quella fratellanza d’idee che noi asserimmo tra Filone e i Farisei.
A pag. 158. Quando Moisè dice «Ognuno che avrà maledetto il suo Dio porterà il suo peccato.» Filone intende pegli Dei dei Gentili, aggiungendo, acciocchè nessun discepolo di Mosè si avvezzi a stimar poco il nome di Dio che sempre stimò. Giuseppe Flavio consente in quella intelligenza del Testo Mosaico col nostro Filone; ma finchè non fossero che questi due scrittori, un dubbio naturalissimo potrebbe sorgere non forse volessero per siffatta guisa amicarsi la opinione dei Pagani, e fare da essi estimare la legislazione mosaica. Ciò che ne interdice di così giudicare ella è l’autorità del Zohar, doppiamente preziosa, vuoi perchè chiarisce ingenua e spontanea la interpretazione dei due scrittori greci con essi consentendo, vuoi perchè ne porge un nuovo anello onde connettere costoro, e specialmente Filone, colla teologia acroamatica e coi principii che ispirarono al zohar la stessa interdizione di Giuseppe e Filone. Vedi mie note critiche al Pentateuco nell’opera mia Ebraica Em lamicra, Levitico Cap. 24.
A pag. 159. La tradizione trova mal fatto chiamare il proprio genitore per nome, sia egli presente o lontano, e quando pure si qualifichi con qualsiasi titolo onorifico. Non è egli in sommo grado parlante trovare la stessa inibizione in Filone? «Perciocchè (egli dice) neppure il nome dei mortali genitori, quelli che osservano la pietà ardiscono nominare, ma lasciando per riverenza i nomi propri, dei naturali si servono, chiamandoli Padre e Madre.
A pag. 160. Chiama vera filosofia, alla quale l’Ebreo attende il giorno del Sabato, quella che in sè questi soli tre capi contiene, opinioni, detti, ed opere. È degno di nota, da una parte come la tradizione esiga il riposo sabbatico, non solo nelle opere ma eziandio nei detti e nel pensiero, astenendosi da parole o cogitazioni che non siano di preghiere o di studio; e dall’altro come il culto perfetto secondo i Teosofi ebrei consista appunto nella consacrazione dei pensieri, dei detti, delle opere, al servizio divino Mahasabà, Dibbur, Maasè.
A pag. 170. La legge di successione registrata nel Libro dei Numeri, tace del Padre, come erede del proprio figlio. Si oda Filone.... perciocchè pazzia sarebbe credere che lo Zio come fratello del Padre fosse erede del figliuolo ed il proprio padre non fosse erede del figliuolo; ma perchè la legge di natura comanda che i figliuoli succedano nei beni dei padri e non i padri in quei dei figliuoli, di questi non parlò come di cosa di tristo augurio e contrario all’amore paterno. Accennò nondimeno tacitamente che quel benefizio che ai zij permette doversi ai Padri ancora esser conceduto: Triplice conformità coi Talmudisti. 1º Nel riconoscere nel Padre il diritto di successione al figlio, nonostante il silenzio del Testo. 2º Nel valore conceduto alla causa di questo silenzio; cioè come cosa di tristo augurio; ragione che il Talmud stesso invocava nel trattato Batrà, Cap. 3º.—; 3º nel convenire che fa Filone, avere Mosè tacitamente accennato questo diritto del Padre; sistema d’interpretazione in uso presso i Farisei i quali dal proibito incesto colla nipote, traggono per illazione de minori ad majus quella della figlia stessa e dalla parola Scèero che si legge nel Testo Mosaico concludono doversi attendere anzi tutto al diritto del padre, verace parente e carnale come Scèero appunto significa.
Noi abbiamo fin qui indagato nella intima natura di questi raffronti, il pensiero comune tra la tradizione farisaica e Filone; e crediamo avere il risultato risposto pienamente alla nostra aspettazione. Rimarrebbe però a desiderarsi che oltre queste concordanze di fatto che offre Filone colla tradizione, ci ponesse egli stesso sulla via per risalire alla origine della tradizione e qualche cosa dicesse che accennasse appunto avere egli da questa fonte attinto che noi presumiamo. Ognun vede la grande importanza di questo deposto di Filone, se pur vi fosse. Avventurosamente egli esiste ed è nei termini seguenti ai quali vuolsi gran peso concedere. «Ma io la invidia di costoro trapassando desidero esprimere di un tal uomo quello che mi hanno insegnato i Sacri libri che egli lasciò.... e che io ho appreso da alcuni vecchi della nostra gente i quali sempre all’antica lettura, alcuna cosa solevano aggiungere, onde maggiormente la vita di lui ho potuto conoscere.» Questa preziosissima confessione pone il suggello a quanto fu da noi intieramente dimostrato per via di raffronti e la sorgente tradizionale non poteva essere meglio dimostrata a dito, di ciò che si fa in queste parole.
(Vita di Mosè in principio.)
[25] Revue des Deux-Mondes, V, 745.
[26] Questo studio rigorosissimo di purità sino al punto di preterire doveri sì sacrosanti ci può far comprendere il valore di certe parole del Fondatore del Cristianesimo. Lasciate i morti seppellire i loro morti. Chi non odierà il Padre, la Madre, il fratello per amor mio non sarà degno di seguirmi. Donna, questi sono mia Madre e questi i miei fratelli. Non è nostro officio sindacare di queste sentenze il valore morale; sibbene il critico. Ora noi fondatamente asseveriamo non d’altronde derivare se non da quel concetto che di se medesimo mirava a far prevalere e che altrove abbiam già veduto informare le sue parole; quello cioè di Tempio vivo e vero ed erede delle prerogative tutte del Tempio reale allora esistente. Quindi per naturale illazione tutti i doveri che cessavano alle soglie del Tempio non potevano più avere niun diritto alla sua osservanza nè a quello dei seguaci. Vediamo infatti non per altro motivo giustificarsi da Gesù le infrazioni del sabato e delle leggi dietetiche se non dicendo esservi allora presente. Qualcheduno maggiore del Tempio. Notabilissimo poi è che il Zoar dà la qualità di Tempio al Dottore Cabbalista (Vol 3º Sez. Zau); nuovo indizio delle origini essenico-cabbalistiche del Cristianesimo.
[27] Risulta dal Testo sacro per duplice motivo e in duplice senso, chiamarsi il Nazireo con questo nome, nel senso di separazione e nel senso di corona. Ciò prova come la nomenclatura biblica sia polisensa, e come bene si appongano i dottori, cercando, oltre la indicazione biblica, altro senso nel nome di quei personaggi. Non meno questo fatto resulta evidente nei nomi apposti ai figli di Giacobbe; per esempio, Giuseppe, ove anche il senso di ritrarre, cessare l’onta dell’orbamento, è accennato dal Testo stesso, allato dell’altro più appariscente di aggiungere, aumentare; e di altri non meno, come avvertimmo nelle nostre note al Pentateuco in lingua ebraica (Em lammicrà, Genesi, cap. I). Questa multiformità di sensi può darci la chiave di alcune anomalie, non ancora perfettamente risolute; qual è, a mo’ d’esempio, la poca convenienza che si nota tra certi nomi biblici nella loro attual giacitura, e la etimologia che ne assegna la stessa Scrittura; così Cain mal consuona col Canisti, da cui si vuole derivato; Noè con Jenahamenu, Samuel con Seiltiv, ed altri, che nel nostro sistema avrebbero avuta altra significazione, eziandio taciuta dal Testo. Si spiegherebbe ancora come siano rimaste in credito certe derivazioni pugnanti colla esplicita dichiarazione del Testo, qual è, ad esempio, la origine del nome Mosè, secondo la Scrittura, dal verbo ebraico Masa e secondo Filone (Vita di Mosè) dal nome egiziano d’acqua, mos. Non è improbabile l’ipotesi che i primi cristiani siansi detti Nazareni, nel senso di Nazirei, piuttosto che in quello di originarj della città di Nazaret, etimologia poco ammissibile, e per avventura immaginata quando l’antica origine dell’Essenato, cominciò a venir meno nella memoria degli uomini.
[28] Chi sa che l’atto di Geremia nel propinare il vino ai Recabiti non sia una di quelle solite parodie onde i profeti solevano contraffare le prevaricazioni del popolo per fargliene rimprovero. Avremmo quindi l’iniziazione e il magistero profetico nei Recabiti eziandio, ai quali era dato il vino come antidoto, siccome ai suoi coetanei rimprovera Amos; e intenderemmo meglio le promesse fatte ai Recabiti da Geremia che suonano così magnifiche. È strana dopo le cose dette fin qui l’opinione di coloro che si ostinano a vedere nell’uso generoso del vino una preparazione necessaria e consueta all’officio di profezia tra il popolo nostro.
[29] L’origine essenica del cristianesimo trova un eloquente riscontro nella foggia di vivere e di vestire del Precursore che da un lato risponde al suo prototipo di Elia di cui adempie le parti; dall’altro non meno bene si confà all’antico uso dei profeti e degli Esseni.
[30] Dante è Maestro in siffatte similitudini; solo che alla Sapienza rivelata, alla Teosofia si sostituisca la filosofia detta da esso «la bellissima e famosissima figlia dell’imperadore dell’universo.»
[31] A chi volesse vedere nella purità e bianchezza dei Nazirei in Geremia, la delicatezza o candor della pelle, dimanderemmo ci dicesse perchè singolarmente si specificano qui i Nazirei. La similitudine poi della Neve, usata, come nota Rasci in Daniel, a indicare la purità delle vesti, non è tralle menome prove che mostrano quanto bene il padre di tutti i chiosatori si sia egregiamente apposto nell’interpretare per le vesti.
[32] È questo uno degli infiniti esempj in cui la Pratica posteriore a Mosè soperchiandone i dettati o diversificandone l’indizio manifesto di una tradizione è coimperante in Israel colla legge scritta. Infatti la Storia biblica ci mostra in pratica il Nazerato perpetuo. Ma dov’è egli preveduto e regolato nel testo mosaico? In nessun luogo.
[33] Abbiamo udito la scrittura parlare di santità a proposito dei Nazirei. Ora è bene che si sappia che ogni qualvolta il nome di santo è usato nel senso di astinenza o di perfezione religiosa la traduzione aramea è sempre Parus. L’atto stesso del votarsi al Nazirato Iafli è tradotto dal Parafrasta Caldeo Jefares; da ciò il nome dell’angiolo apparso al padre di Sansone se in ebraico è detto Peli in arameo è tradotto Meforas; nè altro è da intendersi nel titolo di Meforas dato dai Rabbini al titragramma se non il nome separato e distinto per eccellenza. Qui sarebbe luogo di diffondersi sopra una obiezione speciosa che questo nome di Parus potrebbe suscitare contro l’antichità del Zohar. Tra le tante vestigia di tempi moderni che i critici vollero trovarvi, ora nello stile ora nelle dottrine, non mi venne fatto d’imbattermi in una che tutte le vince in speciosità e verosimiglianza e che pure mirabilmente si solve alla luce delle cose accennate. Le intelligenze superiori angeliche sono dette nel Zoar Periscian: vale a dire intelligenze separate. Ora per poco che si abbia contezza della filosofia aristotelica, specialmente del peripatetismo arabico, facile sarà ricordarsi come in questi sistemi, intelligenze separate siano dette le intelligenze angeliche perchè immateriali e incorporee. Come non dubitare di una traccia della filosofia araba e della sua fraseologia nelle pagine del Zoar? Nelle mie note su quel libro in lingua ebraica osservai che non v’ha ragione di credere piuttosto a una derivazione arabo-aristotelica e quindi posteriore, che ad una origine greca, platonica o aristotelica e quindi più antica, ove meglio non si accetti la originalità del Zohar nel coniare questo epiteto. Ora aggiungo che il Parus, usato dalle tradizioni aramee per indicare la santità in genere, conviene che nulla più, alla frase ed all’uso che il Zohar ne ha fatto, trattandosi d’intelligenze angeliche chiamate dai Profeti antonomasticamente Santi; e che il Mefaras del Parafrasta Ionatan applicato all’angiolo è di una convenienza difficile a vulnerarsi col Perisan del Zoar inteso per gli angioli.
[34] Il Talmud pare, è vero, non alludere che ad un oggetto speciale esclusivo, cioè di porsi in grado di offrire una specie di sacrifizio che solo la merce del Nazirato avrebbe potuto presentare. Tuttavia chi conosca come il Talmud Babilonico sia stato scritto più di sei secoli dopo i più bei tempi dell’Essenato; in terra, e tra costumi tanto dai loro diversi, non stenterà a credere che lo scopo universalissimo del Hasidim nel farsi Nazirei, o per dir meglio la medesimezza dei due personaggi siasi circoscritta nel Talmud e considerata da un solo punto di vista.
[35] Vegga il lettore tra i raffronti da noi stabiliti nella nota 3, pag. 90, tra Filone e la tradizione farisaica, la memoria di questa volontaria continenza mosaica nel filosofo alessandrino. Ragion di più per farle acquistare peso e autorità.
[36] Questa stessa trasformazione dell’eccezione in regola del precetto morale in Cerelo, costituisce uno dei passaggi originarj dall’Etraesmo al Cristianesimo.
[37] Questa bellissima idea, che Paolo presentò ai Pagani nella similitudine dell’ulivo selvatico, appartiene in origine ai dottori interpretanti la promessa ad Abraham: E saranno in te benedette tutte le genti della terra. Il verbo ebraico venibrehu, che suona saranno benedetti, è suscettibile dell’altro senso d’innesto, ed è appunto su questo che i Dottori insisterono veggendovi l’innesto di tratto in tratto operatosi, di un ramo gentile sul tronco ebraico.
[38] Le istituzioni e gli offici sono come le scienze. Dapprima confusi e concentrati in una sola persona, non cominciano a distinguersi che in progresso di tempo. Perciò il sacerdozio fu anticamente centro in cui conversero tutti i rami del sapere e tutti i sociali maestrati, appunto siccome quello che tutti sovrasta. L’ebraismo stesso, per quanto non abbia seguito la legge comune, lenta, regolare del progresso, e sia sorto, come avverte l’autore del Kuzari (libro meditato pure da Guido Cavalcanti, come ci ammoniva l’illustre Mamiani), a guisa delle creazioni in un Fiat; pure non è sì che la legge di unione primitiva non si verifichi in esso ancora comecchè per breve istante. Difatti è sentenza dei dottori corroborata eziandio da qualche cenno del Testo che nei sette giorni d’inaugurazione del tabernacolo il ministero sacerdotale fosse assunto e concentrato temporariamente in Mosè siccome Jerofante e Iniziatore, il quale da quell’ora in poi tornò semplice Levita e subordinato ad Aaron.
[39] Non si attribuisca questo vivere nelle tende a costumi tuttavia rozzi e primitivi. Nè i Cananei sposseduti, nè gli Israeliti erano allora in tal grado di barbarie da non aver ancora case costruite. Esempj di case anteriori a questi fatti non mancano nella Bibbia. Sin dai tempi di Mosè egli promette loro nella Palestina Case piene di ogni bene che voi non avrete ricolmo; prevede e regola la costruzione di nuove case e impone il riparo sul tetto. Contempla e prescrive le regole per purificare le case colla demolizione delle antiche mura, e colla introduzione di nuovo materiale. Egli è quindi indispensabile credere che se ai tempi tanto più posteriori di Devora i Cheniti abitavano sotto le tende, così facessero non per altra cagione di quella che indusse a così fare i loro nepoti a’ tempi tanto più moderni di Geremia, che il vide e li lasciò viventi fuori della città sotto le tende.
[40] Isaia, cap. 1.
[41] Lo avere questa sentenza origine nel Zohar, lungi dal detrarre del suo valore ne accresce anzi il pregio per ognuno che ricordi essere a senso nostro non altro gli Esseni che i predecessori dei Kabbalisti o Teosofi moderni, appo i quali si troverebbe pertanto la stessa denominazione di Eunuchi.
[42] Questa lezione era da lungo tempo scritta quando mi venne fatto d’imbattermi nel florilegio talmudico (En Israel), ediz. Königsberg, e preceduto da bella e dotta introduzione di scrittore moderno. L’autore, ragionando intorno ai versi d’Isaia di cui è parola, esce fuora con questa interpretazione, che se non coincide appuntino colla intelligenza che qui si attribuisce al Testo, pure di molto le si avvicina, e stabilisce un principio e accenna una idea generale che non può trovare la sua realtà concreta, il suo adempimento storico, che nella ipotesi nostra. Ecco le sue parole: «Vuole Isaia significare come allora vi fossero uomini assai che renunciato avevano ad ogni piacere mondano, nè tolto avevano donna; ma attendevano in solitudine con grande amore al culto religioso, nel Tempio divino, e tanto avveniva altresì degli stranieri, vale a dire dei Gabaonti.»
[43] Pel lettore che sa di ebraico non fan mestieri spiegazioni. Pegli altri, diremo solo che tutto il ragionamento presente tende a provare come il verbo Omed lefanai usato in Geremia a proposito degli Esseni, è suscettibile, in forza degli arrecati esempi, dei sensi che qui si accennano.
[44] Tra i trasportati in Babilonia, la storia biblica annovera charas veamasgher alla lettera falegnami e fabbroferrai. La tradizione ne fa altrettanti maestri e dottori; ed è notabile: primo, che Masgher può avere senso di claustro, di reclusione, e poi che il Talmud Gerosolimitano su questo verso (Nedarim, IV) chiosa Ellu ahaberim, Sono questi i soci. Quanto questa frase convenga agli Esseni ognuno il vede; e non si sarà dileguato dalla memoria dei lettori quanto congetturava il dottissimo R. Rapoport intorno al senso della parola Esseni che vale al dire di lui quanto socio, compagno da Jso Arameo. Sotto altra forma l’appellativo di socio è attribuito ai Farisei nel nome Amit (Talmud Tract Sciabuot, cap. IV). Quanto alla identità originaria di Esseni e di Recabiti non d’altronde sembra muovere l’Heckers, (Istoria della medicina, 42) se non da tale premessa, quando scrive: «Gli Israeliti, spezzato il giogo di Babilonia, si dedicarono alla vita contemplativa e solitaria e fondarono la setta degli Anacoreti (Geremia XXXV), i quali privi delle scienze naturali operano colla fede e cogli scongiuri cure portentose.» Qui ognun vede come Recabiti ed Esseni pongano in comune i loro caratteri.
Prima di abbandonare la questione dell’origine degli Esseni, facciamo qui alcuni rilievi che recenti letture ci suggerivano. Il senso da noi dato agli Eunuchi d’Isaia, quello di precursori ed antenati degli Esseni, fu avvertito da un Critico alemanno autore del Biccoret Attalmud, pag. 273; se non che non diè valore ai Proseleti che allato degli Eunuchi figurano nello stesso luogo d’Isaia (cap. 56), e ch’è indizio eloquente dell’origine da noi propugnata. Quanto all’origine dai Nazereni, mentre è consentita da valenti scrittori tra cui il Graetz, è invece combattuta dall’autore sopra ricordato. Ond’è che non sarà discaro udirne le ragioni, e pesarne la forza. Egli si giova di quanto si legge nel Talmud (Nedarim X) essere usi gli antichi Hasidem di far voto di Nazer; dunque ei conclude, eran costoro Kasidim (cioè Esseni) prima che si votassero Nazirei. Il lettore ricorda come cotesto passo fosse da noi noverato tra gli indizi che ci favoriscono. Questo senso ostile che gli si vuol dare non ci par serio; sia perchè può avere appunto inteso il Talmud di svelarci l’origine e il carattere primitivo dei Hasidim; sia perchè il Talmud stesso per le ragioni altrove accennate, può non aver avuto un’idea assai chiara di una origine puramente storica e di piccolo o niuno religioso momento. Il Talmud altrove (Chidduscin, 71) offre un curioso passo che diè luogo ad un antico comentatore (Moarscia) a trovarvi un’allusione agli Esseni sotto il nome di Nazirei. Il Talmud così si esprime «Colui che dicesse: Sarò Nazireo se non svelo i vizj di origine delle famiglie, sia Nazireo e non le sveli.» Qui il Moarscia chiosa dicendo: Si dee intendere mercè quanto scrive Giuseppe, esservi stato durante il secondo Tempio una setta detta dei Nazirei, che amavano la solitudine e i deserti per non cadere nel peccato di maldicenza. Perciò si legge che se taluno dicesse sarò Nazireo se non svelerò ec. sia Nazireo, poichè tale n’è invero il costume per quanto sia cotesto un voto non da tutti laudato a cagione delle astenenze che importa. Tuttavia peggior cosa sarebbe se per annullarlo si permettesse la maldicenza. Quindi si taccia e sia Nazireo. Questo senso dà noia all’autore rammemorato del Biccoret Attalmud: (pag. 279) ma s’è vera la intelligenza ch’egli ci porge, non si comprende come rimanga fermo il voto e sia Nazereo mentre la condizione apposta, cioè quella di propalare le turpitudini delle famiglie non si verifica nè si permette che si verifichi. Quindi ci pare probabile il cenno agli Esseni che vuol trovarvi il Moarscia; ed in ogni caso, è questa prova novella come non appena i nostri scrittori ebbero a narrare o a ragionare degli Esseni, li qualificarono senza esitanza quali veri e propri Nazirei, ossequio spontaneo e tanto più concludente in favore della loro affinità originaria. L’autore medesimo, non a bastanza penetrato dei vincoli strettissimi che uniscono il Farisato nei suoi gradi più eminenti colla società degli Esseni, va in cerca di contradizioni tra l’uno e l’altra. Fra queste pone il bianco vestire in onore nella seconda, in odio presso i primi, e cita il Talmud Sota 22 e Meghilla 24. 2. Ma che cosa si legge invero in ambo i luoghi? Nel primo: Il tribunale supremo si vendichi di coloro che si cuoprono di Gundé? Che cosa è Gundé? Per l’autore, così pare, abito bianco. Non così però per Rasci il quale chiosa addirittura abito nero. Volesse pur dire bianco; non sarebbe altro che un denunciare la ipocrisia di coloro che prendevano le sembianze esteriori degli Ottimi senza averne le virtù. Il secondo suona Chi dicesse non officierò nel Tempio con abiti di colore non officii nemmeno coi bianchi. E i comentatori: perchè era il bianco vestire costume dei Minim (eretici); ma 1º Non si vuol egli distinguere tra il bianco vestire volontario degli Esseni e l’obbligatorio di questi Minim? Sappiamo non meno che gli Esseni vestivano talora diversamente; di sacco p. e. 2º Probabilissimo è poi che in Minim s’intenda i primi cristiani come talvolta significa veramente; e se così fosse, nulla di strano che il costume adottato da costoro tornasse odioso a quegli stessi che lo avevano usato poc’anzi. È questo nella natura dell’uomo, e corroborato da esempi? nostrali. Il Decalogo fu soppresso nella orazione del mattino a cagione dei Minim; anche qui probabilmente cristiani, che ridussero tutta l’antica legge al solo Decalogo. 3º Infine insigni Farisei vestono di bianco nel Talmud e ne vanno ivi stesso celebrati, come ragionando del costume vedremo. Si dirà ancora ch’era tal costume in odio?
[45] Un fatto generale ci avrebbe forse potuto dispensare da tutte queste particolari citazioni; ed è la presenza di Sinagoghe ebraiche per tutta la distesa del romano impero, le quali supponevano certo a capo loro Rettori e Dottori. La storia evangelica ed apostolica è piena di fatti che provano questa presenza, dovunque l’Evangelio fu predicato.
[46] La tradizione che ha per stile di trasformare nell’antica storia ebraica gli avvenimenti guerreschi e politici in fatti dottrinali, o in morali controversie, vede nella promessa di Caleb. Chiunque avrà battuto Kiriat Sefer e l’avrà presa, daragli Ahsà la figlia mia in donna, una ricompensa promessa a chiunque avesse molte leggi restituite che erano cadute in oblio dopo la morte di Mosè. Nulla di più paradossale a prima giunta di questa interpretazione; ma quando riducasi a memoria che cosa questo nome di Kiriat Sefer vuol significare, e quanto saviamente avvertiva Gioberti, facile lo accorgersi come i dottori non abbiano inteso che appigliarsi ad un felice addentellato in cui la espressione storica si presta mirabilmente alla chiosa tradizionale; anzi con questo senso sino a un certo punto s’identifica; volendo dire che colui che sarà da tanto da sottentrare nell’officio che Kiriat Sefer adempiva nel concerto o Antizionato dei popoli Cananei come Archivio dello Stato, e potrà essere utilmente consultato in quella città come lo erano i suoi abitanti Cananei, sarà rimunerato ec. Potremmo aggiungere che in questa trasformazione di guerre politiche in lotte spirituali i dottori nostri non si dilungarono punto dal genio che predomina nelle più antiche epopee orientali.—Ma qui lasciamo per brevità; fidente che il lettore compia il nostro pensiero, solo che attenda per breve istanti a ciò che sono i poemi indiani del Mahabaratta e del Ramayana.
[47] Vedi per la giustificazione di questo supposto, quanto è riferito più oltre in nota a proposito di ciò che narra il Talmud sulle occupazioni dei Hasidim.
[48] Simile circospezione ci viene narrata nel Talmud (Meghilla) dei Traduttori del Pentateuco in greco per ordine di Filadelfo.
[49] Il citato frammento del Talmud forma subbietto di profonda indagine nel rammentato Lessico Ereh Millim del dottissimo sig. Rapoport Rabbino di Praga. Ci sia permesso anzitutto costatare coll’illustre autore la grande antichità di quel frammento, ch’egli crede redatto o almeno formulato molto innanzi al Talmud in qualche raccolta d’Agadot, che, come è noto, precorse il Talmud, e da cui questo l’avrebbe copiato. Sono fondamento a questa plausibilissima congettura, varie singolarità filologiche proprie ai libri Agaditici, e che l’autore saviamente pone in luce. Quello che non potremmo mai consentire al gran critico, si è la pretensione da esso accampata di vedere nei savj e dottori del mezzogiorno, con cui Alessandro favella, uomini pagani anzichè ebrei, e più specialmente sacerdoti etiopici o Brami indiani. Il testo ha un bel opporsi a questa interpretazione mercè le parlanti intercalazioni che corrono fra domanda e risposta. Il nostro autore con un colpo di magica verga le dichiara posteriori addizioni al testo più antico; nel quale egli non crede doversi ravvisare niuna traccia d’Ebraismo. Questo concetto che l’illustre autore si forma degli interlocutori di Alessandro, capovolgendo le basi su cui poggia tutto il nostro argomentare nel testo, e facendo sparire una delle vestigia più splendide, che a senso nostro abbiano lasciato gli Esseni nella Biblioteca rabbinica, merita, anzi esige, che con qualche pazienza vi ci soffermiamo d’intorno, e lo esaminiamo più davvicino. Si noti anzi tratto come:
Fra i neologismi nota il Rapoport Atristun di cui dice non esservi la radice nell’antico lessico Aruh. E pure egli non avrebbe dovuto che gettare lo sguardo sopra taris (bis) per vedere (in fine) il verbo taras col suo esempio tratto dal Talmud (Jevamot 121. 1).
Osserviamo ora le traccie d’ebraismo nel racconto Talmudico che il Rapoport crede estraneo alla primitiva leggenda, e solo aggiunto, vuoi nell’atto della redazione Talmudica, vuoi da copisti posteriori. Lasciamo per ora quanto vi ha di arbitrario a priori nello scindere una narrazione omogenea in tanti frammenti di cui altri avrebbero appartenuto al tessuto primitivo, ed altri sarebbero stati introdotti posteriormente. Guardiamo solo se questo criterio comunque inverosimile, è applicabile al fatto concreto.—In primo luogo, la locuzione Ziknè Anegheb non contiene veruna indicazione che miri piuttosto ai pagani che ebrei.—Anzi il nome Ziknè implica una idea di venerabilità che male si affà, in bocca ai dottori, ai savj gentili. Essi hanno altre locuzioni per indicare questi ultimi, e non si comprende come qui se ne siano discostati; per esempio quella di savj gentili, hahme umot Aolam; Flosofim, che sarebbero state qui tanto più opportune, quanto meglio avrebbero posto in rilievo l’opposizione che segue dei dottori israelitici (Vakakamim omerim) intorno alla distanza dal cielo alla terra. Non ne conviene lo stesso autore quando confessa che l’epiteto di Zikné Anegheb ad indicare i sacerdoti etiopi ed i brami, è nuovo ed unico nello stile rabbinico? Egli, è vero, non ne conclude che una maggiore antichità; ma non so quanto sia lecito trovare anormalità, laddove la locuzione sembrerebbe regolarissima ove intesa come noi la intendiamo, pei dottori dimoranti nel sud di Palestina.
Potremo dunque noi vedere in questi Zikné Anegheb altri che i dottori meridionali celebri appo i Rabbini, par la loro squisita sapienza, come attestano le citazioni, recate nel corpo dell’opera? Il Rapoport crede che ciò non solo si possa, ma si debba. Per esso altro è Negheb (mezzogiorno) da cui qui s’intitolano, altro Darom (altro nome di mezzogiorno) da cui altrove si qualificano. (op. cit., pag. 73, 1). Con quanta ragione però non saprei dire, dappoichè è ovvio, che Negheb e Darom son due nomi egualmente approvati per mezzogiorno o sud; come Iam e Maarab per occidente; e come levante e oriente nel nostro idioma, onde, tanto vale Ziknè Anegheb quanto Zikné Darom. Si dirà che altrove dissero per la parte meridionale di Palestina piuttosto Darom che Negheb? Ciò non si nega, ma se prova qualcosa, ei prova piuttosto l’antichità di questa tradizione che usa di un vocabolo che sa di Arcaismo. Ma vi è nel Talmud un caso a cui pur non badò il Rapoport per triplice ragione, conchiudente in favor nostro, non solo perchè Negheb vi è usato per mezzogiorno di Palestina; non solo perchè tutto il frammento affetta uno stile ricercato e arcaico, ma anche perchè fu usato appunto quando s’intese a significare (come nel nostro caso) la gran scienza dei dottori meridionali. Narra il Talmud (Irubin pag. 53) di varj dottori che affettarono talvolta uno stile figurato e antiquato, e tra gli altri accennando ad un collega che si era ritirato nel Darom presso quei valenti teologi, per impararne la dottrina, si dice «Nitiaaz bemahtir veinghib limfiboscet» si volse al sud verso Mefiboscet, lochè, secondo comenta Rasci, vuol dire:—Si partì pel mezzogiorno di Palestina verso i Zikné Darom sopra gli altri tutti dottissimi, e perciò detti Mefiboscet per la sua gran scienza ch’era causa a David di vergogna. Le conseguenze si fan vedere ad ognuno. 1ª Negheb, pel mezzogiorno di Palestina. 2ª Impronta di vetustà come nel nostro caso. 3ª Infine usato ad indicare, a celebrare i dottori di quelle regioni.
Il sig. Rapoport, come dicemmo, crede che questo sia uno dei casi in cui si riferiscono dal Talmud le dispute o le divergenze occorse fra i savj gentili e quelli d’Israel. Ma se questa fosse la intenzione talmudica, non già colla semplice designazione di Vakahomim omerim avrebbe indicata la dottrina israelitica, che ritorna solo allora che sorge controversia fra i dottori israeliti medesimi, ma coll’altra più peculiare ed esclusivamente usitata di vekakmè israel omerim come ad esempio nel Talmud (Pesakim) ove è questione del moto delle sfere e degli astri.—Non si nega per questo che la menzione della dottrina del Kakamim ed il ragionamento che segue non possano essere stati aggiunti posteriormente al racconto primitivo, ma in ogni caso provano ad esuberanza come a senso di chi operò tale aggiunta, e che non può esser posteriore al Talmud, i savj con cui parlò Alessandro fossero israeliti. E se ciò resulta da una aggiunta, resulta non meno da una frase inseparabile dal tessuto primitivo, ed è quella di Ziknè Anegheb come abbiamo veduto. Altro indizio non meno appartenente al tessuto primitivo è la prova che i savj del mezzogiorno traggono dalla genesi (Scenneemar) a provar l’anteriore creazione del cielo. Avrebbero ciò fatto savj gentili? Il sig. Rapoport dirà che anche questa è una intercalazione arbitraria. Ma in primo, ella fa troppo parte integrale della redazione primitiva, per autorizzare il supposto; e poi, prova ad ogni modo come il Talmud, anzi le versioni anteriori al Talmud tenessero per fermo non altro essere i Zikné Angheb, che dottori israeliti.—Questi alla domanda di Alessandro, quale tra luce e tenebre abbia preceduto, si tacciono. Il Talmud dà a questo silenzio un motivo che non si acconcia che ad uomini israeliti. E qui come ognun vede il carattere israelitico investe l’ordine stesso dei fatti, ed appare manifesto in uno dei suoi più singolari incidenti. Si dirà qui pure che il silenzio loro ebbe altro motivo, e che il Talmud ne escogetò tale che consuonasse colla origine israelitica degli interrogati? Ma allora conviene trovare quale sia questo altro motivo: e in ogni modo sarà una conferma di più, che il Talmud non dubitò mai dell’ebraismo di quei dottori.
Ecco però l’argomento capitale, l’Achille dell’illustre Rapoport; ma che però, come l’eroe di questo nome, ha veramente vulnerabile il calcagno.
Alessandro nel dialogo in questione conclude con questa domanda: «Perchè ci avete voi combattuto?» E i dottori:—Satan vinse.—Ebbene, dice Alessandro, voi sarete uccisi per regio comando.—Ed essi:—Il potere è in mano dei Re; però ai Re non si addice mentire.—Qui il sig. Rapoport pone, e non a torto, in rilievo quanto la opinione che in questo combattere intende un dissenso religioso, il perseverare nell’Ebraismo, sia comento piuttosto forzato; ma non avremo però bisogno per fuggire da questa chiosa improbabile ricorrere ad una vera e propria guerra, la quale verrebbe, a senso suo, da Alessandro rimproverata ai sacerdoti indiani, quali istigatori di quella tra esso e Poro combattuta. Perocchè noi diciamo: Come non un cenno, nè del teatro, nè della causa di questo rimprovero, nella narrazione talmudica? Bisogna dire o che di gentili qui non si può parlare, o almeno che gli autori della redazione che noi abbiamo sott’occhio intesero per questi savj del mezzogiorno, veri e proprj Israeliti; resultato al quale inevitabilmente riusciamo, da qualunque parte prendiamo le mosse. Ma è poi inesplicabile la conclusione del dialogo senza la divergenza religiosa, o la vera e propria guerra? A credere mio, una terza via, ed è la buona, ci viene indicata dal Moarscià, il quale vede nel rimprovero d’Alessandro un lamento superbo della libertà colla quale avevano avvilito ogni più cara cosa, onde egli andasse superbo;—la Scienza, quando risposero che il vero savio è l’uomo previdente, e quanto poco egli lo fosse, gli avvenimenti il dimostrano; il valore, il coraggio, quando dissero vero prode colui che vince le passioni, nè di questa maniera di prodezza ebbe Alessandro. Gli averi, i beni, la potenza, quando chiamarono, solo ricco colui che è lieto e sodisfatto di quanto possiede.—Qual più amara ironia della vita e delle idee di Alessandro! Ma esso è preso più evidentemente di mira in altre loro sentenze. S’ei chiede qual sia il modo di goder la vita essi rispondono di mortificarla. S’ei cerca il mezzo di tornare agli uomini accetto, essi gli additano il sistema opposto a quello che ei seguiva, quello cioè d’odiare il regno ed il potere. Ed è appunto per questa costante censura di tutti i suoi atti, e del suo genio, ch’ei chiede: «Perchè mi combatteste?»—E si noti che Atrastun, che è il verbo che noi traduciamo per combatteste, deriva da Taris, scudo, arma esclusivamente difensiva, ed ha un senso peculiare che si addice molto più a una lotta verbale, a una ardita confutazione o meglio apologia o diatriba, che a una lotta a mano armata. Basta dire che il Talmud chiama Targati (Baalè Terissin) i campioni più abili nella controversia religiosa (Talmud Berakot) e che quell’altra sola volta in cui questo verbo è usato nel Talmud (Jevabot, 121) è appunto nel senso che noi crediamo, vale a dire di un’ardita opposizione scientifica, come a un dipresso noi diciamo oggi Polemica da Polemo guerra in Greco a significare ogni maniera di Controversia. Che rispondono i Zikné Anegheb ai lagni del Macedone? Satan vinse.—Per quelli che veggono nella sua domanda un senso religioso ciò vuol dire:—«Satan vi vince e seduce coi sui errori, quindi fra noi opposizione nel sentire religioso»—e questa interpretazione, come si disse delle orazioni di Demostene, pute di lucerna. L’altra del Moarscià non è meno infelice; il senso suo significa, Noi tuoi avversari (Satan) ti vincemmo colle ragioni. E pel sig. Rapoport che vuol Alessandro lamentarsi delle loro istigazioni alla guerra, che cosa significa? Egli nol dice. Per noi il senso ci pare ovvio. Alessandro si lagna del loro ardito linguaggio. Essi si scusano dicendo. «Satan vinse.» Vale a dire, fu un mal genio che c’ispirò questo parlare a te increscioso.—L’idea del predominio di Satan per significare una sventura che incoglie è usata nel Talmud dal medico e astronomo Samuel, Satanà bitrè ummé la sciallit; e ciò che più monta, ragionando come ragionano i dottori del mezzodì, con un pagano, vale a dire coll’amico suo Ablat, che noi abbiamo gravi motivi per credere non altri essere che lo stesso celebre Plotino fondatore della scuola Neoplatonica di Alessandria.—Un altro segno che questi savj sono sacerdoti tebani, è pel Rapoport (pag. 71) il suggerimento che porgono ad Alessandro per poter penetrare senza pericolo nei deserti affricani. Notiamo come poco innanzi (pag. 69) ei vi vedesse piuttosto etiopi o brami, e che ora divengono sacerdoti tebani come più atti a porgere di questa specie consigli. Non sarebbe però questa la prima volta che nel Talmud, filosofi e principi pagani ricorrono ai dottori ebrei per lume e direzione; testimone fra gli altri i messaggi che Antonino inviò ripetutamente a Giuda il santo per consultarlo intorno ad affari di stato.—Ciò che non dee tacersi però si è, come per espressa dichiarazione del Talmud questi suoi consiglieri, con cui di nuovo confabula al suo ritorno, sono Rabbanan, vale a dire i nostri maestri. Sono essi che vedendolo sorpreso perchè tutto il suo argento e l’oro non bastasse a contrappesare un occhio che aveva riportato dalla sua visita in paradiso, gli porgono il consiglio di provare a porvi sopra un po’ di terra.—Lo che fatto, torna al suo peso naturale. Ora non è difficile scuoprire in questo significantissimo consiglio la impronta della precedente conversazione con Alessandro, lo stesso indirizzo morale, che in quella apparisce. E se autori del primo sono Rabbanan, mestieri è credere che eglino stessi siano i primi interlocutori.
Fosse pure provato che un doppio strato d’idee, di locuzioni si distinguono nella redazione talmudica, che il primo appartiene ad età più antica e nulla abbia di ebraico, l’altro ad epoca più moderna e abbia israelitica impronta: ciò che non potrà in ogni caso negarsi si è, che a senso dell’ultima e definitiva redazione talmudica tutte le cose quivi narrate si riferiscono ai dottori ebrei abitanti nel mezzogiorno. Ora quando pure ciò non avesse nessuna realtà storica, basterebbe, nonostante, al nostro supposto, e bisognerebbe vedervi egualmente un’allusione all’Essenato colà abitante. Giacchè non è possibile che il Talmud attribuisca tutti i fatti e gli incidenti occorsi tra Alessandro e i sacerdoti tebani, ai dottori abitanti del mezzogiorno, se ai tempi medesimi che quest’alterazione si operava, nella tradizione più antica, non fossero esistiti dottori i quali tutte le qualità riunissero atte a rendere verisimile l’applicazione che ad essi si faceva di ciò che spettava in origine ai brami o ai sacerdoti d’Egitto. Non è possibile, in una parola, che il Talmud rapisca ai suoi veri proprietarj una veste per ricuoprirne un Ente imaginario. E ciò basta, come diceva, per vedere nella intenzione dei redattori del Talmud una allusione trasparente allo Essenato. Questo resultato, non è critica che ci possa rapire, ove pure si meni buona la ipotesi dello illustre Rapoport.
[50] Il comento Tossafot osserva (loc. cit.) come dal contesto apparisca esser gli anziani del mezzogiorno, dell’ordine dei Taneiti. Il sig. R. Rapoport Erek Millin, alla parola Alessandro a p. 73.—crede poter fondarsi su quanto si legge (Talmud ivi pag. 22.) Tacah lehu Res Lachis lidromaé; per dedurne che appartengono piuttosto all’ordine successivo degli Emoraiti. Veramente la frase Talmudica non prova; e tanto meno, quanto non si osserva nel contesto quella forma dialogica che sarebbe stata seguita ove Res lachis (degli Emoraiti) avesse coi dottori del mezzogiorno confabulato. Ma ove pure fosse provato che vi erano dottori meridionali che appartenevano all’ordine e all’epoca degli Emoraiti, ciò non osta affatto al supposto che fossero Esseni, siccome noi veramente crediamo, poichè Esseni esistevano in Palestina tanto ai tempi tanaitici quanto a quelli più tardi degli Emoraiti. Anzi, a veder bene, questo trovarsi nel Talmud dottori designati coll’epiteto semplicissimo di meridionali, tanto in tempi antichi che in altri posteriori, prova che si volle con ciò alludere piuttosto a una famiglia di savj che aveva stanza comune e legale e conosciuta in quella contrada, che non a una dimora arbitraria che avrebbe lasciato sempre incerto, di quai dottori a preferenza si favellasse.
[51] L’ebraismo biblico non ha mitologia. Ciò fu da lungo tempo notato e valse a provare sempre più la sua divinità e la superiorità dei nostri sacri libri sulle mitologie paganiche. Però di questo fatto vero in generale non è qui luogo a parlare. In ogni modo questo invertimento d’epoche nella storia dall’ebraismo, questo precedere inatteso, irregolare del vero, e dello storico, del proprio,—al mito, alla finzione, al figurato;—questo tardo comparire della mitologia nello Ebraismo che non comincia fra noi a spuntare che colla cessazione dell’era profetica, e col principiare dell’era rabbinica, è fatto eloquentissimo che dovrebbe dare grandemente a pensare. Non par egli mostrarci a dito che fino a quest’epoca ultima, la mente ebraica, il pensiero umano si rimase ozioso, supplito com’era da una potenza superiore che ispirandolo a suo grado, gli risparmiava naturalmente quelle fasi, quelle transizioni che lasciato a se stesso non può a meno di percorrere; e che appena cessata questa azione straordinaria sul pensiero ebraico, vale a dire al cominciamento dell’era rabbinica, la mente ebraica si trovò a quel punto istesso in cui la mente pagana si sentì all’esordire della sua civiltà, e cominciò allora soltanto a svolgersi per tutte le fasi che le sono naturali? Noi non facciamo qui che accennare una idea, la quale esigerebbe il massimo sviluppo, a cui siamo certo preparati, ma che il luogo non comporta. Ciò valga soltanto a spiegare la parola Mitologia di cui ci siamo valsi ad indicate la Letteratura Agaditica del Talmud.
[52] Vi è in ambo i Talmud un frammento che sembra ostare alla superiorità da noi attribuita ai meridionali, nella scienza dell’Agadà, e quindi sopprimere uno dei punti di contatto che tra gli Esseni abitatori di quelle regioni, e la scuola dei teosofi cabbalisti, abbiam creduto ravvisare. Pure dopo breve esame parvemi vedervi piuttosto ragione di confermarmi sempre più in questo supposto. Ecco i due frammenti preziosi anche per altre conclusioni che sarebbe ovvio inferirne, se qui ne fosse il luogo.—Nel Babilonese si legge (Pesakim V. 62). R. Samlai presentossi e R. Johanan dicendogli: Insegnami, ten prego, il libro delle Genealogie. (Sefer Johassin). Risposegli: D’onde sei tu? da Lydda. E ove dimori? In Neardeà. Non è lecito dunque (replicò) insegnarlo, ne a quei di Lyddà, ne a quei di Neardeà.—E nel Gerosolimitano al luogo istesso.—R. Samlai presentossi a R. Jonatan dicendogli: Insegnami, ten prego, l’Agadà. Risposegli: Ritengo per tradizione dei miei maggiori, di non insegnare Agadà, nè a’ Babilonesi nè ai meridionali, perchè sono alteri, e nella legge dappoco. Tacciamo di molte altre rivelantissime considerazioni che il confronto dei due testi ne suggerisce;—della equivalenza di Sefer Jokassin (Talmud Gerosolimitano) e d’Agadà (Babilonese); di una non meno pronunciata avversione pei Babilonesi che si riscontra nel Zohar; dell’alterigia, ostacolo all’insegnamento della Agadà; come la umiltà fu titolo e pregio singolarissimo per penetrarne i segreti come più oltre vedremo; della importanza che assume l’Agadà in ambo i frammenti; del carattere tradizionale e antico di questa trasmissione a segno d’avere ricevuto per tradizione le regole della trasmissione medesima; del personaggio di R. Samlai—qui studiosissimo dell’Agadà, e celebre nelle pagine del Zohar (76, 2.) come maestro di penitenza, sotto il nome eloquentissimo di Asià, medico o terapeuta;—della identità del Darom (mezzogiorno) del Gerosolomitano con Lydda (Lud) del babilonese frequente soggiorno dei teosofi nel Zohar, e d’altre per avventura non meno importanti considerazioni. Domanderemo soltanto come conciliare la scienza, la celebrità altrove vantata dei dottori meridionali nelle dottrine dell’Agadà con questo rifiuto d’insegnarliela, che sorprendiamo in bocca a R. Jokanan o Jonatan? Specialmente ove si abbia occhio al motivo che di questo rifiuto si narra—l’alterigia loro e la inferiorità nella scienza religiosa. Ma la obbiezione si tramuta in prova, solo che si attenda al comento di Rasci, il quale, non saprei dire troppo il perchè, non vede nel motivo allegato al rifiuto che un pretesto, e riduce per conseguenza la negata trasmissione a un giudizio poco favorevole che dell’attitudine personale del richiedente, avrebbe fatto R. Jokanan o Jonatan. Difatti si legge in Rasci—che non ebbe di mira così dicendo che a respingerlo con un pretesto—o meglio perchè Babilonesi e meridionali non hanno sicura genealogia in Israel.—Ognun vede come nella prima alternativa l’ostacolo è scomparso; ma non tutti veggono a prima giunta come nella seconda sia trasformato in appoggio. Non si comprende invero come Babilonesi e meridionali non hanno sicura genealogia in Israel, dappoichè sappiamo che Essa non si partì da Babilonia, finchè non la lasciò quasi farina schiettissima; come si esprime il Talmud e che il Darom o Lud era parte di Palestina ove pare inconcepibile che vivessero uomini interamente d’origine spuria o dubbiosa. Ma si comprende benissimo ove in questi meridionali almeno si veggano i nostri Esseni, discendenza, siccome più sopra vedemmo, dei Recabiti e ramo gentile innestato in Israele, la gente aliena Benè Nekar di cui parla Isaia. Può darsi dunque che dopo tanti secoli scorsi dai Recabiti e dopo il continuo incorporarsi alla società loro di tanti elementi israelitici, quelli che erano conosciuti per discendenti da quei proseliti (che allor ve ne fosse lo sappiamo da R. Iosè, che è detto nel Talmud apertamente della prole di Jonadab ben Rekab) fossero tenuti in conto di meno degni di penetrare le dottrine agaditiche.
Checchè ne sia, ci sia lecito prima di passare ad altri fatti di osservare alcuni indizj che nel testo talmudico di Zebakim ove si parla di Jeudà Ben Dostai, e di cui si fe’ parola nel testo, ci conducono per altre vie alla società degli Esseni.—È il primo il nome peculiare che il Talmud dà a questo Ieudà ed ai suoi, di Parouscim farisei per eccellenza, nome che essendo comune a tutti i dottori, e che da se stessi si dànno, non può essere inteso che come una più onorifica designazione: quasi i più farisei tra i farisei. Il secondo è il fatto che il comento di Rasci pone in luce quando dice che Ieoudà e il figlio elessero stanza lungi da Gerusalemme per non recarvisi nelle feste, nè sacrificare l’agnello pasquale, nè gli altri sacrificj di Haghigá. Non par egli porgerci la chiave di quel dato singolarissimo che ci somministra Giuseppe intorno gli Esseni dicendoci che non entravano nel tempio per sacrificarvi; e che tanto sembra opporsi alla identificazione loro colla parte più eletta dei farisei? Avremmo dunque nel fatto di Jeoudà ben Dostai la spiegazione di questo astenersi, e in guisa l’avremmo da dissipare ogni nube che sembra elevarsi sulla identità da noi propugnata. Non si dimentichi che Jeoudà è più antico di Giuseppe, di quasi un secolo e mezzo.
[53] Poche linee più sopra, il gran maestro della Teosofia piange di un pianto di gioja. Qui è il bacio che officia come segno di fraterna approvazione. Ambo, a parer mio, indizj significantissimi. L’uno e l’altro provano come questi farisei così posti in mala voce per formalismo, per insensibilità, per ipocrisia, fossero d’una sensibilità, così esquisita da prorompere frequentissimamente in quelle dimostrazioni spontanee che ne sono il più efficace argomento; e che d’altra parte tanto bene si acconciano a quel Misticismo che noi vediamo nelle loro dottrine. Chi scinde i dottori zoaristici, i mistici dai dottori talmudici, non poco dee durare fatica a spiegare quella pronta, vivace, energica estrinsecazione dei proprj affetti che negli uni come negli altri apparisce ad ogni tratto.
Ma se la gioja, il pianto, il bacio fraterno, attestano indistintamente qual cuore si avessero questi farisei calunniati, l’ultimo specialmente, il bacio fraterno, ha una significazione particolarissima in quanto accenna a quella filiazione di cui altre volte toccammo del primitivo cristianesimo, e dei suoi più eminenti rappresentanti, dalla famiglia dei mistici farisei e dei teosofi, si appellino essi Esseni o Kabbalisti. Non è troppo il dire che spesso più nelle piccole analogie che nelle grandi, più nelle minute circostanze che nelle linee più prominenti, si vede la vera affinità e derivazione dei sistemi; perciocchè le prime come più particolari più urgentemente ne fanno fede che non le seconde, siccome quelle che essendo più generali, è più agevole il supporne la fortuita apparizione simultanea in varj sistemi. Così, a mo’ d’esempio, il bacio di cui è discorso. Chi conosce il Zoar sa che non v’è cosa che vi torni più di frequente.
Ma ciò che più monta si è che negli altri monumenti rabbinici come Misnà Talmud, ecc. o non vi si nota, o se tu ve lo scorgi, egli è solo in quei casi in cui dei Misteri è parola.—Per esempio della Mercabà o carro di Ezechiele (V. Talmud trat. Haghigà, 14). Non è questo eloquente indizio che questa forma di approvare e di salutare era peculiarissimo un genere di studj, a quelli cioè dove ebbe culla il Dogma Cristiano? Che sarà se vedremo poi il bacio fraterno apparire nei Vangeli e tra i fondatori della fede cristiana come saluto consigliato e approvato? Salutatevi, dice Paolo, (Ep. ai Rom. sub fine) gli uni gli altri con santo bacio.—E così I. Corint. XVI, 20.—2ª Corint. XIII, 12.—1ª Tessal. V, 26.—I. Piet. V, 14.—Nè mancò neppure chi lo avvertisse. «Dès l’origine de l’Eglise la coutume s’introduisit parmi les Chrétiens dans leurs Assemblées de se donner le baiser de paix. (Bergier. Diction. de Theolog. III. 571.)» Forse non sarebbe erroneo aggiungere che quest’uso fa fede d’un’antichità particolare di quel consorzio, se si dee giudicare dagli esempi della nostra Europa, in cui non è raro vedere il bacio essere il saluto per eccellenza e la forma di esso più antica. Oggi pure in Inghilterra tanto è dire salutare che baciare. «Sous le règne de Henri VII, quand les arrières grand’-mères des douairières actuelles d’Angleterre saluaient un parent, un ami, ou même un étranger, c’était en échangeant avec lui un innocent baiser. Le mot salute est resté en anglais comme synonime de Kiss ou de baiser.—Revue Britannique, Mars 1860, p. 91.
[54] La mèsse è talmente abbondante, che non crediamo con quanto fu detto averla esaurita. Plinio aveva detto (lib. V, VIII,) degli Esseni, Gens socia Palmarum. Ora, oltre la residenza che abbiamo veduto scelta dai Teosofi nella regione delle Palme, il mezzogiorno di Palestina, non si dee tacere come nel Zoar ci si offrano spesso que’ contemplativi a ragionare all’ombra dei palmizj tuté diclé; che notarono la sessualità di quei vegetabili non solo, ma di tutte le creature dell’universo in questi termini. R. Eleazar e R. Hisà andavano per via, e vedendo due palmizi, l’uno maschio l’altro femmina, disse R. Eleazar a R. Hisà: Certo, tuttociò che vegeta sulla terra, è maschio e femmina non solo, ma eziandio tuttociò che cresce in seno al mare. È noto come Empedocle fosse il primo ad osservare la sessualità delle piante; ed Empedocle presenta più di una analogia nelle sue dottrine in generale coi teosofi nostri, sulle quali ameremmo fermarci, ma che i limiti di quest’opera ci contendono. Diciamo solo come il gran poeta e filosofo nostro Ben Gabirol, conosciuto e citato da tutto il Medio Evo sotto il nome di Avicebron, come con grandissima sodisfazione dei dotti, avvertiva l’illustre sig. Munh di Parigi, è reputato dal suo abbreviatore e traduttore Ben Falakira seguace fra tutti gli antichi a preferenza di Empedocle. E ciò torna tanto più verosimile in quanto sappiamo per confessione dei critici stessi più indipendenti, che tra Ben Gabirol e la Dottrina Cabbalistica o teosofia corrono numerosissime affinità a tal punto che fu creduto il primo modello e la seconda la copia. Ma ciò non toglie che questa particolare conformità del Zoar alle teorie botaniche di Empedocle, non abbia il suo valore. Quanto ai Dottori Essoterici abbiamo già avuto luogo di vedere nel raffronto da noi istituito tra le loro dottrine e quelle deposte nel libro di Filone de vita Mosys come della intima struttura delle Palme favellassero come favella la scienza odierna. È inoltre narrato nel Medras Rabbà, il fatto di due Palmizj che divennero fecondi quando ogni ostacolo fu rimosso che li divideva, lo che consuona mirabilmente con quanto narra il Verati, vol IV, p. 268. «È veramente degno di attenzione, scrive il Prof. Gaetano Savj, ciò che si racconta della Palma maschio di Brindisi e della Palma femmina di Otranto. Questa da lungo tempo pareva ed era sterile, ma allorquando ambedue furono cresciute a segno che gli spadui si trovassero al di sopra degli ostacoli che si frapponevano alla diretta comunicazione fra loro, la femmina abbonì dei frutti.»
Abbiamo nel testo veduto gli oratorj posti in mezzo ai campi. Là pure si studiava e s’insegnava ai discepoli. E nulla vi ha di più frequente non solo nel Zoar, ma nei libri essoterici non meno, che i Dottori meditanti o insegnanti ai discepoli all’ombra di un palmizio o di un fico. E molto sarei inclinato a credere che da questo uso derivarono le similitudini tolte dalla vita dei campi a significare la scienza sacra, le sue parti, e i suoi cultori. Forse anche altre allusioni si annodano nel nome Pardes, giardino, dato alla Teologia arcana, ma è probabilissimo che tanto esso quanto l’idea correlativa di guastare o sbarbicare le piante per indicare la introduzione d’errori, o la negazione di alcune verità, non d’altronde abbiano presa occasione a così dirsi. Non è da questo diverso il nome di Cherem (Vigna) dato alle scuole, ed alle accademie. Se pure non vogliasi vedervi una Vigna vera e propria ove si studiava, lo che non pare affatto inverosimile, egli è certo però che la interpretazione che si dà a questo nome, (antichissima, a dir il vero, perchè origina dal Talmud Gerosolomitano) e che significherebbe un luogo distribuito e diviso a guisa di Vigna, non è molto atta a sodisfare la buona critica. Non sarebbe piuttosto una derivazione o una reminiscenza della situazione delle scuole e delle accademie in mezzo a campi ed a vigne? Nè la similitudine quietò in questa idea generale, ma scese analiticamente a distinguere parte a parte i prodotti delle vigne e dei campi, ed a designare col nome di ognuna di esse, una delle parti più cospicue della scienza religiosa. Così il fiore della vite adombra la bibbia.—L’agresto la Misnà.—Il melogranato il Talmud (Irubim, Cap. II, V, ivi Moarscià che connette questa similitudine coll’altra generica della Vigna.) E altrove il grano Dagan significò l’Alakà, il Rito la legge, e il vino Tiros l’Agadà (si noti come Agadà a senso nostro sia la veste leggendaria della Teosofia; e come la Dottrina evangelica che non fu in origine che una Teosofia propalata prenda il nome nei vangeli stessi di Vino): Infine l’uomo pieno di scienza varia fu detto Escol Grappo (Sotà sub fine), come l’indotto, il volgo fu chiamato col nome di pampani che valgono a conservare e difendere i grappoli (ibhun rahamé aalaia deitcaiemùn atcalajà.) E per quanto valenti critici come il Rapoport vogliano vedere negli Aschelot (Sotà ibid) una corruzione o ebraizzamento di scuole, pure, tutto considerato, non si può a meno di conservare a questa locuzione, almeno come senso fondamentale e primitivo, quello proprio di Grappolo.
[55] Questa locuzione è comunissima nei due Talmud, e in generale nell’antica Biblioteca Rabbinica. Egli è da quest’uso che Gesù apprese a dire a proposito di Lazzaro morto, Lazzaro nostro amico dorme. (Gio. XI, 11). Ma ciò che torna incomprensibile egli è che uomini israeliti com’erano i discepoli, abbiano potuto fraintendere, e capire vero e proprio sonno, replicando: Se egli dorme sarà salvo (anche così dicendo si mostrano seguaci della terapeutica talmudica). Questo equivoco non troppo naturale in uomini che ascoltavano tuttodì dormire per morire e che dovevano in quest’ultimo senso tanto più interpretarlo, essendo Gesù a quell’ora troppo da Lazzaro lontano, per saperne tutte le più minute vicende (la morte siccome cosa troppo più importante poteva da essi presumersi conosciuta per chiaroveggenza profetica), farebbe credere che ei fu soltanto appo lo scrittore del quarto Evangelo, siccome dai tempi alieno e dai luoghi ch’ebbe nascimento, e ch’egli per induzione analogica pose a carico dei discepoli.
[56] Questo avveniva nella festa dei Tabernacoli, ed era in quei giorni che ricorreva la straordinaria esultanza ove, dice la tradizione, prendevano parte quasi esclusiva i Hasidim (nome a senso nostro più antico degli Esseni) ed i Pratici come fra poco vedremo; lo che ci riconduce per altra via, alla predilezione degli Esseni per le acque. Il Talmud dice apertamente che si nomava festa della Scioabà perchè di là attingevano (Scioabim) lo Spirito Santo, siccome è scritto: Attingerete acqua con esultanza dalle fonti della salute; e questo fatto come queste parole stringono in un sol fascio. Hasidim antica appellazione degli Esseni, la libazione delle acque; e la ispirazione onde furono celebrati gli Esseni, unione sopra ogni altra eloquentissima. Non taceremo come questa festa e questo Testo Rabbinico spargano gran luce sopra un passo del quarto Evangelo. (Cap. VI, V. 37.) Or nell’ultimo giorno, che era il gran giorno della festa (dal V. 2 apparisce che questa festa era quella dei Tabernacoli) Gesù stando in piè gridò dicendo: se alcuno ha sete, venga da me e bea. V. 38. Chi crede in me, siccome ha detto la Scrittura, dal suo ventre coleranno fiumi d’acqua viva. V. 30. Or egli disse questo dello Spirito il quale riceverebbero coloro che credono in lui.
1º Si noti la qualificazione di grande data all’ultimo giorno dei Tabernacoli, appunto come i Dottori lo chiamano il giorno del grande Osanna. Ma questo titolo ha un valore speciale in bocca a Gesù, perciocchè prova come non siamo andati errati in una Scrittura Ebraica, diretta a confutare le idee del Signor professore Luzzatto, quando asserimmo che il carattere penitenziale e solenne di questo giorno risale a tempi antichissimi. Fra gli altri cenni, questo dei Vangeli non è l’ultimo, mostrando Gesù, che invita in quel giorno a convertirsi alla sua fede, e chiamandolo gran giorno appunto come il Talmud Gerosolimitano chiamato giorno per eccellenza, e lo pone al fianco del Capo d’Anno (vedi mia opera citata). Non è da trascurarsi neppure come il gran giorno dei Vangeli per l’ultimo dei Tabernacoli, abbia non poca analogia col nome gran digiuno Zomà Rabbà dato dal Talmud al 10 di Tisri.
2º Gesù dice Se alcuno ha sete, venga a me e bea. Come non vedere in queste parole un’allusione, vuoi alle acque che si pregavano in quei giorni copiose per tutto l’anno, vuoi alla libazione delle acque nel Tempio che non si faceva mai, tranne quei giorni istessi? E si noti che Gesù proclama questo nel Tempio (V. Giov. VII, verso 14-28), ove questo rito si celebrava, e si mostra per ciò stesso fedele a quella trasformazione ch’egli mirava a operare nel culto ebraico sostituendo sè stesso al Tempio, e appunto chiamando sè medesimo col nome di Tempio, tanto quando promette distruggere e rifabbricare il Tempio in tre giorni, quanto allora che per giustificare i discepoli che profanavano il sabato, cita l’esempio dei Sacerdoti che eseguivano ogni illecita opera nel Tempio, e aggiunge: «Ora io vi dico in verità che vi è qui qualcuno maggiore del Tempio.» Gesù trasporta dunque nel senso figurato delle sue proprie dottrine il rito materiale che allora si celebrava, e neppure così facendo si dilunga dalle dottrine farisaiche, conciossiachè siano esse appunto che hanno detto «chiamarsi quella festa Scioabà perchè vi si attingeva lo Spirito Santo.» Ecco il senso metafisico innestato sul rito delle libazioni. E qual è il verso che s’invoca dai Dottori a sostegno? Quello appunto che dà Gesù. È vero che verso come quello da Gesù rammentato, non si trova affatto nella sua giacitura in tutta la Bibbia, ma è innegabile del pari che il verso a cui si mira (per qualsiasi ragione alterato) è quel che si legge in Isaja XII, V. 3 (non X, 4 come vuole Diodati) vale a dire attingerete acqua con esultanza dalle fonti della salute, che diventa in bocca a Gesù, dal suo ventre coleranno fiumi d’acqua viva. A spiegare la quale differenza, basta osservare che Gesù applica a sè stesso, ciò che il profeta intende per la salute politica e la morale, e i Dottori per la ispirazione. Quindi è che le frasi ebraiche prestandosi mirabilmente a tal metamorfosi—le fonti (Mahianè) da cui si attingerà l’acqua divengono—il Ventre del Messia—dicendosi in ebraico per ventre Mehé per fonte Mahian—ed anche Mahiane;—e la salute Jesciuha è sostituita dal sottinteso Messia Gesù—chiamato Jeosciua che suona all’orecchio come all’intelligenza, quanto Jescuha (Salute). L’imagine poi di ventre ricettacolo di dottrina, se suonerebbe impropria nelle nostre lingue, che per la scienza progredita esprimono più esattamente la situazione d’ogni viscere, è per contro comune e approvata nel biblico e nel rabbinico idioma, dicendosi nel primo: la tua legge nel mio ventre. (Salm.) Vetorateha betoh meai e nel rabbinico: Gioisci, o mio ventre, per dire vo superbo di aver raggiunto la verità.—Questa trasformazione torna tanto più accettabile, ove si riduca a memoria quanto più sopra dicemmo, dell’intendimento a cui mirava Gesù di sostituire o anteporre Sè stesso, le sue dottrine e la sua autorità al Tempio. Ma sopratutto torna qui opportuno notare, come la teosofia cabbalistica, che a senso nostro forma il fondo delle dottrine degli Esseni, e del primitivo cristianesimo, chiami fonte o pozzo di acqua viva Beer maim haim non solo il Tempio di Gerusalemme, (V. Nacmanide e com. al Pent. Sig. Vojerà) ma il suo prototipo, emanatistico—la Sefirà chiamata Regno Malhut e Tempio che è nella serie delle emanazioni—il principio della incarnazione, la umanazione del Verbo o Logo (Tifheret) lo che spiega come Gesù Avatara, chiami sè stesso Tempio, e a sè stesso arroghi l’epiteto di fonte o pozzo d’acqua viva. Si vegga anche nello stesso Vangelo di Giovanni, il colloquio di Gesù colla Samaritana e le parole significantissime che Ei vi pronunzia. Soprattutto non si dimentichi che lì come qui, è Gesù che proclama sè vera sorgente salutare, vera acqua, vero pozzo capace di dissetare. Nella scena del Tempio, come in quella del pozzo colla donna Samaritana, non saria possibile disconoscere le allusioni ai fatti, e alle dottrine dell’Ebraismo, e l’influenza mitica apparisce qua e colà evidente. Nel Tempio non solo, come dicemmo, Gesù ha di mira la ispirazione che in quei giorni reputavasi diffondersi sulle menti a guisa delle acque, che allora appunto l’unica volta in tutto l’anno si spargevano appo dell’altare; ma non si può negare nemmeno che qualche allusione non voglia egli fare eziandio al pozzo, su cui posava l’altare e di cui toccammo nel Testo. Nel colloquio colla Samaritana al pozzo, il Mito non è a parer mio meno sensibile. Chi ne voglia diffusa dimostrazione la troverà nel mio Essai sur l’origine des dogmes et de la morale du christianisme (Manoscritto premiato nel concorso dell’Alliance israélite universelle di Parigi). Solo ci piace qui di aggiungere, come la donna Samaritana si dica avere avuto sette mariti, numero e circostanza di conto indubitatamente cabbalistico, onde il principio d’Incarnazione, il Regno chiamato anche Pozzo, si dice il principio femminile di tutte le Sette superiori emanazioni, e perciò stesso chiamata ora figlia dei Sette Bat Sebah, ora l’ottava (Sceminit. Esmun egizio). Quanto al pozzo, un autore che se ne intendeva appartenendo egli alla Società dei liberi muratori, così s’esprime «Les puits étaient des emblèmes communs à toutes les initiations. Dans tous les temples égyptiens où on initiait, il y avait le puits où descendait le néophyte.... La Maçonnerie considérée comme le résultat ec. per R. D. S. vol. 2. p. 65.» La esistenza dei segni dell’esoterismo e della iniziazione nel Tempio di Gerusalemme, malgrado le apparenze contrarie, dovrebbe ammonirci come sia verissimo ciò che altrove dicemmo, cioè che la sola differenza tra il metodo pagano e l’ebraico in ciò consiste, che il primo pose l’esoterismo e il mistero nella teologia e la divulgazione nella mitologia, mentre il secondo fa patrimonio comune della teologia e pone il mistero nella mitologia, siccome quella che serve d’involucro non alla sostanza ma alla scienza dei Dogmi. Per modo che si può dire che il paganesimo non è che un ebraismo a rovescio.
[57] Alle cose esposte nel Testo vogliamo aggiungere come della sorgente che era nel Tempio ragioni eziandio Aristea nei frammenti riportati da Eusebio. (Prep. evang. ed Paris, vol. 2, pag. 51) Cette eau (che terge il sangue delle vittime) provient d’une source placée dans l’intérieur: source intarissable et abondante ec.; come i Dottori eziandio predilegevano le Rive come sede atta ai buoni studi, leggendosi nel Talmud Oraiot 3: quando leggete o meditate, fatelo, presso ai fiumi; così, in quella guisa che scorrono le acque, scorreranno pure le vostre cognizioni; e finalmente come questa simpatia e quest’uso condusse i primi cristiani a prediligere essi pure le rive, di cui non vogliamo citare qui che un solo esempio. E nel giorno del Sabato (si legge negli Atti, cap. XVI, V. 13) andammo fuor della città presso del fiume dove soleva essere il luogo dell’orazione, e postici a sedere, parlavamo alle donne quivi raunate. Una lettura del Vangelo mostrerà come quest’amor delle rive risalga sino allo stesso fondatore del Cristianesimo, il quale tolto lo ebbe senza meno alla Scuola Essenico-farisaica a cui appartenne.
[58] Queste cose andavamo tra noi stessi conghietturando privi, come siamo, del gran sussidio della letteratura germanica, quando la sorte ci fe’ imbattere in un illustre ausiliare, dell’amicizia del quale ci onoriamo, ed è il sig. Jost nella Storia del Giudaismo e delle sue sètte. Ecco la traduzione delle sue parole recate in idioma francese: «Les Esséniens n’observaient pas si rigoureusement les scrupules rabbiniques sur la transcription de la loi orale, et les Meghillat Setarim mentionnés dans le Talmud ont été écrits par des Esséniens.» Il Redattore dell’Univers israélite, che riproduce queste parole, a torto aggiunge: «Nous ne connaissons quant à nous que les Meghillat Setarim de R. Hija:» dico a torto, perchè altre pure ve ne sono, e la nostra del Talmud Gerosolimitano è tra queste. Che si tratti poi di volumi scritti e non di libro ed opera, lo attesta il verbo Catub che nel citarli si adopera, come il nome di Meghillà indicante invariabilmente volume e non opera, come saviamente avvertiva giù Rasci sul Talmud (Irrubin).
Come astenerci dal rammentare altro autorevolissimo erudito tedesco (specialmente in tutto che tende a favorire l’antichità della teosofia ebraica, alla quale si protessa avverso), ed è lo Zünz di Berlino il quale così esprimesi, Cap. VII.: Altra opera pregerolissima andò perduta la quale ragionava di Morale e di Civiltà (Dereh Erez): è chiamata talvolta Meghillat Setarim vale a dire libro in cui si ragiona di misteri; tal altra Meghillat Hasidim, il libro dei Hasidim. Quindi apparisce come questa opera non di leggi rituali soltanto favellasse, secondo che altri pensò, ma più e meglio di Morale e di Dottrina; e tanto significa il nome che reca, e quello eziandio che per entro vi è contenuto. Due punti pertanto emergono dall’opinione del Zünz 1º Che Meghillat Setarim e Meghillat Hasidim non sono due opere, ma una soltanto; 2º Che reca il nome di Setarim pei misteri ch’ella conteneva. L’autore del Rabia ed Ofen, 1837, benchè di gran lunga più ortodosso del Zünz, non consente nelle conclusioni rammentate, e crede che lo Zünz siasi indotto a credere alla identità delle due opere pel fatto che il Ialcut Simeoni, pag. 73. 2, chiama Meghillat Setarim ciò che altre opere (Talmud Gerosolimitano e Sifré) chiamano Meghillat Hasidim. È lecito credere però che non solo questo sia il motivo che della identità fece persuaso lo Zünz; sibbene ancora l’intima convenienza di libri misteriosi ai Hasidim noti nella storia come proavi degli Esseni, come accennammo e accenneremo più volte. Ma il nome di Meghillat Setarim significa veramente libro de’ misteri, come vuole lo Zünz, o piuttosto libro apocrifo (nascoso), come pare intendere Rasci ed altri, e come oppone il Rabia? Noi inclineremmo a credere come il primo, per certe analogie rabbiniche che lo persuadono. Difatti Meghillat Setarim ha la stessa forma che Bet Assetarim. Ora è indubitato che quest’ultimo lungi da significare il luogo riposto, suona invece il luogo ove stanno le parti riposte; così Meghillat Taanit, significa il libro ove sono descritti i digiuni, e non il libro digiuno.—Meghillat Joasin suona il libro che contiene le Genealogie e non il libro Genealogico,—Meghillat Sammamanim vuol dire il libro ove sono descritti i profumi e gli aromi, e non il libro profumato.—Meghillat Kinot, il libro che contiene le elegie e non il libro elegiaco. Non si vuol dire con questo che il Meghillat Setarim non fosse libro riposto oltre il contenere dottrine riposte, che ansi il primo fatto è conseguenza del secondo; nè si vuol negare che contenesse anche disposizioni rituali, ma non si deve nè si può concludere, come fa il Rabia, dal fatto che non sono citate che queste nel Talmud, che altro non vi si contenesse, stante che il supposto da cui si muove, cioè il carattere misterioso delle altre dottrine, impediva che queste pure si citassero. Inoltre vi sono certi caratteri persistenti in tutte le citazioni che del Meghillat Setarim si fa nel Talmud, che formano a parer mio grave indizio della sua parentela Essenico-cabbalistica. Basti osservare: 1º Che nei tre luoghi onde di essa è menzione nel Talmud (Sciabbat p. 6, 2, e 96. 2 Mezia 92, 1) egli è sempre Rab o R. Abba, che dice averla letta e ne riferisce i dettati; ed è sempre presso R. Hija ch’ella fu trovata. Ora Rab e R. Hija sono due personaggi eminentemente teosofici, l’uno come redattore presunto da Zoar di parte di esso, l’altro come uno del soci (Haberim) e interlocutorio. 2º Il Mazati (trovai) onde si vale invariabilmente Rab nel riferirne il contenuto, tanto poco conviene ad una raccolta di ricordi rituali che dovevano essere frequentissimi e molto letti e studiati, quanto bene si acconcia a libri e dottrine per loro indole misteriose. Altrettanto si dica del Vecatub ba (Ed era in quello scritto) locuzione che torna nel Talmud solo allora che si tratta di libri esoterici come il libro di Balaamo (Sanhedrim XI), e quando la citazione non è consentanea al subbietto generale dell’opera. Lo stesso Isi ben Ieuda le cui parole si citano registrate in quel volume: vi è grave ragione di credere che sotto uno dei sette nomi che reca in Pesahim (113, 2) appartenga agli studiosi dell’Agadà, vale a dire della scienza esoterica.
[59] I dottori Talmudici, se quando ripetono le ricevute tradizioni sono Autorità religiosa nell’Ebraismo, non così quando spiegano, e sono allora discutibili come qualunque altro dottore. Ciò intesero ab antico i più antichi loro successori, i quali spinsero soventi volte l’ardimento sino ad interpetrare il testo misnico diversamente da ciò che fecero i Talmudisti, lo che è bene altrimenti grave che non il trovare inesatta la spiegazione di un fatto per loro stessi remoto, e del quale non era imposto loro il ricordo quai maestri di religione. Di questa e maggior libertà usarono anche largamente i moderni, comecchè in fama di Ortodossi quale il Rapoport nel suo Ereh Millim altra volta citato.
Quanto all’orazione protratta e quasi continua che nel Talmud si attribuisce ai Hasidim, non è a tacersi un curioso raffronto che ci porge la storia delle Eresie. S. Epifanio rammenta due ordini di Messaliti, nome notoriamente derivato dall’Arameo Zalla o Zalle pregare (V. Bergier Dict. de Theologie vol. 3º p. 246), i quali s’imponevano la preghiera continua, che credevano adempisse le veci di ogni altro dovere. Non è difficile ravvisare nel più antico di questi due ordini le fattezze dei nostri Hasidim, coi quali se non s’identifica assolutamente, pare senza meno un ramo Cristiano del più antico ceppo Ebraico. È vero che S. Epifanio dice di questo più antico ordine nè Cristiano essere, nè Ebreo, nè Samaritano; ma si rifletta alla distanza di luogo e di tempo che divideva Epifanio dai nostri Hasidim, alla vita eccezionale e in tante parti discordante dalla comune Ebraica che menavano i nostri Hasidim, o Messaliti, e chiaro si vedrà come l’asserzione di Epifanio non ci toglie la pensata affinità tra i suoi Messaliti ed i Hasidim del Talmud; onde non è da redarguirsi Scaligero se negli stessi eretici vede una frazione degli Esseni. (V. Bergier, Ibid.)
A costo poi di precorrere in parte le cose che saremo per dire, il testo talmudico, onde qui si ragiona, ci mena irresistibilmente, per l’affinità delle idee che qua e colà si acchiudono, a far menzione sino da ora di parecchi e preziosi testi antichissimi riferiti nel Talmud, ove sotto un altro nome eloquentissimo si allude, a creder mio, alla società degli Esseni; e che sono da porsi fra quelle tante memorie che debbonsi oggi restituire alla storia degli Esseni contro la divulgata sentenza che l’Enciclopedia rabbinica dei primi secoli non rechi della società degli Esseni niun vestigio. Questo nome che offre invariabilmente l’idea comune e in sommo grado rilevante di Società, di Sodalizio assume non dimeno tre forme: differenza che a senso mio ad una sola cagione debbesi ascrivere, alla diversa origine e stile dei testi che ne fanno menzione. Queste tre turme sono: 1º Cheillà Caddescià di beruslem (Santa Società ch’è in Gerusalemme); 2ª Edà Chedoscià (Santa Società); 3ª Bene Akeneset (figli della Società). Incominciamo per dire (e per quanto negativo, ci sembra fatto di gran calibro) che le interpretazioni date sinora o sono vaghe o mal sicure; che p. e. per la Keillà Caddiscià mentre il Talmud Gerosolimitano (Mahaser Sceni, cap. 2º) intende due soli dottori ivi nominati (interpretazione, come ognun vede, tutt’altro che seria o verosimile), il Talmud Babilonico ci pone nella impossibilità di sottoscrivervi porgendoci non pochi esempi in cui la stessa Santa Società (Keillà Kaddiscià) si distingue evidentemente da uno almeno de’ due Dottori, onde a detta dello altro Talmud è composta, a segno di figurare al suo fianco come indipendente e distinta (Vedi Talmud Bezà e Iohasin Lettera Iod al nome Iose ben Mescuillam). Che per la Edà Chedoscià (Santa Società) il suo nome si legge nel Medras koelet, ove, oltre altre preziose indicazioni che proveremo fra poco convenientissime ai nostri Esseni, si domanda: E perchè si chiamano Santa Società? Dopo queste parole occorrono due varie lezioni. La prima è quella del Lessico Aruh (alla parola Kaal) ove si risponde «perchè dividevano in tre parti la loro giornata, la prima dedicavano alla preghiera, la seconda allo studio, la terza al lavoro, altri dicono perchè studiavano nell’inverno e lavoravano nella state.» L’altra versione legge dopo la domanda ricordata: Perchè sono R. Iose ben Mesciullam e R. Simon ben Manasia i quali tripartivano la loro giornata ec. L’autore dell’Aruh non ha i nomi proprj rammentati, e niun dubbio che la sua lezione sia da preferirsi non essendo luogo a rammentare chi fossero, dopo aver domandato perchè si nomassero Santa Società. Checchè ne sia, abbiamo qui un motivo del nome loro che mirabilmente si addice al nostro Istituto del quale sappiamo come la preghiera, lo studio ed il lavoro dividesse tutto il loro tempo, come più oltre vedremo. Si avverta però che mentre queste indicazioni si attagliano agli Esseni, non è possibile convenire col Medras Koelet che per ciò solo prendessero il nome di Santi, non essendovi in questo tenore di vita niun carattere che meriti il nome di Santo per eccellenza, e che non sia comune ad altra maniera di dottori. Infine il terzo nome ch’è quello Bene Akeneset ricorre come abbiamo detto nella misna Zabim 3, p. 2. E qui ancora, siccome quello che suona straordinario ed eccezionale, non solo creò interpretazioni disparate, ma diè luogo a differenti versioni. Così il Maimonide nel Comento legge Bet Akenesset il Tempio; ma chi legga attentamente il testo di leggieri s’accorgerà come il senso venga da questa interpretazione forzato, non essendovi memoria che i lebbrosi e gli affetti di gonorrea avessero luoghi apportati nei tempj. Assai meglio però l’altro comento di R. Simson che legge come noi Bene Akenesset e intende oheli hulleen betaará vale a dire coloro che non si cibavano che di cose pure, alieni da ogni immondo contatto; lo che da una parte identifica i Bene Akenesset con altro ordine e nome molto più comune nel Talmud, quello di Haberim o Socj che avremo luogo di ripetutamente citare in questa storia, i quali appunto questo tenore di vita conducevano, e dall’altra porge la mano ad un preziosissimo passo del Talmud Gerosolimitano ove un Asseo (Asia) possessore e insegnatore di nomi divini misteriosi si dice cibarsi di Maaser.
[60] Possiamo ragionevolmente esitare a riconoscere sotto questi varj nomi la società degli Esseni? La loro convenienza non potrebbe essere più manifesta. Il nome di Keillà Caddiscià, Santa Società, che fra gli altri luoghi si legge nel Talmud di Ioma 69, 1, reca tutti gli elementi necessarj a costituire il nome vero e proprio dei nostri Esseni. Chi ha sentore dello stile misnico e talmudico non può non fermarsi al nome di Keillà, unico, meglio che raro, per designare una Società qualunque, e che nel nostro caso tanto per la sua anormalità, come per la identità costante dei suoi supposti componenti, accenna meglio ad un consorzio regolare ed organico, che ad un adunamento precario e accidentale. Quanto poi eloquente l’epiteto di santo che in tutte le lingue sta ad indicare una perfezione religiosa, superlativa, e che nell’Ebraico è l’equivalente dell’Arameo Faruscim, Farisei. Potremmo d’altra parte tacere che il più antico nome onde si distinsero i Cristiani, propaggine secondo noi dell’antico Essenato, fu appunto quello di Santi come sovrabbondantemente attestano Vangeli ed Epistole ad ogni tratto? Nè recar deve fastidio la indicazione topografica di Biruslem in Gerusalemme, poichè se è indubitato che gli Esseni ponessero stanza sulle rive del Giordano sappiamo non meno di certa scienza, come Gerusalemme ne ospitasse parecchi specialmente dei Pratici. Che anzi, a parer mio, tale indicazione lungi dal dilungarci dall’Essenato, più e più ce ne avvicina, non potendosi comprendere come in un’epoca qual è quella in cui si fanno le citazioni in discorso, in cui Gerusalemme avea cessato di essere sede della autorità Rabbinica sottentrandogli in questo ufficio or Tiberiade ed ora altra città di Palestina, venga indicata costantemente Gerusalemme qual centro della Santa Società, se questa non si distinguesse spiccatamente dalla comune scuola dei Farisei, e non fosse per natura più aderente ai luoghi antichi, meno nomade di quello che erano le grandi individualità, ma pur non altro che individualità del comune Farisato.—Il secondo nome di Edà Keduscià, Santa Società offre lo stesso senso e torna egualmente a capello ai nostri Esseni. Più curioso e più nuovo è quello di Benè Akeneset, gli uomini della Società, abbandonato, se non erro, sinora in un canto nell’oscuro e negletto trattato Misnico di Zabim cap. 3º e che non meno si acconcia al nostro consorzio come evidentemente si ricusa ad ogni altra interpretazione, come più sopra accennammo.
Che se i nomi suonano in sommo grado espressivi al nostro uopo, ciò che più monta però, e che non mi è dato qui che in parte lambire, si è una indagine delle dottrine che in nome di questa Keillà Kaddiscià, o Edà Caddiscià o Benè Akeneset si recano in mezzo negli antichi libri Rabbinici onde si vegga sino a qual segno queste dottrine o idee si attaglino alla persona degli Esseni. Il secondo di questi nomi figura nel Medrasc Koelet; e ciò che merita di avvertire si è che qui come in Ioma, pag. 69, 1, Bezà, p. 27, egli è Giuda il santo, il Redattore della Misnà che riferisce la loro dottrina, lo che prova la grande loro autorità ed antichità ed insieme la identità della Keillà Kaddiscià del Talmud colla Edà Chedoscià del Medrasc; e che tanto in Rosc Ascianà 19, 1, quanto in Iomà (loc. cit.) egli è R. Ieosanah Ben Levi il personaggio più Cabbalistico e misterioso di tutto il Talmud, che è l’ultimo depositario delle loro tradizioni insieme a R. Simon Ben Pazl, altro dottore il cui nome e la cui storia sono celebri nelle pagine del Zoar. In due luoghi poi (Berahot, cap. I Rosc Ascianà, 19, 1.) ricorre la forma autorevole ed antica ehid, attestò, che non si usa se non quando è riferibile ad antichi personaggi. Non sono nemmeno da pretermettersi le dottrine che in nome loro si recano in mezzo.—Il lavoro raccomandato insieme allo studio, e la vita loro stessa porta ad esempio (Medras Koelet) il nome di sposa che ivi reca la legge, e sopratutto le decisioni attenenti al Calendario e ai computi Astronomici (Rosc Ascianà, 19, 2.) che non vanno mai disgiunti nei libri Talmudici dalla scienza Acroamatica, che ne hanno tutta la riserva e il mistero e che per ciò stesso sono detti pur essi (Sod) Mistero.
[61] Ei fu sempre e dovunque proprietà inseparabile dal Misticismo, la incuria e il dispregio delle pratiche. Il Talmud rivelandoci in seno ai Farisei una scuola che ad ogni pratica si credeva ed era stimata superiore, ci attesta per ciò stesso la presenza del Misticismo, non potendosi mai credere che se altri studj non si conoscessero tra essi se non quelli che il Talmud acchiude in seno, e che si riferiscono unicamente alla pratica, tanta fosse la stima che se ne faceva da anteporli alla pratica stessa, il mezzo non potendosi mai qualificare superiore allo scopo al quale conduce. Nonostante se il fenomeno comune ad ogni misticismo si verificò pure nel misticismo Palestinese, come vediamo, saria ingiusto disdirgli un’indole al tutto diversa da quella prevalsa in altre parti di Oriente. Mentre in queste era la contemplazione oziosa talvolta ridicola, la inerzia delle facoltà mentali, o come con più nobile nome si chiama la estasi, la quale era il sommo grado della perfezione perchè conducente all’assorbimento in Dio, o Nirvana; in Palestina invece era lo Studio, la Scienza, la speculazione attiva, il moto mentale, il discorso nel suo doppio senso, l’Alaha in una parola, sia che si riferisse alla pratica, sia che alle dottrine, la quale sola aveva virtù di dispensare, quando diveniva Abito permanente, dalla pratica dei doveri religiosi specialmente ove avea per obbietto l’acromatismo, la parte più nobile dei sacri studj. Non potrebbesi mai abbastanza insistere sulla presenza di questi fatti e queste dottrine in Palestina nel secolo che il Cristianesimo cominciò ad operare il suo distacco dal centro Ebraico, proclamando prima con Gesù e poi con Paolo la inutilità della legge e delle opere. Più bello, indizio non potrebbe darsi di quella verità perpetuamente da noi dimostrata nell’Essai sur l’origine des Dogmes et de la Morale du Christianisme (premiato nel concorso dell’Alliance Israélite 1863), vale a dire che non d’altronde originarono le dottrine cristiane se non dal centro Essenico-Cabbalistico ove il Cristianesimo imparò di buon’ora ad anteporre la scienza teosofica alla pratica dei precetti, la quale scienza ei propose all’universale sotto il nome di Fede (Pistis), agli eletti, sotto quello di Gnosis come superiore e dispensatrice di ogni dovere, e costituendo così, mercè la divulgazione dei dogmi riposti, tutto il mondo Ebraico e gentile in quello stato di perfezione peculiare ed anormale in cui l’Esseno-Kabbalismo poneva pochissimi eletti. Se qualche cosa ci sembra dimostrato, nelle tenebre delle origini Cristiane, questo transito ora accennato ne pare dimostratissimo, e lo stimiamo chiave unica capace di aprirci il senso di quella rivoluzione che scisse il Cristianesimo primitivo dalla Ebraica ortodossia. Basti per ora questo cenno del vasto e nobilissimo subbietto.
[62] Nome di origine persiana che i Greci adottarono, tipo del nostro Paradiso e che fa parte della lingua Biblica e Rabbinica. In questa ultima sta sovente a indicare la scienza o teologia recondita, e genera una sequela di metafore secondarie come ad esempio lo strappare le piante ecc. Facendo la scienza sinonimia di Paradiso, i dottori identificarono in guisa mirabile la beatitudine e la contemplazione, e furono in ciò imitatori e seguaci di Mosè che nel suo Paradiso pose la scienza, con tutti i suoi pericoli e con tutti i suoi diletti. Forse non si andrebbe lungi dal vero dicendo che il Paradiso Mosaico porse ai dottori la prima idea del loro Pardes, che vale quanto il Gan o Ganeden della Genesi.
Sarebb’egli possibile disconoscere nei vangeli la traccia dell’antico essenico costume, quando Gesù volendo col suo esempio mostrare come i maggiori debbano farsi servi ai minori, lava egli stesso i piedi ai discepoli, primo atto a cui procede l’ospite innanzi di sedere a mensa? A noi pare vedervi una reminiscenza della scuola Essenica in cui il fondatore del Cristianesimo era stato educato, come un fatto congenere ci pare ravvisare in quegli esempj che ci offre il Talmud di antichi dottori che a segno di umiltà ministrano a mensa ai loro colleghi seduti, esempj che se da una parte si collegano alle esseniche costumanze, dall’altra ci additano nell’Ebraismo rabbinico le origini delle scene evangeliche.
[63] Il sacrifizio ebraico come il pagano erano una vera e propria Comunione eucaristica, una partecipazione alla mensa di Dio in quanto il fedele e i sacerdoti si cibavano di parte dell’animale immolato, mentre l’altra era arsa sugli altari. Per tal guisa l’ara era una mensa religiosa, e il nome di mensa porta veramente in Ezechiele, come per converso la tavola ivi stesso porta il nome di altare. Egli è per ciò che i dottori furono interpreti fedelissimi delle idee bibliche quando la mensa comune dissero stare invece dell’altare, e la scienza farvi la parte del fuoco sacro o della presenza del nume, quando la fecero come l’altare propiziatrice ed espiatrice, e sopratutto levaronsi ad altissimo e nobilissimo pensiero i Teosofi nostri quando videro nella commestione l’atto per cui la materia si eleva allo stato di mentalità mercè il processo di Assimilazione onde i corpi inferiori si assimilano all’organismo dell’uomo. Non d’altronde hanno origine le metafore evangeliche, se pure dapprincipio non furono intese alla lettera, della Tavola in cui Cristo berà del frutto della vite insieme ai discepoli; che ha il suo tipo e la sua fonte in una identica metafora dei Rabbini i quali dicono l’Eden essere il vino conservato nei suoi grappi sino da sei giorni della creazione, che la coppa ne sarà benedetta da David (Padre e tipo del Cristo) nel banchetto finale, ed altre simili. Potrebbesi tacere a questo proposito del sacrifizio eucaristico, e de’ suoi strettissimi vincoli con tutte le idee sopraccennate? Il lettore già ne coglie le grandi attinenze, e ci dispensa dal maggiormente diffonderci nell’ampio e nobile argomento.
[64] R. Neorai nei varj luoghi in cui di esso è menzione offre tutti i caratteri dell’Essena Kabbalista. Egli ha un giuramento poco noto altrove: pel Cielo Asciamaim! (Berahot, 53), che ci spiega come Gesù il condannasse appunto vedendola usata tra i suoi quando disse non giurate nè pel Cielo nè per la terra ec. e si connette mirabilmente colla supposta adorazione del Cielo che agli Ebrei in generale ed agli Esseni in particolare fu attribuita dai Pagani chiamandoli persino col nome di Cœlicoles, onde poi si distinse una setta Cristiana che come le altre non rappresenta che una setta frammentaria dell’antico complesso organico, delle dottrine e della simbologia dei Teosofi Esseni (V. per la storia fra noi del simbolo Cielo, mie note al Pentateuco, Em Lammicrà, Genesi Cap. I.). Egli è identificato con R. Elazar Ben Arah personaggio eminentemente teosofico o Kabbalistico nel 2º di Haghiga (V. Talmud Sciabbat p. 147); egli ha gli istinti democratici come tutti i Farisei (Sanhedrin 20), ei predice pei tempi messiaci, discordie intestine tra figlia e madre, tra suocera e nuora, quali si leggono nei Vangeli espressioni Cristiane dello Spirito Essenico (Ibid. 97), e infine egli ammette una sovrumana efficacia ai nomi divini tratto ad un tempo Essenico Kabbalistico e, oso dire, anche cristiano; perocchè al nome Gesù si attribuisca sino nei Vangeli una straordinaria e miracolosa potenza.
[65] Il Nicolas (Des doctrines qui ont précédé etc., T. 6º p. 86) non sa come porre d’accordo l’identità degli Esseni cogli antichi Hasidim rammentati nei Maccabei, quali strenui difensori della patria libertà, coll’orrore per la guerra e l’esclusivo studio delle arti pacifiche che Giuseppe appone agli Esseni suoi contemporanei. Vi sono pure due fatti che attenuano grandemente il valore dell’obbietto. In prima, non si può negare che la difesa nazionale sia tale dovere religioso eziandio nell’Ebraismo, da obbligare chiunque ad esso appartenga; e più chi più rigorosa se n’è imposta la osservanza. E poi Giuseppe stesso attesta che gli Esseni procedevano armati, del quale uso siamo in procinto di trovare un maraviglioso riscontro nel Zoar e nei suoi personaggi, e tale da rendere quasi inevitabile la parentela dell’Essenato coi Teosofi Ebrei o Kabbalisti. Non possiamo tacere di un autorevole ausiliare che troviamo nell’illustre amico nostro signor S. Munk socio dell’Istituto; il quale nei suoi Mélanges de philosophie juive et arabe, pag. 468, ci offre da un lato una dichiarazione preziosa intorno la identità originaria della Kabbale o Teosofia Ebraica e dell’Essenismo; dall’altro ci reca la testimonianza di un dotto correligionario tedesco, essere gli Esseni i Hasidim del Talmud. La prima così suona: «Les Esséniens avaient donc une doctrine dans laquelle à côté de certaines spéculations métaphysiques, l’Angélogie jouait un rôle important. Il est probable qu’ils cultivaient certaines doctrines qui plus tard faisaient partie de la kabbale, doctrines puisées à des sources diverses et qui ont inspiré les premiers fondateurs de la gnose.» La seconda così si esprime: (ivi in nota) «M. le D. Frankel a essayé de démontrer que les Esséniens sont souvent mentionnés dans le Talmud sous le nom de Hasidim (pieux), et il a fait d’ingénieux rapprochements entre les notices de Joseph et divers passages talmudiques. Voy. Zects Christ für die religiosen interessen des Iudenthums 1847, Décemb., p. 441 et suiv.» Noi non conosciamo gli studj del Sig. Frankel.
[66] Le qualità di Ministro e Discepolo andarono riunite nell’antichità Biblica e Rabbinica. Nella prima Giosuè discepolo di Moisè è chiamato suo Ministro (Mesciret), e nella Rabbinica abbiamo la esortazione al maestro di non astenersi dal fare ministrare il discepolo a proprio servigio; anzi lo studio della legge orale che più dell’altra esige e suppone l’addottrinamento magistrale, è chiamato Scimmusc Ministerio. In senso opposto il Maestro riunisce le due caratteristiche di precettore e maggiore, e la parola Rab tanto significa. Non ne abbiamo noi pure Europei un esempio eloquentissimo nel nostro Maestro, Maître, Signore e Precettore ad un tempo? Si vede nel testo come questi iniziati e novizj si dicessero liberi per torgli ogni imputazione servile. Basti pure ricordare come i figli si dicessero latinamente liberos e come figli chiamino egualmente i Profeti e i Dottori i loro discepoli (Banim). Ma se nell’officio servile dei discepoli convengono Esseni e Dottori, non meno convengono nello studio di escludere il sospetto di condizione servile gli Esseni e i Farisei, nel dar loro il nome antonomastico ai Liberi e più ai Farisei particolarmente nell’escludere dagli offici in cui il discepolo ministrar debbe, quelli che sono per lor natura esclusivamente servili. Entro questo limite, l’antico costume essenico-farisaico ebbe imitatori in Parigi nel secolo decimoquarto quando gli scolari di quella Università servivano come di paggi ai professori.
[67] Vedremo più oltre quando e come acquistassero gli Esseni questo nome di liberi, e vedremo non meno come per altri rispetti oltre quello qui menzionato si meritassero tal nome. A questi altri motivi vogliamo qui preludere con quanto si legge in Plotino (Enneades, vol. I, pag. 472, e pag. 185, nota 1ª): «L’homme est libre quand il exerce la faculté de l’âme raisonnable, quand il s’élève de l’ordre physique qui règne dans l’univers aux choses intelligibles qui ne dépendent de rien. Il est soumis à la nécessité et il devient une partie de l’univers quand il exerce les facultés de l’âme raisonnable et du corps. La Nécessité ou Fatalité est l’ensemble des circonstances extérieures, savoir l’influence des astres.» E (vol. 2º, 3ᵐᵉ Enneades, pag. 17): «Quand l’âme prend une détermination et l’exécute parce qu’elle y est poussée par les choses extérieures, qu’elle cède à un entraînement aveugle, sa détermination et son action ne doivent pas être regardées comme libres..... Au contraire, quand elle suit son guide propre, la raison pure et impassible, la détermination qu’elle prend est vraiment volontaire, libre, indépendante, l’action qu’elle fait est réellement son œuvre, et non la conséquence d’une impulsion extérieure.» E più oltre: «Donc quand elle manque de prudence, les circonstances extérieures sont cause de ses actes: on a raison de dire alors qu’elle obéit au destin comme une cause extérieure.» Per meglio comprendere ciò che Plotino intende per destino, eccone la definizione di Iamblico, che il sig. Bouillet (Enneades. Paris, 1859, vol. 2º, pag. 16, nota 1ª) dice potere servire di Comento alle frasi di Plotino: «Toute l’essence du Destin consiste dans la Nature: j’appelle nature la cause qui est unie au Monde, et qui contient unies au monde toutes les causes de la génération etc.» Plotino stesso avverte come si debba «compter au nombre des causes extérieures l’influence qu’exerce le cours des astres.»
S. Agostino che, come dimostrò altrove il Bouillet, si valse grandemente delle idee di Plotino, scrisse pur esso: Libertas nulla vera est nisi beatorum et lex divina adhærentium. Gli stoici pure avevano detto: Solum sapientem esse liberum. E persino Aristotile disse con frasi più peculiari: Homo sapiens dominabitur astris. Non sono quasi le stesse parole dei Dottori nostri, che udremo fra poco?
In ciò dunque consentono egualmente gli scrittori rammemorati:
1º In quanto ripongono la vera libertà nella conformità del volere alla legge divina.
2º In quanto considerano lo stato opposto come stato di subbiezione al destino.
Ora è innegabile che oltre al consenso che ofirono queste dottrine col nome di liberi che gli Esseni si davano, e di cui vediamo traccia nel Benè horim del Talmud (in Sotà), tornano a capello con moltissime altre idee e dottrine che i pratici del Talmud e dei Rabbinici dettati in generale incontrano ad ogni passo. Così in Abot la libertà è detta retaggio esclusivo di chi accetta il giogo della legge. Così la classica distinzione rabbinica tra figlio e schiavo, la quale, ove si comprenda alla foggia dei Kabbalisti o Teosofi ebrei che veggono nel figlio quello che non accettando che l’imperio divino è superiore alla natura e al destino, e nello schiavo il suo contrario o un grado almeno inferiore, presenterà un’affinità ancor più singolare colla teoria morale di Plotino; ed è che l’uomo, che colle opre e coi pensieri si è fatto superiore alle attrattive, alle forze esteriori, non è più soggetto alle leggi della natura e del fato, e in premio e in conseguenza della libertà morale da sè procacciata, acquista una libertà più sublime sul mondo fisico ch’ei domina, anzichè esserne dominato. Ciò inteso i dottori, sia quando fecero da Dio dire ad Abramo, già circonciso e tuttora ossequiente alla scienza astrologica, Esci dai tuoi pensieri, Abramo non generava, Abraham genererà, sia quando aggiunsero che Dio nella visione in cui gli promise la prole lo elevò al di sopra delle stelle, per significare la libertà da esso acquistata dalle leggi e indicazioni degli astri; infine quando aggiunsero non vi essere fato o legge astrologica per Israel; che rappresentano i liberi i veri figli di Dio. Non sarebbe difficile che anche queste ultime idee si trovassero in Plotino. Ciò ch’è innegabile, si è come il primo Cristianesimo abbia attinto a queste sorgenti, alle sorgenti Israelitiche, tanto il concetto di figli di Dio in opposizione a schiavi della Legge e del Peccato, quanto l’idea concomitante di libertà dalla legge e dal mondo, doppio pensiero che in niuna parte meglio traluce che negli scritti e nelle parole di Paolo, il più dotto Israelita del primitivo Cristianesimo, quegli che studiò la Legge ai piedi di Gamaliel, il Fariseo figlio di Fariseo com’ei si qualifica. Però il concetto nel passare nel Cristianesimo subì una modificazione; anzi si arricchì di un elemento al tutto nuovo, cioè la Libertà dalla Legge invece della libertà della Legge, la quale fu considerata insieme col Mondo come la potenza che la virtù del Redentore avea vinto ed abolito sulla terra. Chi si faccia a studiare con occhio critico le epistole di Paolo, chiaro vedrà come Legge e Mondo procedano appo lui di conserva, e siano in pari modo bersaglio delle sue invettive. D’onde questa dilatazione dell’antico concetto Ebraico e se abbia o no radici nell’Ebraismo stesso, è subbietto grave troppo perchè qui si tratti, e di cui altrove abbiam disputato. Aggiungiamo solo come l’adagio stoico: il solo sapiente essere libero abbia riscontro con altro della stessa setta: il solo sapiente essere re ed entrambi nei Dottori, gli stoici dell’Ebraismo, come li chiamava Giuseppe.
Gli antichissimi Esseni Kabbalisti, e quindi i primitivi Cristiani, sono creduti da alcuni autori progenitori della Francomassoneria e Frammassoni eglino stessi. Questo sistema ch’ebbe ed ha dotti patroncinatori, non manca di verosomiglianza solo che si ammetta o che le dottrine riposte dei Massoni sono quelle stesse dei Dottori, o che quelle degenerarono col lungo avvicendarsi di secoli. Ove ciò si consenta, non negheremo che vi sono non solo nei libri esoterici ma negli essoterici eziandio dei primi Farisei, curiosissimi indizj di quest’antica identità. Non è qui luogo a farne menzione. Solo diremo alquanto di ciò che si attiene al soprannome di Liberi, dato agli Esseni, ai Terapeuti nello stesso Talmud come si vede nei testo. Ora è noto come i Frammassoni dicansi Liberi Muratori o Francs-Maçons. Quale è l’origine di questo epiteto di Liberi o Franchi che tanto già suona conforme ai Liberi dei Terapeuti ed ai Benè horim del Talmud? Sentiamo un dotto scrittore della Società, in un’opera che, se avesse tanto ordine quanto mostra ingegno e dottrina, potrebbe noverarsi tra le prime del genere; il Reghellini di Scio nella Maçonnerie considérée comme le résultat de la Religion égyptienne, juive et chrétienne. Ei crede (vol. 2, pag. 97) che i Liberi Muratori cominciassero ad esserlo di fatto dando opera ai lavori architettonici, e che quindi alla loro corporazione si aggiungessero soci liberi, o come si dice onorarj: «Après ce qu’on vient d’exposer, la corporation des Maçons étant la plus illustre, elle devait être par conséquent la plus recherchée: il était facile à des hommes de qualité et à des lettrés de s’y faire admettre; et comme ces individus n’étaient pas de la profession, ils furent distingués des autres par le titre qu’on leur donna de libres ou francs.» Potrebbe forse escogitarsi simile ragione pel nome di liberi dato agli Esseni; e dire che così fossero chiamati perchè non Medici Assia eglino stessi e non ancora astretti a tutti i doveri sociali? O per avventura non sarebbe meglio intendere nei Liberi Muratori o nei Francs-Maçons lo stesso senso che si annette a quel degli Esseni, vale a dire o un epiteto che stia ad escludere la vera e propria servitù nei novizj, come vuole Filone, o che accenni a quella libertà morale spirituale che campeggia così solenne nelle dottrine kabbalistiche, neoplatoniche, gnostiche e cristiane come più sopra dicevamo? Al lettore l’ardua sentenza.
[68] Platone non isdegnò occuparsi nelle leggi (lib. VII) delle danze sacre. «Le legislateur, egli dice, assortira ces danses, aux autres parties de la musique, les distribuira en suite entre toutes les fêtes et les sacrifices, donnant à chaque fête la danse qui lui est propre ec.» (edit. Paris, 1842).
Il concetto del Ballo fu preso a simboleggiare il moto, l’aspirazione delle anime verso Dio, il perpetuo conato dei Beati;—e ciò nei Dottori ebrei, nei Padri della Chiesa, e finalmente in Dante. Nei primi quando dissero Dio intimerà un ballo ai beati in Paradiso e stando egli nel centro, ognuno mirerà ad esso dicendo: Ecco Dio a cui aspirammo «Atid acadosc baruh u laasot Mahol lazadichim—be—gan—eden ec. Nei Padri, là ove si legge in S. Basilio (Omil. sul rendimento di grazie). Ti manca alcun figliuolo? Ti restano gli angioli coi quali menerai danza intorno al trono di Dio.—E il gran Dante nel Paradiso, come è noto. L’Israelita che nel santificare tre volte Dio ogni giorno solleva il Corpo da terra tre volte, è erede e discepolo senza saperlo di tutta la grande e buona antichità ebraica e gentile. Tanto è vero che l’ebraismo adempie mirabilmente a quell’officio di Nido di Neno che è distintivo di vera religione (religio a ligando) come volle Cicerone.
[69] Non sarebbe inverosimile che la predizione di Gesù a Pietro Prima che canti il gallo tu mi avrai rinnegato tre volte—sia una applicazione a se stesso, vero e nuovo Tempio—com’egli altrove si chiama, di ciò che ivi si praticava nel culto di Dio: volendo dire che il canto del gallo anzichè schiudere la giornata religiosa ad essere il segnale degli officii del tempio che cominciavano con triplice suono di corno, sarebbe stato anzi preceduto da triplice rinnegamento: tanto la Divinità da lui rappresentata sarebbesi inchinata alle più profonde umiliazioni. Non dimentichi il lettore quanto fu da noi provato (Lezione XII, Nota 2) intorno la sostituzione che Gesù insegnava di se stesso al Tempio, qual fonte d’ispirazione.
[70] Ecco la chiave dei lamenti e rimproveri che i vangeli ci narravano dirigere i Farisei contro il costume di Gesù, di sedere cioè a mensa con pubblicani e con malfattori. Nessuno più dei Farisei si adoperava alla conversione dei peccatori; opera che magnificarono nei loro libri più di qualsiasi altro ufficio di pietà; ma non credevano che si potesse senza imprudenza, e senza fallire lo scopo istesso che proponevansi, scender fino a tanta familiarità.
[71] Nessuno negherà che la vita contemplativa ed ascetica non sieno sommi educatori dell’animo a libertà e indipendenza di sensi, siccome quella che insegna a vincer gli altri col lottare con se stesso. Da ciò nacque la gran forza di resistenza che spiegò il Cristianesimo nel suo nascere e che imparò là dove attinse tutto ciò che forma il suo corredo dommatico e il suo pratico indirizzo. Vi è però un pericolo a cui rado è che fuggano i mistici, e che solo l’ebraico per la sua intima connessione con una religione che era al tempo stesso una norma civile e politica, potè avventurosamente cansare. Difatti gli spiriti mistici onde si prova in varj tempi il nostro popolo, e più in quelli di cui discorriamo, non lo spinsero mai a quegli eccessi in cui caddero tutti quelli che calcarono le stesse orme; ma seppe mantenere più o meno l’equilibrio fra la vita attiva e la vita speculativa, fra la mente ed il corpo. Quanto al fatto di cui si fa menzione nel testo, alla conversazione tra i dottori risaputasi dal governo di Roma, e della successiva fuga di R. Simone, e della lunga dimora in una grotta, vogliamo solo aggiungere che forse in questo cenno troverebbe largo campo di esercitarsi una parte dei critici moderni i quali affermarono che lungi da morire Gesù sulla croce, sopravvisse lunghi anni a quel supplizio, protetto e nascoso dal silenzio e dal mistero degli essenici chiostri. Chi sa che non si dica altrettanto dei tredici anni che visse R. Simone Ben Johai lungi e salvo dal decreto romano che l’aveva condannato a morire? Certo che questo scampo prodigioso non si presta meno acconciamente all’ipotesi di un rifugio in qualche riposto asilo degli Esseni fratelli, tanto pel tempo non breve, quanto per i mezzi ch’ebbero esso e il figlio di vivere in tanto abbandono. Quando ciò possa consentirsi, tanto più intelligibile parrà la tradizione corrente tra i cabalisti che là meditasse e coordinasse R. Simone le sue dottrine e la sua teosofia. Ed oltre al tempo, all’ozio, all’asilo, specialmente se essenico che tanto bene si presta, non mancano nel testo talmudico e medrascico cenni che provino come ben altro uomo uscì il nostro dottore dal suo asilo di quello che vi fosse entrato, specialmente per ciò che si attiene alla dottrina, santità e religiosa eccellenza.
È degno di nota il rifugio che anzi tratto si procurano nel Be Medrascià, nell’accademia secondo il Talmud Babilonese (Sciabbat cap. 2), e che dee esser stato luogo e rifugio di un indole affatto speciale per poter sfuggire alle ricerche del governo romano.
Il genio ascetico e taumaturgico si palesa nel padre e nel figlio appena usciti dopo tredici anni dal loro asilo, quando si sdegnano al solo vedere uomini occuparsi di lavori agricoli (Ibid), nelle punizioni che infliggono e nelle guarigioni che operano egualmente prodigiose; nella figlia della voce (Berat Calà) che odono annunziare tanto la caduta di un uccello nelle reti del cacciatore quanto il suo scampo (Medrasc Scemot Rabbà sez. 79), e che ha un eloquente riscontro in voci ed annunzj consimili che si narrano uditi dagli uomini stessi nel Zoar; mentre malagevole sarebbe trovarne dell’indole stessa nei libri talmudici. Nè è da tacersi la singolare conformità della illazione, che da questi fatti trae Simone con un analogo pensiero dei Vangeli. Se un uccello non cade nella rete senza espresso decreto di Dio sarà egli possibile che ciò avvenga per l’uomo? Gesù si valse dello stesso esempio degli uccellini per assicurar ai suoi discepoli il sostentamento per la domane. La grandezza religiosa e scientifica a cui s’inalzò dopo il lungo ritiro, si mostra nel vanto che di sè proferisce, dicendo al figlio: Bastiamo noi due pel mondo intiero e che ha riscontro e interpretazione eloquente in altra sentenza da lui profferita in altra occasione quando disse: Veggo che gli uomini della Camera (Benè Alià) sono scarsi. Se sono due, noi siamo quei dessi. (La Camera di cui qui si parla è lo stesso delle Camerette dei Vangeli, in cui Gesù dice che si comunicano le cose segrete); si mostra nella replica che ci fa a R. Pinehas Ben Jair il quale deplorava vederlo nella persona così malconcio: Beato te che tale mi vedi, che se così non mi vedessi, tale io non mi sarei a quest’ora; e il Talmud chiosandone il senso aggiunge che prima del suo ritiro, ad ogni domanda che Simone faceva, R. Pinehas dava 12 risposte; ma dopo quello, ad ogni domanda del secondo opponeva Simone 24 risposte, lo che nel linguaggio iperbolico talmudico significa che la scienza di questi, sopravanzava di gran lunga quella del suocero.
[72] Questo riempire che fa il Zoar la lacuna istorica che offre il Talmud in fatto dei Haberim, il cui carattere, officio, definizione riuscirebbero vaghi incompleti senza il soccorso del primo, è prova tra mille altre che l’uno e l’altro non formano che un solo corpo di dottrina e si appellano e si completano scambievolmente. È questa in piccolo una immagine dell’officio che sostiene la dottrina cabbalistica o teosofia verso tutto l’ebraismo pratico, cioè quello di fornirlo di una originale e connaturale dogmatica.
[73] Talmid—Kaham—titolo che si danno i Farisei negli antichi monumenti Rabbinici (Misnà, Talmud ec.) e significa scolaro;—discepolo di dottore meglio che dottore. È espressione suggerita da umiltà; e non si comprende come uomini siffatti potessero agognare al titolo di Rabbi, e ad essere tali chiamati su per le piazze, siccome di tanto li appuntano i Vangeli. Altra importante considerazione ci offre il tempo in cui predicava Gesù. Poichè, secondo attestano memorie autenticissime, il titolo di Rabbi lungi dall’essere allora comune fra i dottori, si veggono anzi i più famigerati capiscuola che in quel torno fiorirono, recare nelle opere rabbiniche il nudo e semplicissimo loro nome. Quindi grave dubbio ne emerge che anche da questo lato meglio che la impronta dei tempi in cui quei discorsi si dicono proferiti, quella rechino invece dell’epoca in cui i Vangeli furono redatti; e gli autori di questi facciano usare a Gesù un linguaggio che solo ai loro proprii tempi si addiceva. Checchè ne sia, il nome Talmid Kaham ha molta analogia, quanto allo intendimento che lo dettava, con quello di Filosofo o amante di sapienza che si davano i savi pensatori di Grecia, differenti dagli altri che per presunzione diceansi Sofi o Sofisti.
[74] Non ha guari ricordavamo le parole di Simone Ben Johai nel Talmud in cui se erano due gli uomini della Camera, questi egli diceva essere esso ed il figlio. Or chi non rimarrà sorpreso vedendo il consesso più augusto del Zoar designato collo stesso nome di Camera Iddarà? Può darsi conferma più bella di questa? E si può ancora ragionevolmente dubitare che R. Simone Ben Johai non sia la stessa mente che informa lo Zohar? Si dirà che l’autore qualsiasi di questo libro si prefisse studiatamente un linguaggio che si affacesse al supposto autore? Ma questo studio contrasta con altre dissonanze cronologiche, storiche e filologiche che escludono nel suo redattore l’intenzione di crearsi una forma ed uno stile artificiale; e tanto più rimane escluso nel nostro caso che il senso di Camera nel nome Iddarà fu poco avvertito generalmente ed altre interpretazioni ebbero corso le quali però non reggono ad una indagine severa. Non vogliamo infine tacere di un’altra curiosa analogia che ci offre il nome stesso di Benè Alià con cui nel Talmud si designano, secondo me, gli speculatori e teologi del Farisato. Questo nome alla lettera significa quelli del luogo alto o delle regioni superiori, nè per altro fu così la Camera chiamata se non perchè occupava appunto la parte più alta dell’abitazione. Ora chi non troverà mirabilmente a queste idee conforme, la seguente di Platone nel Teeteto (Ediz. Paris, pag. 64). Mais, mon cher, lorsque le philosophe peut à son tour attirer quelqu’un des hommes vers la région supérieure etc.
[75] L’illustre amico mio, signor professor S. D. Luzzatto, scriveami non è guari, e credo anche stampasse, non potersi credere autentico un libro ove si parla di Compilazione scritta, quando ogni redazione tradizionale era tuttavia interdetta nell’ebraismo. Risposi: doversi distinguere la tradizione legale e rituale dalla tradizione teologico-agaditica: se per la prima è lecito affermare (comechè forse non senza gravi restrizioni) che si mantenesse esclusivamente orale per assai tempo ancora; non così per la seconda, della quale sappiamo avere esistito per tempissimo varie compilazioni, di cui a dilungo si ragiona nel libri talmudici. Ora s’egli è vero, come è indubitato, che l’Agadà non è, come altrove notammo, che il nome e la forma mitica e leggendaria della recondita teologia, ognuno comprende come a nulla approdi la ricordata obbiezione.
[76] Non dimentichi il lettore:
1º Che ogni qualvolta narra il Talmud una cura prodigiosa operata a contatto; è sempre la mano porta e ricevuta.
2º Che Epifanio V ci ammonisce come «les gnostiques (i quali non sono, come provammo nell’Essai sur l’origine des Dogmes ec., che la parte cabbalistica o Essenica degli Ebrei convertiti al Cristianesimo) se connaissaient entr’eux à leurs manières de se prendre la main.»
[77] Chi sa ancora se questo nome di legge di grazia non deriva nei Vangeli appunto da quella divulgazione che Gesù operò fra le moltitudini pagane e israelitiche delle dottrine misteriose dei Farisei, come non ci stancammo di dimostrare nell’opera francese altrove citata.
[78] Quanto è bella la imagine del libro divino a indicare l’uomo dotto e virtuoso! Galileo chiamò la natura il libro di Dio. L’uomo non meritò meno questo nome in specie appo gli antichi che lo dissero Microcosmo. Nè questo è solo il luogo ove il Codice della Rivelazione e l’uomo vengono dai Dottori ravvicinati. La separazione dell’anima dal corpo è comparata al volume rivelato che va preda alle fiamme; quindi l’obbligo dei segni di lutto che s’impongono agli assistenti.—Sulla bara dell’uomo dotto si poneva ab antico, quale insegna del suo nobile officio, il codice mosaico, e dicevasi:—Costui ha osservato quanto in questo libro è scritto.—Ed ove tu sottilmente consideri, vedrai come il dogma del verbo incarnato non sia che una esagerazione del principio incessantemente proclamato dai Dottori, la immanenza nel cuore e nella mente dell’uomo del Verbo Divino.
[79] Vorremmo che i negatori della tradizione, vuoi talmudica, vuoi teologica, riflettessero seriamente a questo orrore di novità che trasparisce in questi luoghi, e in altri infiniti che si omettono, e si domandassero in qual guisa è compatibile tal ripugnanza col supposto di origine moderna nell’una e nell’altra. In qual guisa l’una e l’altra tradizione appena nate, avranno potuto spacciarsi quali antichissime, rigettare ogni aspetto di novità, chiudere per sempre quella fonte da cui scaturirono, senza contraddire al proprio principio e senza temere di essere volti in deriso? I Dottori chiamano altrove quest’obbligo di far risalire, quanto più si può, ai primi autori la dottrina che si espone «lescialscel et ascemuà» svolgere la tradizione.
[80] Senza impegnarci in diffuse dimostrazioni accenneremo qui di volo le massime capitali conclusioni a cui riuscimmo ed a cui riescir deve a parer nostro, ogni spassionata indagine sugli Elementi d’Angelogia, e dei nomi divini che contiene il Talmud.
1º I confini che separano i nomi angelici dai divini sono tutt’altro che fissi e insuperabili, ma anzi mobili e permutabili; onde ogni ostacolo è rimosso alla identificazione dei nomi degli Angioli essenici, coi divini ed angelici talmudici.
2º Che la scienza di questi nomi costituisca nel Talmud una dottrina gelosa ed acroamatica, anche questo non patisce eccezione per chi ne abbia consultate le pagine: nè patisce eccezione pertanto la identità di metodi in ambo le scuole.
[81] Fra i Terapeuti, si trovavano le Terapeutidi, donne iniziate; nell’istituto pitagorico eranvi le numerose e celebri Pitagoresse. Vedi Ritter, Hist. de la phil. ancienne, vol I, 298.
[82] Questa designazione ha origine in seno all’Ebraismo dal divieto di cibarsi di carne che non fosse stata sacrificata, ma è certo del pari che presso tutti i popoli le prime immolazioni, e quindi le prime imbandigioni di carne furono conviti sacri. Sterminata opera sarebbe se tutto volessimo dire che a ciò si attiene.
[83] Nel Talmud si condanna l’uso di prendere i versi del Cantico dei Cantici e piegarli a uso di Epitalamio nei banchetti, nuziali o no.—Si tratta di applicazioni ad amori umani? Si tratta invece di poesie mistiche intessute di quelle frasi?
[84] Preziosa per quanto non avvertita menzione della Setta Accademica nella Misnà di Chelim nelle parole Scel cat cademin i Zò. Ci basti accennarla soltanto, troppo oltre conducendoci una piena dimostrazione, che ad altro luogo serbiamo.
[85] Ciò ch’è anche più degno di nota egli è, come questo ricorrere al greco qual fonte di ebraiche etimologie, è seguito anche dai teologi cabbalisti nella nomenclatura delle loro emanazioni. Vogliamo qui citare un solo esempio ma singolarissimo. È noto come Platone e i nuovi platonici eziandio chiamassero Dio come Primo, come Ente col nome di En. Ed egli è questo il nome che il principio equivalente porta in quella nomenclatura e nel senso stesso di Unità. Ecco uno degli anelli che congiungono i moderni teosofi coi loro più antichi predecessori.
[86] Fatto che nulla più avverato e che resulta luminoso nella enciclopedia rabbinica da un complesso imponente di fatti e considerazioni che ci siamo studiati porre in luce in una nostra Introduzione generale storico-critica a tutti i Monumenti della tradizione. Un solo fatto citeremo qui ad esempio, il nome di Misnà che sempre recò la tradizione e che suona quanto Ripetizione appunto per che lo insegnamento se ne faceva ripetendo il testo.
[87] Giusto però è confessarlo. Il Cristianesimo non sempre fuorviò dall’antico sistema esegetico, non sempre immolò, almeno in teoria, il senso litterale all’allegorico. Il Medio-evo cattolico ammise il quadruplice senso dei Dottori, non solo interpretando la Scrittura, ma nelle opere di grande calibro quale, ad esempio, la Divina Commedia. Ed anche il Protestantesimo nel suo inizio. In due versi furono compendiati i quattro sensi
Littera gesta docet, quid credas allegoria,
Moralis quid agas, quid speres anagogia.
[88] Questa mia congettura intorno alla vera lezione di Maimonide otteneva, poco dopo scritte le presenti pagine, una splendida conferma. Ognuno sa come l’originale del Comento Maimonideo sia stato scritto dall’autore in lingua Araba. Ora essendomi io diretto all’illustre orientalista Sig. Salomone Munk, attualmente Professore di lingue Orientali nella Sorbonne, per qualche schiarimento senza tacergli però la ipotesi mia, n’ebbi per gran ventura a risposta come in un Manoscritto Arabo del Comento stesso, da lui recato dall’Egitto nel 1840, si leggeva anzichè l’enigmatico Cabtazar, Copt-maser, vale a dire i Copti di Egitto.
[89] Nel caso che qui si contempla, il Rito è noachide. Vi è però dottrina nella Misnà secondo la quale il rito stesso israelitico può essere praticato fuori del Tempio e cooperante un Israelita: e l’autore di questa dottrina è R. Simon Ben Iohai. Qual nome eloquente!
[90] Abbiamo taciuto di un uso essenico che ricorda Giuseppe, quello cioè di portar le mani, l’una tra la barba ed il petto, l’altra sospesa ai fianchi. È questo un punto che mi affaticai invano a chiarire. Forse qualche analogia ci offre Champollion Figeac quando nell’Egypte scrive dei sacerdoti egiziani: «Les anciens disent qu’il résultait de ce costume éclatant de blancheur, de la gravité habituelle de la physionomie, de la démarche et des paroles des prêtres, un extérieur imposant que complétait le repos forcé des bras et des mains habituellement cachés dans les plis des vêtemens. Les Monumens confirment cette observation faite par les anciens (p. 113).» Aggiungasi che nei Monumenti egiziani si veggono i subordinati presentarsi al loro superiore e signore «ayant, dice Champollion (Egypte, 185. I.) leur main droite posée sur l’épaule gauche, et leur autre bras pendant en signe de respect.»
[91] Una gran parte di queste Regole portano nel Talmud un nome pregno di senno, quello di Cabbalà. Si legge in Berahot queste parole che porgiamo alla meditazione degli ebraizzanti Annan Cabbalà debet akissè seniutà usticutà. I forzati e inutili tentativi degli interpreti, e tra gli altri di Rasci, provano ch’egli è solo dal nostro ordine d’idee che la frase in questione può ricever lume e verità.
[92] I termini che si riferiscono alle fasi dell’uno e dell’altra generazione seguitano correlative. Così Ara si dice per gestazione e meditazione, onde l’Irur rabbinico.
[93] Per bene comprendere tutto questo, si avverta come una delle emanazioni cabbalistiche porti i nomi ad un tempo di Mi (chi?), di Sceticà (Silenzio), di Mahasabà e Kohmà (Pensiero e Sapienza). Chi subodorò alcun che della teologia dei Gnostici sa benissimo come i nomi di Sofia Superiore e di Sige o Silenzio sieno proprj dei più supremi Eoni o Emanazioni. E poi si dica che la teosofia cabbalistica è cosa moderna!