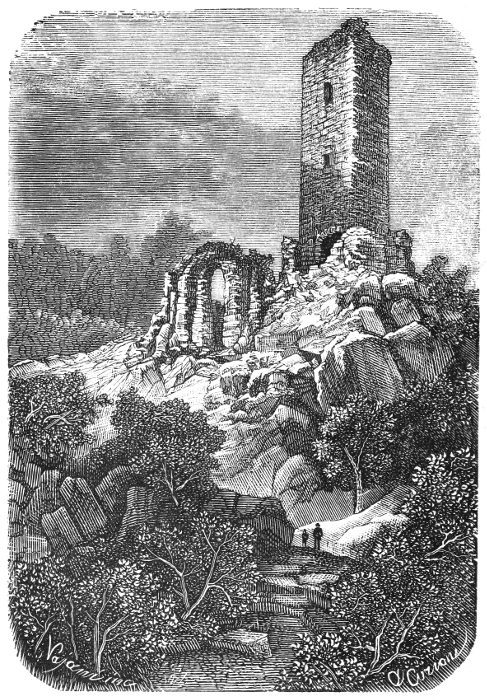
Castello Baradello.
Title: Il Lago di Como e il Pian d'Erba: Escursioni autunnali
Author: Pier Ambrogio Curti
Release date: June 13, 2021 [eBook #65610]
Most recently updated: July 10, 2021
Language: Italian
Credits: Barbara Magni
P. A. CURTI
IL LAGO DI COMO
E
IL PIAN D’ERBA
ESCURSIONI AUTUNNALI
ILLUSTRATE DA INCISIONI IN LEGNO.
Dal bel rapir mi sento
Che natura vi diè.
Parini.
MILANO,
PRESSO L’EDITORE GAETANO BRIGOLA
—
1872
TIP. BERNARDONI.
[5]
L’andare in villa, non molt’anni addietro, era di pochi, di que’ felici soltanto che la fortuna aveva dalla nascita privilegiati, o ne’ commerci arricchiti: ora gli è, può dirsi, dei più.
S’è così tornati alla manía del basso tempo antico, quando noi s’era colonia di que’ famosi prepotenti che erano i Romani. Cicerone — tanto per nominare qualcuno d’universal conoscenza — che non era tra i più facoltosi, nè da patrizia famiglia nato, s’era appagato di una sua velleità e contava nientemeno che ventiquattro ville di sua proprietà, quantunque invero non prediligesse che le sue case di Tusculo e di Pompei; e Cajo Plinio il Giovane, quello stesso che fu delle nostre parti, anzi della città di Como, — senza dir del suo Tusci che [6] egli aveva alle pendici dell’Appennino toscano, e del Laurentino che possedeva in Romagna sul litorale del Mediterraneo fra le città d’Ostia e di Laurento — lungo le sponde ridentissime di questo Lario, dove sto per accompagnare il mio lettore, ne aveva due, l’una a Villa, che denominò Commedia, l’altra prossima a Bellagio, che denominò Tragedia.
Io perfino, che divido le cure della vita fra le cause, i processi criminali e le umane lettere, ma che da Cicerone e da Plinio son per merito e ricchezza lontano quanto ci corre dal gregario al generale, partecipe della febbre che ha i moderni invaso, mi son passata alla mia volta la follia di una villa, piccola sì, ma a me bastevole: parva sed apta mihi, come direbbe il gran lirico latino.
La manía poi del viaggiare a solo titolo di divertimento è tutta propria dei nostri tempi; è il portato inevitabile delle tante vie ferrate e de’ vapori che solcano tutti i mari; i Romani l’avevan pure, ma pel solo gusto matto di tribolar le nazioni cui portavano la guerra e di svaligiarle interamente...
Ma io la piglio forse soverchio da lontano, per ispiegare al mio lettore le ragioni di questo libro, nè va bene che l’annoi sin dal principio.
[7]
Volevo dire adunque che da noi, in Lombardia principalmente, non c’è caso: quando arriva l’autunno, si vuol proprio andare alla campagna; che noi della capitale — intendo la morale — si sognan tutto l’anno le rive del Lario o i placidi e verdeggianti colli del Pian d’Erba, e beati se ci possiamo andare! So di chi s’acconcia a scampagnare nella catapecchia della nutrice d’alcun suo bambolo; d’altri a condannarsi a starsene chiusi nelle case di Milano, purchè si creda che siasi alla campagna.
I viaggiatori che ci visitano, non ci lasciano se prima una giornata non abbiano passato sul lago di Como, percorrendolo su per i piroscafi che vanno e vengono da un capo all’altro; e chi appena lo possa, si sofferma non pochi giorni ne’ diversi e veramente confortevoli alberghi, che si sono venuti stabilendo ne’ varî punti di queste rive popolate di paeselli e di ville leggiadre, che incantano di sè anche coloro che han pur visto que’ miracoli di natura che sono i golfi di Napoli e di Genova.
Nel Pian d’Erba, è vero, non ci vanno come noi; ma la colpa è tutta nostra, che non siamo pur anco giunti a praticarvi strade un po’ convenienti e, meno ancora, alberghi; perchè tali davvero non ponno dirsi [8] que’ che adesso se ne hanno arrogato il nome. Ma la locomotiva non tarderà guari a prolungarsi da Seregno almeno ad Erba, e sarà allora un’altra cosa; la Brianza superiore non sarà più certo un mito pe’ forestieri che saranno stati nella nostra Italia, e il bisogno d’impiantarvi adatte stazioni verrà dietro per conseguenza.
Or bene; villeggianti e viaggiatori, nel soggiorno di questi luoghi, si domandano bene spesso: dove si va oggi? dove domani?
Il mio libro è la risposta.
Milano, maggio 1872.
[9]
Il Castello. — Uno sproposito di geografia. — Etimologia del Baradello. — Un cenno geologico. — La storia del castello. — Liutprando. — Barbarossa. — Camerlata. — Scopo del Baradello. — Napo della Torre. — La chiesa di San Carpoforo. — Lapide. — Villa Venini ora Castellini. — Il collegio alla Camerlata. — Opificî industriali. — Ville Larderia, Martignoni, Prudenziana e Carloni.
Non è alcuno di noi che, giungendo la prima volta in ferrovia alla Camerlata, non appena uscito dal vagone, non abbia rivolto lo sguardo a quella torre che sta di sopra il colle che sogguarda alla stazione, e non sia corso a ricordare le mille storie che nell’infanzia gli saranno state raccontate dalla nonna o dalla fante intorno ad essa, e con certa curiosità non vi abbia per qualche istante tenuto l’occhio, quasi a dirsi: non era dunque una panzana quella che aveva udito del Castell Baravell, che così appunto nel nostro bisbetico dialetto abbiam travisato il nome di Baradello. E siccome una volta almeno anche l’ultimo de’ popolani s’è tolto lo [10] spasso di visitare la città de’ missoltini, — così chiamati que’ dolcissimi pesci che dà il Lario, quando si misaltano o vengono disseccati —; così non è più adesso pel minuto popolo nostro un mito, una favola, un alcun che di immaginoso questo Castell Baravell, che ha udito le tante volte ne’ suoi giorni d’infanzia ricordare.
Ma siccome questo libro non è fatto unicamente per i miei concittadini, non mi soffermerò più altro nè a ritessere quella storia della prima fanciullezza, nè a sceverarla dalle ubbie e dalle fole immaginate all’opportunità dalle serve o bambinaie per aver savî i lor marmocchi; così ora toccherò al sodo ed a quel meglio che interessi.
Sia che tu movendo da Milano percorrendo il cammin di ferro che si ferma a Camerlata, sia che da Colico tu scenda col piroscafo per il lago infino a Como, il castello Baradello ti si annunzia prestamente; perocchè egli torreggi sovra il colle, o monte che meglio ti piaccia di chiamare, il qual si eleva fuori appena la porta che riesce appunto alla via che scorge a Camerlata e per di là a Milano.
Questo colle, io ti consiglio di ascendere, o lettore, nella gita che vorrai fare a Como, perocchè di là ti si parerà avanti il più superbo panorama che si possa figurare; miracolo di cielo e d’aria, vista di città e di paesi, di lago e di ville, di giardini e di poggi amenissimi, di palagi e di chiese, di poveri tugurî e di vasti stabilimenti industriali, di monti selvosi e di massi e vette cinericcie e brulle d’Italia e di Svizzera, che gli è a pochi tratti di distanza, ed anche di Savoja, che si fa rappresentare dal nevoso Monte Rosa.
[11]
Sa ognuno di tutti noi come il monte Baradello chiuda il varco al Milanese, e non sia vero che girando intorno ad esso si ritrovi la strada che passa a Chiasso, primo villaggio della Svizzera italiana: parrà strano nondimeno che a falsamente indicarlo fossero appunto due scrittori di Como, e di quel valore che nessuno loro ricusa, come sono Paolo Giovio, lo storico, o storicone, come chi il voglia coll’Aretino corbellare[1], e Gastone Rezzonico prosatore e poeta non degli ultimi. Scrisse il primo, parlando del Baradello: in edito jugo saxosae viae, quae tendit ad Helvetios; cantò il secondo:
minacciar dal giogo
Lo svizzero pedon che incerto move
Per l’aspro calle i faticosi passi.
Di molto e molto si perdona al poeta, disse Orazio; è vero: ma forse non si è disposti ad accordargli la [12] favolosa possa di Atlante di prendersi sulle spalle poderose un monte per piantarlo, come gli garba, fuor del posto che gli ha assegnato madre natura.
Perchè si chiami Baradello, io potrei dirtene più d’una, chè nulla è più agevole che immaginare origini, etimologie: mi basterà invece di accennare, come coloro che ne’ varî nomi di radice greca che si trovano lungo il lago ne’ paesi — Lemna, Dorio, Nesso, Corenno, Colono, ecc. — presumono argomentare essere qui state colonie greche, vogliano il nome di Baradello derivare dalle voci baris deile (βαρυς δειλη) ossia torre della bass’ora o d’occidente, perchè dietro quelle giogaie tramonti il sole; e chi invece dal celtico Barrdell, che significa monte piccolo; e infatti è nome pur dato all’altro monte Barr presso Lecco, tra Malgrate e Oggiono — Baro —, che Plinio, copiando Catone autore antico, non saprei con qual giudizio, pretende avesse sul suo culmine una città denominata Barra, donde ne sarebbero venuti i Bergamaschi e il nome della Brianza.
Pei geologi può interessare per contrario il sapere come il colle Baradello si costituisca di pietra arenaria, non altrimenti che sono dell’egual roccia altre colline della provincia, e, stando agli Atti della società patriotica di Milano (Vol. III), se ne sarebbe nel passato tratto allume e giallamina.
Se veniamo alla storia, cose del pari malsicure ne segnano i primordî del castello che sovraggiudica questo monte.
[13]
L’illustre autore della Storia della città e diocesi di Como, Cesare Cantù, che, del resto, di notizie del suo lago e della Brianza ne ha diffuse per tanti libri, nè sarà certo l’ultima volta che a lui per esse ricorrerò, nel far cenno di questa torre quadrata che fra le ruine grandeggia di Baradello, la trovò mentovata nel documento di Liutprando re, che reca la data del 4 delle none d’aprile dell’anno dell’incarnazione 800, primo del regno, indizione X, che, riferito in nota a pagina 103 (vol. I, edizione Le Monnier), attesterebbe di assai doni da lui largiti alla chiesa de’ santi Carpoforo e compagni da lui fondata. Al qual proposito commenta lo storico: Sebbene troppi argomenti abbiamo addotti per giudicarlo, perciò vogliam fare stima che chi lo finse avrà procurato, quanto l’ignoranza glielo permetteva, di dargli aspetto di verità.
E soggiunge così le altre notizie che concernono il fabbricato:
“L’abate Uspergense veramente ne attribuisce la fabbrica al Barbarossa; ma può ben essere che abbia il terribile imperatore fatto risorgere quel forte, smantellato dai Milanesi, allorchè Como distrussero. Il castello fu abbattuto, sicchè nulla possiamo dedurre dalla sua forma: resta una torre massiccia, ma senza porta, nè altro carattere. Chi però ne guarda la solidità non troverà improbabile tanta antichità sua. La tradizione aggiunge che una via sotterranea guidasse di lassù sino al piano: fantasie applicate ad ogni castello, e nel nostro la rende meno probabile l’immensa difficoltà! Alla torre si avrà avuto accesso per un ballatoio a quella finestra grande che è alla metà; e le fosse, che vogliono [14] credere vestigia della strada segreta, saranno state cisterne per conservar l’acqua.„
Dei tre castelli che fiancheggiavano la città di Como, e che erano il Nuovo sopra San Martino, quel di Carnasino e il Baradello, è certo che quest’ultimo fosse il meglio importante.
L’opportunità del luogo (perocchè incomba alla città, e perchè non occupata da sue forze e da’ suoi, la rocca le si sarebbe potuto rivolger contro, se tenuta da nemici) non lascia dubitare che da antichissimo, e prima ancora di re Liutprando, fosse una cittadella su quella cima e forse una di quelle ventotto che ricorda il Giovio essere state oppugnate in queste parti da Marcello.
Federico Barbarossa la mise di poi in nuovo assetto, e dovea chiudere nell’ampia sua cerchia il quartiere per la guarnigione ed anche il palazzo ove stanziava il podestà e dove pure albergarono quell’imperatore e la sua donna.
Non sarebbe difficile, a chi volesse studiarvi sulle ruine, assegnar il luogo del di lui palazzo, se esso fosse nel piano eminente, o se alle falde: certo è dato argomentare come esso dalle munizioni traesse il nome di Ca-merlata.
E ad altro vantaggioso scopo valeva eziandio la torre del Baradello, se vuolsi, com’io penso, aggiunger fede a quelle argute osservazioni dello storico testè citato, e che pure è prezzo dell’opera il riportare.
“Vi sarete accorti — scrive egli a pagina 47 del volume primo dell’opera succitata — come i luoghi principali fossero in punto di fortificazioni, così da resistere alla agitata fortuna. Ma poichè ognuno per sè era troppo [15] poco o per difendersi o per offendere, formavano una maniera di federazione, o fosse colla città principale, o contro di quella; ed era perciò mestieri usar qualche guisa per comunicarsi uno all’altro i pericoli, le decisioni, le avventure. L’età nostra adopera meravigliosi telegrafi, che colla velocità dello sguardo tramandano a centinaia di miglia con esattezza le notizie; allora vi si doveva supplire con grossolane maniere. Se ti fai a considerare, o lettore, le nostre parti, vedrai delle torri sulle punte, sui poggi, d’onde lontano possa la vista; or quelli appunto erano i posti su cui stavano le scolte per esplorare la campagna e per ricevere e tramandare i segni telegrafici. Accadeva un bisogno? doveasi chiamare a parlamento, alle armi? comunicar un ordine, una notizia? Bandiere di colore diverso e variamente sciorinate, o meglio una o più fiamme disposte ne’ luoghi e nelle guise convenute, e replicate di vedetta in vedetta, propagavano abbastanza rapidamente le novelle.
“Per questo erano stabilite le torri in modo che una guardasse l’altra. Al Baradello, se vogliamo toglierlo come centro de’ segni, corrisponde, verso il lago, Torno, o piuttosto quel colle presso Pognana che chiamano la Collina della Guardia; indi Argegno, oppure la Cavagnola, che potevano comunicare alla Val Intelvi; poi Bellagio, che da una parte alla Valassina, dall’altra al ramo di Lecco, da sera mandava il cenno alla Val Menaggio e pel castello di Grandola al lago di Lugano, e superiormente a Rezzonico, donde alla torre d’Olonio, posta all’imboccatura della Valtellina. Da quella potea propagarsi all’altra torre, che si vede ancora [16] sopra Samolaco, donde al castel di Gordona, feudo vescovile, ed a quel di Chiavenna; e per la Valtellina al castello di Domosolo; e per le torri, poste principalmente sul vertice degli angoli salienti, fino alla serra che chiudeva i risoluti Bormini. Volgendo a nord-ovest, rispondeva al Baradello la torre di San Nicolao a sopracapo di Mendrisio, poi forse l’erta ed amena cima di San Salvatore, visibile a tutto il Ceresio; poi pel monte Cenere tramandavasi il cenno a Bellinzona, al Verbano, alla Chiusa (la ciosa) dei Lombardi. Verso mezzodì era la posta a Cantù, donde propagavasi al Milanese ed alla rôcca del Montorfano, che può a’ lontanissimi confini della Brianza vedersi. I castelli posti tra mezzo apprendevano le novelle di que’ principali.„
Il Castello di Baradello è ricordato come arnese che assai figura nelle lotte guelfe e ghibelline del secolo decimoterzo. Sono note le guerresche fazioni de’ Torriani e de’ Visconti. I primi, comunque usciti dalla Valsássina della provincia di Como, pur essendo di parte guelfa, s’erano legati a Milano con amicizia veramente larga. Avversi essi ai nobili, ch’erano stati cacciati, ed eletti a capitani del popolo, li combattevano con coraggio e valore, e se crudeli nelle ore solenni della pugna, erano miti nondimeno e generosi dopo di essa; onde la storia registrò quel che Martino della Torre ebbe a dire quando non volle trucidare i ghibellini da lui fatti prigionieri: “Poichè non ho potuto dar la vita, a nessuno vo’ toglierla.„ Ma espiarono tanta generosità; soccombendo a’ Visconti nella battaglia di Desio, Napo della Torre ed altri di sua famiglia vennero chiusi in una gabbia del Castello Baradello, ed ivi così fieramente [17] trattati da empir di gemiti la valle ed a far iscrivere al Cronista: In castro de Baradeìlo quasi canes tractati sunt.
Sovra il colle medesimo del Baradeìlo vedesi ancora a’ dì nostri quella chiesa, che più sopra ho menzionata, sacra a San Carpoforo, che si vuole in paese sia stata eretta ne’ primi secoli dell’êra cristiana. La tradizione pretende che in origine fosse tempio pagano dedicato a Mercurio, e venisse poi convertita in chiesa cristiana e vi fossero deposti e venerati i santi avanzi di Esanto, Cassio, Severo, Secondo, Licinio e Carpoforo, che si dicono qui presso martirizzati per la fede, sotto l’impero di Massimiano Erculeo. Siccome poi nella medesima chiesa sarebbe, giusta la pia tradizione, sepolto anche Felice, pur chiamato santo e che fu il primo vescovo di Como, così alla esistenza di tutte queste preziose e venerate reliquie rese testimonianza una latina lapide, che or più non sussiste, ma che letta in addietro così suonava:
Huc veniens discat quæ corpora sancta requirat
Hoc altare tenet, sex tanto lumine splendent.
Hic sunt Carpoforus, tum Cassius, atque Secundus,
Et simul Exantus, Licinius atque Severus.
Hi spernendo viri mortem pro nomine Christi,
Nec metuendo mori, simul hic voluere reponi.
At talem numquam potuit quis cernere tumbam
Hic sanctis, sanctus locus est, multum venerandus,
[18]
Quem nullus cædat, potius sed dona rependat.
Extat et hic Felix divinis ductus habenis,
Verum divinum studuit qui dicere primum
Comi nempe bonus, primus fuit iste patronus:
In cœlis felix merito sit nomine Felix[2].
Il medesimo re Liutprando, che più sopra ho nominato, e il quale restaurò questo tempio e gli fe’, come già dissi, molti doni, vuolsi vi facesse da Roma trasferire eziandio i corpi de’ santi Giacinto e Proto.
Mette conto a chi ha asceso il Baradello il visitare questi interessanti avanzi. Si conserva tuttavia l’abside rotonda, la torre del campanile quadrata, la confessione sotto l’altare, o scurolo, come si direbbe dal volgo, od altrimenti cripta. All’altare poi si ascende per due laterali gradinate.
Ora il Baradello non è più calpesto da militi catafratti, ma percorso da allegre villanelle e da operosi [19] contadini, perciocchè sia tutto ricinto di fertili colli e vi si scorgano signorili ville. A fianco della suddescritta chiesa di S. Carpoforo sorge la villa de’ signori Venini, ora acquistata dal signor Castellini che ha un suo florido collegio di maschile educazione a Camerlata. Non più l’all’erta delle scolte parte dall’ampia torre, ma la canzone rustica di chi vi alberga si diffonde da quelle coltivate alture; non armi accolgonsi, ma istrumenti di agricoltura; ed alla bassa Camerlata non fortilizî più si ritrovano, ma gli edifizî operosi della ferrovia; e più in giù, nella vallata, alla destra di Como, opificî industriali; e al piede del colle, verso Garzola, la magnifica villa Larderia, ricca di acque che le scaturigini del monte le somministrano; poi quelle altre de’ Martignoni, della Prudenziana e del dottor Carboni. Così ai frequenti gridi di guerra che per quelle vaghe pendici s’udivano ripercossi dagli echi de’ monti circostanti, è succeduto il sibilo prolungato ed acuto, ma pacifico, della locomotiva che annunzia l’arrivo o che saluta la partenza di tanti e quotidiani viaggiatori; alle agitazioni delle fazioni e alle intestine discordie tennero dietro le tranquille cure e i riposi, a’ quali questi beati recessi, privilegiati da natura, sembrano unicamente destinati.
[21]
La città di Como. — La chiesa di S. Fedele. — La basilica di S. Abbondio. — Il Teatro. — Il Camposanto. — L’albergo Volta. — Chiasso. — Il Crotto e le polpette della Giovannina. — L’Albergo di Mendrisio. — Dottore e albergatore. — Il Monte Generoso. — Salita. — L’albergo del dottor Pasta. — La cura dell’aria. — Geologia, flora e fauna. — Il dottor Pasta. — L’albergo del Generoso. — Il tramonto. — Il Dosso-Bello. — La vetta. — Panorama. — Ancora l’albergo di Mendrisio. — La Cantina di Mendrisio. — L’Ospizio. — Vincenzo Vela. — Ligornetto. — Le cave di Arzo. — Le acque solforose di Stabio. — San Pietro di Castello. — Romanzo storico.
Discesi dalla facile e coltivata eminenza del Baradello, non s’aspetti il lettore ch’io lo conduca subitamente al lago e quivi il tragga al piroscafo che fumiga, ardente della sua corsa quotidiana a Colico, o il faccia entrare nel burchiello, come vorrebbe il navicellaio, che ci sollecita, il berretto nell’una e la catena della barca nell’altra mano.
Como ha ben altro ad intrattenerlo per un giorno, e anche più, quando ami le cose veder per bene, non già solo per la futile soddisfazione di poter dire: “ho visto.„
[22]
Fuor le mura avrà a vedere la chiesa di S. Fedele e la vicina fabbrica di macchine idrauliche del Regazzoni; la basilica di Sant’Abbondio, contemporanea a quella di S. Carpoforo, che ha già visitata sul Baradello, e che servì di cattedrale insino al 1013, in cui il vescovo Alberico v’ebbe a collocare i monaci retti dalla regola di S. Benedetto e la cattedrale aprì in città nel Duomo attuale, che pur interessa di visitare, come uno dei più insigni monumenti architettonici di Lombardia, autore Lorenzo degli Spazzi di Valtellina, compiuto poi da Tomaso Rodari di Maroggia, del quale son forse le due porticine dei fianchi, di squisitissimo lavoro. Ammirerà in esso diversi buoni quadri, fra cui il Natale di Gesù; l’Adorazione dei Magi; i santi Cristoforo e Sebastiano e lo stupendo S. Girolamo di Bernardino Luini; lo Sposalizio di Maria e la Fuga in Egitto di Gaudenzio Ferrari. Nè lasci di dare uno sguardo al Pretorio, che sta a lato del Duomo; al santuario del Crocifisso, per la fama che vi chiama a migliaja i divoti; al Liceo, dove è interessante il gabinetto di fisica, in cui si trovano macchine che servirono a quel sovrano intelletto scopritore della pila, ad Alessandro Volta vuo’ dire, al quale nella piazzetta prossima al lago venne eretta una statua, mediocre opera di Pompeo Marchesi; al Teatro, architettato dal Cusi, ampliato dal Ruspini e co’ bei dipinti del Pagliano e dello Speluzzi. Veda anche il Camposanto, architettato dal Tatti, e in cui si chiudono lodevoli monumenti, fra cui uno lodatissimo d’Antonio Tantardini di Milano.
Il ricapito poi per l’intera giornata e per quanto [23] ti avverrà di passare in Como, non andrai errato ad eleggerlo all’albergo Volta che, in riva al lago, sta presso al luogo d’imbarcazione sui piroscafi. Ammodernato, vi si introdussero tutte le lautezze d’un albergo di prim’ordine, e il forestiero di qualunque nazione e di qualunque più elevata condizione non può che trovarsi a suo bell’agio.
Era indispensabile codesta indicazione; il lasciarla sarebbe stata mancanza verso il lettore, ingiustizia verso chi ha dotato Como di uno stabilimento, senza cui avevasi ragione, scesi appena dalla Camerlata, difilarsi pari pari al vapore, per ire in traccia d’albergo o alla Regina d’Inghilterra presso Cernobbio, o alla Cadenabbia, o a Bellagio od a Menaggio.
Una passeggiata conviene ora che facciamo insieme, la quale avrei volontieri riservata, per procedere ordinatamente, allorchè giunti a mezzo del lago, che or misuro da Como a Bellagio, ci sarebbe occorso di scendere dalla barca o dal vapore ad Argegno, per metterci dentro la Valle Intelvi. Ma siccome non intendo di abusare delle gambe del mio lettore, nè farlo inerpicare di troppo su per le balze di San Fedele, così per giungere all’egual meta, approfittando delle mutate condizioni politiche che ricondussero fra noi e i nostri vicini della Svizzera le migliori relazioni d’amicizia, perchè già della medesima famiglia, onde non sia più mestieri ricorrere a passaporti o ad altri documenti [24] personali, usciamo di Como, montiamo adagiati in carrozza il facile pendio dell’Olimpino, varchiamo il confine italiano, e, oltrepassato Chiasso...
Ma no; prima di oltrepassarlo, d’una promessa ho a sdebitarmi.
Chiasso era dapprima una borgata, che sembrava fatta apposta per beneficio di noi Lombardi, che volevamo sdrucciolar fuori dalle mani de’ nostri passati dominatori, quando, per un capriccio di poliziotto, per un sospetto generato da cattiva digestione del direttore di polizia di Milano, ci volevano agguantare. Al di là de’ pilastrini che per mezzo di una trave abbarrano il confine, Chiasso si distende, per mezzo diviso dalla strada che conduce a Capolago ed a Lugano, fiancheggiato da erbosi colli e da montagne popolate da paeselli e casolari, come branco di pecore pascenti[3], direbbe il nostro Manzoni. Ora Chiasso ha bel rilievo da una nascente fabbrica di tabacchi, che prepara sì eccellenti cigari, da sembrare che lo faccia espressamente a rendere ancora più insopportabili quelli che a noi dà la Regía; ha un albergo; e per noi, che non abbiamo l’agio di soggiornarvi, ha il Crotto della Giovannina, deliziosissimo chalet, d’architettura svizzera, che il mio ottimo ed ospitale amico, il colonnello federale Costantino Bernasconi, ha fabbricato, ma che alla barba sua prese il nome dalla sua conduttrice, e che io raccomando a chi transita per Chiasso, non a’ gaudenti della vicina Como, che già vi corrono la domenica a chiedere le polpette della Giovannina, rese celebri oramai, e che farebbero [25] venire l’acquolina... no, volevo dire l’absinzio in bocca al chiarissimo autore della Giovinezza di Giulio Cesare, perchè di color mogano, com’ei le brama.
La promessa era appunto quella di segnalare questo simpatico recesso, a pochi passi dal paese, lungo l’acqua della Falopia che scorre in sottil vena, protetto dall’ombra di superbi tigli, fatto più bello e più fresco da una cascata pittoresca, e più ricerco pel suo vino di Chambery che vi si beve. Non dimenticherò l’ora che vi ho passata, nè il ballo della sera, dove al suono dell’organetto, uomini e donne di tutte le condizioni repubblicanamente ballonzolavano e si turbinavano in certe polke e in certi waltzer, che direbbonsi impossibili, se veduti non li avessi. Vidi colà l’elegante dalla cravatta bianca irreprensibile e il contrabbandiere in manica di camicia rimboccata all’insù del gomito, la guardia di finanza italiana e lo svizzero carabiniere, l’impiegato e il contadino, l’operaja e la sguajata manutengola del frodo; una baraonda, insomma, vispa, matta e rumorosa da comunicarvi, anche vostro malgrado, il buon umore e l’allegria.
Dopo ciò, tiriamo dritto.
Passiamo Balerna, villa un dì del vescovo di Como, rivendicata ora dal Comune, e arrestiamoci in Mendrisio all’albergo che dal paese assunse il nome d’Albergo di Mendrisio, del signor Bernardino Pasta, che, prima d’essere albergatore fu un egregio pittor di genere, [26] le opere del quale andavan spesso assai lodate alle esposizioni di belle arti nel palazzo di Brera a Milano. Sono quivi le pazienti cavalcature che ci devono condurre sul Generoso; perocchè non abbia detto ancora che lo scopo della nostra passeggiata è l’ascesa al Generoso.
E sarà bene che ci informiamo dapprima se l’albergo che sta sopra a questo monte abbia ancora qualche camera in libertà; perchè avvenga non di rado che inglesi e americani, tedeschi e francesi, italiani e svizzeri, tanto in numero vi si trovino, da non lasciarvi uno de’ cento e più letti che vi stanno; e in tal caso il signor Pasta Bernardino di Mendrisio, fratello al dottor Carlo Pasta, ch’è l’albergatore del Generoso, vi potrà allora ospitare degnamente; perocchè vi abbia adesso allestito il proprio albergo di tutti i conforti della vita.
Ad ogni modo, salvo a ridirne nel ritorno dal Generoso, noi possiamo farvi qui l’asciolvere nostro, mentre staccansi gli asini ed i muli dalla greppia e vi s’adattano le selle per le signore, e troveremo il nostro conto. La via ne richiamerà almen due ore; l’aria del monte ne renderà acuto l’appetito; sarà bene pertanto seguire il mio avviso.
Intanto che facciamo onore alla buona colazione che ci dà il signor Pasta, discorriamo un po’ del Generoso, che dovremo ascendere fra breve.
Esso è il monte più alto di quel gruppo delle Prealpi che sorge fra le valli di Mendrisio e d’Intelvi, e De Welden ne misurò l’altezza barometrica della punta meridionale fino a metri 1740, e il ticinese Lavezzari [27] quella della punta settentrionale fino a metri 1733 sopra il livello del mare[4]. Vien chiamato eziandio Mendrisone e Calvagione, con quest’ultimo nome venendo designato da’ valligiani del versante lombardo; ed appartiene tanto alla Svizzera italiana che alla nostra Lombardia, perchè appunto pria di giungere sulla vetta sta la pietra che divide i due territorj. Ma siccome a noi insegnano gli statistici che nel dire de’ confini d’un paese, non si abbadi a que’ limiti temporanei che può imporre la politica contingente, così certo non andò lontano dal vero chi il Monte Generoso, per la maraviglia del panorama di cui dispone da’ suoi culmini, ebbe a chiamarlo il Righi lombardo, a simiglianza di quello svizzero, che ergesi al di sopra di Zurigo, dove, malgrado la sua antica celebrità e la vista de’ sottoposti laghi di Zug, dei Quattro Cantoni, di Loverz e di Sempach, e de’ monti elvetici, non ha però l’ampiezza dell’orizzonte e la serenità del Generoso, ricinto non da brulle roccie, ma da monti coperti di verzura e di fiori, e sorridente alle acque del Lario e del Ceresio che si vedono scorrergli ai piedi, e più lontano a quelle del lago di Varese coi vicini laghetti di Biandronno, di Monate, di Comabbio e di Muzzano, e più lontano ancora a quelle del Verbano.
[28]
Ma le nostre cavalcature scalpitano, le nostre guide attendono: affrettiamoci. Quando discenderemo domani, occuperemo la giornata nel visitare gli interessanti dintorni del piano.
La via che scegliamo è la migliore. Se non abbiamo aspettato ad andare sul Generoso dalla parte di Vall’Intelvi, a causa del cammino dirupato, mai più non ci vorremmo noi avventurare per l’erta e non meno difficile via di Maroggio sul lago di Lugano e che passa per Rovio. Pigliamo adunque questa stradicciuola che ci scorge a Salorino: sarà la più facile, la più amena.
Breve è il tratto che riesce a quel montano paesello, e presto lasciatolo addietro, s’entra in una valle e quindi in boschi di castagni e faggi, poi si traversano praterie, si rasentano burroni, si aprono prospettive mirabili ed incantevoli: dappertutto si svolgono quadri d’una natura agreste, ma piena di poesia, onde legittima è l’estasi degli artisti, che ad ogni istante vi rinvengono trovate e soggetti a studî ed a schizzi. A quando ridente, a quando severa, sia che si presentino verdi tappeti smaltati di fiori, sia che si parino avanti roccie ed abissi, la via riesce ognora interessante, ed è appena se dal tumulto degli affetti che vi tenzonano nell’anima, tutta occupata dalle più svariate sensazioni, ora liete or melanconiche, e se dalle or sublimi ed or terrene imagini, che vi avvicendano il sorriso e la volontà del piangere, l’inno e l’anacreontica, vi richiama [29] il tintinnío della campanella del vostro ronzino, o l’inciampar di esso in qualche ciottolo importuno.
Non temere, gentile compagna della nostra peregrinazione; nessun pericolo si presenta lungo tutta la via; affidati secura alla robusta guida che fiancheggia la tua comoda cavalcatura, e tutta e interamente godi del nuovo spettacolo che ti si offre davanti.
Ma il filo telegrafico che d’un tratto si vede, ti invita a seguirne il corso e presto ti fa scorgere primi i fumajuoli, che mandando dalle loro gole colonne di fumo, avvertono che la meta è vicina, che l’abitato è imminente.
Ecco, l’albergo si affaccia finalmente; ecco.... lo vedi in tutta la sua estensione. Tanta grandiosità ti fa maravigliato e corri subito a pensare quanto ardimento sia stato quello di chi osò escogitarlo a tanta altezza, poichè siamo a 1209 metri sul livello del mare[5], e quanta fede abbia egli avuto nella sua impresa da avventurare tanta fortuna.
Questo coraggioso fu il signor Carlo Pasta.
Vorrei descrivere l’albergo magnifico a cui siamo arrivati; ma prima ne reclama l’attenzione nostra la persona del suo proprietario. Egli è venuto incontro a riceverci del miglior garbo possibile; è di lui dunque che prima dobbiamo intrattenerci.
[30]
Il signor Carlo Pasta non è soltanto albergatore: egli è il dottor Pasta. Non è quindi a cercarsi se in lui l’idea di rizzare questo magnifico stabilimento sia stata pullulata dall’interesse unicamente: egli, se da esso fosse stato mosso soltanto, non l’avrebbe osato; vorrei dire di più, sarebbe stato temerario. Medico dotto, egli vagheggiò la sua impresa anche a beneficio di chi vorrebbe poi ricercare il ristauramento della salute alla salubrità dell’aere. Sì, quassù sul Generoso non si viene per cure termali; il buon dottore lascia che le acque di queste balze scendano pei due versanti e si gittino per una parte nel Lario, per l’altra nel Ceresio; la cura ch’egli vi offre è quella dell’aria, ed è la meno incomoda, la meno dispendiosa, la più certa. Qui si allargano i polmoni che la bevono, si rinnova l’appetito, si rintegrano le forze, si alleggerisce dalle cure lo spirito, e si discende poi con tanto tesoro di salute e di buon umore da sfidare e le umide brume della bassa e il cumulo, non meno infesto, delle cure cittadine.
Lettore, se a te sono aperte le discipline delle scienze naturali, il tuo cammino può fornirti inoltre larga materia ad osservazioni e studî. Le condizioni geologiche delle roccie e l’abbondanza dei fossili possono esercitare assai spesso il tuo martello, se geologo; come la ricchissima flora ad ogni momento può arricchire la tua raccolta, se botanico.
La natura delle roccie è la calcarea grigia basica dell’êra giurassica; più in su per altro si incontrano banchi estesi stratificati di calcare rosso ammonitico, e più in su ancora altri banchi di un calcare bianco, più comunemente detto majolica, atto a mutarsi in [31] calce eccellente. Sulle vette del Generoso, nella roccia di calcare fosco si scoprirono conchiglie, spirifere, terebratule e pentacriniti, e nel calcare rosso molte specie di ammoniti.
Se poi si voglia erborizzare, verrà in copia sotto mano l’aconito, l’arnica, la genziana, la belladonna, l’assenzio, i rododendri, le rose, gli anemoni, le primule soavi, i ranuncoli, le achillee, le sassifraghe, le cinerarie, i candidi asfodeli, il nero veratro, le dafni alpine, le rute, le peonie, le silene, le betulle, le orchidee, i crisantemi corimbosi, e cento altre specie di piante, che io non saprei enumerare, ma delle quali il dotto Lavizzari ha tenuto esatto conto colla nomenclatura di Linneo e d’altri botanici[6]. Tutti però, anche al nostro occhio profano, col loro abito roseo o cilestro, giallo oppur bianco, violaceo o nero, fra tappeti di verzura e con tutte le gradazioni dell’iride, cospirano a smaltarci il cammino, a rallegrarci la vista, a profumarci l’aere, a compiere l’incanto di sì diverse scene. Fra’ cespugli s’ode il zirlare del tordo, su per gli alberi il gorgheggiare dell’usignuolo e il trillar della capinera; mentre dai greppi inaccessibili modulano i loro canti il passero solitario e il codirosso, e lontano lontano s’ode l’intermittente suono delle campanelle delle mandre pascolanti sulla montagna.
A tutto ciò aggiungi l’azzurra vôlta de’ cieli, limpida e pura come tra’ monti, il bacio dell’aure che ti refrigerano [32] e fanno stormir le frondi, le liste argentee dei laghi che ti vengono poco a poco apparendo, mano mano che salendo domini l’orizzonte, e ti scompajono quindi dietro un colle, per ricomparirti dipoi più estesi.
Io vi consiglio adunque la cura dell’aria del Generoso per una ventina di giorni almeno. Dai primi di maggio a tutto settembre lo stabilimento del dottor Pasta è a vostra disposizione; con riserva, io credo, che lo sia tutto l’anno, quando la ragione e la moda pe’ viaggiatori vi trarranno non interrotto concorso, e una via di ferro, come ho udito dirsi che intendasi di fare, ne agevolerà la salita.
Questo brav’uomo del dottor Pasta diventa ben presto l’amico e il consigliero de’ suoi ospiti. Di gentili e aperte maniere, colto non solo ma dotto, voi vivete tranquilli anche sul più leggiero incomodo di salute. Tutto ciò costituisce il segreto che attira tanto concorso a quest’albergo, sì che non valse a rattenere in Mendrisio più d’un Inglese, cui fu dall’alto telegrafato essere tutte occupate le camere dell’albergo e i più che cento suoi letti.
Stretta la mano al simpatico albergatore, sul piazzale stesso che sta davanti all’albergo, malgrado che la salita vi abbia per avventura un po’ affaticati, pure non potete a meno di rivolgervi a scorrere d’un’occhiata tutt’all’intorno il superbo e pittoresco orizzonte che vi si schiera davanti.
Ma esso vi basti per ora: di quell’orizzonte, ed anche di meglio, ci occuperemo nella gita che faremo sulla vetta di questo monte; ora piuttosto uno sguardo all’edificio.
[33]
La sua ortografia non presenta a primo aspetto eleganza di linee architettoniche; ma in compenso il suo disegno è pieno di armonia e severo. Sorge a tre piani da un terrazzo, entro il quale sono praticati sotterranei, dove è la cucina, la panatteria ed altri locali di servizio. Dalla parte opposta al piazzale d’ingresso ve ne ha un altro con giardino, e da dove l’occhio si spazia lungo il piano lombardo, giù per la china della valle del Po. Quivi è collocato un telescopio inglese, intorno al quale sono sempre i numerosi ospiti in traccia del più diletto punto di vista. Le città, le grosse borgate, le migliaja di villaggi, i santuari co’ loro acuminati campanili, le ferrovie, le lunghe linee delle più vaste strade e quelle de’ fiumi, e i bacini de’ laghi coi fumiganti piroscafi che li solcano, sono disseminati nel più stupendo panorama.
Entrati nell’albergo, tutto ammirar dobbiamo distribuito colla migliore intelligenza. V’è una vasta sala da pranzo, dove tutti i numerosi ospiti convengono all’ora indetta per la table d’hôte; una per la lettura, e vi stanno libri e giornali d’ogni nazione; un’altra assai ben intesa pel bigliardo; e tutte adorne di bei quadri e di specchi e addobbate con semplicità ed eleganza.
I tre piani superiori hanno ognuno una propria sala comune di ricevimento e numerose camere con eleganti suppellettili ed assai soffici letti.
Ho già detto più sopra che i comforts di questo stabilimento sono completati da un servizio telegrafico: la posta poi vi giunge quotidiana colle lettere e coi giornali.
[34]
Se si chiede poi quale il trattamento, la risposta si riassume in una parola: squisito. La cucina vi è ottima e scelta; latte, burro e miele freschissimi sempre e saporitissimi, quali possono fornire l’erbe aromatiche e i fiori della montagna onde si nutrono mandre ed alveari; e dopo tutto, la vostra borsa non si spaventi: i prezzi vi sono moderatissimi.
L’albergo, insomma, è accessibile a tutti, ed è già molto che in mezzo a tanta letizia non si cacci il roditore pensiero che poi vi si abbia a far iscontare in danaro gli splendidi orizzonti, le poetiche passeggiate e il sottile e salutare aere bevuto.
Cominciamo ora le nostre escursioni, poichè ci siamo riposati e rifocillati col copioso pranzo. Come, chiederete voi, ora che il sole tramonta?
— Precisamente perchè il sole tramonta.
Entriamo in questo sentiero quasi orizzontale che fiancheggia l’albergo e guida in dieci minuti alla spianata dal lato occidentale del monte.
Qui esso declina, qui sotto scintilla l’onda del lago di Lugano, ripercossa dai raggi del sole che piega al tramonto.
La scena è stupenda che ti si distende davanti. Nuvoletti frangiati d’oro o porporini vagano là sul confine dell’orizzonte, dove il Rosa lo chiude colle sue cime candide di neve; lunghe strisce del color della viola in altre parti listano il firmamento; il rancio del lembo [35] estremo si muterà fra breve nel rosso di fuoco, onde sembra che il
Ministro maggior della natura
pria di calar dietro i monti, ne baci d’un ardente bacio i culmini più sublimi.
Voi riguardate a quel solenne occaso, nel silenzio religioso di quell’ora; e dalla valle sottoposta, dove l’ombre giganti si distendono, sorge e viene insino a voi la squilla vespertina del villaggio che saluta il dì che muore.
La brezza aleggia più sollecita e viva...
Il sole è sceso dietro la linea de’ lontani monti: la luna gli succede nell’impero del firmamento. — Ritorniamo all’albergo.
Se t’arresti più giorni sul Generoso, non obbliare l’altra vaghissima escursione al Dosso-Bello, da dove ti si offriranno le ridenti sponde del Lario, colla fila non interrotta di paesi e di ville, e ti verrà dato rivedere da lunge la terra che già visitasti del Baradello, e la striscia del fumo che libera la locomotiva che da Camerlata muove per Monza e Milano.
L’indomani affréttati alla escursione più vagheggiata, fino alla vetta cioè del Generoso. È la meta di quanti traggono al già descritto albergo: e ben ne vale la pena. Sono alquanto più di cinquecento metri di altitudine a montarsi (531); il cammino richiede almeno un’ora e mezza.
Non isgomentarti, o lettore, delle prime asperità delle vie aperte sul fianco orientale del monte; più agevole si rende di poi la salita, mercè le cure del dottor Pasta. [36] Sono cinque anfratti che avrai a percorrere, ma dolci, senza vepri nè ciottoloni, in mezzo a pascoli ubertosi, ricchi di mandre, che vedete liberamente pascolare, sì che non la sete, ma piuttosto la curiosità di trovarvi fra roccie calcari una fonte a un chilometro dall’albergo, vi trae a gustar la limpida linfa che vi sorge.
Ma lieti e non affaticati, eccoci pervenuti alla vetta. L’ho già detto: la punta meridionale è a 1740 metri sul livello del mare e la settentrionale è di sei metri più depressa.
Qui sul molle e verde tappeto sediamo, perocchè le infinite meraviglie che ad un tratto si rivelano all’esterrefatto sguardo sieno troppe, e convenga una ad una distinguerle ed ammirarle.
Ah! voi vi sentite ora maggiori di quel che siete, quasi numi che imperate al creato, nel veder tanta e sì stupenda natura svolgersi sotto di voi. Ne’ giorni estivi, mentre sul vostro capo si distende limpida e serena la vôlta de’ cieli, vedreste adunarsi i nembi sotto de’ vostri piedi, scoppiar gli uragani, guizzar le folgori, e l’illusione della vostra divinità vi parrebbe più vera.
Ecco: la vetta, come dissi, è partita in due distinte prominenze, l’una dall’altra distante di circa trecento metri; questa che sogguarda al Lario segna il principio dell’Italia; quella che al Ceresio segna il principio della Svizzera. Su quest’ultima veggonsi gli avanzi di un segnale trigonometrico che servì per la triangolazione iniziata dagli astronomi ai tempi del primo regno d’Italia.
Qui posiamo, esclama pure il Lavizzari, sotto il cielo di Dante, di Colombo, di Leonardo, di Raffaello, di Galileo; [37] qui viviamo sul suolo di Lutero, di Haller, di Rousseau, di Bernouilli, di Saussure. Qui l’anello delle due nazioni; qui la terra dei vulcani tocca la terra dei ghiacciai; qui cessano i lauri, i mirti; qui incominciano i licheni, gli abeti; qui la rosa delle Alpi si intreccia colla peonia peregrina; qui il ranuncolo glaciale s’annoda alla silena insubrica; qui infine la flora del Mediterraneo si sposa alla flora germanica.
Girate ora lentamente lo sguardo all’intorno del vastissimo orizzonte. Da questa parte, che direi italiana, voi vedete dalle montagne della Valtellina, giù giù, seguendo la linea del lago di Como, tutta la lunga sequela di quelle, verdeggianti per lo più, che costituiscono l’ultimo contrafforto delle Alpi, e dietro le altre sul cui pendio s’adagia Bellagio e più giù la Pliniana, il Moncodine o Grigna, il Monte Campione ed il Monte Serada o, come più popolarmente è detto, il Resegone, onorato di mirabile descrizione da Manzoni.
Pervenuto il vostro occhio alla città dei Plinii e di Volta, più in là sospingendolo, per una infinita serie di punti biancheggianti, che sono altrettanti paesi, vi trovate a Monza, quindi a Milano, subito di essa avvertiti dalla freccia ardita dell’aguglia principale del suo Duomo; indi vi si presenta la valle del Po e nel fondo l’azzurra linea degli Appennini. Convergete la pupilla a destra e vedrete Varese, Arona, Novara, Torino: Crema, Cremona e Vigevano le vedrete del pari al manco lato, o in direzione su per giù di Milano.
Poi, a sfondo di quella ove avete distinta Torino, vedete le cime del Rosa e del Bianco incoronati di perpetui geli, il Monviso, il Cenisio, l’Ortlerspitz, il Mischabel, [38] il Pizzo della Bernina, lo Spluga, il Medelser, il Lucmagno, il Gottardo, il Galenstock, il Wetterhorn, il Fünsteraarhorn, l’Eiger, il Mönch, la Jungfrau, il Bietschœrner, l’Aletschkorn, il Fletschorner, il Mittagshorn, il Weissmies, il Cervino, il Winterberg ed altri moltissimi, che dalla vetta di questo Generoso vide e nominò quel rinomato naturalista che è G. Studer, nel suo Panorama des Alpes, disegnato sullo stesso nel 23 settembre 1869, e che io sono lieto di possedere.
Verso ponente poi la vista riesce per avventura più pittoresca, dominando sulla vasta regione montuosa che dalla Val Sássina si stende alla Val Cavargna, scorgendovisi l’estremità del lago di Lugano col villaggio di Porlezza, un breve tratto di quel di Como verso Bellagio, e belle ondulazioni di monti, e vallate disseminate di villaggi, di prati e di boschi, coi più graziosi contrasti di luce e d’ombra, da innamorare un pittore.
L’intrepido passeggiero, dove il voglia, potrà nel suo soggiorno sul Generoso pigliarsi un bel dì lo spasso di scendere dalla sua vetta alla Vall’Intelvi, prendendo il sentiero che mena ad Orimento, indi a San Fedele o a Castiglione in due ore e mezza; da dove potrà andare per San Fedele e Luino ad Osteno, che si specchia nelle onde del Ceresio, oppure per Dizzasco ad Argegno, che si specchia in quelle del Lario.
Ma noi dobbiamo rifare la nostra strada, riedere all’albergo del dottor Pasta, dove le cavalcature ci attendono per ridiscendere a Mendrisio.
[39]
E poichè siam di nuovo all’Albergo di Mendrisio del signor Bernardino Pasta, ch’era una vera necessità per questa grossa borgata (la quale vi rammenta la Gismonda di Silvio Pellico), le lautezze che offre e le comodità che lo fanno raccomandatissimo ai touristes, v’invogliano certo a fermarvi una o più giornate.
Nè vi troverete pentiti, da che le vicinanze hanno non dubbie attrattive per chi a viaggi od anco alle escursioni di piacere non pone scopo il materiale diletto soltanto, ma la ricreazione dello spirito eziandio.
A coloro che di quest’ultima sono poco curanti e preferiscono il primo, additerò le rinomate cantine di Mendrisio stesso, e avanti tutte quella che si denomina il Crotto del monte Generoso, e il buon vino parrà loro migliore per la vaghezza del luogo.
Agli altri indicherò visitare dapprima l’Ospizio di Mendrisio stesso, aperto agli infermi del Canton Ticino, giusta il volere del suo fondatore, il conte Alfonso Turconi. Quivi ammireranno un pregevolissimo bassorilievo in istucco dello scultore Pietro Bernasconi, e una statua rappresentante il Turconi medesimo, alla lode della quale basta pronunziare il nome del suo autore: Vincenzo Vela. — Tanto nomini nullum par elogium!
E poichè v’ho proferito il suo nome, come non visitarne l’elegante edificio, o villa, in Ligornetto, che sta a mezz’ora da Mendrisio e sorge in piccola eminenza tutto recinto da giardini, e dove quell’egregio si ritrasse [40] troppo presto ad onorato riposo? La cupola che si eleva nel mezzo piove la luce sull’ampio locale, dove l’illustre artefice raccolse i modelli delle opere principali sue, che il resero così illustre, da divider egli meritamente col toscano Dupré lo scettro della italiana scultura.
Poi potrete visitare le cave de’ marmi di Arzo, che sono di un rosso variegato, e le acque solforose di Stabio efficacissime e che solo han d’uopo d’avere decenti stabilimenti che le ministrino, per conseguire fama ed affluenza maggiori; e finalmente la storica chiesa di San Pietro presso Castello, che dista pure non più di mezz’ora da Mendrisio.
La rinomanza della chiesuola non è soltanto per la bella vista che vi si gode di parecchie terre svizzere e lombarde, ma altresì per un’orrenda strage avvenutavi in que’ miserevoli tempi che ardevano le ire fratricide de’ Guelfi e de’ Ghibellini.
Gli è un soggetto da romanzo, e però chiuderò la passeggiata nostra, col toglierla di netto dal Lavizzari e ripetervela adesso.
L’avo dell’illustre letterato Virunio Pontico della famiglia dei Busioni di Mendrisio, era Pietro, uomo d’alto affare; e Margherita sua moglie era ornamento delle donne de’ suoi tempi. La loro figlia Lavinia colla rara sua bellezza destava tale ammirazione, che vedevasi costretta ad evitare il pubblico sguardo. Invaghitosi perdutamente [41] di costei il ghibellino Vizzardo Rusca, dimandolla sposa, rinunciando alla dote, e offrendosi non solo alla pace, ma ad imbrandire le armi contro i nemici della famiglia di lei. La supplichevole inchiesta fu negata dai genitori; ma Vizzardo, non perdendo la speranza, e vagando di nottetempo al modo degli innamorati intorno alla dimora della fanciulla, udì una sera da una stanza terrena i genitori di Lavinia dire che avrebbero piuttosto strozzata colle mani loro la figlia, anzichè concederla sposa a Vizzardo. Questi, fremendo d’amore e di sdegno, diessi ad ordire il feroce disegno di esterminare tutta la nemica famiglia. Egli uccise nove figli di Pietro; ma non potè raggiungere Lavinia, che il padre aveva nascosta entro un sotterraneo, ove rimase finchè Vizzardo fu ucciso. Il costui cadavere fu trascinato sulla sepoltura dei nove innocenti e quivi lasciato in pasto alle fiere. Frattanto moriva il padre, il quale fu sepolto in marmoreo avello nella chiesa di San Sisinio alla Torre, sovra un poggio presso Mendrisio.
I Ghibellini andavano tessendo insidie a Giorgio, avvenente fanciullo, decimoquinto figlio di Pietro, e che fu poi padre di Virunio Pontico[7]; volevano farlo divorare dai mastini, che a tal uopo nutrivano. A Margherita riescì di celare il prediletto Giorgio ne’ suoi poderi [42] di Besazio presso il monte San Giorgio. Ma nel tornarsene a casa l’afflitta e irrequieta donna, di nuovo corse indietro per rivedere il figlio, e non avendolo tantosto colà trovato, cadde svenuta, nè si riebbe se non quando il rivide. Diede allora al figlio molto denaro ed un gomitolo di refe (marsupium pecuniarum auri et glomum rephi tradit)[8], comandandogli di fuggire tanto lungi che non udisse più il nome del suo paese. Giorgio recossi a Napoli; e mentre da parecchi anni viveva in molto favore della regina Giovanna, la madre, caduta in potere degli spietati nemici, veniva tratta da Mendrisio al castello di Capolago, e quivi sul lato sinistro della via crudelmente sospesa ad un’arbore. L’infelice Margherita, in procinto di morte, implorava contro gli uccisori de’ nove innocenti suoi figli un vendicatore. Udito l’orrendo fatto, Antonio, altro suo figlio, maggiore di Giorgio, radunò la sua fazione, e nella notte di Natale, entrato nella chiesa di San Pietro in Castello, trucidò uomini, donne, fanciulli ed il sacerdote all’altare; vi lasciò più di cento cadaveri. Questa inaudita strage avvenne nel 1390, quando già da dieci anni Antonio e Giorgio erano andati in lontano esilio. Lavinia, innocente causa di sì miserandi fatti, ricoveratasi a Belluno, ove il fratello Giorgio era capitano del presidio, si consacrò a vita claustrale e fu sepolta nella chiesa di [43] San Francesco. Antonio, andando peregrino al Santo Sepolcro per espiare, secondo l’uso de’ tempi, i suoi delitti, perì in mare.
Compiuta così questa gioconda camminata, rifacciamo ora la strada e riconduciamoci, piena l’anima di sì svariate impressioni, a Como; nè più deviamo quindinnanzi dal proposito delle nostre escursioni per le sole terre dal Lario e per quelle dall’Éupili bagnate.
[45]
Brunate e la leggenda di Guglielmina. — La Grotta del Mago. — Le ville Castiglioni, Sessa, Pertusati e Cornaggia. — Villa Angiolini. — Villa Rattazzi. — U. Rattazzi e Maria Bonaparte Wyse. — Villa Pedraglio. — Le ville Trubetzkoi, Ricordi e Artaria. — La villa Carena inabissata. — Blevio. — La villa Bocarmé e la Comton, ora Lattuada. — Il Pertugio di Blevio. — Il Buco del Nasone. — Le ville Taglioni, Schuwaloff, Vigoni e Sparks. — La Roda e Giuditta Pasta. — Adele Curti. — Il Nino.
Dovrei dedicare questa escursione, più che alla comune de’ miei lettori, a que’ beati gaudenti che si chiaman felici allora che hanno potuto snidare alcun luogo, in cui il buon vino, o la specialità di qualche intingolo o manicaretto li han solleticati. Essi vi danno una fama, una celebrità, che si conserva anche quando la ragione più non ne esista affatto.
E i beati gaudenti intraprendono pellegrinaggi appositi per visitare queste stazioni epicuree: testimonio questo Nino, a cui traggono non soltanto i buongustai della vicina Como, ma e da’ paesi più alquanto lontani e perfin da Milano. Una bella giornata di primavera o d’estate, una festa, il ferragosto, deve essere consacrata [46] a qualche baldoria che già abbia il suo principale obbiettivo nella tavola e più ancora nel buon vino? La brigata operaja di Milano o di Como per acclamazione elegge subito d’andare al Nino.
Seguiamoli noi pure. Avremo noi di tal guisa occasione, più che di deliziarci del buon vino, di rapidamente percorrere le ville che sono sulla destra sponda del lago infino alle sette città di Blevio, che così designansi per celia quelle frazioni d’un unico villaggio che si sparpagliano sul monte, infino a quella punta sporgente, che con quella che ha di fronte, e che denominasi del Pizzo, accenna al fine del primo bacino del lago, il quale si viene ripartendo in tanti bacini, tutti aventi peculiari bellezze, qual più vasto, qual meno.
Pigliam la barca pertanto, e il nostro uomo costeggi pur lentamente questa sponda, su cui poggia il Nino; chè pria di giugnervi, avremo a parlar di più cose.
E poichè ci siamo, vedete là su in alto del monte il paesello di Brunate. A me che amo raccogliere le leggende popolari, come ad un geologo balzerebbe il cuore di gioja alla scoperta d’un petrefatto, o ad un numismatico il ritrovare una medaglia antica, non è possibile passar oltre senza narrarvi che lassù raccontino le comari, come la figliuola di un possente re d’Inghilterra, a cui fanno il nome di Guglielmina, avesse un bel dì (l’epoca però non sanno e tutt’al più se ne sbarazzano colla frase d’uso: ne’ tempi antichi) a fuggire dalla reggia di suo padre, e per farvi vita santa ricoverasse a Brunate e vi morisse poscia in odore di santità. E la pia leggenda ha sì fonde le radici, che le madri alle quali il latte faccia difetto, la invocano protettrice. [47] Quale poi sia la relazione che corra fra la santa giovinetta ed il latte, nè esse lo sanno dire, nè m’accingo a indovinarlo.
Alla falda del monte v’è la Grotta del Mago che potrebbesi visitare, costituita di banchi calcarei che s’incavernano; ma siccome non mi fu detto perchè mai così con nome di mistero nominata, voghiamo avanti.
Qui appena usciti dalla cinta del nuovo porto — il quale, se risponde forse meglio al bisogno cittadino e varrà fors’anco a infrenare certe piene che in passato troppo spesso han nuociuto alla parte di Como che si curva intorno al lago, certo poi le ha rapito anche parte della vista del lago stesso, e il discapito mi par grande —, passato il borgo di Sant’Agostino, incominciano le ville.
E prima la Castiglioni, indi la Sessa, poi la Pertusati; e questa che s’avanza sul promontorio detto di Geno è la villa dei Marchesi Cornaggia, dove un giorno era un convento di Umiliati, che durò dal 1225 al 1516, tramutatosi poi in lazzaretto pei colpiti dalla peste, onde fu travagliata non solo Como, ma Lombardia tutta sul finir del secolo XVI.
Svolta la punta di Geno, si nicchia, come in un angolo che fa il monte, la villa Angiolini; ma più in vista vi tien dietro quella che assume il nome da quell’eminente uomo di Stato che è il commendatore Urbano Rattazzi, a cui ingiustamente tiene Lombardia il broncio per averle estese sollecitamente quelle leggi amministrative che aveva il Piemonte e che le sarebbero pervenute egualmente più tardi, se non dovevano essere [48] un’irrisione il patto dello Statuto patrio che vuol la legge eguale per tutti e l’unità nazionale; senza aggiungere che taluno de’ lombardi deputati d’allora avesse fatto nel Parlamento suonare alta la voce che, fossero state anche ottime le leggi austriache che si avevano prima, per ciò solo si dovessero mutare. Il più liberale di quanti ministri ebbero Piemonte ed Italia, è sventura che scribivendoli piovutici in Milano, e impossessatisi de’ nostri giornali, abbiano potuto sostituirne l’opinione e, facendo la storia a loro talento, avessero a presentare questo illustre personaggio, dal cuore pari allo ingegno eccellente, poco men d’un nemico del paese. Il tempo che non è così grullo e che non giura nelle parole di questi sicofanti, farà la giustizia.
È in questa leggiadra casina che Maria Bonaparte Wyse, bella e colta consorte sua, e fra le più riputate scrittrici francesi, dettò le più lodate pagine della sua Louise de Kelner, in cui tanta parte è trasfusa delle amarezze, onde l’anima sua generosa venne dagli stolti abbeverata.
Se recinto da maggiori simpatie, alle quali avrebbe avuto diritto Urbano Rattazzi, nella quiete di codesta sua villa, dopo le lotte parlamentari e le cure di Stato, vi sarebbe più frequente venuto a ritemprare lo spirito e rinnovare le forze.
Tien dietro, a poca distanza, la villa Pedraglio, e poi ci si affaccia il sospirato Nino.
Diamovi gli ordini pel pranzo, indi proseguiamo a costeggiare questa sponda.
Il principe Trubetzkoi, colle mine si preparò lo spazio [49] entro la dura roccia del monte per rizzarvi un casino di stile nordico, onde colla più sciagurata freddura fu chiamato del principe Turbascogli; non è forse la postura più allegra ad una villa; l’arido sasso che incumbe non vi concede quella gajezza di pensiero, che tutta invece vi ispira la villa Mylius, che, se al vero non mi appongo, è tra le meglio intese del lago. Casa e giardino vi sono egregiamente distribuiti.
Le ville Ricordi e Artaria hanno del pari i loro pregi: presso a queste era la villa Carena, ma un bel dì del novembre 1868 inabissò nelle ore meridiane, volendo fortuna che nessuno degli uomini che vi lavoravano perisse, perchè appena usciti. Fosse lezione ai molti che troppo spesso, ad ampliamento di loro possessi, invadono ciò che spetta al lago, il quale non attende a’ loro comodi, ma viene il dì che si ripiglia i suoi diritti!
Eccoci a Blevio.
È paese alpestre che non mette conto di ascendere, da che le belle ville che adornan la sponda ci seducano meglio; a meno che non vogliate visitar quella che più su è dei signori Bocarmé e che dicono meritevole di vedersi, e la villa e vaghissimo giardino già Comton ed ora spettante al signor F. L. Lattuada, negoziante di Milano; o spingendosi ancora più su, noncuranti delle asprezze del cammino, non vi prenda curiosità di cercare il Pertugio di Blevio, lunga galleria orizzontale alta un braccio al più e occupata dalle acque colatizie della montagna. Se di siffatte naturali cose voi siete amanti, non lasciate allora di volgere la vostra attenzione all’altro speco, o spacco verticale, che da quegli alpigiani vien designato col nome di Buco del Nasone, [50] opportunamente difeso da macigni onde non vi precipitino dentro gli armenti che vi pascolano vicino. Forse nel fondo di tale speco si potrebbero rinvenire fossili, se fosse possibile di praticarvi indagini.
Presso alla chiesa parrocchiale di Blevio è la villa di quella famosa danzatrice che fu Maria Taglioni, la quale, fabbricandola, sperò passarvi gli ozî dell’età matura, quivi pascendosi delle floride memorie che le avrebbero richiamate le corone d’alloro, i ritratti e tante altre opime spoglie de’ suoi teatrali trionfi, che qui depose. Ma la fortuna, bizzarra e spesso crudele iddia, volle disporre altrimenti.
Così chi avrebbe detto al principe Schuwaloff, che vi eresse vicino una graziosa villa con architettura russa, che di essa, come d’ogni altra pompa e commodità mondana, sarebbe stato sì presto schivo, e colla religione greca de’ suoi padri, l’avesse ad abbandonare per rendersi barnabita in Milano, e poscia in Parigi, ove scrisse La mia conversione e la mia vocazione, ivi morendo nel 1859?.... Legata egli questa sua villa del lago a’ suoi compagni di religione, veniva da essi venduta a quel dotto intelletto di donna che fu Cristina Trivulzio principessa di Belgiojoso, autrice di lodate opere dettate nell’idioma francese, e spentasi soltanto nel passato anno 1871. Ora toccò la villa in eredità alla figlia Maria maritata al marchese Trotti.
Tengon dietro le ville Belvedere Vigoni e la Sparks, questa d’architettura svizzera; ambe leggiadre, e con peculiari caratteristiche che le rendono interessanti allo spettatore.
Un’altra villa succede, che ricorda pure entusiasmi [51] teatrali: La Roda è detta e fu di quella grande artista cantante che si nomò Giuditta Pasta. Apparteneva prima a madama Ribier, la crestaja che a Milano fu ricerca da tutto il mondo elegante e accumulò gran fortuna. Venuta poi alle mani della celebre cantante, per la quale Bellini scrisse la Norma e la Sonnambula, cioè i suoi insuperati capolavori musicali, la ampliò d’assai, vi fabbricò, vi dispose giardini ed ombre, e fino a certo tempo vi accolse anche ospiti e amici, fra cui sovente quella gentile e rinomata poetessa che fu Adele Curti, troppo presto rapita alle lettere, e troppo presto e ingiustamente dimenticata, anche da chi ipocritamente si scagliò su colui che fu creduto averne con offesa d’amore accelerato il fine, su colui che invece non ha cessato ancora d’amarla, testimonî questi versi, che di lui si leggono stampati sulla strenna edita in Napoli, intitolata Il Vesuvio, a scopo di beneficenza, e dettati ventiquattro anni dopo quella immatura morte.
Sovente l’ora quando è fatta bruna,
A te pensando che ogni dì più adoro,
Io chieggo ai raggi dell’argentea luna,
Se il tuo bel peplo è della luce loro.
Ed alle stelle che la notte aduna,
Se son le gemme del tuo serto d’oro,
E se dal ciel se ne dispicca alcuna,
Io tremo e quasi per dolcezza moro.
Chè penso allor che tu fedel mantenga
Quella promessa che mi festi pia,
E che ti prego dal Signor m’ottenga.
E che la stella fuggitiva sia
L’anima tua, che dall’empireo venga
A raccoglier la stanca anima mia.
[52]
Giuditta Pasta in questi suoi diletti recessi della Roda trascorse i suoi anni provetti, ma afflitti però da domestici lutti. Ella anche vi morì. Un suo busto, opera egregia dello scalpello del milanese Antonio Tantardini, fu da’ Comensi collocato nel loro casino.
Ma l’ora del pranzo ci richiama al Nino.
La mensa, noi, stando in barca, la vediamo apparecchiata sotto un pergolato che dà sul lago; così al diletto dei cibi avrem congiunto quello non meno grato della vista.
Risparmio la descrizione del Nino: è un’osteria, un restaurant, quel che volete chiamarlo, di volgare architettura a cui chi giunge non fa attenzione. Vi si sbarca, si pon piede su d’un terrazzo, dove son disposte tavole per chi vi mangerà o beverà; v’è buona cucina, v’è buona cantina; chi ci viene, lo sa, se ne approfitta; nè parte, come da tanti altri luoghi, disilluso.
D’altre specialità, che non sieno brigate, canti, giuochi alla morra, suoni di qualche menestrello che capita da Como, non vi saprei dire veramente.
Il Nino è il ritrovo della buona classe borghese, per definirlo in due parole; come per la haute volée è l’albergo della Regina d’Inghilterra, che sta alquanto più in su nella sponda opposta, ed al quale riserbo condurre il lettore in una prossima escursione.
[53]
San Fermo e i volontarî di Garibaldi. — Borgo Vico. — Villa Barbò. — Il Museo di monsignor Giovio e la villa Gallia. — Villa Saporiti, già Villani. — Bonaparte e i deputati di Como. — Palazzo Resta. — Ville Salazar, Bellotti, Mancini, Brivio, Belgiojoso, D’Adda e Pisa. — Villa Mondolfo. — L’Olmo del marchese Raimondi. — Caninio Rufo e Plinio il Giovane.
La meta di questa escursione è pel contrario un cotal po’ aristocratica. Non prometto ai lettori di condurli alla scoperta d’un Crotto, o di qualche elegante albergo: la nostra passeggiata non va che di pochi passi fuor del sobborgo Vico, che si distende sulla destra sponda del lago, il qual può dirsi in questo suo primo bacino una serie non interrotta di ville, che si riflettono con femminile civetteria nelle onde.
Ci basti all’uopo noleggiare un burchiello, e così, toccando appena dei remi, farlo avanzare lentamente. Nè vi darò l’incomodo di scendere ad ogni tratto, chè mi sento d’informarvi d’ogni cosa interessante rimanendo in barca seduti.
Quel filare di piante è il pubblico passeggio della città; più dietro e per la via che vi fu praticata forse [54] trent’anni fa, si ascende a S. Fermo dove ne’ primi di giugno 1859 audacemente i volontarî di Garibaldi attaccarono gli austriaci di Urban e li ruppero con prodigi infiniti di valore.
Dopo la chiesa di S. Giorgio, che precede al pubblico passeggio, incomincia il Borgo Vico e con esso la villa dei marchesi Barbò da Soresina, dove un giorno sorse la celebre villa denominata il Museo del già ricordato Paolo Giovio, vescovo di Nocera, che, a’ suoi giorni, aveva il poco invidiabile coraggio di altamente proclamare aver egli a propria disposizione due penne, l’una d’oro per chi ben lo pagava, di ferro l’altra per chi ciò non faceva: su per giù del resto il mal vezzo di certi giornalisti d’oggidì di mia conoscenza, che senza quel coraggio di dirlo, han tuttavia quell’altro di farlo. Or bene il Giovio, lo storicone altissimo dell’Aretino, in quella sua villa accumulato aveva quante preziosità potè racimolare, sia per doni avuti spontaneamente, sia per premi imposti e ricatti. Nella prefazione alle sue opere Ritratti d’uomini illustri ne fece una lunga descrizione, che, comunque interessante, risparmio al lettore, del quale debbo già di troppo esercitar la pazienza col narrargli delle ville che sussistono realmente adesso. L’abate Gallio demolì nel 1616 il Museo, e la villa che ne sorse sulle rovine si chiamò la Gallia, che ultimò il marchese Fossani, ed ha buone pitture del Morazzone e del Bianchi.
Segue la villa Saporiti, che un dì apparteneva ai marchesi Villani e figurò allora nel processo intentatosi a Londra contro Carlotta di Brunswick, regina d’Inghilterra, del quale dirò parte a parte nella ventura [55] escursione, e narra Cesare Cantù che vi alloggiasse nel 1797 il generale Bonaparte, prescelta per l’eleganza del suo ammobigliamento, e che ai deputati di Como che gli si erano presentati, porgesse franche assicurazioni che non sarebbero ni francesi, ni tedeschi, ma italiani. Dopo i Villani ebbero la villa i Battaglia.
Sul terreno della Badia di Vico fu eretto il palazzo dei conti Resta; più indietro è la villetta elegante dei conti Salazar; ancora lungo il lago sorge quella de’ Bellotti; poi quella de’ nobili Mancini, dei conti Belgiojoso, dei marchesi Brivio, de’ marchesi D’Adda, del banchiere Pisa, e finalmente del conte Sebastiano Mondolfo, che coll’orgoglio legittimo consentito dal merito, giusta il concetto d’Orazio, sume superbiam quæsitam meritis, può come il romano Oratore vantarsi incominciare da sè la nobiltà. Colle ingenti somme da lui consacrate a scopi di beneficenza, coll’ajutare nazionali imprese, egli, triestino, s’è conquistato la cittadinanza milanese e la benemerenza nostra.
In questa sua villa, che siede sulle rive ridenti del Lario, trovò nell’acquisto un prezioso e grandioso dipinto del pittor Bossi, rappresentante l’ingresso del general Pino in Milano da Porta Romana alla testa dell’armata italiana reduce dalle campagne napoleoniche del nord. Interessantissimo riesce principalmente un tal quadro per tutte le foggie di vestir popolare che vi si riscontrano nelle molteplici figure che lo popolano, e più ancora per i ritratti dei principali personaggi che vi sono rappresentati. Vi si ammirano altresì quattro pregevolissimi acquerelli del Migliara, resi ancora più interessanti, perchè istoriati da quattro diversi episodî [56] di quel tristissimo tumulto che finì coll’eccidio dell’infelice ministro Prina, onde si bruttò la storia della mia città.
E così eccoci giunti ora alla meta della nostra odierna escursione: all’Olmo.
Possiamo lasciare la barca.
Codesta villeggiatura, veramente principesca, oscura tutte le altre in grandiosità e ricchezza. Anche la villa che su questa dell’Olmo o ben presso sorgeva, a’ tempi di Plinio, ed era di Caninio Rufo, non era di certo inferiore, se non all’odierna grandiosità, certo alla sua amenità e vaghezza; e poichè mi son proposto di ricordare storici fatti e tradizioni che si collegano a queste ville lariane, mi si permetta che io qui trascriva il brano di Plinio il Giovane[9], nel quale l’amico Caninio Rufo intrattiene di questa sua villa:
“C. Plinio a Caninio Rufo.
„Che fa Como, tua e mia delizia? Che quell’amenissima tua villetta? che quel portico, dove è sempre primavera? Che quell’ombroso boschetto di platani? Che quel verde e lucidissimo canale? Che quel sottoposto ed util lago? Che quel molle e pur saldo stradon gestatorio? Che quel bagno tutto quanto riempito e circondato di sole? Che quel tinello per molti e l’altro per pochi? Che le stanze da giorno e quelle da notte? Ti godi forse a vicenda or le une or le altre? O, come [57] îl solito, ne sei distolto da frequenti corse, a fine di attendere a’ tuoi negozi? Se tu ne godi, sei felice e beato; non sei che volgo se ne fai senza.„
Distrutta, non si sa come nè quando, la villetta di Caninio Rufo, ora questa più vasta vi sorge, che dicesi dell’Olmo. La fabbricò il marchese Innocenzo Odescalchi di Como su’ disegni di quell’illustre architetto ticinese che fu Simone Cantoni[10], vi profuse stucchi, dorature, specchi e dipinti. V’è in una sala una gran fascia di figure scolpite da quell’emulo di Canova che fu Thorwaldsen, e vi sono mille altre preziose cose d’arte.
Toccò questa villa in eredità al marchese Giorgio Raimondi, che generosissimo vi menò lungo tempo la vita; ma dopo le sventure toccate alla insurrezione nostra del 1848, fra le proprietà sequestrate dalla stoltezza de’ proconsoli austriaci, questa fu pure dell’Olmo, che, a sommo dispregio delle cose nostre e in odio del Raimondi, le dorate sale convertirono in caserma, e sallo Iddio di qual modo conciassero tutte quelle preziosità.
Sciolti dopo i sequestri, di tanti guasti stomacato forse il marchese Raimondi, piacendosi d’altre sue comode e non profanate villeggiature, questa più non curò e, se la voce non erra, non ricuserebbe dallo spropriarsene.
Qualche regnante o gran ricco che aspiri a trovarsi [58] lungo il Lario una delizia — poichè nella amenità di queste terre e di queste acque si danno convegni principi e ricchi d’ogni nazione —, vi troverebbe alla villeggiatura dell’Olmo il suo conto, e la villeggiatura dell’Olmo ritornar potrebbe tuttavia a’ suoi giorni di prosperità e splendore.
[59]
Gite montane. — Il trovante dell’Alpe di S. Primo. — Il Sarizzo. — Grotte e caverne. — Grumello. — Villa Celesia. — La Zuccotta e I Tre Simili. — Il signor G. B. Brambilla. — Villa Caprera del signor Loria. — La Tavernola e l’Albergo. — Villa Gonzales. — Il capitano De Cristoforis. — La Villa Bignami. — La Villa Blasis. — A Carlo Blasis. Versi. — Il Bisbino. — Il Pertugio della Volpe. — Marmi e pietre.
Alla campagna, non è sempre a paesi, a mercati, a ville che si ami, a ragion di piacevole passeggiata, andare; ma assai spesso ben anco a cert’altri luoghi, dove o la natura li rese interessanti, o la loro postura concede che si godano panorami od estesi orizzonti. Nè sono cotali escursioni le meno piacevoli, anzi il più spesso sono quelle che divertono meglio. Il lago di Como e il Pian d’Erba, che noi dobbiamo percorrere allegramente insieme, ti presentano, amico lettore, molti e amenissimi punti di tal fatta, che saran certo anche per te deliziose mete a gite, a refezioni allegre, come lo sono per tanti.
D’ordinario infatti vi si va recando il necessario per la colazione: è così buono anche il più semplice companatico quando è ammanito dall’appetito, reso più acuto [60] dal lungo cammino fatto a piedi o sul dosso di qualche mulo o asinello, e dalla fresca brezza che spira sempre dalle frondose selvette, onde si vestono le nostre colline, i nostri monti. E quelle chiare, dolci e fresche linfe che scaturiscono improvvise dai massi, e, formantisi in rivoletti, scendono così seducenti di balza in balza, che t’invitano a gustarle o nel palmo della mano, o alla foggia dei biblici soldati di Gedeone, o nella barchettina di cuojo.
Qui lungo il lago di Como avviene che nelle corse montane che si fanno si trovino altre curiosità, che, anche senza essere geologi e naturalisti, richiamano l’attenzione; quali, a mo’ d’esempio, enormi massi o trovanti di granito, staccati dal monte e per nulla aventi a fare colla natura della roccia di esso. Celebre è quello, a cagion d’esempio, che scorgesi a sinistra del lago sull’alpe di S. Primo e che molti traggono a vedere, e quelli che vedremo sul monte che sovrasta a Blevio. La presenza di tali trovanti ci attesta de’ cataclismi avvenuti, come i fossili e le conchiglie, che su per le vette di queste Prealpi si trovano, ne lascian credere che veramente un giorno fosse questa nostra Lombardia tutta quanta un mare.
Ma di secoli da quel tempo devono essere trascorsi a centinaja.
Diffatti massi erratici si sfruttano dall’industria per fabbriche, e in commercio si conoscono sotto il nome di sarizzo; tanto l’uomo sa trar profitto di tutto!
Richiamano altresì l’attenzione e de’ geologi e dei profani certe grotte e pozzi e caverne che si trovano, come il Pertugio detto della volpe, al quale è diretta [61] la nostra peregrinazione odierna; il Buco di Blevio e quello appellato del Nasone che gli stanno rimpetto; quello dell’Orso su Torrigia, a cui pure ne ho destinata un’altra; e la Grotta della Masera sopra Careno e Premenù sopra Pognana, e il Buco della Nicolina e quello di Vallombria sovra il piano del Tivano, dove pure condurrò più avanti il lettore, e la Tana Selvatica sopra Grandola in Val Menaggio e Biancamonda sopra Villeso, per non dir di tutte.
E siccome mi piace serbare un po’ d’ordine in queste nostre escursioni, e far in modo che nulla sfugga alla nostra osservazione (s’intende nulla del meglio), così, rammentandomi che siam rimasti alla villa del marchese Raimondi, denominata l’Olmo, passiamo in rassegna le graziose e ricche ville che si vengono succedendo: ci parrà più corta la via, per giungere al Pertugio.
Se vi pare di variare, qui potete farne senza della barca; perocchè è una buona via abbastanza larga per trascorrervi la carrozza e farvi pure lo scambio con quell’altra che le venisse incontro per ricondurvi al sentiero che si sale alla montagna. Io per altro ho promesso di accennarvi a tutte queste leggiadre casine che si specchiano come vaghe odalische nel lago, e tiro dritto in barca.
La prima che s’incontra è il Grumello, villa ora del genovese banchiere Celesia, ma che prima fu dei Gallio e poi de’ Giovi. Ha vicino la sua darsena, come, quale in un modo, quale in un altro, l’hanno tutte; perocchè aver la villa lungo il lago e non possedere la sua lancia, o la gondola, o il canotto, o il piccino ed [62] agile sandolino che sfiora appena l’acqua, è quanto non averla. La più parte delle passeggiate è sul lago, e sovr’esso si trascorre sempre al mattino, meno al meriggio, indispensabilmente prima o dopo il desinare. Con taluna di queste snelle imbarcazioni si va al mercato di Como, si passa alla posta del paese a dare e ritirar le lettere, si rasenta la sponda o si traversa per le visite, si va incontro a’ piroscafi per vedervi i passeggieri, o per la sola voluttà di farsi cullare dalle grosse onde che nel moversi ne fan le ruote; si fanno infine le escursioni di piacere; insomma si san sempre trovare le occasioni d’essere in barca; così che possa dirsi, senza dare nell’iperbole, che gran parte della giornata la si passi sovra il lago.
Eccovi questa villa che è al di là della strada: è la Zuccotta e appartiene al signor Giovan Battista Brambilla, banchiere di Milano. Innanzi ad essa sarei tratto a farvi un po’ di maldicenza, non a danno del suo ultimo possessore, ma a beneficio del suo antecessore, sempre nell’interesse della storia; ma preferisco rimandarvi a quel libretto divertentissimo che dettò quello svegliato ingegno di Defendente Sacchi, molti e molti anni fa, allorchè la Zuccotta era venuta alle mani di quel furbissimo abate che fu il professore Pietro Configliachi. Il libretto ha per titolo I tre Simili, e ci dice come qualmente la villa la Zuccotta, acquistata co’ danari d’una signora, rimanesse invece con mirabile artificio proprietà dello abate. L’è tutta una rappresentazione di prestidigitazione da disgradare Cagliostro. A’ tempi in cui usciva questa storia per le stampe, gli Austriaci erano qui nell’apogeo della loro [63] dominazione; epperò dovette stamparsi alla macchia e passarsi dall’uno all’altro, quasi un numero rivoluzionario della Giovine Italia.
Questa villa era stata edificata dai signori Volpi; il Configliachi, da uomo di sottile ingegno, ne l’aveva di molto abbellita; ma chi la ridusse alla vaghezza d’oggidì fu l’odierno proprietario di essa signor Brambilla, che elevandola fino al sommo della collina e occupando parte del Cereseto, che il Cantù dice lodato per fichi squisiti, la fece tra le migliori onde il lago si pompeggia. Quivi accolse oggetti di pittura e di scultura, e deve essere per lui di non poca soddisfazione nel vederli innanzi a sè, ripensare che ognun di essi rappresenta una commissione da lui data a questo o a quell’artista, e da lui data in tempo, quando cioè può valere altresì a beneficenza. Queste cose sono omai così poco e da’ pochi comprese, che rilevarle, per lo scrittore è un dovere.
Più avanti il medesimo signor Brambilla, traendo partito da qualche spazio concessogli dal capriccioso lago, fabbricò un bellissimo palazzino, che, in omaggio al Titano d’Italia, intolò Caprera, e non è a dirsi come lo fornisse d’elegante suppellettile. L’una sola di queste ville oh come appagherebbe le aspirazioni di molti! Ora essa divenne proprietà del ricchissimo signor Loria, che la grande fortuna ammassata ne’ commerci in Egitto sfrutta degnamente fra noi. Il suo palazzo di Milano è tra le migliori e suntuose opere architettoniche del nostro tempo.
Dalla Caprera alla Tavernola, già degli Stagnoli, ora di proprietario tedesco, non corrono che pochi passi. [64] Quivi è facile trovare chi vi affitti, se bramate gustarvi gli ozî lacuali, molto più poi che ora vi si è stabilito un albergo. Il luogo è bello, comoda la casa, proprie le suppellettili, splendide le vicinanze. Non sarà certo inopportuna questa mia designazione. Essa venne architettata da quel valoroso che è il Tatti.
La villa Gonzales vi succede. Sorge a testimonio di quanto possa l’ingegno anche sopra la nascita e l’educazione di convenzione. Il Gonzales, datosi agli appalti e fattosi più volte milionario, qui si aveva preparato deliziosissimi ozî e riposi dalle annuali fatiche. Spiegò il gusto de’ gran signori dalla natività: le sue allogazioni artistiche non sono state mai a casaccio, ma presiedute dalla intelligenza. Il Fasanotti, principe de’ nostri paesisti, della villa del Gonzales fece uno de’ soliti suoi capolavori. Fu l’onore allora della pubblica mostra di belle arti di Brera; ora lo è della superba casa del signor Gonzales. Fra gli altri molti oggetti d’arte che vi accolse, evvi il bellissimo Ismaele dello Strazza e un bel quadro di Sebastiano De Albertis, raffigurante la morte del capitano De Cristoforis, avvenuta nella fazione di S. Fermo già ricordata. Ma, tanta delizia, contro la comune aspettazione, ora da lui fu ceduta a ricco straniero; tanto è vero che l’uomo propone e Iddio dispone.
Poi la villa Bignami, eseguita dietro disegno dell’architetto Clerichetti, e basta per dirla di buona architettura; e quindi la Cima, che deve la sua esistenza al generale Pino, di cui dissi già addietro e avrò a dire nella prossima escursione ancora. Fu in questa villa che quel famoso vi moriva nell’anno 1826.
Dietro di queste ultime ville, al di là della strada [65] carrozzabile, che ho già sopra ricordata, presso il torrente della Breggia, che passando nella Vall’Intelvi, viene presto a buttarsi nel lago, una graziosa villetta, che per me ha grandissimo valore, attrae il vostro sguardo. Tersicore vorrebbe esser detta, perocchè essa appartenga al suo più celebre sacerdote vivente, a Carlo Blasis vuo’ dire, che congiuntamente a quella somma artista che fu Annunziata Ramaccini, che gli è compagna, portò la R. scuola di perfezionamento di ballo di Milano a quell’altezza e fama che ognun sa. Nel Blasis l’insegnamento egregio non fu l’effetto soltanto delle tecniche nozioni apprese alla sua volta in giovinezza, ma il frutto altresì di quella coltura onde erudì lo spirito, e delle dottrine estetiche nelle quali è maestro e per le quali potè donare alle lettere e all’arte sua un preziosissimo Manuale della danza, un filosofico volume Sull’uomo fisico intellettuale e morale, e infinità d’altri lavori di scienza e di erudizione, che il resero l’indispensabile collaboratore di non so quanti giornali artistici italiani ed esteri.
Mi conceda il lettore che io dedichi all’amico la versione d’un enfatico carme latino che il direttore del Propagateur du Var, Dario De Rossi, pubblicava in onore di lui. È sì raro che periodici francesi riconoscano il merito de’ nostri, che chi legge avrà caro che le pagine di prosa ora alterni con versi che sì onorevolmente testimoniano d’un nostro concittadino.
Non mai, se il dolce di Calliope labbro
Mi sorridesse, o da Polinnia il dotto
Artificio non fosse a me negato
De’ carmi, o pur se d’imitar col canto
Mi fosse Orfeo da pio destin concesso;
[66]
Non mai, Blasis, potria le tue virtudi
Degnamente narrar onde risplendi,
Siccome astro fulgente in sul creato.
A la palestra le solerti membra
Ad addestrar tu insegni, e tu la danza
Guidi ed al piede la cadenza, e il modo,
E la posa ed il gesto e ogni movenza,
Memore ancor dell’arte prisca, apprendi.
Il diviso dall’orbe irto britanno,
Ammira e plaude; e quei che pria Colombo
Sotto l’ardente sol scopriva audace
Dopo acerbe fortune e l’aspra gente
Delle Esperidi e quei che del Sequano
Flutto nobil si fa, popol di Francia,
Inclito in armi e nel civil costume,
Blasis, dal genio tuo, da tanta altezza
Di tua mente commossi, al ciel la lode
Del tuo nome innalzar e della terra
Itala che ti fu larga nodrice
E della tua s’onora inclita fama.
Te la Gloria sublima e il tuo sembiante
Ritrae nel marmo. — A che ricordo io mai
Queste povere cose? — Oh! non da meno
De’ più gagliardi ingegni, osasti primo
Tu dell’uomo indagar le meraviglie
Note appena ridir ed ogni moto
Dell’animo a che valga e i nostri petti,
L’abito di natura, onde agli offici
C’informiam della vita ed alle eccelse
Regioni ci estolle, o in giù trascina
E ci offusca le menti e il corpo solve;
Che mai possa la donna e quanto ingegno
E nelle membra sue vigore accolga;
Quali rifulgan per sapere e quali
Alla patria devoti emergan forti
Nelle battaglie eroi, o la lor vita
Abbian dell’Arti al sacro culto intesa.
[67]
Quanto fai, quanto scrivi, a te le menti
Concilia, o Carlo, e raddolcisce i petti
Ed è fama così che la prestanza
De’ tuoi modi squisiti abbia lasciati
Ricordevoli molti; al par di pianta
Che frondosa al venir di primavera
S’incorona di fiori e nell’estiva
Stagion pendon dai rami i dolci pomi.
Quivi de’ lor melodïosi canti
Empion l’aure gli augelli e qui per lungo
Cammino il vïator stanco riposa
E le forze a la fresca ombra rintegra.
O dell’Italia onor, de la severa
Sofia decoro, lungamente vivi
All’arte e a’ tuoi, felice! e quando avrai
Grande e incolume i tuoi giorni compiuti,
Te Clio, te Euterpe e la virtù non morta
De la tua patria adducano immortale
Sovra nuvola ardente in grembo al cielo!
Ma qui ne è forza balzar dalla barca e ascendere il monte che nomano il Bisbino. Badiam però che la sua sommità sia libera e serena; perocchè quando essa si incorona di nubi, gli è indizio che il cielo si turberà, che non tarderà guari a piovere a dirotto:
Se il Bisbin mette il cappello,
Corri a prendere l’ombrello;
così avvertono, a mo’ di sentenza, quelli del luogo.
Sulle sue pendici seggono le grosse terre di Piazza e di Rovenna, dove è anche una bella chiesa e dove, non ricordo in qual tempo dell’anno, è una sagra a cui corre gran gente, ma più ancora al Santuario sulla vetta.
Più in su è il Pertugio della Volpe.
La vista che al di fuori ci si offre è incantevole: valeva [68] la pena di venirvi. Ma descrivervi il panorama non mi calza, da che la descrizione è esaurita per chi montò sul Generoso. Tuttavia a chi non garba il maggior incomodo di salire fin lassù, questa vista del Pertugio della Volpe lo paga certo del minor disturbo.
Entriamo adesso. È una grotta che s’addentra assai e assai: i banchi calcarei che vi sorgono e la rendono ineguale, vi palliano la lunghezza. Fu misurata novecento metri: sarà vero? Io non mi sto fra coloro che si mostran troppo increduli, nè mi voglio, San Tomaso novello, metter la mano a sindacare. Parmi migliore civiltà arrendermi a chi me la spara grossa... e saran dunque novecento metri di lunghezza, e voi credetevi, o lettori; e se no, pigliatevi il gomitolo del villano di Barnabò Visconti e misuratela a vostro talento.
Vuolsi ricca questa grotta — alla quale per avventura qualche volpe snidata ha dato il nome — di alabastri venati; ma già questi monti che fiancheggiano il vaghissimo Lario sono sì larghi depositari di marmi e pietre che interessano il naturalista e lo speculatore, che se n’avrebbero a scrivere volumi. Intanto godono gran rinomanza il marmo bianco di Olgiasca che prolungasi sulla riva opposta del lago, ove presso Musso già esistevane una cava; quello nero di Varenna; la pietra di Moltrasio che riducesi anche a lamine sottili per grondaie di tetti e pavimenti; le lumachelle della Tremezzina e il sarizzo che ho testè accennato, e il marmo bindellino che è nel letto del Varrone, e moltissimi sassi calcari che alimentano attivissime fornaci.
E qui basti e discendiamo, perchè l’ora si fa tarda.
[69]
Cernobbio. — Debitori e Monache. — Villa Bolognini. — Villa Lejnati. — Villa Belinzaghi. — Garrovo. — Il general Pino. — La villa d’Este. — Giorgio IV d’Inghilterra. — La principessa di Galles. — Suo processo. — Sua morte. — Sue opere alla villa d’Este. — L’Albergo della Regina d’Inghilterra. — L’acqua della Coletta.
Un giorno m’accadde di dire che un libro ben curioso sarebbe quello che s’avesse a fare Dei misteri del lago di Como. Già il lettore che mi ha seguíto ne ha per avventura intraveduto taluno; ma siccome questo volume è destinato a tutt’altro fine, non mi farò a rivelarli adesso, limitandomi però a riassumere quelli che sono già caduti nel dominio della storia, e che per conseguenza non ponno più esser misteri.
D’altronde, so che il titolo di Misteri del lago di Como piacque ad altro scrittore e li ha dettati; non li ho letti, — come si può giungere a tutto? — ma suppongo che saranno indubbiamente una storia immaginosa, [70] sul tenore delle altre congeneri, — e allora non era quella la mia intenzione[11].
Io voleva con quel pensiero alludere alle cento misteriose scene cui furono teatro le varie ville che si stendono dall’una e dall’altra sponda del lago; scene d’amore, scene di crimini, di romanzo e di assisie, burlevoli e più che serie, che a raccorle ed ammannirle vi vorrebbe la penna di Sue o di Dumas, di Ponson du Terrail — poichè v’ha anche il terribile — o di Gaborieau, i romanzieri alla moda in Francia.
Ora in questa mia escursione non chiamerò il lettore ad assistere a scene misteriose, ma ad uno storico avvenimento; quantunque il processo cui fece luogo fu ben lungi dallo squarciare interamente il velo di tutto quanto si compì fra le pareti della villa d’Este.
E prima di tutto non lasciamoci passare queste altre che ci conducono alla nostra meta; esse hanno tutto l’interesse al nostro sguardo: eleganti, graziose ne accivettano a far omaggio anzitutto alla bellezza, poi a monsignor Milione.
La prima è rappresentata nella villa Bolognini, dalla più leggiadra e graziosa creatura, cui stia a maraviglia sulla bellissima testa la corona ducale; la madre sua, divenuta principessa, ebbe la dedica d’un magnifico [71] romanzo di Balzac, in cui le è dato tributo altresì di spirito, e quel messere in fatto di spirito poteva ben essere giudice competente.
Ma qui ci troviamo in Cernobbio: una parola del paese.
Il nome di esso lo si fa derivare da cœnobium, cenobio, da un monastero che v’era di cluniacensi, e credo che sia una delle migliori e incontrovertibili etimologie. Ai cluniacensi succedettero le monache; ma sembra che l’aria del lago e queste naturali maraviglie delle sue rive rendano infiammabili gli animi, ardenti i cuori, e che le povere recluse fossero facilmente spinte a voluttà e gusti poco ascetici, se non soltanto qui, ma anche altrove, come vedremo, l’autorità regia, o l’ecclesiastica, se ne dovette ingerire e mandarle a menare quella vita altrove. Le monachelle di Cernobbio furono cacciate dal loro ridente soggiorno da quel nemico di cocolle e di veli che fu Giuseppe II.
La cronaca ha serbato memoria d’un solo avvenimento di questa borgata, che pare dovesse essere un tempo più popolosa e forte. Narrasi che nel 1433 alcuni uomini di Cernobbio fossero stati tratti per debiti nelle carceri di Bellagio; che ad altri loro conterranei fosse entrato il ruzzolo di liberarneli, e là recatisi di cheto, ne li avessero cavati a forza. Era duca di Milano allora quel prepotente di Filippo Maria Visconti, il marito della sventuratissima Beatrice di Tenda, che, avuto sentore appena dell’avvenimento, mandò ad istituire il processo, sperando scoprire i colpevoli; ma poichè la sapienza di quegli inquisitori non giunse a darli nelle mani, il Visconti fece sommaria vendetta, [72] desolando tutta la terra di Cernobbio, ch’era assai più industriosa, e consegnando alle forche quanti avevano osato opporgli resistenza.
L’industria maggiore de’ suoi abitanti è in oggi la pesca e i nauli, guidando essi cioè le imbarcazioni de’ molti che affluiscono a bearsi delle delizie del Lario, ed eseguendo i trasporti di pietre, calce e derrate.
Ho dato omaggio alla bellezza: ora alla ricchezza.
Questa è rappresentata in Cernobbio dalle due ville dei banchieri Lejnati e Belinzaghi, che vi raccolsero in esse tutte le opportune comodità della vita.
Più oltre un cancello vi annuncia il parco della Villa d’Este.
Il cardinal Gallio, che si pretende nato in Cernobbio, fabbricò questa villa che è fra le più grandi e sontuose del lago; tanto così che or fan due anni l’imperatrice di tutte le Russie vi trovava comodo albergo. Passò di poi in proprietà ai conti Calderari, onde da Garrovo, che si chiamava dapprima, si nomò poscia da essi, infino al dì che Carolina Amelia Elisabetta di Brunswick, principessa di Galles, venuta in Italia nell’anno 1816, eleggendola a propria stanza, vi impose il nome di Villa d’Este, che le rimane ancora.
Il general Pino, che sposava una donna dei Calderari, riceveva con essa anche la villa; e un bel dì che l’affettuosa sposa attendeva in quegli ozj il marito, fece, sulle alture onde si chiude il recinto della villa e che per felice combinazione rassomigliavano in minori proporzioni a quelle su cui a Tarragona di Spagna si distendevano i fortilizî che il marito aveva coll’armi italiane espugnati, rizzare tanti fortini che imitassero [73] in piccolo que’ maggiori, così preparando al marito la più grata sorpresa. E poichè meglio si ravvivassero in lui quelle grate e gloriose memorie, disponeva che gli alunni del collegio militare di Milano, istituito a San Luca dal generale Teulié, vi venissero a far loro armeggiamenti, attacchi e fuochi con mirabilissimo effetto.
Ma la Villa d’Este fu teatro a scene più importanti di questa, per lo scandalo che ne fu fatto per Europa tutta, e che rivelò il famoso processo che si compì in Londra nel 1820; e siccome da tutti si chiede come, perchè e quando venne dato alla villa il nome che essa ha, come e perchè il nome di Regina d’Inghilterra fu imposto al bellissimo albergo che nel giardino venne edificato dal barone Ciani, che tutta la villa acquistò e vi fabbricò per entro casini, dominato, com’era solito a dir egli, dal mal della pietra; così mette conto che io narri questa storia scandalosa e più scandaloso processo, compendiandola da’ Processi Celebri che la resero ne’ suoi particolari.
La vita di disordine e di dissipazione, cui, dopo d’essere uscito nel 1781 dalla minorità, s’era interamente abbandonato quel Giorgio Augusto Federico, principe di Galles, erede presuntivo della corona d’Inghilterra e che fu poi Giorgio IV, rimase così notoria, che di poco aggiunse a popolarizzarla il bel romanzo di Gozlan.
I suoi banchetti ricordavano le cene dell’impero di Roma: Fox, Sheridan, Brummel, Erskine, Grey e Russel [74] ne erano i compiacenti compagni nelle orgie, negli stravizzi, nelle vergogne, come erano i più eleganti che costituivano la fashion inglese. Superbi equipaggi, amanti di gran prezzo, dispendî pazzi in giardini e palazzi, e perfino giunterie di giuoco si alternavano co’ stravizzi nelle più ignobili taverne: non una tradizione in lui di quella moralità e austerità, nella quale era stato nella fanciullezza cresciuto in corte. Carlton-House fu il teatro di tanto scialacquo e dissolutezza.
Non bastavano a sì grandi follie nè la rendita fattagli di cinquantamila lire sterline, nè i redditi del ducato di Lancaster. A capo di tre anni di sua maggiorità egli aveva già inoltre creato a sè un debito di mezzo milione di sterline, vale a dire dodici milioni e cinquecentomila franchi. Insorsero i creditori, il re Giorgio III si ricusava di pagare, lo scandalo crebbe, e la Camera dei Comuni, dopo un dibáttito scandaloso, finì col votare una somma di 161,000 sterline (4,025,000 fr.) per pagarne i debiti.
Incappato dipoi nelle reti di una signora Fitz-Hubert, cattolica irlandese, costei giunse a farsi segretamente sposare, sebbene un tal matrimonio fosse colpito di nullità, contrario essendo alle leggi del regno, queste non permettendo a’ principi della famiglia reale di contrarlo prima de’ venticinque anni; oltre che il matrimonio del principe ereditario con una cattolica lo escludeva dalla successione al trono.
Aumentati inoltre i suoi debiti, dai quali punto non aveva ristato, fino alla ingente somma di 642,890 sterline, a meglio cioè di sedici milioni di franchi, parve al governo non esservi altro riparo che un matrimonio legale.
[75]
A vincere gli aperti rifiuti opposti dal principe, fu adoperato James Harvis, più tardi conte di Malmesbury, esperto negoziatore durante le guerre della repubblica e dell’impero francese, le cui Memorie, lasciate dopo morte, forniscono i più curiosi particolari circa il modo da lui usato per condurlo ad accogliere l’offertogli partito.
I creditori, all’uopo sollecitati e divenuti a lui insopportabili, determinarono finalmente l’adesione del principe al matrimonio, ch’egli chiamava il proprio suicidio.
Gli venne fidanzata Carolina Amelia Elisabetta di Brunswick, figlia di quel duca di Brunswick che nel 1792 forzò audacemente le frontiere di Francia.
Mirabeau aveva attestato di lei esser amabilissima, spiritosa, bella e assai vivace; ma il signor di Malmesbury nel 1794, quando fu conchiuso il matrimonio (2 dicembre), la trovò, oltre che già di più di ventisei anni, se abbastanza bella e con due stelle di occhi, anche un cotal po’ triviale, con denti mezzo guasti e spalle impertinenti.
La cronaca del paese mormorava di lei, come di donna leggiera, avida di piaceri, e la faceva eroina d’una romanzesca fuga con un giovine uffiziale della corte del padre.
Ne completeranno il breve schizzo che ne ho fatto queste bizzarre particolarità che si leggono nel giornale dello stesso conte di Malmesbury.
“— Il principe, madama, — le disse questo abile negoziatore un giorno — è assai delicato per ciò che riguarda la nettezza. — Il giorno dopo la principessa comparve assai bene lavata dalla testa ai piedi.„
[76]
“Ho avuto, scrive lo stesso Malmesbury, due colloquî colla principessa Carolina, uno sulla pulizia e sulla decenza, ed un altro sul riserbo nel parlare. Ho procurato, per quanto può farlo un uomo, di convincerla della necessità di porre molta attenzione in tutte le parti del suo abbigliamento, sia in quello che si vedeva, sia in quello che rimaneva ascoso... Sapevo che portava delle sottane grossolane, delle camicie ruvide e delle calze di filo, e non fossero neppure ben pulite e cambiate abbastanza di frequente!... È singolare come su questo punto sia stata trascurata la sua educazione e come sua madre, benchè inglese (Augusta, sorella di re Giorgio III), vi abbia fatto poca attenzione. L’altro nostro colloquio versò sul modo leggiero con cui parlava della duchessa (sua madre), burlandosi sempre di lei e dinanzi a lei... Ella capisce tutto ciò, ma lo dimentica...„
Questi erano gli sposi: vediamo i frutti di tal connubio.
Il principe di Galles mandava a Greenwich, a ricevere la sua sposa, lady Jersey sua recente amante, ciò che stabiliva fin dai primi momenti in costei una acerrima nemica di Carolina, perchè non le aveva dissimulato frizzi pungenti che non si perdonano.
Trovo scritto che la prima notte di matrimonio fu degna di questi sponsali. Dopo alcune ore, il principe abbandonava il letto nuziale, senza dissimulare il suo [77] turbamento, la sua collera e il suo disgusto. Che pensare dei misteri di questa notte? Si parlò d’ubbriachezza, di trasporti lubrici, di scoperte umilianti.... Checchè ne sia, è certo che il principe, ubbriaco come un facchino, passò la maggior parte della notte sdraiato, non nel letto nuziale, ma su d’un tappeto.
Dopo tutto, il 7 febbrajo 1796, nove mesi successivi a quella notte, Carolina dava alla luce la principessa Carolina Carlotta Augusta di Galles.
Ma non fu codesto un anello di ricongiunzione fra i due sposi. Il principe di Galles continuò a vivere separato dalla moglie; anzi, dopo due lettere scambiatesi fra essi, come a specie di convenzione d’una separazione di fatto, la principessa di Galles si ritrasse a Black-Heat nel Devonshire, da cui di rado si toglieva per comparire a corte; intenta, del resto, alle cure della propria bambina.
Nel 1804 cominciò la maldicenza, incitata da lady Jersey, a esercitarsi a di lei danno. Disse di scandalosi amori suoi con lord Eardley, e si pretese che William Billy Austin, fanciulletto da lei caritatevolmente ricoverato e amato, fosse il frutto di adulteri amori.
La delicata investigazione che si istituì l’assolse completamente, e si trovò che il fanciullo era invece dello spedale di Brownlow-Street, ed erano suoi genitori Sofia Austin e un falegname di Deptfort, conchiudendosi che i di lei accusatori avrebbero meritato di essere processati con tutta la severità delle leggi.
Ma ciò non avendo giovato a ritornarle tutta la reverenza dovuta al suo grado, molto più che l’investigazione e i suoi risultamenti erano stati tenuti segreti, [78] ella ne reclamò al re suo suocero, invocando la pubblicità di tutto. The Book, che ne fu la raccolta degli atti, comparve; ma giunto al potere Perceval, che era stato consigliero alla principessa di quella pubblicazione, ne scongiurò lo scandalo e soppresse il libro, e diè egualmente soddisfazione a Carolina, operando in guisa che Giorgio III e i due fratelli del principe di Galles le facessero solenni visite, e che una decisione del consiglio di Stato ne confermasse l’innocenza.
Ma gli odî del marito crebbero a dismisura, ed ei le tolse la figlia. Ricorse ella, ebbe nuova riconferma d’incolpabilità, ma non riebbe la figliuola.
Le fu interdetto allora ricomparire a corte, non potendo il principe, divenuto reggente per la demenza del padre, incontrarsi con lei. Ne chiese ragione a lui medesimo, ma non n’ebbe risposta tampoco.
La figlia Carlotta veniva destinata dal reggente al principe d’Orange, erede presuntivo del trono de’ Paesi Bassi; dovendo mal suo grado obbedirvi, in capo lista delle persone che dovevano invitarsi al matrimonio la giovinetta scrisse il nome della madre. Giorgio gliela ritornò radiandone il nome; ma Carlotta alla sua volta cancellò un nome: era quello del futuro sposo, e rinviò al padre la lista. Ella andava sposa poco dopo al duca di Sassonia Coburgo.
La principessa di Galles risolse allora di abbandonar l’Inghilterra.
Il Parlamento le fissava l’appannaggio d’annue lire cinquantamila sterline; essa non ne accettò che trentacinquemila, e partiva il 9 aprile 1814, assumendo il nome di contessa di Wolfenbüttel.
[79]
Si diresse dapprima al suo paese natio; quindi partì per la Svizzera, visitò l’Italia, la Grecia, la Turchia, la Palestina, Tunisi; poi si stabiliva a Pesaro, e da ultimo a questa villa Calderari sul lago di Como, che ricevette da lei, come già sa il lettore, il nome di Villa d’Este.
Quale fosse la vita della principessa di Galles all’estero, e principalmente su queste rive del lago, non ne è spenta la memoria fra noi. V’hanno di molti ancora che rammentano averla veduta, che si trovarono ai licenziosi balli cui ella assisteva alla Barona presso Milano, che la riconobbero ai veglioni della Scala con travestimenti impossibili o toalette sconvenienti; come moltissimi ne levano a cielo ancora gli atti infiniti di una inesauribile generosità e carità.
Queste sponde del Lario echeggiano tuttavia degli inni riconoscenti alle sue splendide beneficenze. Ella allargò e compì la via che da Como metteva alla sua residenza e spese assai denaro in altre opere vantaggiose a quel paese.
Se non che l’odio del marito e l’ira de’ nemici da lei lasciati in Inghilterra non s’erano tenuti paghi di sua partenza: essi la seguivano nelle sue peregrinazioni, nel suo volontario esilio. Neppur si volle informarla della morte della figliuola, neppur di quella del suocero Giorgio III, avvenuta il 29 gennajo 1820, da lei sapute entrambe soltanto a caso.
[80]
S’inasprì ancor più la persecuzione contro di lei coll’avvenimento di suo marito Giorgio IV al trono. Il suo nome fu tolto dalle preghiere della liturgia britannica, e le fu messa, per così dire, a’ fianchi una commissione segreta che ne spiasse la vita.
E questa nella sua permanente inchiesta, stabilita fra persone influenti in Milano, raccoglieva fatti, circostanze, nomi e testimonianze terribili contro di lei.
Carolina, reclamando contro le misure summentovate prese in Inghilterra contro di lei, minacciava recarsi a Londra a reclamare i suoi privilegi di regina; ve la aizzavano i whigs che avrebbero voluto suscitar con ciò gravi imbarazzi al nuovo regno; sconsigliavanla i tories collo spauracchio d’uno scandaloso processo. Nulla temendo Carolina, sullo scorcio del maggio 1821, arrivò in Francia, deliberata d’incarnare il proprio progetto.
Lord Hutchinson le venne incontro, e da parte di lord Liverpool, ministro di Giorgio IV, le offriva aumentarle l’appannaggio fino a 50,000 lire sterline all’anno, purchè restasse fuor d’Inghilterra, non assumesse titolo di regina, nè altro spettante alla famiglia reale d’Inghilterra.
Ella rispose a questa proferta, imbarcandosi sul pachebotto inglese Principe Leopoldo per Londra.
Sbarcata sul suolo inglese, vi fu accolta colle dimostrazioni più onorifiche dovute a regina e con entusiasmi che l’accompagnarono fino alla capitale, dove passando innanzi alla residenza reale, la folla emise all’indirizzo di Giorgio IV formidabili grugniti, modo col quale quegli eccentrici isolani esprimono disapprovazione; ma questa marcia trionfale veniva arrestata [81] dal ministero in cui sedeva lord Liverpool, il quale la sera del sei giugno presentava alla Camera dei Lord un messaggio reale, mentre lord Castelreagh faceva altrettanto alla Camera dei Comuni, quivi depositando un sacco verde contenente i documenti d’accusa contro la regina, che nel messaggio e nelle parole de’ ministri veniva tuttavia chiamata la principessa di Galles. L’accusa era di adulterio.
L’impressione prodotta fu grave, poichè si temesse non fosse per riuscire a rinnovare i tempi d’Anna Bolena e Giovanna Grey; ma lord Liverpool temperavala, dicendo che il fatto d’un adulterio commesso all’estero con uno straniero non costituisse che un’ingiuria in linea civile; e voleva con ciò rassicurare i nobili lord che non si sarebbe trattato di pena di morte.
Carolina intanto aveva preso alloggio in Brandenburg-House.
Ecco il bill delle pene e delle penalità (Bill of pains and penalties), che lord Liverpool lesse nel Parlamento:
“Atteso che nell’anno 1814 S. M. Carolina Maria Elisabetta, allora principessa di Galles, ed ora regina sposa d’Inghilterra, residente allora a Milano, prese al suo servizio il nominato Bartolomeo Bergami o Pergami, straniero, di bassa condizione, essendo stato domestico; atteso che dopo d’essere il detto Bergami entrato al servizio di S. A. R. vi fu tra di loro un’intimità sconveniente e ributtante, e che non solo S. A. R. lo innalzò ad un posto eminente nella sua casa e lo ammise a rapporti confidenziali colla propria persona, ma gli conferì anche gli attestati più straordinarii di favore e di distinzione, ottenendo per lui ordini cavallereschi e titoli [82] onorifici, conferendogli un preteso ordine di cavalleria, che S. A. R. erasi arbitrata di istituire, senza averne nè il diritto, nè la facoltà; atteso che la detta A. R., dimenticando sempre più l’elevatezza del suo rango ed i suoi doveri verso V. M., non avendo più alcun riguardo al suo onore ed al suo carattere, si è condotta col detto Bergami in altre occasioni, tanto in pubblico che in privato, con una famigliarità indecente ed una singolare libertà nei diversi paesi visitati da S. A. R., e che finalmente ha avuto rapporti licenziosi, umilianti ed adulteri col detto Bergami, che durarono per lungo lasso di tempo, durante il soggiorno di S. A. R. all’estero, con grande scandalo e disonore della famiglia reale e di questo regno;
„Volendo, per tali motivi, manifestare la nostra intima convinzione che con questa condotta scandalosa, disonorante e viziosa, S. M. la regina ha violati i suoi doveri verso V. M. e si è resa indegna dell’alto rango di regina sposa di questo regno; volendo attestare un giusto rispetto alla dignità della corona ed all’onore della nazione; noi umilissimi e fedelissimi sudditi di V. M., lordi spirituali e temporali, e così pure i deputati della Camera dei Comuni, raccolti in Parlamento, supplichiamo V. M. di ordinare quanto segue:
„Che sia ordinato dalla Eccellentissima Maestà del re, coll’avviso e il consenso dei lordi spirituali e temporali e dei deputati della Camera dei Comuni, riuniti nel Parlamento al presente convocato, e per la loro autorità, che la detta Maestà Carolina Amalia Elisabetta, quando sia passato questo atto, abbia ad essere spogliata del titolo di regina e di tutti i diritti, privilegi, [83] prerogative ed esenzioni che le appartengono come regina sposa di questo regno; che sia dichiarata incapace ad esercitare alcuno di questi diritti, a godere alcuna di queste prerogative, e di più che il matrimonio fra S. M. il re e la detta Carolina Amalia Elisabetta, sia coll’atto presente sciolto per sempre, totalmente annullato e reso vano sotto tutti i rapporti ed in tutte le conseguenze.„
Il processo fu iniziato e consiglieri della regina furono i signori Brougham, che fu poi illustre ministro, Denman, il dottor Lushington, John Williams, Tindal e Wildas.
Facciamo grazia a’ lettori delle particolarità della procedura e di quanto deposero i testimonî, molti de’ quali chiamati da Milano e dalle sponde del Lario circa gli scandali su di esse compiuti dalla regina Carolina: sono particolarità indecenti che offenderebbero il senso morale loro; ma d’altra parte resta monumento imperituro della ingratitudine di molti, tra i quali di un Teodoro Maiocchi e di una Dumont cameriera, che furono beneficati da quella donna dissoluta ma ad un tempo di generosissimo cuore. Parve si mettessero in sodo gli amori suoi con Bergami, aiutati da una sorella di lui, che figurò col nome di contessa Oldi, dal fratello creato prefetto di palazzo alla villa d’Este e dalla madre che assunse il nome di madama de Livris.
Si parlò del teatro erettosi in questa villa del nostro lago, delle rappresentazioni che vi si diedero, in cui la [84] regina era sempre l’amante di Bergami, e certi giuochi detti del turco Maometto di eccessiva libertà e licenza.
Ciò che per altro fu notato e sorprese, fu il fatto di danari e promesse dati e fatte ai testimonî da parte d’uomini indettati col governo; onde al popolo inglese e ai difensori della regina rimase presa a revocar in dubbio le accuse e proclamarne la innocenza.
“In quanto alla villa d’Este, disse il Solicitor general nella sua requisitoria, le deposizioni si accumulano. Là non provengono soltanto dai domestici della regina. Dagli operai, dagli artigiani, impiegati accidentalmente nella casa o nel giardino, si attestano tali intimità che non lasciano il più piccolo dubbio sul commesso adulterio.„
Si seppe tuttavia che de’ molti testimonî chiamati da Cernobbio a Londra a deporre in processo, la più parte, memore de’ ricevuti beneficî, non le rese ingrata mercede.
In quanto alla generosità, alla carità e alla bontà della principessa, messa dai dibattimenti in piena evidenza, il medesimo Solicitor general fu costretto dire: “Io sono lontano dal voler contestare queste virtù alla regina. Quando rammento di che illustre casa è rampollo, non dubito punto che le possieda in tutta l’estensione mostrata dalla lettera della testimone (la Dumont). Ma gli è andare troppo oltre il dire che la generosità più elevata, la carità più estesa, la sensibilità più squisita, non possano cambiarsi nel cuore di una donna con un attaccamento ignobile e colpevole.„
La difesa degli avvocati della regina, quella di Brougham principalmente, parve splendida; i lordi Erskine, [85] Gray, Rosselyn, Harrowby, King e l’Arcivescovo di Thuam vi aggiunsero nelle discussioni proprî e vigorosi argomenti in favore.
Si trattava finalmente di venire alla definitiva lettura del bill: l’agitazione era immensa, impazientissimo il pubblico di vederne il risultamento, perocchè tutto dipendesse da essa. Lo scrutinio fu aperto: cent’otto membri avevano votato in favore, novantasette contro. Non fu più permesso allora di pensare a mandare alla Camera dei Comuni un atto votato con nove voci di maggioranza; e lord Liverpool si vide forzato a mettere ai voti il rinvio del bill a sei mesi. Era questa la formola consacrata per non parlarsene più e mettere a dormire per sempre il processo.
Questa accorta mozione venne votata il nove settembre alla unanimità.
La vittoria fu dunque della regina: essa fu salutata dal popolo con frenetica gioia, e le si fecero le più pazze dimostrazioni, con voci di morte ai testi Maiocchi e Dumont.
La plebe, portando queste sue gazzarre ovunque, voleva che tutti vi pigliassero parte, e, ritrovandoli sul suo cammino, obbligò molti aderenti del re ad unirsi ai proprî entusiasmi; ma lord Lauderdale, cui fu arrestata dalla plebe la carrozza, costretto da essa a gridare: Viva Carolina! se ne trasse con molta disinvoltura e spirito, dicendo: Vi auguro a tutti una moglie come la principessa Carolina.
[86]
Ma durarono poco i popolari saturnali.
La regina s’era ritirata ancora a Brandenburg-House. Volendo ella nel maggio 1821 reclamare di nuovo i diritti di regina sposa, e pretendere d’essere pur ella incoronata, l’Attorney general respinse il reclamo, che nel di lei interesse era stato presentato dal suo avvocato Brougham, sul motivo che nessuna legge accordasse alla regina sposa il diritto agli onori dell’incoronazione; e quando nel dì medesimo della stessa si presentò a ciascuna delle porte dell’abbazia di Westminster, dove veniva celebrata, le si chiese rispettosamente il biglietto d’entrata e le fu ricusato l’ingresso. Ella allora, nell’allontanarsi, attendevasi una dimostrazione popolare; ma non raccolse che urli e fischi sul suo passaggio. Andate a fidarvi dell’aura popolare!
L’umiliazione di Westminster fu per Carolina il colpo mortale. Il 30 luglio successivo cadeva malata, uscendo dal teatro di Drury-Lane. Si vociferò che fosse stata avvelenata in una limonata che vi aveva bevuta, quando moriva il 7 agosto; ma la sua morte fu dichiarato invece, officialmente, che fosse stata in causa di infiammazione intestinale. La malevola insinuazione era la naturale conseguenza degli odî che universalmente si conoscevano nutrirsi dal sovrano contro di lei.
I suoi beni espresse ella medesima il desiderio che passassero alle mani di William Austin, il trovatello, per il quale aveva subíto in addietro i primi strali della calunnia, e che la sua salma venisse trasportata in patria, essendosi preparato il seguente epitaffio:
“Qui giace Carolina Amelia Elisabetta di Brunswick, vilipesa regina d’Inghilterra.„
[87]
Sulle sponde del Lario la sua memoria, ho già detto, è congiunta a molte opere di generosità e beneficenza ed alla via che ella aprì da Como fino alla sua villa d’Este che aveva eletta a sede de’ suoi poco regali amori; e pel filosofo rimane oggetto di meditazione per la strana contraddizione ch’ella presentò di grandezza e di bassezza, di carità e di corruzione, di virtù e di colpe.
In questi ultimi anni, nel fianco destro del giardino della Villa d’Este, il baron Ciani eresse un magnifico albergo, che dal personaggio che que’ luoghi abitò, assunse il nome di Regina d’Inghilterra, e vi è condotto con tutte quelle commodità onde van lodati gli alberghi della Svizzera. Magnifiche piante formano avanti ad esso una specie di grato e fresco luogo di passeggio e lettura.
Vi si aggiunse uno stabilimento idroterapico, fornito di doccie a soffioni, al quale poteva giovare e l’acqua del torrente Garrovo, che dava prima il nome al luogo, e quella leggiermente magnesiaca, che sul colle sovrastante ha la sua sorgente e si denomina della Coletta; ma forse più che a cura di malattia, vi traggono numerosi gli stranieri a ricercarvi soggiorno ameno e tranquillo.
La facilità di recarsi a Como, a cui muove più volte al giorno un omnibus; quella di aversi pure più volte al giorno corrispondenze e giornali; la strada Regina, abbastanza valevole a percorrerla in carrozza; l’agio [88] di passeggiate montane e di gite sul lago; la non ampiezza del bacino, che permette di solcarlo e traversarlo in pochi minuti, senza tema di pericoli, rendono quest’albergo assai frequentato. Difeso dai venti troppo impetuosi dal promontorio di Pizzo che gli sta a fianco, anche a chi meglio si piace di solitudine e silenzio è conveniente asilo; ed io più d’una volta vi cercai riposo e quiete dalle tumultuose cure dell’avvocare e dai cittadini rumori.
[89]
Madama Musard. — La villa il Pizzo. — G. B. Speziano la fabbrica. — I conti Muggiasca. — Il Vicerè del Regno Lombardo-Veneto. — Migliorie. — La villa Curié.
A Parigi, al Bois de Boulogne, che è il convegno delle carrozze più ricche, de’ campioni dello Sport e de’ passeggianti e che noi diremmo il corso di quella grande capitale, nazionali e stranieri ammirano e seguono sempre collo sguardo avido e maravigliati, fra gli altri, un equipaggio elegantissimo a cui sono attelate pariglie di superbi cavalli, che traggono sempre una gentile signora, che “la dev’essere ben ricca„ esclamano sempre quanti l’osservano. Le toalette di essa rispondono allo sfarzo dell’equipaggio.
— A chi appartengono equipaggio e toalette? — ognuno domanda e la curiosità è ben naturale.
— A madama Elisa Musard — vi si risponde subito da tutte parti, chè a Parigi non v’ha persona, io credo, che lo ignori.
[90]
Ed ella, madama Musard, la moglie di tale che ottenne una speciale celebrità musicale, è la proprietaria pure di questa principesca villa che, procedendo dall’albergo della Regina d’Inghilterra, che abbiamo appena lasciato, in poco volger di remi vi si presenta sulla punta sporgente nel lago e che con quella che le sta di fronte di Torno, chiude il primo bacino del lago, il quale abbiamo oramai tutto quanto percorso e visitato.
Chi la vide in passato questa magnifica villa, più non la riconoscerebbe; tanto la ricca signora la ingentilì, restaurando e riducendo a nuovo la casa e le scuderie, e vi profuse cospicue somme nell’arricchire il bel giardino a cui natura prestò i più opportuni e vaghi accidenti di terreno.
Fabbricata a mezzo circa il secolo decimosesto da Gian Battista Speziano da Cremona, senatore, e fatto altresì per tanti meriti patrizio di molte città, fra cui di quella di Como, vi apportò tutto l’amore ch’egli aveva alla scienza agricola; e compiuta la parte del fabbricato, vi avrebbe eziandio raccolto quanto di peregrine produzioni gli fosse dato, se non fosse stato da morte arrestato nella esecuzione del suo concetto. Passò di poi ai conti Muggiasca, e quel che di questa famiglia fu vescovo di Como, e di essa si piacque approfittando della pendice del monte a cui la villa s’addossa, vi ingrandì il giardino, usando anche delle mine per aprirvi sentieri e vie, onde poterlo tutto percorrere agevolmente.
Il conte Giacomo Muggiasca, nipote di lui, poichè fu morto, la villa fu acquistata dall’arciduca Ranieri, [91] vicerè del Regno Lombardo-Veneto, finchè sopravvenute le fortune politiche e l’italiana indipendenza, che ne resero mal proprio alla famiglia sua, che si aveva alienate le simpatie del paese, il possedimento, la signora Musard la comperò.
Mai non sarà sembrato a questa signora di dovervi ritrovare tanta negligenza di coltivazione e di abitato, pensando riceverla da principesca famiglia, e certo vi dovette profondere egregie somme per ridurla alla condizione presente. Infatti, per dir del solo giardino, non vi trovò che produzioni spontanee delle nostre rive lacuali, e tolti i cinquecento cipressi, anche la selva, bella senza dubbio, non constava che di pini, di abeti, di lecci, di quercie, di faggi, di alberi, di piante insomma tutt’altro che peregrine.
Ora, mercè del signor Villoresi, che vi è preposto a cura, migliorò, anche da questo lato d’assai e d’assai la villa. Piante esotiche, arbusti rari, fiori ed erbe vaghissime e forestiere vi introdusse e coltivò, con quell’amore e dottrina che si può dire tradizionale nella sua famiglia. Tuttavia la villa del Pizzo, per essere di quella rinomanza e valore a cui ha diritto di aspirare, non ha d’altro bisogno che di essere arricchita nel palazzo, già sontuosamente addobbato, d’oggetti d’arte insigni, ciò cui del resto la ricchezza sfondolata della signora del luogo può facilmente provvedere; ella che d’altronde con intelligente generosità s’acquistò già tanti titoli alla benemerenza di queste terre circostanti.
Confina colla villa del Pizzo quella modernissima, dell’inglese Curié, il quale la nicchiò nella specie di [92] seno che forma la punta che si protende nel lago. Con enorme spesa rivestì la nuda roccia e la rese tutta quanta verdeggiante per belle e preziose piante, e intorno alla ricchissima casa seppe praticarvi un bel giardino ed un elegante parco.
Quivi colla intelligente opera di Gioachimo Curti, che fu padre della poetessa Adele, già per me ricordata in una precedente escursione, adunò preziosità artistiche; ma resosi defunto chi s’era di questo luogo così compiaciuto da erogarvi tanto denaro nel fabbricarsi la villa, e passata questa al figlio che milita allo straniero, è appena se egli la visiti qualche giorno entro l’anno; e però chi va a vederla non vi rinviene quel non so che di indefinito che rivela la vita e la presenza del nume famigliare.
[93]
Il bacino di Moltrasio. — L’osteria del Caramazza. — Un mio episodio. — Villa dei signori Nulli. — La leggenda della Ghita. — Perchè si nomi Moltrasio. — La Vignola dei Passalacqua. — E la villa Durini? — Geologia. — La Cascata.
Io l’ho già detto in non so quale mio scritto, che del lago di Como, di questa privilegiata parte d’Italia, benedetta dal sorriso della natura, preferisco il bacino di Torno, che è il secondo del lago, e lo preferisco pure a quello sì decantato della vaghissima Tremezzina; e delle ragioni di siffatta predilezione, a non ripetermi, non mi farò qui inutile espositore.
Basti tuttavia a solo complemento di questo esordio il dire che, sebben più angusto tale bacino e meno ricercato dell’altro, lo si può nondimeno meglio godere, percorrendolo in ogni senso, senza tema d’essere sorpresi a mezzo dalla tempesta, e liberi da quella soggezione che troppo aristocratici villeggianti impongono, [94] e che vi richiede l’impegno di toalette e riguardi che vi infastidiscono e attossicano gli ozj autunnali.
Nel bacino di Torno, anzi proprio dicontro a questo paese, dove il battello a vapore fa la sua prima ordinaria sosta dopo avere lasciato Como, si adagia il bel villaggio di Moltrasio colle sue ville che si specchiano nell’onde, coll’ampia strada della Regina che lo divide per mezzo, colle sue case scaglionate su per il declivio della montagna, co’ suoi crotti estivi pei dilettanti del buon vino, massime con quello del Caramazza, osteria e convegno de’ buongustai di Como che il preferiscono eziandio al Nino, co’ suoi rigagnoli, colla sua cascata, col suo orrido...
Ma non anticipiamo l’argomento... M’ho degli obblighi verso Moltrasio da adempiere dapprima: or ringrazio l’occasione che mi si porge di sdebitarmi.
Era l’aprile del 1859. I tempi erano grossi, l’orizzonte politico nero, le nubi presso a squarciarsi, la folgore a scoppiare; o, per uscir dal figurato, stava per incominciare la guerra delle armi sardo-francesi contro l’Austria, che doveva redimere l’Italia dalla oppressione straniera. La polizia austriaca vedeva dovunque congiure e congiurati, e a buoni conti andava pazzamente facendo razzia de’ liberali che, non potendo varcare colle altre migliaia i confini per ingrossare le fila dell’esercito piemontese, rimanevano ad agitar il paese, a tener viva la fiamma della rivoluzione che non cessava di lavorare alla cheta. Impossibile pertanto che un pensiero non si degnasse da essa di concedere pure a me, che più d’una volta m’aveva fatto l’esagerato onore di chiamare ne’ suoi segreti processi verbali corifeo della rivoluzione.
[95]
Aveva in que’ giorni arrestato già un mio fratello, e i miei concittadini alla notizia scrollavano la testa; e l’un l’altro si mormorava: hanno preso un granchio, doveva essere l’altro; e declinavano il mio nome. In verità si giunse a mettermi nel cuore una puntura di rimorso, e una mattina, a scandagliare il terreno sul quale mi trovava, e all’occorrenza pronto a pagare di me l’equivoco preteso dalla pubblica carità, osai picchiare all’ufficio del consigliere M... commissario superiore di polizia nel temuto palazzo di Santa Margherita. Avevo una scusa, mancando di carta di sicurezza — arnese indispensabile a quei tempi di non compianta memoria tanto pel ladro che per il galantuomo — e però entrato da quel signore manifestai il mio bisogno.
Il consigliere M... era un buon tedesco, una mosca bianca tra i cagnotti polizieschi; nè appena avevo aperto bocca, che così m’apostrofava:
— Ma ella è malato; m’avevano detto ch’ella fosse in campagna a curare la sua salute, perchè mo’ è tornato?
— Hanno arrestato mio fratello, temevo non fosse un equivoco.
— Ma no, no, suo fratello uscirà oggi o domani, ed ella è molto malato, vada in campagna... e alzatosi mi fe’ senza perditempo disporre la mia carta di sicurezza e consegnandomela, tornò a dirmi:
— Dunque la vada, curi la sua salute.
Guardai commosso in faccia al buon tedesco, gli strinsi la mano e risposi:
— Anderò; ma dove in avvenire potesse aver bisogno di me, la mi comandi — e me ne andai.
[96]
Anche in Polizia gli impiegati tedeschi non erano i peggiori; se valesse la pena di rammentar nomi, si vedrebbe che le più nefaste memorie di que’ tempi si legano a nomi sventuratamente nostrali.
Qualche ora dopo ebbi un altro amichevole avviso che riguardava la mia salute; ond’è che quantunque mi sentissi perfettamente, pure udendomi, come Don Basilio, gridare che brutta cera! bisognava ben che vi credessi, e me ne andassi non a letto, come quel messere della commedia di Beaumarchais e di Rossini, ma sì a pigliare un po’ l’aria balsamica della Svizzera.
L’importante era il varcare i confini; passaporto non avevo nè potevo chiedere, se non per la gattabuia, dov’erano già stati dati ordini di ricevermi; dunque presi la via di Como e precisamente mi diressi a questo bel paese di Moltrasio, da dove a notte una guida m’avrebbe fatto passare la montagna per discendere nel Mendrisiotto.
Una bella villetta fiancheggiata da due torricelle a finestrelle a sesto acuto, come un castello tradizionale del medio evo, si fa innanzi dipinta a nuovo e bagna i proprî piedi nell’acque del Lario: allora apparteneva al signor Nulli, bravo e onesto commerciante di Milano, che in un colla sua giovane sposa mi accolse, non dirò soltanto con patriarcale ospitalità, ma perfino con entusiasmo, in grazia della causa che ad essi mi conduceva. Non fu maniera di cordialità e cortesia che non mi usassero questi eccellenti cuori, e così mi disposero a calcar la via dell’esilio, che per sommo di ventura non doveva essere molto lungo, quantunque subito amareggiato da grave malattia.
[97]
Oh! io mi rammenterò tutta la vita quella giornata da me trascorsa nella villa di Moltrasio! il mio pensiero ed il mio cuore la rammenta con dolcezza e con sincera riconoscenza.
Qualche anno dopo, io elessi a stanza autunnale una villa prossima a Moltrasio, nel vicin paesello d’Urio: corsi difilato, come voleva il cuore, alla villetta delle due torricelle; ma colà più non erano i signori Nulli...
Essa è ora di ragione dei conti Belgiojoso, e v’hanno appiccicato, come s’usa a tante, un nome, e vien detta Il Pensiero. Per me, l’ho detto, essa sarà sempre un pensiero di gratitudine.
Rifaceva allora la via nel mio burchiello, che il Bellasio spingeva avanti lentamente, quasi ei pure non volesse turbare il mio silenzio e la mia penosa meditazione; poi l’accorto barcaiuolo, che sapeva un cotal po’ de’ miei gusti prediletti, presumendo fosse tempo di finirla colle ubbie, venne a rompere il silenzio.
— Vede? Anche qui a quello scoglio — e sospendendo un tratto i remi, mi indicava una scogliera che dal lato manco del paese si protende un cotal poco — si racconta una storiella, una di quelle ch’ella piacesi d’ascoltare. —
Il Bellasio (così chiamato per avventura, altro essendo il suo vero nome, perchè venuto da Bellagio, borgata più in su del lago, che visiteremo, e la quale sta a capo della punta che divide il Lario in due rami, [98] l’uno che scende infine a Como, l’altro che spingesi infino a Lecco, da dove poi le sue acque ripiglian il diritto primitivo, uscendo di sotto il ponte col nome anteriore di Adda e colla qualità di fiume) era un valente barcaiuolo ed a lui più d’una volta mi son mostrato avido di leggende e di racconti, come quegli che pur la storia anedottica d’ogni terra del Lario e d’ogni villa aveva sulle dita; mi aveva messo un giorno il ticchio di descrivere quella storia de’ misteri del lago, della quale già feci cenno; e vi so dire che se tempo e volontà m’avessero bastato, se ne sarebbero dettati più volumi tutti pieni e palpitanti d’interesse. Dal santo chiodo e dalla gamba d’un de’ bambini trucidati dal Re Erode, conservati nella chiesa di San Giovanni Battista di Torno, al processo della regina Carolina d’Inghilterra; dagli sposi annegati, ricordati dalla ballata del Cantù, al processo B.... e alla conversione del principe Petrovich di Schuvaloff, fattosi poscia barnabita e di cui si veggono le ville sulla sponda opposta vicino a Blevio e che ho già rammentate, sapeva il Bellasio tutto; e più d’una volta me ne aveva fatto curiosa imbandigione, nè era sempre stata infruttifera a lui la parlantina.
— E che si narra intorno a quella scogliera? — chiesi allora al barcaiuolo.
Questi incrociò di nuovo i suoi due remi e più lentamente ancora adoperandoli, incominciò:
— Erano i tempi antichi. La Ghita era una bella montanina che abitava una casipola lassù presso alla cascata di Moltrasio.
— La cascata? — interrogai io, come uomo che fosse nuovo a quella locale particolarità.
[99]
— Che? non c’è stato a veder la cascata di Moltrasio? La ci vada che ne sarà contento.
Io fermai dentro di me che vi sarei andato all’indomani.
Il Bellasio proseguì:
— Dunque la Ghita in sul pomeriggio d’una giornata era andata giù a Cernobbio a trovare non so qual parente e fra una parola e l’altra il tramonto approssimava e l’ora della cena pur con esso. — Che ti fermi, Ghita, a mangiare con noi un bocconcino? le dice quella parente. — Sì, no, è troppo tardi, m’aspetta la mamma — risponde la forosetta e intanto la chinava la faccia fatta rossa come una melagrana. Gli è che la Ghita, come ella può bene figurarsi, aveva a casa il suo Tonio che l’attendeva, un pezzo di giovinotto che le invidiavan tutte le ragazze. — To’, siedi: sono agoni che due momenti fa ballonzolavano ancora vivi sul tagliere. — E la Ghita, mal resistendo, si sedeva sur un trespolo di legno intorno a un desco su cui fumava una soda polenta e gli agoni esalavano una fragranza provocante. L’ora così si era fatta tarda, quando la Ghita si accommiatò. Ben è vero che qualcuno l’accompagnò un piccol tratto di strada fino alla punta del Pizzo, ove è adesso la villa del passato Vicerè e ch’ella sa; ma, qui giunta, sentendo venir da lunge come uno zufolare d’uomo e credendo che si fosse il proprio Tonio che le venisse all’incontro, licenziava l’uomo che l’aveva accompagnata col pretesto che in due salti ella sarebbe a casa, nè voleva di tanto dargli più incomodo e fatica.
E la Ghita camminava.
La strada allora non era come la vede adesso, così [100] bella che la fu un vero beneficio di quella donna caritatevole che è stata la principessa di Galles, la regina che per tanto tempo fu la nostra provvidenza; la strada era su e giù serpeggiante fra la boscaglia, fitta, scura, che chi non fosse stato del paese non ci avrebbe certo a notte trovato il conto di uscirne, e se incauto si fosse un po’ tenuto verso il lago, avrebbe corso anche il rischio di fiaccarvi il collo; perocchè prima che Monsù Curié avesse fabbricato la sua bella palazzina, là vi stavano bronchi, massi e precipizî pericolosi mascherati da liane e spine secolari.
Era la Ghita giunta poco più avanti ove è appunto la villa Curié, che sentissi da una voce sconosciuta intimare:
— Alto, chi va là?
— Son io, son la Ghita di Moltrasio — rispondeva sgomenta la fanciulla.
E l’incognito ridendo allora di un riso satanico, venendole incontro, le diceva:
— Ah! ah! a quest’ora qui la Ghita di Moltrasio? Sei venuta ne’ miei domini ed è giusto che paghi il tuo pedaggio — e stendeva ver lei la mano.
Diede la giovinetta un salto indietro e intimava al temerario:
— Statevi un po’ sul vostro e lasciatemi ir oltre, perchè è tardi e sono attesa.
Lo sconosciuto rispose con un ghigno da demonio e mosse invece innanzi risoluto per abbrancarla; ma la Ghita, lesta più ancor di lui, in un attimo, fatto in cuore un voto alla Madonna a tutela del suo onore, spiccò un salto per quei burroni, e quel tristo che la stava [101] per afferrare, nè pel bujo aveva avvertito l’imminenza del pericolo, fallendogli il piede, giù egli pure precipitò.
Si sentiva tosto dopo un lungo grido come d’uomo cui sia tocco una terribile percossa, ed un giovane che muoveva da Moltrasio e l’udiva, com’era ben naturale in quella generale quiete della sera, affrettando i passi per il sentiero della foresta, giunto presso alla scogliera dove il fatto era accaduto, presago in cuore che la sventura avesse toccato la fanciulla dell’amor suo, si diè a chiamarla.
— Ghita! Ghita! —
La voce infatti della fanciulla gli rispose. Oh! era lei, proprio lei, chè nel cadere per quei burroni la sua gonna s’era impigliata fra i rovai e le liane e l’avevan impedita di rovinare giù nel lago sfracellata, dove era andato invece a piombare il suo turpe tentatore.
Tonio, il fidanzato della Ghita, espertissimo di que’ greppi, avvertita dapprima la fanciulla che non si avesse ad agitare, ma cercasse d’attenersi ad alberelli i più robusti, si condusse cautamente presso ad essa e protendendole la mano, poichè l’ebbe ad afferrare, giunse in breve a districare la sua Ghita e condurla a salvamento; e dopo udito il tristo caso, quando presa la sua barca venne sotto alla scogliera a cercarvi il mal capitato, nè egli, nè i suoi compagni che recavano accesi de’ legni resinosi, ritrovarono il cadavere. Solo un feltro galleggiava là vicino e la gente del paese andò divisa nel pensare a chi spettasse. I più dicevan che ei fosse un contrabbandiere della Svizzera vicina, altri invece e le comari affermarono, pel contrario, che potesse essere il demonio, e che la Ghita fosse stata salva [102] per il voto alla Madonna. Certo è che ancora la sera, quando il tempo mena burrasca, proprio come quella notte che avvenne il triste caso, vedesi un fuoco errare su quel greppo, e chi passando lo vede si fa il segno della croce, perchè o lo spirito del contrabbandiere o il demonio in persona è condannato a qui far la penitenza.
Il Bellasio gittò i remi: io sorrisi per la conclusione della storiella e m’accorsi che eravamo giunti agli scaglioni della casa de’ miei eccellenti amici, i signori Turati di Urio, che mi ospitavano cordialmente.
Come avevo stabilito, all’indomani m’avviai a Moltrasio di nuovo, alla ricerca della cascata che m’aveva accennato il barcaiuolo. Attraversando il paese scaglionato su quel pendio, io, studioso dell’antico, ricordai come gli etimologisti pretendano derivare il nome del paese da Monte Raso, e misurandone tutta la lunghezza coll’occhio vedevo l’ampio palazzo dei conti Passalacqua, detto la Vignola, architettato da Felice Soave con soverchia semplicità, con giardino avanti di esso a varî piani che discendono al lago sempre fiancheggiati da cipressi. Volgevo poi lo sguardo da l’un lato e dall’altro della villa e cercavo indovinare dove mai avesse potuto sorgere quella del baron Durini, citata dall’abate Amoretti nel suo Viaggio da Milano ai tre laghi, dove questo autore lasciò scritto trovarvisi una magnifica raccolta ornitologica.
[103]
Passai il paese, e a mano manca, fuori appena di esso, nella parte superiore allo stesso si presenta infatti quel grande scoscendimento e la cascata d’acqua che que’ del luogo chiamano l’Orrido di Moltrasio, ma che non ne ha le condizioni, essendo ben lungi dall’ispirar orrore, e da cui scende un torrente che attraversando il paese lo rende veramente pittoresco.
Il lettore ne ha l’idea nel disegno veritiero che ne ha tratto felicemente il mio amico Curioni: le mie parole non gli apprenderanno gran che di più.
Il geologo qui ritrova un grandissimo interesse, e questa linea non interrotta di montagne, che comincia dopo Cernobbio e procede lungo il lago, è di un calcare bigio azzurrognolo e dell’epoca giurassica, di struttura fossile, opportunissima alle costruzioni, facilmente sfogliantesi in lastroni fin della grossezza di mezzo metro e con qualche rara striscia di calcareo cristallino bianco e qualche vena di litantrace. È conosciuta in pratica col nome di pietra di Moltrasio e quivi cavansi altresì le ardesie onde copronsi i tetti in molti luoghi.
I cataclismi formidabili in secoli antidiluviani imperversarono certamente in tutte queste località, e le ammoniti che ritrova col suo martello il geologo, pesci e rettili che si rinvengono sulle cime di queste montagne, reliquie dell’Ursus Spæleus raccolte in grotte, crepacci spaventosi, burrati e fenditure, e questo dirupamento medesimo di Moltrasio con quelli di Molina, di Nesso, di Bellano ed altri molti, rivelano que’ tremendi sconvolgimenti naturali, per i quali si esercita lo studio ed anco la fantasia di tanti indagatori della natura, così spesso traviati dalle disparate dottrine e dai sistemi.
[104]
La Caseata di Moltrasio è del più bello e singolare effetto.
Una grossa massa d’acqua gittasi da una grande altezza fra una immensa spaccatura di montagna. Superiormente alla caduta sonvi fertili e popolati piani; onde rasente al punto di caduta evvi una casipola che, a chi riguarda dal basso, molto aggiunge alla vaghezza pittorica del luogo. L’acqua, rovesciandosi spumeggiante per quelle dirupate frane, forma in basso un piccolo bacino su cui corrono, come ponte, alcune tavole, dove sempre il visitatore si arresta nell’ammirazione di quella grandiosa naturale maraviglia. Alberi ed alberelli, rampicanti verdi e rossi e muschio rivestono qui e qua i grossi massi della frana e prestansi mirabilmente a compiere una magnifica scena.
Piena la testa, più che del frastuono dell’acque cadenti, delle profonde impressioni lasciatemi dalla vista di sì imponenti bellezze, ritornai sul mio cammino, raccolto nelle più svariate meditazioni, nullamente distratto tampoco da quell’altro miracolo di cielo ed acqua, di colli e monti, di ville e casali, di giardini e di colti che mi stava tutt’all’intorno e che costituisce giustamente l’oggetto dell’ammirazione e dello stupore anche del forestiero più disilluso.
[105]
Perlasca. — Tradizione. — Villa Tanzi ora Taverna. — Torno. — Storia. — Gli Sposi annegati. — Ville Croff, Righini, Antonelli. — La chiesa di S. Giovanni e pia leggenda. — Mompiatto. — Le sue monache. — La Pietra pendula e la Nariola.
La giornata è serena: lasciamo la sponda di Moltrasio e volgiamo la lancia alla opposta di Torno.
Il piroscafo ha già toccato la punta di Geno, su cui siede la villa Cornaggia e già dirizza la prora verso Cernobbio, per venire a deporre passeggieri nel burchio della Regina d’Inghilterra, dell’albergo, s’intende, del quale ci siamo già intrattenuti.
La riga di bianco fumo che lascia addietro di sè il vapore ci avverte che va sollecito; affrettiamo, che lo vedremo passare dinnanzi a noi e giungeremo in tempo di farci cullare dalle grosse onde che solleva col volgere delle ampie sue ruote, e passeremo in rivista i passeggieri che muovono ai diversi punti del lago.
Intanto eccoci in faccia la villa Taverna sulla sponda destra: dirizziamo la punta della lancia alla volta di [106] essa, se vogliamo trovarci al sito in cui il piroscafo rallenta; la campanella della fermata suona e noi possiamo goderci dello spettacolo che ci siamo ripromessi.
Il paesello vicino è Perlasca, terricciuola già fiorente per l’industria della lana che vi si esercitava, ammencita ora di molto nelle guerre astute e ladre, direbbe il Torti, de’ passati tempi. Vi è ancora una casetta in cui la tradizione pretende siavi nato Benedetto Odescalchi, quegli che fu pontefice sotto il nome di Innocenzo XI, da soldato ch’era dapprima. Quivi ad ogni modo era la villeggiatura degli Odescalchi e quivi egli veniva al divertimento della caccia, come lasciò ricordato in un suo scritto.
Fu nel secolo scorso che venne edificata la villa Tanzi, ora denominata dall’attuale suo possessore conte Lodovico Taverna, patrizio milanese, che l’eredò da un conte Tanzi, senz’altra ragione, dicesi, che quella della simpatia, con un bel gruzzolo insieme di denaro per la relativa manutenzione. Fu l’incarnazione di uno di quei bei sogni di una notte d’estate che facciamo noi popolani, e la cui realtà non avrà già recato tutta quanta la sorpresa al già ricco patrizio, che avrebbe fatta a noi. Era in addietro la più bella villa del lago: ora si conserva sempre fra quelle che attraggono meglio l’attenzione, senza pretendere al primitivo vanto. Delle due ale sporgenti del fabbricato, una non è internamente ultimata ancora. Accrescono pregio i giardini disposti maestrevolmente, con serre chiudenti peregrinità botaniche e fiori d’ogni specie, su tutti ottenendovi culto speciale la rosa in infinite sue varietà, e ve ne aggiungono eziandio belle ed esotiche [107] piante. Nè ciò faccia maraviglia, da che il conte Taverna si piacque di orticoltura e giardinaggio, e Lombardia gli va debitrice dell’introduzione di più d’una delle piante ornamentali, venute poscia in voga tra noi, e tra le quali quella bellissima tussilaginea, detta il Farsugium grande.
Ma ecco il vapore ci è alle spalle; sostiamo.
Gustata la voluttà di questi sobbalzi dell’onda, progrediamo verso la meta della nostra odierna peregrinazione.
Questo paese è Torno col suo bel promontorio. Ebbe un dì stabilimento degli Umiliati che vi fabbricavano panni. Narra il Cantù, che mentre Francesi e Svizzeri combatteano contro i Tedeschi, i Tornaschi favorirono i primi, e quando rimasero sconfitti alla Bicocca (1522), resistettero ancora, come Brescia nel 1849, e ne corser la sorte. Perocchè il governatore di Como assalse e mandò a ruba e fuoco Torno, neppur la chiesa risparmiando; e restò memoria d’una fanciulla che il fior verginale salvò dirupandosi da una finestra e perendo colla patria. Lo stesso Cantù verseggiò un’altra pietosa romanza o storia di sposi annegati, sotto il titolo: I morti di Torno. Io mi fo lecito ridurla a prosa.
Linda, la bella fanciulla di Torno, era fidanzata a Fernando, quando questi aveva dovuto partir soldato per la guerra. Si scambiarono i due giovani i giuramenti d’amore, e, mentre Fernando era alla guerra, ella attendea e pregava la Vergine e i santi pel suo ritorno. Un dì finalmente, reduce Fernando dalla Spagna, spediva lettera a Linda che le annunziava la sua venuta al paese fra sette dì. Ognuno immagina la gioia della [108] poveretta a tal novella, ognuno le ansie di sì lunga settimana: alla fine spuntò l’alba dell’ultimo giorno. Spia tutte le navi, i battelli che solcano il lago; ma egli non viene: finalmente, alla militare assisa che è in un burchio, più col cuore che coll’occhio lo divina, lo riconosce... è lui. Ma intanto sul lago si è ingrossato un fiero temporale, il tuono scoppia, l’acqua diluvia, è un tempo d’inferno. L’amato burchio avanza lentamente lottando colle onde, e Linda, a seguir meglio il progresso di esso, a meglio vedere il suo bene, vola su d’un’eminenza che sta lungo il lago; ma giunta a mezzo dell’erta, per l’erba molle e bagnata, il piè le scivola, e giù dalla china precipita nell’onde. La vide Fernando e la conobbe, nè curando il furiare dei flutti, si slancia in mezzo ad essi, drizzando il nuoto verso la sua fidanzata. Invano facevano forza di remi i battelli spiccatisi dal lido e il burchio dove era Fernando, per accostarsi agli infelici sposi che non si videro più ricomparire. Solo la dimane se ne ritrovarono i corpi: erano abbracciati insieme nell’amplesso castissimo di morte. Là venne posta una croce a memoria del pietosissimo caso e il barcaiuolo che vi transita prega loro la requie eterna.
Poichè siam presso al porto, ecco vedete là su è la villa Croff: vi stan presso le ville Righini e l’Antonelli a destra, due operosi negozianti milanesi che raggranellarono gran fortuna e procacciaronsi questi agî signorili; a sinistra sono la casa e i giardini a cedriere sporgenti sul lago appartenenti ai signori Ruspini e da’ quali si gode di bellissimo panorama. Nella casa di questi signori di Como, fra qualche altro oggetto d’arte [109] è un marmo egregiamente scolpito dal Tantardini di Milano, del quale abbiamo già ammirato in Como altre opere commendevoli.
Scesi a terra, ci si para avanti la chiesa del paese e più su l’altra dedicata a San Giovanni Battista, intorno alla quale è pure una leggenda. Narrasi da que’ pescatori che al tempo delle crociate un arcivescovo tedesco tornando da Palestina ne riportasse un santo chiodo e la gamba d’uno degli Innocenti. Fermatosi a Torno, ebbe sì continuamente contrario il vento, che gli parve riconoscere in ciò la volontà del cielo ch’ivi lasciasse quelle sante reliquie, e le depose infatti nella chiesa suddetta di San Giovanni.
Per questo calle montiamo, montiamo, onde raggiungere l’altipiano a cui siamo diretti, a Mompiatto. Nè lunga, nè aspra la salita: rivoletti d’acqua limpida scendono lungo il cammino, che presto ci scorge avanti la chiesa che sta in cima e dov’era già un chiostro di vergini. Quivi però le monachelle, più che a mattinar lo sposo divino, come direbbe l’Alighieri, ed attendere a vita contemplativa, s’abbandonavano ad amori e baldorie poco canoniche e meno caste; tal che S. Carlo Borromeo, che alle monache ed a’ frati solea spesso riveder le bucce, ne lo chiuse, e le suore trasferì al Sacro Monte di Varese a più severa disciplina. L’episodio ricorda la novella prima della terza giornata del Decamerone del Boccaccio, fondata sulla vecchia tradizione del contado toscano che presso a Lamporecchio fosse un convento di monache, che pel vezzo di divertirsi come quelle di Mompiatto, ebbero il convento demolito ed esse furono trasferite altrove.
[110]
Sull’ameno altipiano del Mompiatto vengono sovente le brigatelle villeggianti ad asciolvere allegramente; ma più matte e curiose sono quelle che vi chiama quella sagra che al due luglio vi si celebra e dove è tutta la giornata il più lieto via vai, su e giù per l’erte viuzze, d’uomini e donne e di fanciulli; ed in cima si merenda sotto gruppi di annose piante; si gozzoviglia e canta finchè calano da’ più alti monti le ombre, e alla chiesa di San Giovanni spirano i tocchi dell’avemmaria vespertina.
Su questo monte, che s’eleva sovra tutte queste ville che si schierano da Blevio infino a Torno, attira poi la curiosità la Pietra pendula, di forma conica, sulla cui punta sta in bilico un trovante o masso granitico di due metri d’altezza e di cinque di diametro, che pretendesi formi sistema col Poncione di Blevio, che gli abitanti chiamano Nariola, altro masso più enorme che sporge sul pendio che tocca appena d’una estremità la terra, solo sorretto dalla punta d’una roccia calcare, sicchè guardato di fianco, sembra prossimo a rovinare.
[111]
Le vittime del lago. — La villa Matilde dei signori Juva. — Villa Canzi. — La Pliniana. — Plinio il Giovane e il flusso e riflusso. — Spiegazione del fenomeno. — La Breva e il Tivano. — L’assassinio di Pier Luigi Farnese. — Giovanni Anguissola. — La villa e l’attuale proprietaria.
Non erano più i giorni gloriosi della celebre danzatrice, di Maria Taglioni... Il tempo, questo terribile devastatore della bellezza e del valore, aveva già da un pezzo chiuso i battenti de’ più cospicui teatri a quella grande artista che aveva stancato i plausi dei pubblici più difficili d’Europa, ed eletto soggiorno in Parigi, lasciava deserta la sua vaghissima villa di Blevio, la quale si specchia nell’onda del Lario.
Non erano dunque più gli ammiratori e gli amici di quella illustre alunna di Tersicore che animavano di loro presenza nell’agosto 1868 i freschi recessi della suntuosa villeggiatura; ma sì i vispi figliuoli di mia sorella, [112] a cui era stata locata, ed io che, dopo un’arringa al Tribunale di Como, ero venuto ad abbracciarli, io di fianco alla mia buona Emilia, sorridevo alla bravura di Giulio e di Gigi suoi che maneggiavano il remo, come se fossero nati e cresciuti sempre su quelle sponde e facevano volare il canotto, leggiero come un alcione, sulla quieta faccia del lago.
Avevamo già lasciato addietro quelle ville che al piede di Blevio abbiam passato in rassegna; già sussurrato mentalmente un vale alla memoria del povero figlio dell’Inghilterra[12], che assueto al mare, credette far troppo a sicurtà colle onde del Lario, le quali ogni anno reclamano il tributo di vittime umane; passata innanzi alla villa Taverna ed a Torno; già svolto i giardini dei signori Ruspini che fiancheggiano vagamente Torno; rasentata la villa Matilde dei signori Juva, piccola ma elegante, da cui uscivano note dolcissime di canto, come le sa rendere quella esimia dilettante, che a valore potrebbesi dire artista, che è la signara Matilde Branca, la quale ne è la proprietaria; e quindi la villa dell’ingegnere Canzi architettata sul far de’ [113] palagi di Venezia, con finestre e loggie di terra cotta, come ne è la balaustrata: quattro colpi di remo, ed ecco ci trovammo nel pieno ed austero seno della Pliniana.
— La Pliniana! esclamò Emilia.
Infatti ci riconoscemmo in grado di vederne il fabbricato intero. Un grandioso loggiato d’ordine dorico prospetta il lago e serve di vestibolo al palazzo che si addossa al monte con giardino a varii piani, i quali s’innalzano fino ad una specie di romitaggio, in cui la solitudine profonda e l’isolamento assoluto della villa ispirano gravi, melanconiche o appassionate meditazioni. Un torrente che le sta a lato, dall’altezza di novanta metri balza con bell’effetto dalle roccie e rumoreggia transitando per l’atrio, per confondersi da ultimo colle acque del lago.
— Fu Plinio forse qui ad abitare ed a lasciarvi il suo nome? — mi domandò Antonietta, la mia eccellente e affettuosa nipote.
— No — rispos’io. — Plinio il Giovane lasciò nelle opere sue la descrizione della fontana intermittente, che avrai veduta nella villa e di cui anzi fa cenno la lapide latina che vi avrai scorta, ma non capita, e che qui chiama la curiosità del forastiero; ma la villa non appartenne mai a quell’illustre.
— Ah sì, la fontana che ha il flusso e riflusso come il mare e che è inesauribile.
— Essa ha infatti un’intermittenza; or cresce a ricolmare un bacino, ed ora, ad occhio veggente, scema; ma questo flusso e riflusso non è regolare come quello del mare, nè poi è tutta vera la credenza ch’essa sia [114] inesauribile. Vuolsi inoltre ch’essa abbia relazione col Buco del piombo, che si vede all’opposto versante della montagna che sogguarda il Piano d’Erba, ma non sono che supposizioni codeste.
Ora udite quale spiegazione ne dia il detto Plinio, non già per dirvi che l’abbia azzeccata giusta; ma per darvi un saggio della scienza fisica d’allora: la traduzione dal latino è del Paravia:
“C. Plinio a Licinio.
„Io ti ho recato dalla mia patria il regaluccio di una quistione, la quale è degnissima della profondità del tuo ingegno. Scaturisce da un monte una sorgente, scorre fra sassi, si raccoglie in un loghicciuolo fabbricato per cenarvi; quivi dimorata un tantino, va a perdersi nel lago di Como (in Larium lacum decidit). Mirabile è la sua natura; tre volte al giorno con invariabili aumenti e diminuzioni si alza ed abbassa. Ciò si vede apertamente, nè può vedersi senza un grande diletto. Colà presso tu siedi e mangi, e bevi anche a quella medesima fonte, da che è freschissima; ed essa intanto a certi e misurati intervalli o cala o cresce. Poni all’asciutto un anello o chechessia, l’acqua a poco a poco lo bagna, e tutto finalmente il ricopre, e si scopre di nuovo e bel bello rimane all’asciutto. Se ti fermi ad osservar questo giuoco, il vedrai rinnovarsi e due e tre volte. È forse un qualche occulto vento, che la bocca e le fauci della sorgente or apre, or chiude, secondo che entra cacciando l’acqua, o esce cacciato da questa? Il che noi veggiamo avvenir nei fiaschi e in tutti i vasi di questo genere, i quali non hanno una libera e súbita [115] uscita. Poichè ancor questi, benchè capovolti e inchinati, rattenuti da non so qual vento contrario, ritardano il liquore, il qual non esce in certa guisa che a frequenti singhiozzi! Forse le leggi dell’oceano son le medesime che quelle del fonte? E per la stessa cagione che quello ora s’innalza, or s’abbassa, eziandio questa fonticella con alterna vicenda ora sporge, or s’arresta? O forse come i fiumi, che scaricandosi in mare, sono dagli avversi venti e dall’impeto dell’onda risospinti, evvi qualcosa che ritarda per qualche istante il corso di questo fonte? O hanno gli interni canali un’assegnata misura, per cui, mentre si rimettono le perdute acque, il rivo si fa più scarso e lento, e rimesse che siano, corre più spedito e copioso? Od evvi, non so quale, interno ed occulto recipiente, che quando è vuoto desta e sospinge la fonte, quando è pieno la ritarda e la soffoca? Or tu che il puoi, fa d’investigar le cagioni che producono questo fenomeno. Per me è anche troppo, se ti ho a sufficienza dimostrato com’esso avvenga. Addio[13].„
L’Amoretti invece, nel suo Viaggio da Milano ai tre laghi, dopo aver notato come i movimenti dell’acqua abbiano un’esatta relazione con lo spirare del vento, sì che incominciando su que’ monti a spirare il ponente verso la nona ora del mattino, che quei del lago chiamano la Breva, a quell’ora eziandio incomincia a crescer l’acqua nella fonte; dice questo crescimento potersi generalmente calcolare di tre in quattro ore. Infatti ad un’ora, al Tivano del mattino [116] succede il vento che procede da Como e si denomina la Breva[14]. Simile interviene alla sera. Più cresce il vento, più si alza la fonte; l’aria è affatto placida, e la fonte punto non s’altera. Or come fa egli il vento a produrvi sì fatte cose? L’Amoretti, premesso che in vetta a’ monti soprastanti alla fonte Pliniana v’ha delle caverne o pozzi naturali, che penetrano nel seno del monte e vi mantengono degli interni serbatoi d’acqua, spiega il fenomeno in questo modo: “Siavi in seno del monte uno o più recipienti d’acqua, corrispondenti alle bocche superiori, i quali all’orlo abbiano delle uscite che portano alla Pliniana. Soffiando il vento perpendicolarmente, comprime l’acqua e la spinge all’orlo in maggior copia, e quindi più copiosi sono i canaletti pei quali portasi alla fonte. Quando il vento cessa, l’acqua si rimette a livello, e l’interno laghetto, a cui il monte ne somministra cogli incessanti stillicidi, torna a ricolmarsi d’acqua, che il seguente vento torna a respinger fuori. Ma quando un forte vento ha soffiato lungamente, più d’un giorno sta la fonte senz’alterazione, perchè l’interno recipiente di tropp’acqua è stato privato, e il consueto spazio di tempo non basta a riempirlo nuovamente. Se questa spiegazione [117] non soddisfa pienamente, quella mi sembra almeno che soffra minori difficoltà[15].„
— Ma allora chi fabbricò la Pliniana, se il luogo non fu di Plinio? — chiesero in coro i miei nipoti.
— La è tutta una storia — risposi io.
— Contala, zio; contala.
Giulio e Gigi macchinalmente appena muovevano il loro remo; noi lentamente intanto approssimandoci ognor più al silenzioso palazzo e di pochi tratti discosti dallo scalo della Riviera, sospeso ogni altro movimento, il canotto sostò, ed io m’accinsi a dire la storia che mi veniva domandata.
— Mi bisogna far viaggiare la vostra mente da queste rive a Piacenza, e farvi dar addietro, meglio certo di tre secoli, all’anno 1547.
Pier Luigi Farnese, da non molto creato duca di Piacenza e di Parma da papa Paolo III, teneva stanza in quella città ed era da essa che esercitava la sua tirannica signoria. Se egli avesse virtù alcuna, hanno gli storici taciuto; all’incontro il Varchi ne lasciò orribile pittura de’ suoi difetti, che del resto erano anche proprî del tempo, e il Segni poi, altro storico fiorentino, non so con qual fondamento di verità, ce lo descrisse storpio di mani e di piedi, sicchè bisognava aiutarlo fino al mangiare; e tuttavia rotto a tutti i vizî.
[118]
Proprio a que’ giorni Spagna e Francia tenevan l’occhio sul paese nostro, e Carlo V imperatore l’aveva a morte col Farnese, e perchè lo stimava, se non promotore, complice almeno dell’attentato di Gian Luigi del Fiesco contro Genova, e perchè, ciò che più gli cuoceva, scorgesse in lui propensione maggiore per Francia, tanto più che il Pontefice aveva ottenuto a Orazio Farnese per moglie Diana, figlia naturale del re di Francia Enrico II. Riuscì facile pertanto all’imperatore di soffiar dentro gli odî de’ nobili Piacentini, che lamentavano la passata libertà, e la tirannide attuale mal sapevano comportare, e si tramò allora una congiura ch’ebbe a capi Girolamo e Camillo Pallavicino, Agostino Landi, Giovanni Anguissola e Gian Luigi Confalonieri. Si pretese poi da chi si piace di stranezze e di bisticci che i nomi loro fossero già preconizzati nella parola Plac (Placentia), che abbreviata si leggeva impressa nella moneta del Duca.
Ai dieci di settembre di quell’anno 1547, que’ congiurati, con alcuni loro aderenti, in numero di trentasette persone, portanti soppanni armi coperte, côlta l’ora che il Duca avesse pranzato e i suoi ministri fossero pure a tavola, entrarono alla spicciolata nella cittadella, ove dimorava Pier Luigi, nullamente impediti dagli svizzeri che vi stavano a custodia e che di nulla certo erano in sospetto.
Vuolsi che il Farnese fosse stato, per avvisi venuti da Milano e da Roma, prevenuto della trama; ma quando incalza il destino, invano vi si vuole porre ostacolo: egli allora non vi pose attenzione.
Mentre adunque taluni de’ congiurati, uccidendo alcuni [119] labardieri svizzeri e tedeschi, si impodestarono delle porte della cittadella e della sala, Giovanni Anguissola con due fidati suoi compagni penetrò in quest’ultima dove stava Pier Luigi in ragionamenti con Cesare Fogliano, e fattoglisi sopra, con poche pugnalate lo freddò, senza provare resistenza; perocchè il Duca, a causa di sua intemperanza, si fosse reso quasi infermo agli atti.
Il popolo e il capitano delle milizie ducali Alessandro da Terni avrebbero voluto accorrere al parapiglia in fortezza; ma i congiurati ne avevano prevenuto il colpo alzando il ponte, e Agostino Landi, rappresentando al popolo il fatto e a lui mostrando il cadavere di Pier Luigi, gridò Libertà, Libertà, Imperio, ed annunziò l’imminente venuta, per S. M. Cattolica, di don Ferrante Gonzaga, governatore di Milano, colle truppe di Cesare, il quale due giorni dopo infatti capitò e prese possesso della città a nome dell’imperatore.
Così si intendeva la libertà allora in Italia, e così poteva dire di noi con ragione alcun tempo dopo il Filicaia:
Per servir sempre o vincitori o vinti.
Poco frutto veramente raccolse del perpetrato assassinio il conte Giovanni Anguissola. Perocchè, se egli venne a rifugiarsi a Milano sotto le tende di Carlo V, il quale malgrado l’aver attizzato la congiura, non era però meno parente suo per la figliuola Margherita data [120] in moglie ad Ottavio figlio di Pier Luigi, e se fu poi nominato al governo di Como; non egli potè tuttavia far tacere il grido della coscienza che l’accusava assassino, comunque le sue mani si fossero insanguinate del sangue di un tiranno.
Papa Paolo III aveva risentito acerbissimo dolore della uccisione del figliuolo, e il re di Francia egualmente; nè si ritenne dal dissimularne i fieri risentimenti, se lo stesso suo ambasciatore in pieno palazzo a Coira ebbe a tirare all’Anguissola una stoccata, che per altro no’l tolse da questo mondo. Anche il sicario che in abito da frate lungo tempo fu veduto aggirarsi nelle circostanze di Como, aspettando luogo e tempo per iscannarlo, ed altri emissarî, con non dissimili propositi, se non vennero a capo del loro truce mandato, mantennero pur sempre nell’Anguissola quella paura continua e quelle agitazioni che gli dovevano turbar l’esistenza.
Fu allora che nel 1570 egli elesse questo luogo, ove è la fonte da Plinio il Giovane descritta, a edificarvi questa villa, e dove, malgrado le naturali bellezze, la cascata e la magnificenza dell’edifizio, pure è impossibile difendere l’animo da un certo senso di malinconia.
Ben poco il conte Giovanni Anguissola potè godere degli ozî non gai che qui egli si era preparato; la villa poscia venne acquistata dal conte Fabio Visconti Borromeo, indi dai Canarisi, sinchè pervenne al principe Emilio Belgiojoso, dove un amor tempestoso gli abbreviò una vita che era dapprima sembrata così sorridente ed elegante, passando per tal modo la proprietà della Pliniana alla figliuola sua che impalmò il milanese marchese Lodovico Trotti.
[121]
La mia storia era finita.
I miei nipoti ripresero taciturni il remo, virarono la barca e si scostarono dall’austero luogo.
Intanto le ombre scendevano giganti sul palazzo e ne’ giardini: al mio povero occhio, non armato in quell’istante dell’occhialino, parve per quella tetraggine e per le liane della cascata veder qualcosa che si agitasse, forse lo sparnazzare di qualche augello notturno, e l’immaginazione, ch’io medesimo avevo eccitata col richiamo di truci fatti antichi, mi raffigurò lo spettro del primo signore di quel luogo, dell’assassino, cioè, di Pier Luigi Farnese.
[123]
Orrido di Molina. — Lemna e la Colonia greca. — Una sventura nel 1863. — La villa Buttafava. — Pognana e Palanzo. — Premenù. — Ancora a Moltrasio. — Ville Salterio, Invernizzi, Tarchini-Bonfanti, De Plaisance. — Pensiero. — Rosiera. — Villa Pavia. — La Partenope. — Igea. — Villa Savoja. — La Minerva, ora villa Elena. — Villa Ostinelli-Turati. — Urio. — Ville Melzi, Jenny, Calcagnini, Taroni. — Sofia Fuoco. — G. B. Lampugnani. — Sonetto a Katinka Evers. — Ville Rocca, Tarantola, Ottolini, Battaglia, Viglezzi. — Villa Sangiuliani. — Ville Lavizzari, Porro e Longoni. — Cantiere dei fratelli Taroni. — Laglio. — Monumento a Giuseppe Franck. — Villa Galbiati. — Torrigia. — Villa Cetti. — La punta.
Perchè ci tratterremmo ancora in questo seno della Pliniana così severo e malinconico? Solo ne’ giorni più ardenti del luglio potrebbe fornirci un freschissimo recesso: or che siamo in pieno autunno, della frescura non abbiam troppo bisogno.
E poi, le dolorose memorie che di questa parte conservo, mi fanno dire coll’Epico latino: Eheu fuge... fuge litus avarum.
È vero che a pochi tratti avvi l’Orrido di Molina, che non è tempo certo sprecato il visitare e che è dato argomentare non esistesse in addietro, se nessuno degli scrittori del lago ne fa menzione. È veramente [124] orrido, come invece quello di Moltrasio, che non lo è, ho preferito, per maggior verità, appellare Cascata. L’acqua si precipita per un burrone dall’altezza d’una cinquantina di metri e mette i brividi addosso a chi vi guarda.
Presso a Lemna — paese, il cui nome greco, come altri che troveremo lungo il lago, rivela la presenza un giorno di una colonia greca, quella forse che vi si dice dedotta da Giulio Cesare — e giù al piede ove era un gruppo di case e una villa, una notte dell’ottobre 1863, ospite io a Urio in casa della signora Ostinelli-Turati, sulla sponda opposta era un furiare di pioggia e di vento, e gli echi dei monti avevan dopo, in mezzo al silenzio succeduto, ripercosso dall’una all’altra sponda un forte e cupo rumore. Ognun che l’intese si domandò che avesse potuto essere. L’indomani mattina il sole riapparso illuminava a Lemna uno spaventoso disastro. Le acque infiltrandosi tra la roccia e la terra sovrapposta ve l’avevano staccata interamente; sicchè nel colmo della notte tutta quanta scivolando improvvisamente in basso e producendo un borro, o lavina, aveva abbattuto e invaso tutti i sottoposti casolari, seppellendovi sotto ben quarantacinque persone. Anche la villa Buttafava fu nella massima parte riempita di fango, e tale ne fu l’orrore della scena, che i proprietarî se ne debbono essere disgustati e fu detto infatti che non vi volessero più ritornare.
Io visitai quel tristissimo e toccante spettacolo l’indomani e vidi più di un cadavere sterrarsi, più d’un orfano desolarsi, più d’un superstite reso quasi stupido dal dolore.
[125]
Tutto il terreno franato e melmoso giaceva là; la roccia era nuda e da essa scendeva un rivolo d’acqua.
Più avanti sull’alto vi sono i villaggi di Pognana e di Palanzo (nome pur greco quest’ultimo), ma deserti assai, perchè la più parte de’ loro abitanti emigrano mercanti girovaghi. Nulla poi offrono che chiamino a visitarli, se pur non interessi Premenù, che è uno dei soliti bacini o pozzi che su quest’Alpi si incontrano, ma non ha speciali particolarità.
Ritraversiamo pertanto il lago e ritorniamo al sorriso della opposta sponda.
Da Moltrasio a Torrigia non è che una serie di leggiadri palazzini. Disseminate per il paese vi sono case civili di villeggiatura; rasente il lago vi sono quelle dei signori Salterio, poi degli Invernizzi, a cui fa seguito la villa del barone Tarchini-Bonfanti, distintissimo medico milanese.
Usciti appena dal primo paese, ci si offrono i due corpi di casa costituenti la villa della Duchessa di Piacenza, illustre dama francese che s’innamorò dell’Italia, o, a meglio dire, della nostra Lombardia, e da tanti anni divide il suo soggiorno fra Milano e il lago di Como. Della villa Pensiero dei conti Belgiojoso, che le vien dopo, già parlai nella escursione alla Cascata di Moltrasio; così passiamo a quella che succede, e che si denomina Rosiera: essa appartiene a Giovanni Casati, uno de’ migliori coreografi de’ nostri tempi, e il nome che le fu imposto ricorda appunto una delle più applaudite sue composizioni coreografiche date nel massimo teatro milanese.
Un grazioso chalet svizzero, ch’era prima del nobile [126] Vitali, fu ceduto ai signori Pavia e continua la lunga e graziosa sequela delle ville. Dopo di esso sorge la Partenope, che colla vicina Minerva venne fabbricata dal signor Ambrogio Robiati, per condurvi il suo collegio d’educazione maschile che aveva in Milano, e dove largheggiò cospicue somme a beneficio... di chi le comperò di poi a prezzi d’assai inferiori. La Partenope è divenuta ora proprietà del conte Gamberini di Imola, che v’ampliò il giardino, abbellì la casa, tutto informando alle proprie comodità. La Minerva ha mutato ora nome, quello assumendo di villa Elena, essendo al presente posseduta dalla russa contessa Elena Goloubtzoff nata Pahlen, sorella di quella generosissima contessa Samoyloff, che per tanti anni erogò in Milano gran parte del suo patrimonio in beneficenze. Essa pure sta annettendovi locali e migliorie e vi fa erigere scuderie che mancavano, poichè da qualche anno la via che corre dietro alla villa fu resa carrozzabile infino a Torrigia.
Tra la Partenope e la Minerva, l’editore e libraio Gaetano Brigola di Milano si fabbricò la sua graziosa Igea, e può dire che il commercio librario, da lui con tanta intelligenza esercitato, hæc otia fecit. — Anche l’ing. cav. Savoja vi eresse a fianco un elegante casino.
Fa séguito alla Minerva la villa della signora Ostinelli-Turati, due nomi che ricordano due notorie case librarie, la prima di Como, la seconda di Milano, nella quale, come già dissi al lettore, ebbi ospitalità cordialissima e più d’una volta, perchè ad amici della tempra de’ Turati rifiutare è offesa. Vuolsene ammirare la bella e buona architettura del cav. Dupuy.
Vien presso il paesello di Urio, a fianco del quale [127] scorre il torrente Strona e una grandiosa villa che già apparteneva ai Melzi e poscia di padrone in padrone capitò alle mani dell’avvocato Peduzzi, che la va affittando, finchè capiti qualche gran signore che se ne invaghisca e la ristauri e perfezioni, di che ha veramente bisogno per essere detta fra le più interessanti del lago. Evvi anche molto terreno addetto, attissimo a convertirsi in bel giardino, ed ha al piede una bella darsena, che all’uopo basterebbe a tramutarsi essa sola in villa.
Quella detta Jenny, che seguita, è dei signori Uboldi; quindi la villa Calcagnini, e dopo altre due spettanti ai signori Taroni, una cioè al di là della strada, l’altra di qua e respiciente il lago.
Sofia Fuoco, or fa qualch’anno rinomata danzatrice, uscita dagli insegnamenti del Blasis, si raccolse qui a Carate in una comoda villetta a riposarsi sui conquistati lauri teatrali. — Quivi si tramutò pure da una villeggiatura suburbana di Monza, ch’ebbe cara finchè fu rallegrata dal sorriso dell’unica figliuoletta Giuditta, leggiadra, spiritosa e di sè assai promettente, il mio amico dottor G. B. Lampugnani; ma rapitagli questa da inesorabil morte, più non volle rivederla, ricercando i conforti di tanta jattura a queste amenissime rive. Alla consorte sua, quell’esimia artista cantante che fu Katinka Evers, la quale ne divideva inconsolabile il dolore, io in quel suo domestico lutto rivolsi questo sonetto.
Alle lagrime il fren, povera afflitta,
Lascia libero pur, che n’hai ben d’onde:
No, non basta il saper che a più gioconde
Regïoni volò la tua Giuditta.
[128]
Solo t’è in cor la verità confitta
Che tu la chiami ed ella non risponde,
Che col tuo bacio il suo più non confonde.
Ch’ella per sempre t’ha quaggiù relitta.
Era sì bella, sì gentil, modesta
E del suo spirto le virtù supreme
Così colpian ogni persona onesta;
Che nell’acerbo duol che il cor ti preme,
Altra parola non so dir che questa:
Povera madre, lagrimiamo insieme.
Qui pure in Carate hanno ville il signor Rocca, che ristaurò la propria recentemente; il conte Alfonso Visconti, che dall’angustia dello spazio seppe trarre il miglior partito, e però chiamolla Ripiego ed ha assai leggiadra architettura; il Battaglia, il cav. dott. fisico Francesco Viglezzi, il Tarantola e la Ottolini, tutti accorrenti dalla ricca Milano; e qui la contessa Sangiuliani, presso la quale a sera convengono i villeggianti a conversari e danze. Al suo giardino la piena del lago ritolse, or fa qualch’anno, un chiosco ch’era in riva e che con tutto il mobiglio una bella notte scomparve, a nuova prova che il Lario non patisce gli si rubi terreno. Quindi si schierano in bella mostra le ville Lavizzari, Porro e Antongini, or passata quest’ultima in proprietà del nostro bravo generale Longoni, che ne abbelliva casa e giardino col miglior gusto, e che dopo le cure ed esercitazioni militari quivi
Scende del campo a tergere
Il nobile sudor[16].
È nello stesso paese di Carate che i fratelli Taroni [129] hanno operoso cantiere per la costruzione di ogni sorta d’imbarcazione del lago: navi, battelli, canotti, gondole, lancie, quattrassi e sandolini, tutto vi si fa e con bella eleganza.
E così eccoci giunti a Laglio, altro paesello montano, senza alcuna particolarità, come tutti gli altri che discorriamo, costituiti dalla chiesa e suo campanile, da casupole di pescatori e tutt’al più da una osteriuccia, dove si eccettui il dottor Casella, del quale avverrà nella prossima escursione che più intrattenga il lettore.
È fuori di Laglio che fu collocato il monumento piramidale ad un medico, Giuseppe Franck, che, transitando sul piroscafo, ognuno crede possa essere di Pietro, l’illustre, il quale lasciò molte opere della sua scienza, ma che non è; essendo invece eretto a Giuseppe, figlio, autore per altro egli pure, ma di meno riputate opere di medicina: nè si comprende perchè abbiasi voluto funestar con quel segno funebre il sorriso di questa sponda.
Affrettiamoci invece a esaminare la villa che succede ed è de’ Galbiati, che ci avvicina a Torrigia, dove alla punta sporgente nel lago sorge la villa dei signori Cetti, alla famiglia de’ quali appartenne il gesuita Francesco Cetti, che a mezzo il secolo scorso insegnò e dettò opere lodatissime di storia naturale.
Qui, in antico, forse perchè il lago restringesi, era una torre che diede per avventura nome al paese, turris regia, che aveva un faro, buono a dirigere a notte le imbarcazioni. Ora a notte questo tratto pescoso di lago è occupato dalle reti, che calate vi avvertono di [130] loro presenza coll’agitarsi continuo de’ campanelli, scossi dall’onde o dal vento, i cui suoni scorrendo monotoni sulla superficie del lago, producono un singolare effetto per chi ignora che stanno a segnale de’ pescatori.
E qui fermandosi la via carrozzabile, arrestiamoci anche noi; rimanendoci una interessante escursione a compiere da qui, prima di allontanarci.
[131]
Il dottor Casella di Laglio. — La brigatella. — La vista. — Il cammino. — Il Buco dell’Orso. — Sua scoperta. — Descrizione. — Visite di dotti. — Le scarpe di S. Pietro. — Questioni geologiche. — Paleontologia. — Gallerie o pozzi scoperti dopo. — La discesa.
Per l’escursione attuale mi risparmio la fatica d’intrattenervi del Buco dell’Orso con nuovo scritto: parmi ne dirà meglio quello che ne dettai nell’anno 1864, quando, come già feci sapere, essendo ospite ad Urio, consegnai nel seguente articolo le impressioni in me prodotte e le analoghe osservazioni. Doveano essere allora sì pochi i giorni che m’eran dati ai riposi autunnali, che neppure avevo fatto conto di procacciarmi questi nuovi e studiosi ricreamenti, a’ quali or chiamo a parte il lettore.
Dopo le fatiche autunnali, qui venuto a ragion solo di riposo, a me sarebbe bastato il solo aspetto di questo tranquillo lago, sospinto nelle ore mattutine verso Como dall’immanchevole soffio del Tivano e nelle ore [132] pomeridiane di colà respinto dalla Breva, quasi a giovamento delle cento vele che riconducono a’ paeselli delle riviere chi è corso per la mercanzia alla città; sarebbe bastata la voluttà di scivolarne la piana superficie sul burchio o sul canotto, mollemente adagiato in traccia della curiosa emozione che vi dà l’onda agitata, come la lasciano i piroscafi percorrenti la lunghezza del lago; sarebbe bastato in una parola il dolce far niente che ha sì recondite dolcezze per chi tutto l’anno si trova nel mare magnum della città, perchè potessi dire ottimamente impiegati i pochi giorni concessi; ma pure distrazione novella, impreveduta mi attendeva. Lascerò ora i simpatici ritrovi di parecchie ville che mi si dischiusero amicamente e che valsero tanto a ingannare deliziosamente le ore della sera, lunghe, interminabili alla campagna; lascerò le danze e le musiche da cui eran bandite le ricercate toalette, e piuttosto vi dirò di quella spedizione che feci in allegra compagnia al Buco dell’Orso, spedizione che interessa tanto il profano, quanto chi si piace di geologiche novità.
A noi fu guida in questa alpestre escursione il bravo dottor Giuseppe Casella, medico condotto di Laglio e d’altre terre vicine.
Chi sa quanti nell’udire tal nome si rammenteranno di giorni amenamente passati sul Lario! Perocchè il dottore Casella, colto e socievole quant’altri mai, è una vera fortuna per quanti passano i bei giorni di [133] ottobre ne’ paesi di questo incantevole bacino: egli direbbesi il tratto d’unione fra l’una famiglia e l’altra, l’autore de’ progetti di gite e di comitive; senza lui non seguirebbero le ilari carovane che pellegrinano al Piano del Tivano; senza lui infine non avremmo compiuta l’ascesa al Buco dell’Orso.
Egli aveva data la posta alle varie famiglie villeggianti ad Urio, Carate e Laglio per la mattina del 5 d’ottobre al paese di Torrigia: si diceva che le leggiadre signore, che avrebbero fatto parte della brigata, sarebbero venute in abito d’amazzone, perocchè i greppi su cui avevasi a inerpicare, le boscaglie che si dovevano transitare avrebbero dilaniato crinolini e gonne, e di ciò pure ci ripromettevamo spettacolo sollazzevole; ma di questo fummo compiutamente delusi: al mattino ci trovammo al convegno in una ventina soltanto, le amazzoni brillarono per la loro assenza: una sola non era mancata, ma il suo costume,... di vestiario... ah! il suo costume non era quello che avevamo vagheggiato.
Il dottor Casella diè il segno della partenza e ci precedette, e noi ci difilammo dietro a lui. Difilammo è la parola sola che conviene, perocchè non appena usciti di Torrigia fosse mestieri mettersi per l’angusto sentiero de’ monti. Presto una viuzza di ciottoli e di pietruzze acuminate provò il nostro coraggio, perchè difficilmente vi si potesse reggere; ma vinte le prime scabrosità, si ascese liberamente per le mille anfrattuosità di quella montagna. E qui notiamo, poichè ne viene il destro, come sia questa di roccia calcarea bigia azzurrognola, continuazione più o meno eguale [134] di quella che incomincia appena fuor di Cernobbio e si prolunga fino all’insù del lago, costituita di tante sovrapposizioni o grosse lastre dello spessore talvolta d’oltre il mezzo metro, che valgono assai opportunamente alle costruzioni, sostituendo la materia laterizia con moltissimo vantaggio di resistenza e di spesa[17]. L’ombra e la frescura vi è procurata dai frequenti castani isolati o da macchioni, che vedevamo da montanine e garzonetti flagellati per farne cadere i già maturi frutti. Fuor di costoro non eran rotti que’ solenni silenzi che dalla lontana campanella delle capre che scorazzavano per i più alti dirupi, o dalla monotona cantilena delle fanciulle che pascolavano su qualche altipiano le loro magre giovenche. A tratti noi sostavamo a ripigliar lena, ad attendere i più tardi e ad ammirare i maravigliosi punti prospettici che ci si venivano mano mano presentando. Di fronte vedevamo il villaggio di Careno, più su quello di Zelbio, a destra Lemna, Molina e l’orrido suo, a manca Nesso e la punta di Cavagnola, e quando, voltandosi alquanto a manca la montuosa via, noi riguardavamo in basso, [135] scorgevamo Brienno e più in là Argegno, il capoluogo della Valle Intelvi, e quei paeselli eziandio che dal greco nome accusano quali colonie vi stanziassero un giorno.
Una colonna di denso fumo dal mezzo del lago svolgevasi lungamente per l’aere e pareva come una nuvola leggiera adagiarsi sulla costiera che ne stava dirimpetto, e noi seguendola coll’occhio potemmo appena distinguere ch’essa liberavasi da uno dei battelli a vapore che in quell’ora drizzava la prua verso la punta di Torrigia, perocchè noi dovessimo essere in quell’istante a seicento metri sopra il livello del lago.
Il mattino si faceva alto, e noi, chiedendo consiglio alla voce imperiosa dello stomaco nostro, ci credevamo vicini alla meta, ma questa pareva discostarsi ognor più: essa ci era come il fatale miraggio del deserto.
Poi si giunse dove il monte s’addentra e si forma come un letto torrenziale: colà la via si faceva più scabra e il nostro attento duce ne faceva avvertiti che non dovessimo riguardar in basso se temevamo delle vertigini, perchè paresse che a noi di sotto la valle si sprofondasse quasi a picco. Fuvvi un tratto di strada che era tutta pietra brulla e alquanto declive: a noi fu però mestieri d’addoppiare le precauzioni; una voce sola era sorta a segnale di scoraggiamento, ma la parola e l’esempio d’altri vinsero quelle paure, e dieci minuti dopo, per un sentiero apertoci fra virgulti ed arbusti, ci trovammo innanzi al Buco dell’Orso. Il viaggio aveva durato un’ora e mezzo. Italiam! Italiam! gridammo noi pure, che ci vedevamo giunti allo scopo del nostro pellegrinaggio, e in quest’inno di gioia c’entravan [136] certo di molto gli acuti stimoli della fame. All’essere poetico preferisco l’essere veritiero.
Ci sedemmo allora sui massi che sono sparsi avanti l’ingresso della caverna, e tratte le nostre copiose provvigioni, ci diemmo ad asciolvere con un appetito che meglio s’accostava alla voracità, mescendoci del buon vino e dell’acqua limpida e fresca che ci forniva una polla della caverna stessa.
Poichè fummo tutti rifocillati, ci disponemmo ad entrare nella profonda cavità, e tutti allora accendemmo il moccolo, di che ognun di noi doveva esser munito a rompere le tenebre e godere delle bellezze naturali della natura, e dello spettacolo di che noi eravamo materia a noi stessi.
A noi aveva il Casella saviamente consigliato di servirci di questi moccoli anzi che di torcie a vento o di legni resinosi, e perchè meno incommodi a portarsi fra quelle sassose latebre, e perchè ci avrebbero risparmiato d’ingoiarci l’esecrabile fumo che le altre fiaccole avrebbero mandato per quelle volte. Perdevamo così del pittoresco, ma innanzi tutto curar ne piacque il più conveniente, e pur di questo vogliamo essere riconoscenti all’esperto mentore nostro.
Il Casella e don Baldassare Bernasconi, buon prete di Laglio della più eccellente pasta, che aveva voluto unirsi alla brigata, ci andavano innanzi rischiarando ed additando le traccie che avevamo a seguire, perocchè [137] e i frequenti massi colà trascinati in antico dalle correnti o là sfranati dalla vôlta superiore, tutti investiti d’un’argilla umida e sdrucciolevole, e le filtrazioni dell’acqua che formavano rigagnoli, e le stalattiti della vôlta rendessero lento e pericoloso il passo. Dapprima avevamo trovato il suolo piano, poi s’era venuto abbassando con inclinazione sensibile, che ci obbligava a passare carpone per un angusto varco o pertugio, onde poter progredire.
Come fummo giunti per entro una certa galleria più vasta, ci compiacemmo volgere addietro lo sguardo e riguardarci scambievolmente, e in verità tutti que’ venti giovani, quale in piedi, quale assiso su d’enorme sasso, tutti il moccolo acceso alla mano, presentavano una scena curiosa, strana, suscitatrice di un mondo di idee.
Fu qui che il dottor Casella, a renderci più importante la gita, a farci comprendere tutto l’interesse che aveva preso la scienza alla scoperta di quella grotta che a lui primo era dovuta, ad incoraggiarci a percorrerla interamente, ce ne venne raccontando per filo e per segno quella storia, che noi procaccerem modo di riassumere sotto brevità.
Era la state del 1841, quando ad esso dottor Casella, che aveva udito parlare della esistenza d’una grotta superiormente a Torrigia, cui la tradizione popolare, che la credeva antica tana di orsi, aveva imposto il nome di Buco dell’Orso, prese vaghezza di rintracciarla. Associatosi alcuni amici, percorse la montagna, sinchè appunto sul versante del monte che sovrasta a Brienno, a due terzi di esso, rivolta a N. N. E., [138] la discopriva. Si presentava quella caverna quasi un ampio crepaccio apertosi nella roccia, alto metri 2,7, largo quattordici e profondo dieci, e pareva a prima giunta non dovesse aprire l’adito ad un lungo cammino. Sgominate le tenebre che vi regnavan perpetue col mezzo di faci ch’egli aveva seco recate, percorso quel tratto testè da me ricordato, parevagli avesse qui il suo termine l’antro che decoravasi di belle stalattiti e corrispondenti stalagmiti, come veggonsi frequenti nelle varie grotte che s’aprono nelle montagne che costeggiano questo lago. Se non che, piegando a destra alquanto, trovava quel pertugio che rivelavagli prolungarsi ulteriormente la caverna, e cacciatovisi animosamente dentro, si era veduto in quella più ampia galleria che sì pittorescamente a noi offeriva lo spettacolo di una processione che ritraeva del misterioso e dell’infernale, siccome a me rammentava il facile descensus Averni di Virgilio. Le cristallizzazioni or bianche, or grigie, or giallognole, bizzarre e spesso trasparenti, venivano riflesse da quella luce con bell’effetto; ma nulla di più interessante erasi offerto fin là, se si eccettui un cupo rumorío che richiamò pur la nostra attenzione, prodotto dallo scorrere di una fiumana dietro le non grosse pareti a destra dell’antro e che in verità sgomenta, poichè sembra che agevolmente possa dischiudersi un varco e irrompere ad allagar lo speco. Questa recondita corrente viene a gittarsi in un lago, che vietò la prima volta al Casella, ed a’ suoi compagni, come lo contese anche a noi, di andar più oltre. Dalla bocca dell’antro a questo speco la lunghezza è di passi 370 o metri duecento.
[139]
Da quel dì il Buco dell’Orso fu scopo a frequenti pellegrinaggi del dott. Casella, e quando nel settembre 1850 vi ritornò con don Vincenzo Barelli, proposto allora di Laglio, e con altri suoi amici, il caso lo favorì, poichè, avendo messo allo scoperto un frammento di costola uscente da quell’intonaco argilloso, lui e il Barelli consigliava a tentare altre escavazioni, che procacciarono infatti alcuni denti smisurati ed altre ossa gigantesche, che si ravvisarono come appartenenti ad animali, la cui specie ora più non esiste. Qualche tempo dopo il Casella vi scopriva un immane cranio, e questo, come le ossa già scoperte, veniva riconosciuto essere stato di orso, che Blumenbach e i naturalisti designano col nome di Ursus Spæleus. Queste spoglie petrefatte vennero dal Casella donate al civico Museo di Milano, dove, per la rarità di esse, il cranio venne formato in gesso ed inviato ad altri gabinetti di scienze naturali: tutte poi coordinate valsero alla ricomposizione d’uno scheletro che è di un grande interesse per la paleontologia.
La curiosità nel Casella e nel prete Barelli di ulteriori indagini crebbe allora ognor più, e trasportatevi due navicelle, o scarpe di S. Pietro, come si chiamano quelle imbarcazioni da quei del lago[18], poterono navigare [140] tre laghetti, l’ultimo de’ quali, lungo circa cinquanta braccia, non fu possibile percorrerlo tutto quanto, perchè la vôlta vien così declinandosi al pelo dell’acqua che l’imbarcazione non vi può passare. La lunghezza quindi accessibile si valuta a trecento metri.
Dopo Casella e Barelli la curiosità dei dotti fu vivamente eccitata, e da allora trassero a visitar il Buco dell’Orso e il dottor Emilio Cornalia, che ne lasciò un’accurata descrizione già per noi citata, e l’abate Antonio Stoppani, che vi consacrò pure una parte nella sua Paleontologia Lombarda, a cui rimandiamo il lettore per le più proprie informazioni della scienza, e il dott. Giovanni Omboni, e il prof. F. De Filippi, e il professor L. Patellani, e i fratelli Villa. A complemento anzi di questo scritto, io verrò spiccando alle memorie del Cornalia quel tanto che giovi a somministrare più esatte quelle notizie che hanno più stretta attinenza colla scienza, e così io pure avrò agevolato il cómpito che mi sono proposto, e il lettore vi avrà di certo guadagnato, più che con una semplice e inconcludente narrazione. Riferirò ciò che riguarda alle condizioni del suolo ed alle cause che produssero l’agglomeramento delle ossa fossili discoperte: le sole indagini, credo io, che interessi di istituire in argomento.
[141]
“Giunti al punto di maggior declivio, scrive adunque il dottor Cornalia, il suolo comincia a rialzarsi tutto coperto di massi accatastati l’uno sull’altro. È tra questi giganteschi, ma ancor mal fermi macigni, che bisogna avanzarsi. Qui pure cominciano i depositi di argilla alternantisi con croste stalattitiche e strati di sabbie e ghiaie; le quali stratificazioni solo nelle parti più interne si mostrano con ordine disposte, lasciando là prendere precisa idea de’ loro rapporti. Altrove o l’uno o l’altro degli strati manca, il fossilifero rimanendo il più costante. Le pareti dello speco e i massi più voluminosi che ne ingombrano il suolo mostrano le striature che le correnti rovinose e trascinanti ciottoli sogliono imprimere alla superficie delle roccie che ne sopportano e frenano gli urti. Al di sopra di questi massi, e lungo tutti i fianchi della grotta, una crosta stalattitica vela agli occhi dell’osservatore la natura del terreno; la qual crosta in alcuni luoghi arriva alla grossezza di 0.08 e più. Spaccata, mostra una serie di zone o strati d’un bell’alabastro cristallizzato a varî colori, traccie delle successive deposizioni.
„Più s’interna il torrente, di cui prima s’udiva solo il fragore tra i sassi profondo, e più comparisce alla superficie aggirandosi per un piano leggermente declive. — Di là poco un lago di qualche estensione occupa tutto il fondo che solo con un istrumento adattato alle [142] angustie del luogo si può traghettare. A nuoto non vi si regge: l’acqua non ha più di 7 gr. R.[19].
„.... Fra la prima raccolta d’acqua e la seconda esistono, come io prevedeva, altre argille che bisognerà smuovere con regolari scavi... È nelle vicinanze del primo lago, ove non è necessaria una istraordinaria innondazione affinchè il livello delle acque s’elevi molto e v’abbandonino i loro depositi, che si osserva il maggiore numero di strati.
„Superiore a tutti si ha uno strato di ghiaia, mista a sabbia nereggiante. I ciottoli sono in parte della calcarea che forma il monte, in parte di roccie d’altra natura. Questa sabbia si vede solo in siti limitati. È dovuta certamente alle ultime innondazioni che saranno state le più parziali. — Al di sotto delle ghiaie (ed ove queste non esistono, direttamente allo scoperto) si trova la prima crosta stalagmitica che s’estende quasi uniformemente da per tutto. Dopo il deposito calcareo havvi uno strato considerevole di un’argilla cinericcia d’una purezza e d’una finezza straordinaria. È compenetrata da molta umidità, sicchè lasciasi facilmente tagliare con una lamina da coltello e si spoglia in straterelli orizzontali esilissimi e paralleli. È si tenace da parere elastica, e non contiene nè sabbie, nè ciottoli, nè avanzi organici; questo deposito arriva anche a un metro di potenza, e lui oltrepassato si trova un’altra argilla di color bruno. Questo strato è piccolo (0m 1) e [143] di poca importanza mancando in più luoghi. L’un deposito però è sempre assai distinto dall’altro. Ove l’argilla cinerea manca, la bruna è coperta direttamente dalla crosta calcarea. Lo strato che più di tutto deve attirare la nostra attenzione è il sottoposto fossilifero. Consta di un’argilla tutta distinta, grossolana, mista a del tritume calcareo; il suo colore è il gialliccio per ossido ferrico; la sua durezza varia, in alcune parti già compatta passando ad una marna in attualità di formazione. Questo strato contiene dei ciottoli, taluni anche voluminosi, arrotondati, per lo più ellittici e deposti col loro piano massimo orizzontale. Questi noduli non appartengono tutti al calcare bituminoso della montagna, ma altresì a roccia di diversa natura, e vanno misti a frammenti di stalattiti. L’argilla gialla costituisce uno strato di circa 0m 4 di spessore, ed è in essa che si rinviene la massima parte delle ossa. Continuando gli scavi, dopo questo strato si trova un’altra crosta stalagmitica simile per natura e potenza alla prima, sotto la quale si ripete un’argilla eguale alla fossilifera e che del pari contiene ossa sebbene in minore abbondanza. È però più compatta, come più anteriore; ed i fossili sono maggiormente petrificati. La potenza di questo strato non la conosco; poggiando direttamente sul masso, varierà secondo i luoghi. Nuovi siti tentati potranno in avvenire fornire differenti cifre per la potenza di questi strati; dipendendo questi dagli accidenti del suolo.
„La natura e i rapporti di questi strati ci chiariscono sufficientemente del modo con cui si depositarono e delle cause che li produssero. Una corrente [144] alquanto forte, e quale appunto sarà stata la più antica, fu quella che depose l’argilla ocracea. Lo provano la sua estensione, i ciottoli che contiene, le grosse ossa cilindriche che travolse. Gli altri strati indicano correnti più miti, che durarono però più tempo; infatti sono più limitati in estensione e composti di finissimo limo esenti di ciottoli e di ghiaie.
„Questi depositi poi occuparono lungo spazio di tempo a formarsi e furono separati da lunghi intervalli, come ne sono prova i ripetuti e grossi strati stalagmitici interposti. La corrente attuale è del certo un tenue avanzo di quelli, cui gli strati descritti devono la loro esistenza, e che altre volte avrà sempre o assai di frequente occupato tutto il lume della caverna. Che se anche attualmente le acque venissero a crescere a dismisura e la crepa già esistente non bastasse ad inghiottire quelle che a metà della caverna si inabissano, esse, occupato tutto il primo basso fondo, si alzerebbero a segno di livello da uscire dall’apertura attuale della grotta.
„Nel vedere questa successione di strati tanto simili a quelle descritte per le caverne ossifere di Francia, di Germania, di Ungheria, ecc. ecc., ricorre subito alla mente la possibilità della presenza di ossa fossili. Queste che io rinvenni, e delle quali sotto il rapporto paleontologico parlerò poi, hanno nel Buco dell’Orso due modi distinti di giacitura, che però accennano ad una medesima causa: le correnti.
„L’uno di essi già indicai per incidenza: la giacitura cioè nel deposito dell’argilla giallastra inferiore alle prime due. È sulla fine di questo strato che esse [145] si depositarono, ed anzi molte giacciono alla sua superficie tra l’argilla gialla e la bruna. Alcune anzi trovansi già in quest’ultima, e il colore bigio che assunsero indica la loro giacitura.
„Anche la seconda argilla, quella che giace al di sotto della più antica crosta stalattitica, contiene questo avanzo organico, ma in minor copia: una sola mezza mascella inferiore e qualche osso della gamba (genere Ursus) io vi trovai in tutto fino ad ora. Questi pezzi sono più che gli altri alterati.
„Le ossa robuste e solide sono le più numerose; le più fragili andarono quasi tutte perdute. Sebbene anche delle prime alcune siano abbondantissime, altre invece rare assai. Così, per esempio, mentre che raccolsi molte ossa del carpo e del tarso, e falangi (persin le unghiali), e piccoli molari, trovai appena una vertebra caudale e qualche incisivo. Forse perchè queste parti assai facili a staccarsi dal restante scheletro vennero dalle prime correnti in altre direzioni trascinate e altrove deposte. Una prova che queste ossa debbono la loro attuale giacitura alle correnti, la trovo in ciò che la maggior parte si ricetta nei piccoli seni che formano le rientranti e sporgenti pareti della grotta, e che rimangono per opera de’ massi difesi dall’impetuosa corrente. Ivi l’acqua, perdendo di sua forza e diffondendosi più tranquilla, potè deporre le ossa fin là travolte. Un altro modo di trovarsi le ossa nel Buco dell’Orso merita attenzione, giacchè spiega l’origine d’una natura particolare di roccie: impasto di ossami, di frantumi calcari e di marne da tempo celebri lungo le rive del Mediterraneo, intendo dire [146] delle breccie ossifere. Su quei grossi macigni che dissi occupare per lungo tratto e molto spessore il suolo della caverna, l’acqua attualmente non scorre o scorrerà solo nelle epoche di massima innondazione, mentre che in tempi più remoti facilmente avrà raggiunto quel livello e vi avrà sopra trascinate le sostanze che travolgeva. Ma le ossa, e le voluminose di preferenza, e i grossi tritumi di roccia, percorsi alcuni dei meati esistenti tra i massi, vi si impegnarono e valsero anzi ad arrestare alla lor volta le sorvegnenti materie che tenevano la medesima via. Il limo, le sabbie sottili, ecc. passaron oltre per quella specie di filtro. Queste ossa così non restarono circondate dall’argilla che invase le altre. Che se però andarono prive d’una materia meccanicamente deposta, valsero ad attirare e trattenere chimicamente le particelle di carbonato calcare che le acque del torrente o stillanti contenevano, e di esse se ne fecero involucro e cemento. Io stesso, non senza fatica, introducendo delle picche tra gli interstizi dei macigni, riuscii a staccare molte ossa disordinatamente aggruppate e cementate da un calcare grossolano e cavernoso. Così ha origine una breccia, alla cui formazione noi siamo contemporanei e presenti, simile alle descritte da Cuvier[20] e da altri. — Così anche questo modo di trovarsi delle ossa è spiegato dalle correnti. Le quali sono provate altresì dalla mancanza di coproliti, dalla mancanza di quello strato di terra nera, bituminosa, comune in altre grotte e che s’attribuisce allo sfasciamento delle parti molli dell’animale; finalmente [147] dalla mancanza delle ossa di animali che avrebbero potuto servire di cibo a quei primi feroci abitatori della caverna[21].„
Il dottor Casella portò diversa opinione da quella del Cornalia circa alla causa di queste ossa riunite, ritrovate da quest’ultimo nelle correnti, e noi, riferendola, pensiamo poter egli alla sua volta avere ragioni forse maggiori di probabilità. Crede egli adunque che queste ossa possano aver appartenuto ad animali antidiluviani, giacchè per la loro mostruosa grandezza appartengono a specie ora affatto perduta. Su di che io penso non esservi controversia, ed anzi nell’opera di Figuier La Terre avant le déluge, parlando appunto dell’Ursus Spæleus, reca la descrizione e il disegno del cranio di tal animale scoperto dal Casella, regalato al Museo Civico di Milano, e da questo, come già avvertimmo, distribuito in esemplari di gesso a varî gabinetti di scienze naturali, come lo riprodusse istessamente nella sua Paleontologia l’abate Antonio Stoppani. A quell’epoca tali animali avranno per molte generazioni trovato rifugio in questa caverna, e successivamente in essa terminata la loro esistenza o per vecchiaia, o per alluvione, o per qualunque altra causa dipendente dai grandi sconvolgimenti geologici. Queste [148] congetture non torrebbero egualmente che le correnti, introdottesi poscia nella caverna, abbiano ravvolte quelle ossa di que’ sedimenti che valsero o alla loro fossilizzazione, od a determinare quelle condizioni nelle quali si rinvennero a’ dì nostri. E mi pare ancor più probabile una tale supposizione in quanto mi sembri assai arduo l’immaginare che le correnti intime del monte possano avere trascinate le ossa intatte e giganti, quali si videro alcune di esse. L’ipotesi del dottor Cornalia ci obbligherebbe inoltre a premettere l’esistenza di un’altra località, da dove le correnti abbian potuto impodestarsi di quelle ossa per poi qui trascinarle; mentre la capacità di questa tana porge maggior argomento a credere che servisse prima a ricovero di orsi, come gli abitatori di questi monti per tradizione ne ebbero sempre credenza, se l’appellarono il Buco dell’Orso, assai prima che il dottor Casella discoprisse le ossa e queste si riconoscessero della specie Ursus, anzi da tempo immemoriale. Il qual argomento della tradizione deve essere di importantissima significazione in questa tesi.
Il medesimo dottor Cornalia, in questo lodato suo studio intorno ad Alcune caverne ossifere dei monti del lago di Como, ne dedusse le seguenti conclusioni, che è prezzo dell’opera il trascrivere, perchè speciali nella massima parte al Buco dell’Orso di cui parliamo.
1.º Anche in Lombardia esistono caverne ossifere [149] identiche a quelle di Germania, Francia, Inghilterra. Anche fra noi è la calcarea giurese che le offre.
2.º Le grotte di questi monti, appendici ad una catena delle nostre Prealpi (catena Ceresia), riconoscono forse una sola epoca e una sola causa: l’emersione delle roccie che rialzarono e sconvolsero il calcare bigio.
3.º Gli strati che si depositarono nelle caverne spettano o all’epoca quadernaria, o all’epoca attuale.
4.º I fossili del Buco dell’Orso (quadernari) vi furono strascinati dalle correnti. Lo strato dei fossili, il sito profondo assai ove si rinvengono (continuamente umido e tenebroso), la mancanza di molte circostanze fanno preferire quest’opinione all’altra che ammette aver quegli animali vissuto là entro; — opinione che si adatta assai più ai depositi moderni delle altre grotte.
5.º I varî depositi richiesero molto tempo a formarsi. La loro potenza, l’alternanza colle croste stalagmitiche, lo stato vario di fossilizzazione delle ossa in rapporto colla profondità lo provano.
6.º Le ossa trovate spettano quali a specie ancora viventi tra noi, quali a specie perdute, e quali finalmente ad animali che ora vivono solo in paese più meridionale.
In quanto a me, pellegrino recente al Buco dell’Orso, pago degli studî per altri fatti, mi bastava di constatarli, [150] ma arrestandomi però sulla sponda del primo lago, perchè non avevo avvertito dapprima tampoco alla probabilità di tragittare quelle acque interne, e però non avevo provveduto le opportune imbarcazioni. Quivi nella parete friabile incidemmo io e i miei compagni i nostri nomi, espressione di quella contentezza che ci aveva dato la longanimità di avventurarci per quelle cavità tenebrose ed aspre. Seduti poscia su questi umidi massi ad asciugarci il sudore della fronte che ci gocciava, prodotto dal trascinarci a fatica collo stomaco pieno, e rimasti colà alquanto, ripigliammo poscia la processione del ritorno. Qualche moccolo veniva già meno, sollecitammo quindi i passi rifacendo il cammino percorso.
E fu nel ritorno, a distanza di forse sessanta a settanta metri dell’uscita, che il buon prete Bernasconi mi faceva accorto della esistenza di un pozzo od apertura, per la quale si poteva calare in una galleria, sottoposta a quella che percorrevamo e dentro cui mostravasi pronto a calare, quando noi ne avessimo esternato il desiderio, siccome quegli che già vi fosse altre volte disceso, ciò che per altro non volemmo, accontentandoci di quegli schiarimenti ch’egli e il Casella ci fornirono. Io mi intratterrò alcun poco di questo pozzo, da che le precedenti relazioni del Buco dell’Orso non ne abbiano fatto ancora parola e da che potrebbe valere d’argomento ad altre indagini e discussioni geologiche. La discesa adunque è di circa quindici metri, e la galleria alla quale si riesce ne percorre circa quaranta, sempre nel senso stesso della lunghezza della galleria superiore verso N. N. E., e [151] sempre a massi e piano ineguali, come è superiormente. Quasi in corrispondenza a questo pozzo se ne vede un altro nella galleria sottoposta, per il quale si cala ad una terza galleria, scendendovi per circa altri venti metri. In questa non è calato ancora alcuno, perchè presenta per avventura pericolo di franamento, nè sarebbe prudente l’esporsi a vedersi chiusa l’uscita e impossibilitato il ritorno. Converrebbe all’occorrenza prendere le maggiori precauzioni ed essere assistiti da più. Tuttavia nel fondo della terza inferiore galleria sentesi il mugghio delle correnti ancor più forte che non nella prima o superiore. Forse è la corrente stessa della galleria superiore che viene a scaricarsi e che forse esce da quelle latébre pel versante del monte e alimenta l’acqua o fonte detta il Vermocane, che serve a mettere in movimento il mulino che è di poco sopra Brienno.
Nella galleria intermedia si trovarono e vi sono pure altre ossa della stessa specie che nella superiore, con questo solo divario che quelle della galleria superiore sonosi trovate intatte, perchè ravvolte nelle stratificazioni argillose che le hanno preservate dal contatto dell’aria, e quelle invece della galleria intermedia si veggono parte in istato di decomposizione, o tarlate, perchè non vennero ricoperte da veruno strato. Io ho avuto nelle mani ed esaminate e le une e le altre, come si conservano dal dottor Casella, e credetti nella predetta mia osservazione di ravvisare un’induzione di più che avvalora l’ipotesi del Casella, anzi che quella del Cornalia; perocchè se il rinvenirsi di tali ossa fosse l’effetto esclusivo delle correnti, tutte [152] indistintamente le ossa sarebbersi ritrovate involute dai sedimenti argillosi: mentre invece è lecito di inferire che i petrefatti della galleria superiore saranno stati ricoperti da tali strati per i depositi che vi avranno fatto le correnti, e quelli della galleria intermedia, immuni dal passaggio di esse, saranno rimasti nello stato primitivo, dove cioè saranno morti gli orsi che in quella caverna debbono necessariamente un tempo aver avuto ricovero.
Come poi queste gallerie inferiori siensi formate, io credo di spiegare dicendo, che tutte le probabilità conducono a ritenere che prima non fosse che una sola ed ampia caverna, che poi per la caduta di massi dalla vôlta siansi venute facendo; perocchè percorrerebbero esse nell’egual senso della galleria superiore quasi la medesima lunghezza.
Siccome recentissima sia la scoperta di questi altri due pozzi, così chiamar io reputo su di essi l’attenzione dei nostri geologi e massime del Cornalia, dello Stoppani e dell’Omboni, i quali forse da una novella loro visita al Buco dell’Orso potrebbero trarre materia a nuovi studî non infecondi di buoni risultamenti per la geologia.
Finalmente, dopo un’ora che eravamo rimasti nell’antro, lieti, ma inzaccherati e molli degli stillicidi che non avevamo potuto evitare e de’ rigagnoli nei [153] quali il piede non aveva fatto a meno di scivolare, via gettando la stearica che tuttavia ardeva,
Uscimmo quindi a riveder le stelle....
come direbbe Dante, o a meglio esser precisi, a riveder il più limpido sole, il quale era ormai giunto al meriggio.
Allora riconoscemmo qualche disertore della nostra brigatella che, dati pochi passi appena nella oscurità della caverna, era tosto ritornato addietro; scambiata qualche celia e riposatici ancora alquanto, ripigliammo il primitivo sentiero.
La discesa a Torrigia fu naturalmente più presta che non era stata la faticosa salita, e consolata alla pendice del monte dalla apparizione della leggiadra fanciulla del dottor Casella che ne veniva incontro a scusare la non involontaria mancanza alla gita.
Se rivolgendo indietro lo sguardo alla asperità della via, ai disagi del camminare fra i dirupati meandri della caverna dell’Orso, io posso essere indotto a dire che non vi tornerei una seconda volta, per l’adipe che un cotal poco mi si è messa intorno ad accusare l’età che avanza a gran passi, è altresì indubitabile che io, che tutti che mi furono compagni in quella gita, conchiudemmo sinceramente assicurando d’essere lietissimi d’averla fatta.
Ma prima di chiudere la presente escursione, mi sento in debito di porgere le mie scuse a quelle cortesi leggitrici che ho per avventura fatto sbadigliare, loro tenendo un linguaggio arido e tutto di scienza, esse che si attendevano amenità di racconto. Ma che [154] farci? Il libro è fatto per tutti i lettori, massime se il libro è del genere del mio; epperò molteplici e svariatissimi i gusti, e nell’olla potrida degli argomenti non doveva dimenticare i palati dei geologi e dei naturalisti. D’altronde fra le molte caverne che ho già avvertito su questi monti, mi verrà perdonato se almeno scientificamente trattando di una, avrò chiarito la natura, assai somigliante, delle altre.
[155]
La Cavagnola. — Careno e Quarsano. — La Grotta della Masera. — Nesso. — Erno, Veleso, Gerbio. — Il Piano del Tivano. — La brigata del Pian d’Erba. — Il Buco della Nicolina. — Vallombria. — Il palazzo di Andefleda. — La marcia della partenza.
Se si piglia il piroscafo che vien da Como, allorquando in faccia ad Argegno la campanella suona e l’impiegato grida — Argegno e Cavagnola — voi, se volete visitare il Piano del Tivano, è qui che dovete scendere, purchè non prenda capriccio all’Amministrazione di far sosta a Nesso, come accade in qualche stagione, perchè allora è a Nesso che converrà smontare.
Ma d’ordinario la gita al Piano del Tivano non è che l’effetto di amichevoli concerti e spesso ben anco accada che l’andarvi sia combinato da amici che villeggino lungo il lago di Como e da amici che villeggino nel versante opposto del Tivano, cioè nel Pian d’Erba. Il convegno allora è più allegro e il lettore che mi segue lo vedrà.
Ad ogni modo, se a questo convegno egli giunga col [156] mezzo del vapore che vien da Como e ne smonti alla Cavagnola, non lasci di visitarne la modesta osteria: vi beverà buon vino; se no da un pozzo che è nella cantina ne faccia trarre acqua che troverà freschissima, come in nessun’altra parte del lago.
Da Cavagnola, retrocedendo per un sentiero praticato fra’ boschi, giungerà a Nesso, punto di convegno della brigata che sale al Tivano; ma se non è giunta ancora e vuol visitare più giù qualche terra fino ai limiti di Pognana, che ho mentovato già con Palanzo e Lemna, oltre Nesso troverà un piccol gruppo di case, poi a egual distanza Careno, e a egual distanza ancora Quarsano. Ma importanza tutti questi luoghi non hanno, ove eccettui la Grotta della Masera sopra Careno, che può essere altro punto di passeggiata per chi brama di variare. Ma questa grotta non ha nè ossa fossili, come il Buco dell’Orso che abbiamo non ha guari visitato, e neppur ossa d’animali dell’epoca nostra, come il Pertugio della Volpe che abbiamo visto del pari: tutt’al più alcune ammoniti che interessano il geologo. Nondimeno ha la particolarità di un lago e fa veramente piacere su in alto la scoperta d’un capace bacino d’acqua; qui esso si sprofonda per un cammino di un quarto d’ora ed ha per fine una voragine.
Ma ritorniam presto sui nostri passi, onde non farci aspettare da coloro che ci attendono a Nesso.
E Nesso, rimpetto a tutti i paeselli che ho testè nominati, è grossa borgata e si distende per tre fila di case sulla montagna con bell’effetto per chi la riguarda dal lago: il torrente vi passa per mezzo con fragore che s’ode anche lontano. Que’ del paese vogliono che [157] la loro chiesa prepositurale sia stata fondata da Sant’Ermagora: i passeggeri invece, e massime quelli che dai piroscafi osservano Nesso, ricordano che Gian Battista Bazzoni, morto in età assai provetta e dell’amicizia del quale mi onoravo, come ne son ricordevole del cuore, che aveva al par dell’ingegno eccellente, lo illustrò col suo Falco della Rupe, romanzo, che forse quarant’anni fa ebbe la propria voga, nè vuol essere ancora dimenticato.
Ma raccoltici tutti in Nesso, acceleriamo i passi alla volta del Piano del Tivano. Pigli chi vuole la sua cavalcatura e su e su.
Si arriva dapprima ad Erno, quindi a Veleso, poscia a Gerbio: il divertimento della salita è indescrivibile. Noi ci facciamo spettacolo di noi stessi; la lunga fila della carovana, or si vede spuntar da un greppo, or interrompersi, or riapparire. Quando è un cappellino da signora che domina, quando è un gruppo di amici; io resto ultimo, poichè mi piaccia godere dell’effetto curioso. Poi si intendono parole interrotte che pervengono da chi è in capo della fila, poi più spiccate di chi segue, poi un grido di chi incespica, uno scroscio di risa, un commento, uno scherzo: è un assieme lieto, piacevole, artistico.
Il Tivano, per chi nol sa, è un’alta montagna che si eleva tra la Valassina ed il lago di Como: ecco perchè i villeggianti del Pian d’Erba si dan la posta con quelli del lago per ritrovarsi tutti in cima al monte e vi traggono, mettendosi per la via che, oltrepassato Canzo, Asso e Lasnigo, s’inoltra appunto per la Valassina.
[158]
Sulla vetta è una grande spianata erbosa a 1280 metri sul livello del mare, ed è questa che si designa col nome di Piano dei Tivano.
I nostri contadini ci hanno preceduto colle gerla piene del pranzo; hanno disposto il luogo dove assiderci: ma que’ del pian d’Erba sono essi arrivati? Attendiamoli e intanto racconciamo le nostre toalette scomposte dalla disagiata cavalcatura.
La piccola banda musicale seco noi venuta apre a un tratto i suoi concerti; sono gli amici che giungono trafelanti dalla Valassina, che si son visti spuntare dall’ultimo anfratto, e la musica nostra li annunzia.
Allora saluti, strette di mano, baci fra donne, discorsi, complimenti, pettegolezzi narrati e scambiati: in cinque minuti que’ del Pian d’Erba han narrato a que’ del lago le storielle tutte del mercato di Lecco, di quello di Incino, gli episodî erotici, i cancans d’ogni villa; e di ricambio hanno fatto altrettanto que’ del lago con essi.
Ma l’appetito ne reclama. Per un po’ si tace, intenti tutti a smascellare; poi si ripiglia il chiaccherio, si fa anzi, maggiore, a seconda che i fiaschi di buon vino si vuotano. Levate le mense improvvisate, incominciano le danze sull’erboso piano e le due brigate qui convenute si mescono a vivaci polcke, a più concitati valzer, a più vorticose galoppe.
Ma anche questa vetta ha le sue curiosità per chi la sale e cerca di più utile che il ballare sulle ineguali zolle. Il naturalista vi ravvisa le torbe miste a enormi larici ed a petrolio, e conviene che l’altipiano potesse un giorno, come fu scritto, essere stato un lago: i curiosi [159] corrono a vedere il Buco della Nicolina, che è una grande grotta, come le tante altre che ho diggià ricordate. Quando è stata assai piovosa la stagione, vi si vedono le acque che vi sono dentro scolate; ma deve essere ben profonda, se nessuno n’ha saputo trovare il fine.
Un miglio infatti a distanza di questo Piano del Tivano e ad ostro del medesimo, è un’altra pianura circondata da scoscesi monti, che solo si vede in tempo d’estate abitata da’ pastori colle mandre numerose; essa appellasi Vallombria. Ora in una di quelle montagne si riscontra una forte e profonda spaccatura, per la quale vien detto che un dì essendo penetrato un cane, vi sarebbe poscia uscito per il Buco della Nicolina.
Se mi chiedete poi se anco quassù si piaccia la tradizione di voler favoleggiare; anche quassù, vi risponderei. Perocchè senza darvi ragion di sorta, gli alpigiani vi narrino seriamente come vi fosse ai tempi antichi fabbricato un gran palazzo abitato da Andefleda, moglie del goto re Teodorico. Qualche cialtrone si sarà divertito alle spalle di questa buona gente, dandole a bere questa fiaba, e la poco spiritosa giunteria trovò presa in quegli animi semplici e per essi si è fatta pretta e indiscutibile storia.
Ma l’aura imbruna; il cammino che ci resta a scendere vuol più ore: rifocillati e rinnovati di forze, salutiamo gli amici dell’opposto versante e disponiamoci a partire.
La marcia della partenza suona, le resinose torcie a vento ardono e si squassano; i lampioni si accendono [160] e ne dan nuovo e inatteso spettacolo; succede un bisbiglio di voci che si salutano, baci che scoccano, addii che si vanno ripetendo e allontanando delle due comitive e che gli echi ripercuotono, la canzone si intuona da una parte e dall’altra per gli opposti versanti, la secondano tutti, e allegramente si riprendono i sentieri che ci tornano a Nesso, dove i nostri barcaiuoli ne attendono per ricondurci alle nostre ville.
[161]
Brienno. — Archigene fonda Argegno. — La Vall’Intelvi. — Sua parte nella guerra decenne. — Diventa feudo. — La rivolta del 1806. — Cospirazione del 1833. — Insurrezione nel 1848. — Andrea Brenta. — I cospiratori del 1854. — L’insurrezione e i volontarî del 1859.
Vale davvero consacrare una buona giornata a percorrere questa alpestre, ma bella e simpatica parte del territorio comasco.
Noi proseguendo il cammino nostro da Torrigia, lungo la sinistra sponda del lago, per certo tratto di riva non rinveniamo più nè ville, nè case; le prime che rompono la monotonia di quelle roccie, non più così fiorenti e verdeggianti, come quelle che abbiamo lasciate, sono i casolari del montuoso Brienno. Quivi furono trovate iscrizioni romane, di cui una rammenta un Archigene, dal quale si vuol derivata la denominazione del non discosto paese di Argegno e ne lo si dà per fondatore. Null’altro offre che valga ricordare.
È da Argegno che si entra in Vall’Intelvi per due vie; l’una sulla sinistra del torrente Telo che va a Sant’Anna e Schignano; l’altra sulla destra, per la [162] quale ponno ascendere carri, e riesce a San Sisino, a Castiglione e a San Fedele, e da cui si può andare a Lugano: ambe poi belle di alpestri bellezze.
È dall’ultima via che si accede al Calvagione, o monte Gionaro, che è quello che conosciamo già col nome di Generoso.
Tutta la Vall’Intelvi è bella di prospetti, di naturali bellezze, di vegetazione; essa è anche interessante per gli episodî delle sue sommosse, che attestano i suoi abitatori animosi e teneri di libertà.
Vollero alcuni derivato il suo nome dall’intelligenza de’ suoi figli, quasi Val d’Intelletto; ma chi nelle carte dell’ottavo secolo la trovò indicata col nome di Intellavi, la volle parola corrotta da Inter lacus, sorgendo essa difatti fra il Lario ed il Ceresio.
Nella guerra decenne, incominciata col 1118 ed ultimata il 1127 fra Milano e Como, e nella quale le terre del Lario si scissero parteggiando per quella o per questa città, questi alpigiani furono utilissimi difensori di Como, e poscia, al tempo della dominazione spagnuola, divennero le loro terre feudo dei Marliani.
Bartolomeo Passerini, curato di Ramponio, terra della Vall’Intelvi, nel 1806, indegnato che Napoleone tradisse la libertà facendosi imperatore, alzò il vessillo della ribellione: lo seguirono gli altri curati di Dizasco e Cerano e seco loro trassero altri generosi; ma privi di armi e d’ogni altro mezzo, pochi gendarmi bastarono a disperderne il manipolo: e carcerati tutti, decapitati i capi, gli altri, dopo breve carcere, rimisero in libertà.
Di sè non diè a parlare la Vall’Intelvi se non nel [163] 1833, quando essa ruminando una sollevazione ad ajutar la Giovine Italia, il governo Austriaco vi mandò il commissario Piccinini ad arrestare un Piazzoli, che si dava per l’anima della cospirazione in quella parte; ma una fucilata stese morto il commissario, il Piazzoli riparò in Isvizzera e ogni cosa fu ultimata.
A maggiori avvenimenti fu teatro invece negli anni 1848 e 1859, quando la causa dell’italiana indipendenza fu intrapresa seriamente; ma a narrarli mi valgo di quanto ne scrisse Gaetano Ferrabini e stampò a beneficio della famiglia di Andrea Brenta, perocchè per essere il Ferrabini mio cognato, non m’è tolto dal ricordarlo come fervente patriota, egli essendo stato animoso volontario nelle fazioni patrie allo Stelvio, dopo d’aver avuto nelle cinque giornate di Milano mutilato più d’un dito della destra mano dalle sciabole poliziesche. Come in quel di congiunto, metto franca la mano e senza scrupoli nel suo sacco[22].
Argegno e la sua vallata singolarmente sono assai memorabili, come dissi, per la loro insurrezione dell’autunno 1848, quando volevasi, rivoluzionando tutta la parte montuosa della Lombardia, ritentare il nostro riscatto.
Quell’ardimentoso rivolgimento, che si potrebbe appellare l’ultimo disperato sforzo della Lombardia per vendicarsi a libertà, perchè già chiusa colla peggio la male augurata campagna combattuta dall’armi sarde contro gli Austriaci colla capitolazione di Milano, fu [164] iniziato in Argegno da Andrea Brenta, nativo di Varenna, ostiere e fornajo di San Fedele d’Intelvi, ove si stabilì fin dal 1833; uomo, che comunque di volgar condizione, era nondimeno distinto per l’ardore di patriottici sentimenti e degno al certo di più vasto ed importante arringo. Disceso costui, poco dopo la metà dell’ottobre, ad Argegno con soli quattro determinati compagni (fra cui piacemi segnalare il prete don Francesco Cavalli, in allora parroco del luogo di Pigra), vi disarmò subito la imperiale gendarmeria, e cacciandosi poi nella vallata, la faceva insorgere tutta quanta.
Que’ gendarmi disarmati si portavano di cheto a Como, ove riferivano l’accaduto al comandante militare di questa città, generale Wimpfen. Il 27 di quel mese, ordinati da costui, giungevano ad Argegno, trasportati dai battelli a vapore, più di 700 Austriaci affin di reprimere quel movimento. — Avviaronsi essi per la strada a destra della valle; ma giunti appena al luogo detto Cavrano, o Crotto del Piazza, poco oltre la chiesa di S. Sisino, dovettero far sosta, perchè salutati da ben nudrita moschetteria dei nostri quivi destramente imboscati, quantunque non fossero questi che in numero di sette. Erano costoro il Brenta medesimo, i quattro suoi compagni, e Bernarda Niceforo e Grandi Andrea detto Botris di Argegno, i quali eransi ad essi aggiunti. — Si impegnò allora uno scambio non interrotto di fucilate, che lasciò credere a quelli di parte avversa che assai più numerosi fossero i sollevati coi quali avevano a fare, e non s’ebbe in quel primo scontro a lamentare dai nostri alcun danno, nè a perdere, ciò che meglio importava, la posizione.
[165]
Il mattino del dì susseguente (28), gli Austriaci ripresero primi il fuoco, senza osare, per altro, avanzarsi oltre il summentovato luogo, certo sospettando che l’avvisaglia del giorno innanzi accennasse ad una più estesa partecipazione di tutti i valligiani. — Con molto accorgimento erano i nostri gagliardi qua e là distribuiti, e dietro le macchie degli alberi o gli accidenti del terreno montuoso mascherati; sorprendente era la lestezza che usavano nel ricaricare le bocche da fuoco; ed a tanto pervenne da ultimo il loro ardimento, che il summentovato Andrea Grandi, balzato solo fuor d’una macchia, stringendo sempre il proprio moschetto, simulando che altri molti il seguitassero, li andava ad alta voce chiamando ed eccitando a buttarsi su’ nemici; a tal che questi ne furono sgomentati in guisa che gli fuggirono davanti. E così finalmente procedettero le cose in quel giorno, che verso le due pomeridiane gli Austriaci, i quali già contavano perdite e feriti in buon dato, si trovarono costretti a volger le spalle e discendere precipitosi e nella massima confusione, raccogliendosi a mala pena in Argegno. — Avevano però prima gli infami, seguendo il barbaro loro costume, appiccato il fuoco a ventotto cascinali e a due crotti, di cui uno del Piazza, le rovine del quale veggonsi ancora oggidì.
In Argegno, a rifarsi della vergognosa ritirata, usarono con quei terrieri, senza riguardo a sesso ed età, ogni modo di violenze, mali trattamenti e minaccie; e tolti con loro sette uomini del paese quali ostaggi, nelle persone di Antonio Cresseri, Francesco Peroni, Adriano Balzaretti, Santo Scotti, Giovanni Rigatti, Giovanni [166] Santi ed altro di cui non si ha il nome, s’imbarcarono e si ricondussero a Como.
Di quei sette statichi, i quali non è a dirsi a quali e quanti insulti e tormenti avessero, contro il diritto delle genti, a patire per opera di quei sicarî piuttosto che soldati, basterà rammentare come venissero tenuti per ben due intere giornate colle mani legate al tergo e senza cibo, e non ne fossero poi rimessi liberi che sei; l’altro, il Cresseri, uomo di avanzata età, ammogliato e con figli, essendo barbaramente fucilato in Como a’ 17 novembre di quell’anno, perchè lo si volle ritenere proprietario di una pistola sguernita di acciarino, rinvenuta dietro un muricciolo in Argegno presso cui s’era trovato nel momento del di lui arresto. — In quella stessa occasione che l’infelice Cresseri veniva messo a morte, questi avevasi a compagno di pena un tal De Maestri di Orzinovi, incolpato d’aver donate dodici lire a due giovani di una famiglia ungherese.
Il Comitato della Emigrazione Italiana residente in Lugano, al quale avevano fatto ricapito dal precedente agosto gran parte di coloro che avevano anteposto l’esiglio al ritornare sotto gli artigli dell’Austria, venuto a cognizione di quella sollevazione, nella speranza avesse essa a prendere più vaste proporzioni, decretò sostenerla; e mandò a tale uopo danaro, armi e munizioni, e più di 400 militi, de’ quali il maggior numero disertori dalle bandiere dell’Austria, capitanati una parte dal generale D’Apice, l’altra dal comandante Arcioni.
Nella Chiesa di S. Sisino, posta a breve distanza sopra Argegno, venne istituito un governo insurrezionale [167] per la provincia di Como, il quale assumesse la direzione del movimento e delle operazioni militari; e allora fu che molti altri paesi del lago insorsero del pari, e corsero ad ajutare la insurrezione.
Così provocati in più audace e considerevole modo gli Austriaci, ritornati in grosso corpo, tentarono essi più volte di penetrare nella Valle, non per le vie di Argegno soltanto, sibbene da varie altre direzioni; ma furono sempre e gagliardamente dovunque respinti con gravissimi loro danni, finchè nel giorno 3 novembre, dopo aver sostenuto con quelli del lago un breve fuoco, riuscirono, scortati da due guide di Finanza — Pensa e Melloni — che a loro vergogna van ricordati, a salire per il Bisbino, e avanzandosi a rapida marcia, pervennero poi ad impadronirsi delle vette dei monti che fiancheggiano a sinistra la parte della Vall’Intelvi, la qual si chiama di Schignano, dal paese di tal nome — ciò che non sarebbe stato loro possibile certamente, se il generale D’Apice, che fin dal giorno avanti occupava co’ suoi 200 bravi soldati quelle cime, veduti da lontano gli Austriaci, non avesse fatto retrocedere la sua truppa infino a Schignano. —
È la gente di questo paese assai rimarchevole per islancio, per coraggio e per costanza in tutto che riguarda alla patria libertà: e dove il D’Apice avesse fatto debito assegnamento su di essa, avrebbe indubbiamente trovato nella medesima un validissimo appoggio. Ma egli, riuniti e fatti schierare sulla piazza comunale tutti gli uomini suoi, che sommavano, come si è detto, a meglio di 400, ordinò loro la marcia di ritirata per le gole che transitano al territorio della Svizzera.
[168]
Perchè mai questo generale aveva egli lasciato scoperto il passo alla Valle dalla parte del Bisbino?.... Perchè non ha poi riparato a tale mancanza approfittando delle magnifiche posizioni che avrebbe potuto agevolmente tenere con duecento militi valenti come quelli che erano sotto i proprî comandi, ed ardentissimi inoltre di battersi per la libertà d’Italia, e da dove si sarebbe potuto di leggieri, non che impedire al nemico d’inoltrarsi, respingerlo e sbaragliarlo quantunque assai superiore di forze; ed ordinava invece, all’appressarsi degli Austriaci, l’abbandono vigliacco di quel campo senza colpo ferire, lasciando così ai medesimi libera la via a discendere nella insorta vallata, che metteva poi tutta in loro balía ed in preda alle loro vendette?
Operò così il D’Apice per codardia, ovvero per tradimento?.... Non si potè da alcuno asserire se per l’una o per l’altro; soltanto corse voce allora che forti dissidî fossero nati tra lui e il comandante Arcioni: certo è che egli bruttò la sua fama con quel fatto, che ridusse quella nobile insurrezione alle proporzioni d’una inutile fazione, che valse a nuovo pretesto alla bestiale ferocia dei nostri oppressori.
Perdurando nella lotta con tanto vigore ed entusiasmo fino allora sostenuta, ed alla quale avevan già presa parte energica molti altri paesi del lago, è a credersi che, caldi com’erano tuttavia in quei giorni gli animi lombardi, si sarebbe tradotta in fatto la idea preconcetta di redimere nuovamente colla rivoluzione la Lombardia. Perocchè, alimentata la sollevazione e mantenuto inviolabile quel centro d’opposizione per [169] alcuni mesi ancora, avrebbe di non poco contribuito alla campagna che si aprì nel marzo del successivo anno; e divergendo parte delle forze nemiche e costituendo un nucleo importante, sarebbe stato un freno ai tradimenti che disonestarono in quell’epoca il nome italiano e la nostra causa, ed un eccitamento a non vederla finita nella giornata infelice di Novara.
I pochi dei nostri, quelli cioè di Argegno e della vallata cui s’erano collegati alcuni Ungheresi disertori dell’Austria, trovatisi soli nel vasto campo, distesisi in catena pel monte S. Bernardo, sperarono un momento, dandosi a molestare il nemico che loro stava di fronte, di potersi ancora sostenere. Ma dopo poche ore di accanito combattimento, scarsi troppo di numero, privi di chi sapesse con valentia dirigerli, difettosi affatto di viveri e disperando soccorsi, cessarono, ma onoratamente, dal loro gagliardo e generoso proposito.
Gli Austriaci, cui erano toccate nei diversi fatti di quella rivoluzione considerevoli perdite, baldanzosi di trovarsi finalmente — senza alcun loro merito — padroni di quei luoghi, si diedero a fare stragi e mal governo.
Il Casino, detto dei Signori, posto sulla cresta della montagna alla destra di Schignano e che dà alla Svizzera, fu da loro saccheggiato: la povera osteria del Brenta, noto ad essi per il promotore di quella sollevazione, soqquadrarono tutta quanta e poi diedero alle fiamme, sì che fu tolta alla diserta famiglia di lui, che s’era di là involata e ramingava altrove, la speranza perfino del ritorno: fucilarono un tal Domenico Ceresa detto Tardett di Schignano, che tentava sottrarre alla [170] loro rapacità i proprî armenti, ed un Ungherese che, diretto alla Svizzera, si era per quelle vie smarrito.
La insurrezione per tal guisa soffocata, ebbero la Valle Intelvi ed Argegno a deplorare in seguito, oltre ad enormi contribuzioni, la carcerazione e la morte di parecchi individui che furono dei più risoluti, il cui arresto avvenne nella festa di Pasqua del 1849 in una osteria di Casasco, chiamata del Foino, dove i medesimi trovavansi tuttora armati; e ciò in seguito a delazione fatta dalla Gendarmeria di Castiglione di Intelvi all’I. R. Comando Militare di Como. — Costoro erano: Andrea Brenta, Giuseppe Manzoni, detto Rossin, un disertore ungherese, Giovanni Pizzala, Niceforo e Luigi Bernarda, uno svizzero ed un varesotto.
Meno i primi tre, che furono fucilati nel sesto giorno dopo la suddetta Pasqua, cioè a mezzo l’aprile (14), gli altri ottennero poi la libertà, perchè s’avesse anche il dovere di proclamare l’austriaca clemenza. Taluni di questi ultimi per altro, onde assicurarsi della vita, dovettero tosto emigrare, conscî che l’Austria non perdona e non oblía.
Brenta, il caldo patriota, l’iniziatore di quell’insurrezione, andò incontro alla morte da coraggioso ed intrepido, siccome aveva vissuto. Egli contava soli 37 anni. Sul luogo del supplizio, che fu il piano della Camerlata, stringendo la croce, simbolo del comune riscatto, rivolse al popolo efficaci parole di fede sulla redenzione della patria nostra, e moriva, come muoiono gli eroi, ricusando aver bendati gli occhi, poichè il morir per la patria non l’atterriva, e gridando: Viva Italia! Lo stesso ufficiale austriaco, che dovette comandare [171] di far fuoco sopra di lui, fu talmente commosso da cotanto patriottismo ed intrepidezza, ch’ebbe a dire, che se gli fosse stato possibile, avrebbe voluto ad ogni costo salvar la vita di quel magnanimo. — Mentre veniva tradotto al luogo della esecuzione, al Giuseppe Manzoni che doveva subir l’egual pena e che si lamentava di dover per quel modo morire, così francamente parlava il Brenta: Taci, e tienti contento, chè anche tu hai fatta la tua parte!
Queste prove d’eroismo si rinnovarono fortunatamente spesso tra noi in questi ultimi anni di lotta; e si vorrebbe che a perpetua memoria si scolpissero i nomi e i fasti gloriosi in marmorei monumenti, e che il paese non fosse così trascurato, siccome si mostra, della povera condizione delle famiglie de’ suoi martiri. Chi finora ha pensato a quella, per esempio, numerosa del Brenta? — Egli lasciava nella desolazione e nella miseria la moglie e nove teneri figli, che ancora attendono che la patria paghi inverso di essi il debito della riconoscenza.
Ridotta la Valle Intelvi ed Argegno al silenzio, gittati nella costernazione per la morte di tanti suoi valorosi, non si diedero i loro abitatori a vigliacco avvilimento; ma chiusi nelle più generose aspirazioni, tenendo l’occhio alla capitale d’onde muovevano quotidianamente esempî di ostinata opposizione contra l’austriaco governo, stettero aspettando che suonasse nuovamente l’ora della riscossa. Impazienti per altro taluni de’ sunnominati, fra cui l’Andrea Grandi e un de’ Bernarda, nell’atto che dalla Svizzera, nell’anno 1854, stavano riportando alle loro case le armi che [172] avean ricevuto dal partito d’azione in Lugano, venivano arrestati e tradotti nelle segrete di Mantova, da dove, dopo la tortura inquisitoria di quei famigerati che furono Sanchez e Pichler, uscirono condannati agli ergastoli di Padova, da cui vennero liberati dall’amnistia del 1857, prima conseguenza del congresso di Plombières.
Dieci anni durò la dolorosa prova e l’aspettazione degli animi: spuntò finalmente il 1859.
Voci di guerra, mosse primamente dalle sponde della Senna, corsero presto anche le rive del Lario: il tempo della rivincita si appressava, quello dell’espiazione per l’Austria era imminente.
Non tardò essa a scoppiare: noi tutti salutammo felici e benedicemmo la terribile distruggitrice dell’uman genere, la grande sventura dei popoli, la guerra: era essa l’unico mezzo onde porre fine alla sventura ancora più grande e deplorabile, la oppressione straniera.
Sul principiar della guerra di quell’anno, Argegno, fra i più ardenti paesi di Lombardia, fremeva attendendo il momento propizio di infrangere alla sua volta, e per sempre, il giogo della schiavitù.
Son note le ragioni che servirono a rompere le ostilità fra Piemonte ed Austria, ad allearsi Sardegna e Francia; son noti i gloriosi combattimenti dell’armi alleate: io non mi arresterò a tener conto di essi, onde venir difilato all’argomento mio.
Giunse il 26 maggio: in quel mattino un battello a vapore percorreva il lago annunciando ai varî paesi d’ambe le sponde, allo scopo di farli insorgere, la vittoria riportata dal corpo del prode Garibaldi a Malnate, [173] terra fra Varese e Como. Ognuno sa come il fatato Nizzardo, spiccatosi coi Cacciatori delle Alpi da lui comandati dal nucleo dell’esercito alleato, si fosse condotto pei paesi del Lago Maggiore a Varese, e di là avesse incominciato una serie di gloriosi combattimenti, di fatti d’armi arditi e fortunati: e però la notizia che si diffondeva era di non dubbia importanza.
Don Battista Rosati, vicario della parrocchiale d’Argegno, uomo svisceratissimo della sua patria, italiano in cui fu sempre calda la fede della redenzione di essa, e che molto si adoperò nei tempi difficili a propagarla in quei dintorni, onde vi fosse prontezza d’ajuti nel giorno del cimento, messosi in un burchio, andò incontro a quel piroscafo per aver nuove da Como, e vi raccolse infatti la fausta novella.
Ritornato costui alla sponda d’Argegno, non è a dirsi con quale accento di giubilo e di entusiasmo gridasse a’ suoi conterranei: Figliuoli, viva Italia! — l’ora segnata dalla Provvidenza è giunta — vittoria di Garibaldi a Malnate — il generale Garibaldi colle sue valorose truppe è in vicinanza di Como. — Ringraziamo Iddio, e facciamo tosto il dover nostro.
E la gente d’Argegno fu pronta e sollecita alla riscossa. Avendo a capo quel medesimo prete, parecchi, de’ quali i nomi sono: Plinio Peroni, Giacomo Bernarda, Tomaso Spinelli, Antonio, Luigi e Santino fratelli Rosati, Costante Ambrosoli, Pasquale Grandi, Carlo Fraquelli, Antonio Visini, Giacomo e Antonio fratelli Grandi, Ernesto Bernarda, Carlo Patriarca, Andrea Grandi, Eugenio Zucchi, G. B. Bosisio ed Eugenio Bernarda — ristrettisi insieme, disarmarono in quel [174] Comune i soldati austriaci, i finanzieri e i gendarmi; indi percorrendo la valle, dove si unì loro, prestando energico ajuto, un giovane milanese, l’ingegnere Tizzoni, che per lavori censuari colà si ritrovava, operarono dovunque il disarmo delle guardie di Finanza, fecero l’arresto del commissario di dette guardie in San Fedele d’Intelvi, signor Durini, uomo che si rese indegno del nome italiano e della illustre famiglia alla quale appartiene; e sarebbero pur riusciti ad arrestare anche quelle due guide di Finanza, Pensa e Melloni, che nella rivoluzione della Vall’Intelvi nel 1848 si erano infamati guidando gli Austriaci nella detta valle per la via del Bisbino, se costoro, avvertendo al pericolo che lor sovrastava, non se ne fossero in tempo sottratti. Essi vennero catturati in appresso per cura della R. Questura di Como.
Cotali atti della gente di Argegno devono dirsi di sommo ardimento, considerato che nel giorno 26 maggio si compivano da quel solo paese, mentre le altre terre del lago se ne stavano ancora titubanti a cagione che l’Urban, generale dell’Austria, aveva in Como concentrato un corpo di oltre dodicimila uomini, e si mostrava disposto, bestiale siccome era, a far man bassa con chichessia avesse mostrato di partecipare al generale commovimento; talchè da tutti si dicevano impazziti gli abitanti di Argegno.
I battelli a vapore del lago, che fin dal mattino di quel dì si emanciparono dal servizio austriaco, ebbero in detto giorno e nel susseguente ad unico sito di stazione la riva di Argegno: nè vi fu modo, finchè gli Austriaci rimasero, che si riconducessero a Como, dov’erano [175] istantemente richiamati, perchè il capitano di uno di essi, lo Scannagatta, che collo scampanellar del suo piroscafo e con efficace parola avea contribuito potentemente a bandir quella sommossa, risoluto ad ogni audace impresa, seppe persuadere il rifiuto. — E gli abitanti di questo paese furono i primi altresì che, partendo la notte dal 27 al 28, si portarono a Como per ricevervi festosamente l’invitto Garibaldi e la valorosa sua armata, alla quale si unirono tosto come volontarî ventitrè di essi Argegnesi. E qui è da notarsi che la popolazione di Argegno, sommando soltanto a 650 anime, forniva con quei 23 volontarî un ben importante contingente alla guerra nazionale.
Onore pertanto a questa valorosa terra, onore a’ suoi animosi abitanti!...
A coloro che, leggendo questo libro, avranno domandato a questa Escursione la semplice descrizione di luoghi, o romanzesche leggende, io penso che la narrazione che ho fatto invece di antichi e gloriosi fatti e della patriottica partecipazione di questa amena e magnifica valle all’epopea della italiana indipendenza, penso che sarà stato di largo compenso, come sarà di più efficace eccitamento a percorrerla ed ammirarla.
[177]
Le cascate di Camoggia. — Colono. — Sala. — Villa Beccaria. — Zocca dell’Olio. — Isola Comacina. — La sua storia. — La processione e la Scorobiessa. — Isola. — La torre del Soccorso. — Campo. — La villa Delmati. — Dosso di Lavedo. — Balbianello e la villa Arconati. — Il torrente Perlana. — La Madonna del Soccorso.
Riconducendoci ad Argegno, e da qui movendo all’insù del lago, seguendo la medesima sponda, dobbiamo questa volta proporre a meta della nostra peregrinazione questa Isola Comacina, un dì più famosa certo di quello non lo sia oggidì. Vi troveremo importanti memorie di storici avvenimenti, che non sarà, per chi ha cuore e amor di studî, discaro di ricordare.
Intanto lungheggiando questa sponda, la sua severità, che ebbe, a vero dire, il suo principio dalla punta di Torrigia, è divertita dalle bellissime cascate di Camoggia, le cui acque con molto fragore balzan dalle alture e spumeggianti si gettano nel lago. Una semplice casetta da contadino sta al piede del monte e testimonia che vi ha chi sfrutta e que’ pascoli e que’ boschi.
Dopo un certo tratto silenzioso e disabitato, si presenta [178] Colono, paesello, come Blevio, Careno, forse Corinto in antico, Palanzo, Lemna e Nesso che già visitammo, il qual rivela nel suo nome, che ricorda altresì l’Edipo a Colono di Sofocle, la presenza di una immigrazione greca; la quale, come già altre volte notai, pur si manifesta nel nome di altre terre, come Campo, che troverem tra breve, Lenno, Dorio e Dervio, forse anticamente Delfo; avvalorandosi così la credenza di coloro che pretesero aver qui, come pur già dissi, Giulio Cesare dedotta una colonia ellenica di cinquecento uomini di prestanti famiglie. E pare che gli abitatori di questi paesi serbassero le costumanze antiche, computando gli anni dai consoli, e rammentando l’autorità dell’imperatore greco sedente in Costantinopoli, quantunque non ne avesse su di essi giurisdizione, negli anni di Cristo 571 e 572, a’ quali accennano due lapidi latine che si distinguono tuttavia in Lenno, e che riferirò a suo luogo.
Tuttavia a Colono si hanno traccie sufficienti di colonia romana nei ricordi di un arco antico, che evidentemente lo attestano di romana architettura.
Succede a Colono, Sala, paesello che vive di pescagione e sul confine del quale ha il suo letto il torrente Premonte, e sulla punta sporgente nel lago sorge la villa Beccaria, che appartenne a Cesare, l’immortale autore Dei Delitti e delle Pene e dove vi morì il suo degno figlio marchese Giulio; e la quale chi la visitò afferma somigliare ad un buon libro che attiene più che non prometta.
Tutta questa parte, che forma un certo grazioso bacino, la si può dire una primavera anche nel verno: la [179] neve, se cala, vi sparisce subito: il verde vi è costante e però agrumi e ulivi vi allignano, per la mitezza del clima, all’aperto, nè i fiori han d’uopo di serre: lo stesso che sul lago Maggiore avviene ne’ dintorni di Cannero, che si trovano nell’eguale condizione di postura. La calma che anche regna nelle onde di questo seno, a cui l’isola forma quasi baluardo contro l’ira dei venti e dei flutti, ha fatto dare a questo tratto dagli abitanti del paese la denominazione di Zocca dell’Olio. Perocchè davanti a questa villa Beccaria si schierino a fianco Sala e davanti l’Isola Comacina, a cui eravamo diretti, e che è anche la sola isola del lago.
Essa conta tutta una storia; nè è a credersi che la sua estensione fosse quella che presenta oggidì, dovendo certamente essere stata maggiore, rôsa quindi all’intorno dalle innondazioni che via ne trascinarono poco a poco molto terreno.
Chi conobbe l’itinerario d’Antonino, vuole che dell’Isola Comacina vi sia fatta menzione: certo all’epoca dell’invasione longobarda cominciò ad essere teatro di lotte animose e fiere. Un Francione, generale di Maurizio imperatore d’Oriente, vi si rifuggì e mantenne indipendente, l’isola appellando Cristopoli, quasi posta sotto la protezione speciale di Cristo. Ma Autari, re longobardo, la strinse e l’assalì vigorosamente con numerosa flottiglia, e dopo una gagliarda resistenza di sei mesi, l’ebbe per onorevole capitolazione di quel prode, che ottenne di ritirarsi colla moglie a Ravenna. Ricchissimo fu il bottino che vi fe’, occupandola, il longobardo.
Successivamente fu l’isola ricovero a Gaidulfo duca [180] di Bergamo, allorchè si ribellò a re Agilulfo; poi al re Cuniberto, quando dovette cedere alla prevalenza del duca Alachi di Brescia; quindi alla famiglia di Ausprando, dove per altro essa fu immolata dal suo nemico Ariberto, che a maggiore vendetta smantellò anche l’isola che l’aveva ricoverata.
Quivi pure rifugiavasi la famiglia di Berengario nel 962 dall’irruenza delle armi del suo più felice competitore Ottone di Germania, e gli abitanti di queste rive che, parteggiando per quest’ultimo, lo forzarono alla resa e ne disarmarono il castello, ebbero in premio la conferma dei diritti di comune all’isola nel seguente documento, che val la pena di conoscere:
“In nome della santa ed indivisibile Trinità, Ottone, per voler di Dio, imperatore augusto.
„Se assentiamo alla domanda degli altri nostri fedeli, molto più giustamente inclinar dobbiamo le orecchie alle preci della diletta consorte nostra. Sappiano dunque tutti i fedeli nostri e della santa Chiesa di Dio presenti e futuri, che Adelaide imperatrice augusta, moglie nostra, invocò la nostra clemenza, affinchè per amor suo gli abitanti dell’isola Comasca e del luogo che dicesi Menaggio ricevessimo sotto la nostra tutela e confermassimo coll’autorità nostra i privilegi che ebbero dagli antecessori nostri e da noi stessi aventi l’unzione imperiale, cioè di non far oste, non aver l’albergario, non dar la curatura, il terratico, il ripatico, e la decima del nostro regno, nè andar, se non tre volte l’anno, al placito generale in Milano. Tanto concediamo ecc. Dato all’ottavo avanti le calende di settembre (25 agosto), anno dell’incarnazione 962, I dell’impero del piissimo Ottone, indizione V, in Como.„
[181]
La giurisdizione politica dell’isola doveva estendersi a que’ giorni, oltre l’isola propriamente detta, a tutto il tratto da Argegno sino a Villa di Lenno, dall’una e dall’altra sponda.
Gli isolani nella guerra dei dieci anni, dal 1118 al 1127, mossa dai Comaschi a’ Milanesi stati prima amici coi primi, poscia congiuntamente a Menaggio, Gravedona e a tutte quelle terre del lago ch’erano a queste vicine, lor si chiarirono avversi; onde i Comaschi ne tiraron vendetta, desolando molti loro paesi e l’isola, che da allora cessò d’essere popolata e dal dare a parlare di sè.
Oggi, a chi la vede, par non credibile che possa essere stata importante luogo: eppure fu scritto che sul ripiano più elevato sorgesse il castello, che i pochi abitanti odierni additano ancora ove fosse; che ben nove chiese vi esistessero e che il vescovo Litigerio vi avesse collocato perfino una Collegiata di canonici.
Ruderi ad ogni modo di fortilizî veggonsi tuttavia, che si vanno però sempre struggendo, per sostituirvi piante e seminagioni, e in una festa annuale, nel 24 giugno, per antichissima tradizione, si riproduce intorno ad essa una delle tante assurde e superstiziose scene, onde non è libero ancora il cristianesimo del contado.
In quella giornata, sacra a San Giovanni Battista, il clero in processione vi gira in una gran barca detta la Scorobiessa, e negli anni addietro essa veniva altresì accompagnata dalla rappresentazione scenica della decollazione del Precursore.
Raffiguravasi il re Erode, che, in mezzo al suo corteo, [182] comandava decapitarsi il santo, il qual doveva essere un fantoccio, perchè realmente si vedeva, al calar del fendente, balzare la testa e il sangue sprizzare da un otre che vi era predisposto dentro, con immensa edificazione e gaudio della devota popolazione.
In seguito della suddetta guerra decenne, gli abitanti, parte ripararono a Varenna; gli altri si fabbricarono sul lido le loro case, e il paese che ne uscì appellarono dal luogo che avevan dovuto abbandonare, Isola, dove risiedette anche la Collegiata che ho testè ricordata.
Lasciando Isola, in su spingendo l’occhio, vedesi su d’un greppo un avanzo di torre, che denominano del Soccorso, di solida costruzione, quadrata, e che doveva servire o di vedetta o di momentaneo rifugio.
Subito dopo Isola, è Campo, ove la villa che prima era dei Giovio, venduta poscia a Tolomeo Gallio, che di ville sul lago n’ebbe più d’una, ebbe a ritornare di poi ai Giovio; nel 1787 venne da essi ceduta al cardinale Angelo Durini, che l’ampliò ed arricchì di molto; e forse è questa la villa del prelato, che, colla scorta dell’Amoretti, io cercavo a Moltrasio invanamente.
La superstizione, svegliata dal giuoco dei venti che vi producevano rumori, tenne lungo tempo disabitata la villa; ma essa ora appartiene ai signori Delmati, che l’abitano senza tema che diavoli e fantasime vi facciano ridda e tregenda.
Proseguendo il cammino, giungesi al Dosso di Lavedo, ov’era prima un convento di Francescani, che, acquistato dallo splendido cardinale sunnominato, vi fabbricò un portico sull’eminenza, e ne costituì la villa [183] che vi si vede, che si noma Balbianello, e spetta adesso al marchese Arconati. Da questa villa si domina il maraviglioso bacino della Tremezzina, cui ci tarda di giungere, e più giù il tratto di lago che abbiam trascorso in questa nostra escursione, la quale chiuderemo additando all’insù di Spurano ed Ossuccio il Santuario della Madonna del Soccorso, al quale conduce un’ampia strada fiancheggiata da quindici cappelle sul far di quelle della Madonna del Monte di Varese, con entro raffigurati, taluni in plastica, taluni in pittura, i religiosi misteri. L’opera di queste cappelle è dovuta alla pia costanza di Timoteo Snider, che fu eremita di questi monti, il quale e col mendicare e collo insistere presso le famiglie più facoltose, potè recare ad effetto il suo divisamento. Degli artisti che vi lavorarono, si addita un Francesco Torriani da Mendrisio per la cappella dell’Orazione di Gesù nell’Orto, dipinta; e un Agostino Silva, per le figure non senza merito scolpite in quella che rappresenta la disputa dei dottori, che è anche la più ricca cappella. Forse è pur egli l’autore di sculture di altre cappelle. Il Santuario è un bel tempio cui traggono continuamente, massime alla Madonna di settembre, i devoti. A mezzo la via, si passa sul torrente Perlana, traversandolo su di un ponte di legno, e le tumultuose sue acque, che mettono in movimento de’ mulini, precipitandosi al basso, formano una cascata di effetto assai pittoresco.
L’origine del Santuario vogliono che derivi da una effigie mutilata di sasso rinvenuta colà, Dio sa come, da’ montanari, alla quale, appiccicata una testa e una figura di bambino, la salutarono Madonna, la venerarono [184] in una chiesuola; poi, per grazia ricevuta, questa, a spesa de’ terrieri del lago, fu tramutata nel grandioso Santuario, conosciuto sotto il nome della Madonna del Soccorso, stato consacrato nel 1837 dal vescovo di Como, allora monsignor Bonesana.
Un’altra statua si conserva ed è dipinta e porta infatti questa iscrizione: Questa figura è quella che fu depinta quando questa gexia comenzò ad essere frequentata per li molti miracoli e grazie.
Legati e doni arricchirono la chiesa per parte di chi si professò riconoscente per qualche grazia colà supplicata ed ottenuta.
[185]
Le bellezze della Tremezzina. — Versi. — Villa. — Villeggiatura Carove e la Commedia di Plinio. — Ville Torri e Vacani. — Lenno. — Lapidi antiche. — L’abbazia dell’Acquafredda. — Il chiostro di S. Benedetto. — Ville Litta, Barbavara, Carmagnola e Carcano. — Bolvedro. — Villa Busca. — Le ville Spreafico, Scorpioni, Kramer, Gerli, Della Tela, De Orchi, Campagnani, Sala, Mainoni, Guy, Giulini. — Il caffè di Tremezzo. — Albergo Bazzoni. — Hôtel garni. — Grianta. — La grotta.
Entrati in questo bacino, che è il più bello, il più ampio e il più ridente, una vera meraviglia insomma di terra e di acque, par che il cuore ci si allarghi, che si dilati il polmone a bevere quanto di questo aere purissimo è capace, e la mente corre a cercare immagini poetiche e versi che esprimano tutto quell’ineffabile sentimento che si prova. Hic ver assiduum, atque alienis mensibus æstas[23], come direbbe il Poeta delle Georgiche; ma se poi avviene che al fianco vi troviate un’Eva qualunque di questo paradiso, l’inno allora vi sgorga più limpido ed acceso, perocchè l’ammirazione divisa e più accesa si avvalori, si faccia maggiore.
[186]
Molt’anni addietro, ne’ passeggi che facevo tra questi monti, che ricingono verdeggianti queste rive; nelle gite del lago, durante il giorno; nelle sale di conversazione, a notte, non c’era caso, una giovinetta leggiadra e sola, piena di riserbo e cortese ad un tempo, io la scontravo sempre, s’anco avessi preferito, al chiudermi la sera in una sala, lentamente trascorrere in canotto sotto i vaghi palazzini; se mi giungevano i suoni or mesti, or lieti di Schubert o di Fumagalli, chiedendo da chi il piano-forte fosse stato tocco, ero certo mi si dicesse da lei, da quella giovinetta che aveva finito per appellare il Genius loci, per desiderarla in ogni escursione, per non divertirmi ov’ella non fosse. Era agevole farsi a quella simpatica abitudine.
Lo seppe ella? Nol so: prima di partire, a mo’ di memoria, mi chiese de’ versi pel suo Album: eccoli, che non so com’io li abbia conservati.
O del Lario incantevoli
E benedette sponde,
Ov’io passai dei liberi
Ozî l’ore gioconde,
Qual mai spirto cortese
A voi rivolse il piè
E in voi l’oblio discese,
E cancellarvi dal suo cor potè?
Non io, non io: fra i turbini
Della città ravvolto,
Fra i polverosi codici,
Ne’ studi miei sepolto,
O nel rumor del giorno,
O nel notturno orror,
Sempre fa a voi ritorno
Sull’ale del pensiero il mesto cor.
[187]
E veggo allor sorridermi
Il vostro azzurro cielo,
Sento il mitissimo aëre
Scender nel petto anelo,
M’inerpico pei monti
Con fervido desir
Vaghissimi orizzonti,
Non prima immaginati, a discoprir.
E fiso il guardo immobile,
Come se mai non pago,
Nell’onda queta e cerula
Del scintillante lago,
In cui superbe a mille
Come odalische in mar,
Terre, palagi e ville
La lor bellezza alternansi a specchiar.
Poi, come fosse il genio
Di quelle rive amiche,
O come ondina e silfide
Delle canzoni antiche,
Dovunque il guardo io giro,
Nel suo leggiadro vel
Una fanciulla io miro,
Quasi una cara visïon di ciel.
Entro la snella gondola,
Fra i ciclamin’ del monte
D’ogni ruscel sul margine,
Sempre mi sorge a fronte;
E i balli se rammento,
O l’ilare canzon,
Veggo il suo piè, ne sento
E mi accarezza di sua voce il suon.
Anco i vocali avorii
Da lei percossi ascolto,
Seguo il vivace eloquio
Che sì le irradia il volto:
No, questi monti e il lago
[188]
Più non potrò veder
Che la gentile immago
Non s’affacci repente al mio pensier.
O del Lario incantevoli
E benedette sponde,
Ov’io passai dei liberi
Ozî l’ore gioconde,
L’anima pellegrina
Sovente a voi verrà
A chieder la divina
Che m’ispiraste arcana voluttà.
O voi, se a quelle floride
Pendici un dì trarrete,
E in quel leggiadro spirito
Se mai v’incontrerete,
Non creder che a me il canto
Fiamma volgar dettò:
— Ella fu a me soltanto
Musa che gli estri accese ed ispirò. —
La Tremezzina, delle etimologie del cui nome faccio grazia al lettore, per non infilargliene di marchiane, seguendo i diversi che la pretesero indovinare, e che forse ebbe il suo nome da Tremezzo, paese che siede tra mezzo il bellissimo golfo, comprende quel tratto di lago che, dopo Balbianello, si distende fino a Menaggio, ed è in quanto ai monti a cui s’addossa tutto ricco della più rigogliosa vegetazione: a campi, a vigne, a uliveti, a giardini, a quando a quando intersecati da’ torrenti che portano abbondanti acque al lago; e in quanto alla sponda del lago, essa non è che una serie continua di ville, di paeselli, di palazzi, di alberghi, che riflettonsi vagamente nell’onde.
Passiamoli tutti in rassegna.
[189]
Primo del bacino è il paesello di Villa, interessante a vedersi, perocchè qui si dica vi fosse, nel luogo ove sorge adesso la villa dell’ingegnere Carove, la villeggiatura di Plinio il Giovane, ch’egli chiamava Commedia, e della quale dicono si veggano tuttavia avanzi entro il lago, allorchè limpida è l’onda. Qui vi hanno ville di presente anche le famiglie Torri e Vacani.
Procedendo oltre, a breve distanza è Lenno, terricciuola non priva d’interesse ed ove ci tratterremo alquanto di più. Il suo nome è pur desunto da Grecia, Lenno, essendo un’isola del mar Egeo già sacra a Vulcano. Eravi in addietro un tempio periptero, o tutto recinto da portici, e nella cripta pur sussistente si leggono due lapidi cristiane, delle quali feci parola nella escursione passata, come testimonî che i greci qui immigrati continuarono per lungo tempo a contare gli anni come se ancora fossero stati nella madre patria.
Eccole:
Hic requiescit in pace B. M. (bonæ memoriæ) Cyprianus qui vixit in hoc sæculo annos p. m. XXXII dep. sub. d. VII. octob. ind. V. post cons. d. n. Justini p. p. aug. ann. VI, cioè nell’anno sesto dopo il consolato di Giustino nostro signore perpetuo augusto; lo che equivarrebbe all’anno 572 di Cristo.
La seconda: .... Vixit in hoc sæculo a p. m. XXVI dep. sub..... III post consulatum Basilii d. n.; e sarebbe nel 545.
A Lenno è il torrente detto dell’Acquafredda, che si butta nel lago: più sopra diede già il nome ad un’abbazia di Cistercensi soppressi nel 1785 da Giuseppe II; e chi la visita, salendo il monte, trova compenso alla [190] fatica nel più superbo panorama che gli si distende avanti. Da questo chiostro, per sentieri praticati nel monte ed aspri, non par vero che si giunga poi ad altro edifizio non meno interessante e bello, il chiostro di S. Benedetto, dove l’architettura della chiesa dell’undecimo secolo merita essere veduta e dove mirabile del pari e pittoresca è la veduta.
Non si lasci Lenno senza volgere lo sguardo alle ville dei Litta, dei Barbavara, dei Carmagnola e dei Rezia, ora Carcano, che si succedono, una dell’altra più bella.
A Bolvedro, altro paesello che segue, havvi la villa più superba de’ marchesi Busca, dove l’ultimo di essi, Antonio, arricchì di opere d’arte il palazzo, ivi, fra l’altre, trovandosi quel bellissimo quadro del mio povero amico, Cesare Poggi, da cui è trattato l’evangelico episodio l’Adultera. Al giardino aggiunse nuove vaghezze. Narrano que’ di Bolvedro che appena sposa la marchesa Busca-Serbelloni, venuta a questa sua villa, ne avesse nell’unica notte che vi soggiornò così turbata la fantasia da creduti fantasmi, che rifattasi subito a Milano, non vi riportasse in tutta la sua vita più il piede. Lungo queste sponde abbiam già trovato radicate ubbíe e superstizioni, alimentate forse da qualche avvenimento di naturali fenomeni e dalla solitudine che vi regna, ma spariranno certo fra breve. Non così è infatti della erede ed attuale proprietaria, la gentile contessina Antonietta, figlia di que’ miei due dilettissimi amici che furono i marchesi Lodovico e Clementina Busca, rapiti troppo presto entrambi all’amor delle figlie ed all’affetto degli amici, che le prime letizie [191] di un ben assortito connubio col giovane conte Sola rese ancora, non ha guari, più soavi nel soggiorno di questo suo Bolvedro.
Delle ville Spreafico, Scorpioni, Kramer, Gerli, Della Tela, De Orchi, Campagnani, Sala, Mainoni, Guy ed altri avrebbesi a dire ed a lungo; ma come occuparci di tutte? Degne son esse di trovarsi l’una all’altra vicine e d’essere a Tremezzo, dove è il convegno di tutto il mondo elegante milanese. La villa Giulini, ora ad altri venduta, fu l’oggetto di tutte le cure del suo primo proprietario, che lo aveva fatto il più leggiadro ed olezzante nido. Comodità di casa, ricchezza di serre e giardino vaghissimo, oh! come lo ha egli potuto mutare col pur elegante suo palazzino di Milano?
Nel caffè che si asside in mezzo a queste ville sontuose, riserbatevi ad entrare a sera, quando i villeggianti vi si danno la posta. Gli uomini al bigliardo, le signore s’accolgono tutte all’intorno di una sala a ripetersi gli avvenimenti della giornata, i progetti dell’indomani, le visite scambiate, i romanzi iniziati, le somme perdute al giuoco dagli eleganti fannulloni, le divertenti maldicenze, i pettegolezzi tutti cittadini, che qui concentrati, tramutano la quiete che vi si viene a ricercare in soggezione e preoccupazione. Ah! io amerei davvero non mescermi a tanta baraonda, per fruire invece delle sole dolcezze di questi luoghi.
Nell’albergo Bazzoni e nell’Hôtel garni si convengono coloro che non avendo villa propria o possibilità di valersi dell’altrui, amano tuttavia godere di questo terrestre paradiso che si chiama la Tremezzina.
Da qui breve è la via che conduce per boschi a [192] Grianta, paese che dà ragione agli etimologi, che il nome dedur vorrebbero da riant, sorridente, perchè infatti è amena e lieta per ogni riguardo. Beyle vi collocò le più interessanti scene del suo bel romanzo la Chartreuse de Parme: io invece ricordo le case signorili dei Riva, dei Mainoni e de’ Malacrida.
Montando più in alto si ritrova una delle molte grotte di questi monti che fiancheggiano il Lario, dove se ben si riguardasse al masso che vi esiste sconnesso dalla montagna, inorridirebbe pensando alla possibilità che un dì avesse a staccarsi e rovinar giù nel lago, suscitandovi uno sconvolgimento pari a quello che il masso staccatosi nella notte del 4 novembre 1856 di sopra le gallerie di Varenna ebbe già a produrre, cagionando non pochi danni.
[193]
La villa Sommariva. — Suo primo proprietario. — Opere d’arte. — Giardino. — Carlotta di Prussia e il principe di Sax-Meiningen. — La Cadenabbia. — Albergo di Belvedere. — Ville Brentano, Noseda, Piatti, duca di Sangro e Seufferheld. — La Majolica. — L’albergo Righini. — Villa Ricordi. — Maxime Lari. — Questione filologica.
Dicono i Francesi: à tout seigneur, tout honneur; e però a questa villa denominata ancor Sommariva, che per universal sentimento si estima la più grandiosa e splendida di quante abbellano le ridenti sponde del Lario, vuolsi, come da quanti visitano questi luoghi, dedicare una speciale escursione.
Sorge essa fra Tremezzo e la vicina Cadenabbia, isolata come una regina a cui le altre dame stieno per reverenza a certa distanza. È ingiustizia della sorte che non le sia stato conservato il nome del suo primo proprietario che la fe’ costrurre, del marchese Giorgio Clerici, cioè, che fu presidente a Milano del Senato e del quale pure era il magnifico palazzo nella contrada appunto detta de’ Clerici, convertito ora in sede della Corte d’Appello, dove pitture e dorature in profusione [194] attestano ancora della immensa ricchezza di sua famiglia; perocchè il primo merito andrebbe dovuto a questo nome.
Incominciata essa da quel patrizio, veniva ultimata da Anton Giorgio suo nipote, che, a dir di Gianbattista Giovio, l’amico di Foscolo, vi esercitò lo splendore e la magnificenza cinto d’ospiti numerosi e in banchetti luculei.
Ma piacque tanto, e per la casa e per i ben disposti giardini, e per le acque che vi zampillavano, al lodigiano avvocato Sommariva, che fu tra i direttori della repubblica cisalpina e che vi si arricchì, a prova che in ogni maniera di governo la fame dell’oro prende sempre i maggiorenti, che se la fece sua, acquistandola.
Nè è a dire quanto alla sua volta l’abbellisse ed arricchisse; dipinti e sculture vi recò de’ più eminenti artisti antichi e moderni. Parecchi quadri vi si veggono di scuola fiamminga; una bella testa, di Leonardo; e de’ moderni, l’ira di Achille, del Bossi, e le ceneri di Temistocle rese alla patria, dell’Appiani; un Marte disarmato dalle Grazie, del Landi; il bacio di Giulietta e Romeo, di Hayez; e la morte d’Atala, del Lordon. E di scultura, di antico, un’Andromeda che si fa passare per opera di greco scalpello; di moderno, il Palamede, il gruppo Amore e Psiche; e la Maddalena e la Tersicore di Canova, e diversi suoi modelli; e la fascia in basso rilievo rappresentante il trionfo d’Alessandro, di Thorwaldsen, allogato al grandissimo artista da Napoleone il Grande per il Quirinale di Roma e valutato ben settecentomila lire; un gruppo dell’Acquisti, raffigurante Marte e Venere; poi nell’attigua chiesuola due monumenti [195] ai Sommariva, padre e figlio; l’uno eseguito da Pompeo Marchesi, l’altro da Pietro Tenerani con quattro statue di Luigi Manfredini, e una Deposizione dalla Croce, di Benedetto Cacciatori.
A tanta ricchezza d’arte corrisponde la vaghezza del giardino e la peregrinità delle piante e de’ fiori.
Vi si ponno spendere insomma nell’ammirazione più ore e partirne contenti.
La villa fu anche detta Carlotta, perchè dopo acquistata da una principessa di Prussia di questo nome, che naturalmente l’aprì ad ospitarvi spesso regnanti e principi stranieri, e dalla quale, morta il 30 marzo 1855, passò al marito di lei, il principe Giorgio, duca di Sax-Meiningen.
Confina colla bellissima villa l’albergo della Bellavista (Hôtel de Bellevue) della Cadenabbia, — paese che originò forse da cà de’ nauli — e il forestiero anche più schifiltoso vi trova tutto e le lautezze e i comodi degli alberghi svizzeri.
Dopo l’albergo e le poche case della Cadenabbia, si trovano le ville Brentano e Noseda, quelle dell’artista Piatti, e accanto, colla medesima architettura, quella dei duca di Sangro, che rivela che a quelle due ville presiedette il pensiero d’una fraterna amicizia. Seguita poi la villa de’ signori Seufferheld, e dopo, il paese mutandosi in quello della Majolica, segue l’albergo Righini, cui tien dietro la villa del principe de’ nostri musicali editori, Tito di Giovanni Ricordi, al quale Euterpe e Melpomene hanno preparato il più gradito e riposato nido. Vuolsi che il solo spartito del Trovatore di Verdi abbia, ne’ guadagni fruttati, fornito la spesa di così splendida villeggiatura.
[196]
Oggi è breve la nostra escursione: ma in ricambio tante bellezze di natura e d’arte ammirabili ci occupano siffattamente, che è bene arrestarci e riandarle poi tutte nella memoria: meminisse juvabit.
Immenso è il dominio dell’arte e immenso è il campo a meditare in esso, come ampio si presenta il bacino allo svolger del lido, appena tocca la villa Ricordi; e noi quivi fermadoci, pare che il vasto pelago armonizzi colla vastità del pensiero che accoglie e medita tutte le meraviglie vedute.
Da qui si comprende come si potesse credere finora dai più, che massimo venisse chiamato il Lario, nella Georgica seconda di Virgilio, leggendone così i versi:
An mare, quod supra, memorem, quodque alluit infra?
Anne lacus tantos? te Lari maxime; teque
Fluctibus et fremitu assurgens, Benace, marino?[24]
Ma forse il poeta volle dire invece: te, Lari, Maxime; teque etc., e così ricordare e il Lario e il Verbano, che tuttavia chiamiamo Maggiore, e il Benaco, che così meglio risponderebbe al concetto espresso da Virgilio nel tantos lacus, perchè due soli laghi, il Lario e il Benaco non sarebbero, a vero dire, tanti laghi. A coloro poi, i quali a questa lezione oppor volessero che in antico si chiamasse Verbanus e non Maximus quel [197] lago, potrei rispondere che, se accademicamente quello fosse il suo nome, potrebbe anche essere stato che volgarmente venisse detto anche Maximus, se poi italianamente fu da poi appellato Maggiore.
Congeneri esempî si potrebbero all’uopo recare; ma rammentandomi che il mio dire non deve essere irto di discettazioni filologiche, abbandono cui piaccia la nuova questione; chiedendo anche questa volta scusa, se immemore d’essere un semplice cicerone da campagna, ho dato mano per un istante alla ferula del pedagogo.
[199]
Lézzeno. — Villa Vigoni. — Villa e Cappelletta. — I Sassi Grosgalli. — Il Buco de’ Carpi. — Pietosa istoria. — Villa Besana. — S. Giovanni. — Ville Ciceri, Trotti e Poldi-Pezzoli. — Villa Luppia. — Villa Melzi. — Bellagio. — La Tragedia, villa di Plinio. — Il castello di Bellagio. — Marchesino Stanga vi edifica la villa e que’ della Cavargna la distruggono. — Ercole Sfondrati la riedifica. — La Sfondrata. — La contessa di Borgomanero, tradizione. — La villa passa ai Serbelloni. — Parini vi ospita. — Ora mutata in albergo. — La Crella dei Frizzoni. — Pescaù. — La villa Giulia, ora albergo.
Anche la sponda opposta alla Tremezzina ha le sue vaghezze in questo bacino, le quali possono rivaleggiare con essa, e noi dalla Cavagnola dove siamo rimasti nel visitare tale sponda, costeggiamo colla nostra barca, che l’escursione riescirà amena ed istruttiva.
Il primo tratto è un po’ malinconico, è vero, e disabitato; ma svoltato il piccolo promontorio ci vediamo avanti Lézzeno. Ecco il clivo è più coltivato, il dosso dei monti più selvoso, le case sparpagliate ne formano il paese e ve n’ha taluna di bella mostra, e quivi soleva passarvi gli ozî autunnali quel distinto oratore e pubblicista che fu il prete Ambrogio Ambrosoli, che vi [200] morì il passato anno, il cui busto, scolpito da Pompeo Marchesi, fu, non ha guari, donato dalla Gazzetta di Milano, arringo ordinario de’ suoi liberali e dotti scritti, alla Società di mutuo soccorso tipografico della quale fu benemerito. Così più anni addietro da qui mossero due Mocchetti che ebbero qualche fama nelle lettere. Con tutto ciò gli abitatori di queste rive ne ripetono questa cattiva raccomandazione del paese:
Lezzen dalla mala fortuna,
D’inverno non c’è sol, d’està la luna.
Avviene tuttavia che vi ci si trovi la particolarità di buoni fichi in primavera, che son quelli dell’anno precedente, che, non maturati in autunno, si compiono all’aprirsi della buona stagione dell’anno successivo.
Un po’ più all’aprico, dopo Lézzeno, si specchia nel lago la villa Vigoni; poi segue il gruppo di case denominato Villa; quindi un altro detto la Cappelletta, dopo la quale si elevano i Sassi Grosgalli, brulli ed enormi massi e però formanti uno strano contrasto col rimanente del bacino tutto verdeggiante e sorridente. Scabra ne è la pendice che va a picco nel lago reso oscuro e tetro da essi, che vi progettano l’ombra e appena vi si può per aspro sentiero percorrerla. Sotto di essi, di fronte a Lenno, scavata nel sasso, evvi come un’ampia grotta, che i paesani chiamano il Buco de’ Carpi, forse perchè in quel riparo abbondano i pesci di questo nome, ed è qui che le genti de’ luoghi circonvicini narrano una storia pietosa d’amore, che formò soggetto ad una commovente novella di Antonio Picozzi, la quale provò anche una volta, dopo la Guerra [201] di Pret del Porta, o la Fuggitiva del Grossi, la potenza del milanese vernacolo a trattare la cosa più seria ed anche lagrimosa.
Se sapessi che il libro non andasse tra le mani di lombardi, sarei tratto a commettere un reato di contraffazione letteraria, riproducendo l’intero episodio nel suo bell’originale; ma siccome non sarà così, debbo chiedere venia al mio concittadino, se le sue belle e toccanti sestine riassumerò in modestissima prosa.
Erano i tempi del primo Napoleone, di colui che ci aveva regalata quella coscrizione militare che colla guerra ne mieteva il fiore della nostra gioventù; e nella Tremezzina viveva un buono e aitante giovane, che s’era fidanzato a Teresa, la più leggiadra fanciulla dei dintorni. Poichè tutti ora sanno come costei fosse bella, per coloro che capiscono il vernacolo nostro non so trattenermi dal farne loro il ritratto coi versi del poeta:
De sedes ann, dersett, minga deppù,
Bianca la carnagion, rosa el faccin,
Folt negher i cavej comè on velù,
Negher i bej oggioni de bambin....
Dal tutt’insemma con la prima oggiada
Se ghe vedeva l’anima ben fada.
Erano già intese le nozze che compier dovevansi nel successivo carnevale, e però la Teresa attendeva a prepararsi il suo corredo. Ma ecco un dì del settembre il Peppino, che a questo nome rispondeva l’innamorato garzone, facevasi attendere alquanto e la poverina a correre a pensar male. Nè l’ingannava il cuore. Cápita il fidanzato alla fine e tutto conturbato le narra come, [202] côlto dalla coscrizione, egli debba il posdomani essere a Como all’estrazione del numero ed alla visita militare. Ognun pensi l’affanno della giovinetta. Il posdomani arriva, Peppino è a Como, è ritrovato abile al militare servizio, ei deve giurare.... è soldato e appena gli son concessi tre giorni agli addii, perchè ei dovrà marciare per la Russia.
Egli è dunque di ritorno al paese; i tre giorni passano velocissimi fra i pianti della Teresa e i giuramenti del coscritto: l’ora della partenza definitiva è suonata. La povera tosa, presaga di sventure, poichè dentro di sè ella sente
comè ona vôs
Che tœujendegh el fiaa la ghe dis su:
“Teresa, el tò Peppin tel vedet pu;„
non sa staccarsi da lui, e però s’imbarca ella pure con un suo minore fratello e lo vuole per qualche tratto accompagnare.
Ma il tempo, triste dapprima, viene facendosi peggiore, l’uragano imperversa sul lago:
Han penna ciappaa el largh, che a pocch a pocch
Oltra el piœuv, se destend ona fiadura;
El ciel vers Val d’Intelvi a tocch a tocch
L’è già scur, burrascôs ch’el fa pagura;
Ma el coscritt per la sira a tutt i cost,
Piœuva, tempesta, l’ha de vess al post.
Cress el brutt temp anmò col cress del vent
Ch’el sifola piangend in di orecc;
Ingajarda la sluscia in d’on moment,
Ch’el par che la stravacchen cont i secc;
No se pò pu andà innanz; bœugna cercà
Quai paes o quai riva de prodà.
[203]
Ma il vento ha sbattute le fragili imbarcazioni verso l’opposto lido, e giunte presso il Buco dei Carpi, qui dentro traggonle i rematori a riparo dalla bufera, attendendo ne passi la furia. Quivi nuova scena d’amore e di strazio. La Teresa coglie un ciclamino, che sbucciava tra i crepacci della grotta, e il porge al suo Peppino a memoria sua. Il vento si è alquanto calmato, il lago può ritentarsi di nuovo; i due amanti si abbracciano e baciano tra le lagrime e si son detti addio. Esce prima la barca che si dirizza col coscritta a Como, poi l’altra della Teresa. Si riguardano mestamente finchè lo possono, poi ognuno se ne va. La Teresa, di ritorno a casa, trova la madre del suo fidanzato affranta dal colpo che le è toccato d’esser priva del figlio, indi a pochi giorni se ne muore. La Teresa vive da allora nel corrotto e nel duolo, e sola consolazione è al suo cuore visitare talvolta il Buco de’ Carpi, testimonio de’ suoi estremi saluti al suo Peppino, e vi ci va anche soletta una volta almeno la settimana a nutricarvi il cespo de’ ciclamini da cui avea spiccato quello ch’ella aveva dato al suo povero amico. Ma ella pure deperiva in salute. Un venerdì dell’aprile, anniversario della partenza del suo Peppino, essa, giusta il consueto, si avviava al Buco de’ Carpi: il lago era tranquillo, era l’ora del vespro, e un pensiero di tristezza, un malore che provava, la sconsigliavano alla gita; ma l’idea che non andarvi sembrasse cosa di poco amore alla memoria del suo caro, la prosegue inesorabile. Essa dunque solca le onde col suo burchio, traversa il lago, vi è presso, è sull’orlo della grotta, già la prua vi penetra; quand’ecco un uccellaccio con rumoroso e [204] largo sparnazzare d’ali, vi sbuca improvviso, rasenta la fronte della Teresa,
Scappand giò per el lagh alla distesa.
La povera tosa, per lo spavento dell’inatteso augello, si china onde schivarlo; il battello a quel suo movimento urta nel masso e si torce, ella perde l’equilibrio per la scossa, rovescia fuor dello stesso, gitta uno strido e giù va sotto l’onda. Due volte parve venisse ella respinta sulla superficie, e due volte risospinta giù, finchè l’onda si chiuse per sempre su di lei.
I parenti più non la vedendo ritornare, andavano in cerca di lei, e dopo lungo affannarsi, trovarono il burchio vuoto, che dondolava a discrezione dell’onde, ma nulla di lei, per quanto la chiamassero altamente a voce. Solo due mesi dopo, un pescatore, ritirando le reti, ne raccolse la inanimata spoglia. Narra il poeta, che lo scheletro dell’infelice fanciulla stia ora nell’ossario di Lenno presso alla chiesa e vi appaja ginocchione; che il soldato reduce dalla Russia, quando credeva aver cessato di soffrire, ebbe il più fiero martirio, ritrovando morta e la madre e l’amante; sicchè non volesse più vivere che mesto e sconsolato nella memoria de’ suoi poveri morti.
Proseguiamo ora l’escursione nostra.
Oltrepassati i Sassi Grosgalli, si presenta la villa Besana e ritorna da questo lato pienamente ridente il golfo. Perocchè a breve tratto si schiera il paese di S. Giovanni colle belle ville dei Crivelli, ora Ciceri, e de’ Trotti; quest’ultima di stile fra il bizantino e il lombardo; succeduta poi da quella del nobile Poldi-Pezzoli, [205] che prima era dei Taverna, più grandiosa e rinnovata da quell’abile architetto che è il milanese Balzaretti, al quale si debbono i nuovi giardini pubblici della sua città, e non poche architetture civili, fra cui ne primeggia la recentissima, appena ultimata, della Cassa di Risparmio in via Monte di Pietà. La casa qui, o piuttosto palazzo del nobile Poldi, si costituisce di tre corpi legati insieme da due eleganti terrazzi; il giardino poi è ricco di piante straniere, tra cui la canna di zucchero, il sovero, la canfora, l’olea fragrans e boschetti di magnolie che profuman l’aere tutt’all’intorno.
Poi v’è una villa Luppia, e da ultimo si chiude a San Giovanni colla più superba villeggiatura del duca Melzi, che mi reclama maggiori parole.
Francesco Melzi D’Eril, che fu vicepresidente della repubblica italiana e poi duca di Lodi, l’edificò al principiare del secolo su disegno di quell’esimio artista che fu Giocondo Albertolli, del quale io già dettai le memorie biografiche e artistiche nel giornale dell’Ingegnere-Architetto del Saldini di Milano. Come quegli che ridusse alla sua castigatezza l’arte ornamentale, l’Albertolli vi portò semplicità di linee architettoniche, ma ad un tempo armoniche e di gusto. Il proprietario poi l’arricchì internamente d’ogni maniera d’opera d’arte. A memoria di quel suo antenato, Francesco Melzi, che fu allievo di Leonardo ed erede dello studio di lui, volle il duca che il pittore Giuseppe Bossi in quattro sopraporte monocromatiche dipingesse quattro episodî del sommo Leonardo, e l’opera riuscì egregia. Nell’un disegno vedesi Leonardo [206] che insegna al Melzi il disegno: nel secondo, il gran maestro, che recinto da’ suoi scolari sta pingendo il proprio ritratto; nel terzo, la scena in cui lascia erede il Melzi; nel quarto, il Melzi che insegna nella scuola eredata da quel grande. — In altre sale ammiransi dipinti dello stesso Bossi, di Appiani, di Migliara e di Sanquirico; le statue, il Davide del Fraccaroli, l’Esmeralda, il busto somigliantissimo di Giocondo Albertolli, e copie de’ famosi capolavori antichi, il Laocoonte e la Cerere, e i busti di quattro imperatori romani e di Letizia e Giuseppina Bonaparte; oltre affreschi pregevolissimi di quel famoso prospettico che fu il sunnominato Sanquirico, per non dire d’opere di altri minori. Nella cappella mortuaria, pur disegno dell’Albertolli, e in cui riposano le ceneri del duca, vedesi l’avello lavorato da Vittorio Nesti; il Salvatore, scultura del Comolli e un bellissimo cartone del Bossi.
Ma se è degno di osservazione il palazzo, non ne son meno i giardini, cui presta la natura del suolo, che è un colle, la cui cima sovraggiudica il busto d’Alfieri. Il marmoreo gruppo di Dante e Beatrice, sculto dal suddetto Comolli, è nel mezzo del viale che costeggia il lago; se poi l’economia dell’opera me lo concedesse, darei un mezzo trattato di botanica nel descrivere i fiori, le erbe, le piante che li decorano in tanta copia da essere eziandio altrettanti vivai per altre ville.
Ma altre cose degnissime abbiamo a vedere in questa nostra escursione: affrettiamoci dunque alla vicina borgata di Bellagio.
Oltre San Giovanni e i giardini della villa Melzi, è Bellagio, che gli etimologi fanno derivare da Bilacus, [207] come a dire fra i due laghi, non altrimenti che in Isvizzera per la stessa ragione vi è Interlaken, perchè infatti Bellagio siede sulla punta d’un promontorio, che i paesani appellano Colunga, appunto perchè quasi una lingua di terra il cui capo si prolunghi nel pelago, dove il Lario che vien da Colico si divide in due rami, l’uno quello che già conosciamo e che va a Como, e l’altro che discende a Lecco. Una tale situazione dà a Bellagio una particolare vaghezza, nè per essa, nè per le magnifiche ville onde è lieto e che gli fan corona, e diciamo anche per i due ottimi alberghi, non vi ha persona che tragga alla Tremezzina, senza che ne traversi il lago e venga a vedere Bellagio. Tutta questa plaga può contenderla in bellezze di natura a quelle meraviglie cantate da’ poeti e levate a cielo da’ forestieri, che sono Posilippo e Mergellina, Portici e Sorrento.
Voi vedete allora di che buon gusto dovesse essere Cajo Plinio Cecilio Secondo, detto il Giovane, nello eleggersi proprio la cima di questa scogliera che sta a capo del promontorio per erigervi la sua villa che, a riscontro di quella che nomò Commedia e che ricordammo a Villa presso a Lenno, come attesta il Giovio, o sul basso lido presso Varenna, come vorrebbe il Boldoni, appellò Tragedia.
Più tardi, ne’ tempi di mezzo, come le altre terre del lago si facevano irte di fortilizî e torri, arnesi di guerra giovati spesso a contenere le rapine degli Elvezî che facevano frequenti scorrerie, ma ben anco a mantener vive le lotte fraterne e massime contro Como; anche Bellagio ebbe il suo forte castello, riparo di facinorosi [208] e banditi, il quale venne poi fatto smantellare da Galeazzo Visconti nel 1375. Risiedeva allora in Bellagio un capitano del lago, e convien dire che vi facesse capo ogni terra del Lario, se i cattivi debitori di Cernobbio ve li abbiamo veduti cacciati nelle carceri di Bellagio, dove i loro compaesani vennero a trarneli colla forza al tempo di Filippo Visconti, come narrai quando dissi di quei paesi del primo bacino.
Ogni traccia di efferatezza sparve dal colle di Bellagio qualche tempo dopo, quando un Marchesino Stanga, favorito di Lodovico il Moro, vi edificò una splendidissima villa. Ma non era appena compiuta, che que’ della Val Cavargna, a vendicar non so qual torto, vennero furibondi e la misero a ferro ed a fuoco.
Ercole Sfondrati, duca di Monte Marciano, nipote di papa Gregorio XIV e capitano suo nella spedizione che fece in ajuto della lega e contro il Bearnese, dopo le battaglie, avuto a sè infeudato il borgo, riparò su questo colle e vi rialzò la villa e riordinò i giardini, piantandovi lecci, quercie, allori, cipressi e pini, che pur esistono in gran parte, e vi eresse qui e qua sacre cappelle, che or non si veggono più.
E un edificio esisteva pure verso il lato del ramo del lago che sporge a Lecco e che dicevasi la Sfondrata; e qui la tradizione del paese rammenta una di quelle infami memorie di dissolutezza e di crudeltà, onde in Francia andò tristamente famosa la Torre de Nesle, e in Italia si ricordano i trabocchetti di Castel dell’Ovo di Giovanna I regina di Napoli, e che io brevemente riassumo.
Una Contessa di Borgomanero, forse legata per parentela [209] agli Sfondrati, e qui dimorata per qualche tempo, abbandonandosi a osceni amori, vuolsi che facesse pei trabocchetti precipitar giù per le acute balze della scogliera che sta a picco del lago i mal capitati suoi amatori d’una notte, a ciò forse non ripetessero intorno le sue brutte lascivie, e fors’anco troppo presto desiderevole del nuovo; ma di più non se ne sa dire, e certo allude a questa tradizione la poesia scritta da signora che da un album dell’albergo della Cadenabbia trascrisse Cesare Cantù, diligentissimo indagatore d’ogni particolarità del lago, nella seguente terzina:
O ti piacesse più, solcando l’acque,
Veder le balze dell’opposto lido,
Ove talor precipitato giacque
Il drudo infido.
Poscia il feudo passò ai conti della Riviera, signori della Valassina; ma la villa degli Sfondrati passò per eredità ai Serbelloni, onde villa Serbelloni si noma in oggi tutto l’ampio recinto che chiude la vasta casa, che altamente reclama una migliore architettura esterna e più moderni riattamenti. Come Plinio, ne’ tempi di Roma, Parini al principiar del secolo nostro veniva nella villa de’ Serbelloni a ricrearsi e ispirarsi, e ne aveva ben d’onde.
Estintasi in questi ultimi anni questa patrizia famiglia, ora l’appigionò Antonio Mella per convertirla in albergo, a soccorso dell’altro che ha in riva al lago, detto della Gran Brettagna, l’uno e l’altro forniti di tutte le comodità.
Un albergo ha pure in questo borgo Melchisedecco [210] Gandola, sotto il nome di Antico albergo e pensione Genazzini, e vi ha pari importanza e fama.
Più prossima alla punta è la Crella, villa dei Frizzoni da Bergamo, che su disegno di Rodolfo Vantini, di stile bramantesco, costò un ingente patrimonio. Bella, ricca, splendida, non è per avventura così comoda, come si vuole sia una villeggiatura molto più signorile.
Per un ampio viale, che fa maravigliare come sia stato praticato nella roccia, da Pescaù, che sta in cima di Bellagio, si arriva alla villa Giulia, con dir della quale mi piace chiudere l’escursione per la Bellagina. Essa sta sul poggio a cavaliere dei due rami del lago e sorge maestosa, quantunque la facciata più bella riguardi, non saprei dire perchè, i giardini. Fu il luogo dapprima dei Camozzi, poi l’acquistò la famiglia Venini sullo scorcio del passato secolo, e don Pietro vi costruì la villa che volle portasse il nome della moglie, Giulia, onde ancor si designa, malgrado che divenisse poi proprietà di Leopoldo, re del Belgio, che vi condusse a grande spesa le acque e la rese una vera delizia regale, che non lo lusingò per altro così possentemente, da non cederla in affitto dodicenne al signor Mella che la tramutò in albergo. Il panorama stupendo che si gode dalla villa Giulia, dell’un ramo del lago e dell’altro, impreziosito da poggi fioriti, da grotte, da fontane, da ruscelli, da boschetti, da pratelli e da piante peregrine, e le attrattive d’ogni maniera che presenta, rendono questo luogo uno de’ più deliziosi ritrovi che lungo le sponde del Lario meritino d’essere visitati.
[211]
Il Monte degli Stampi e l’Arca di Noè. — Ville di Menaggio. — Loveno. — Ville Pensa, Garovaglio, Alberti, Azeglio, Mylius-Vigoni. — Cardano. — Villa Galbiati. — La Val Cavargna. — Porlezza. — Fabbrica di vetro. — Il Castello di Menaggio. — La Sanagra. — Lapide romana. — Nobiallo. — Ligomana, Plesio e Naggio. — Il Sasso Rancio. — I cosacchi al Sasso Rancio.
Visitata la Bellagina, riconduciamoci all’opposto lido, dove nuove dolcezze ne attendono. Veramente il bacino della Tremezzina non s’arresta alla villa Ricordi: non è lungi Menaggio, che vi è compreso, e merita che vi ci andiamo e vi vediamo le cose interessanti de’ dintorni. E poichè siam ritornati da questa parte, non lasciamo di rivolgere l’attenzione al Monte che sta sopra la Tremezzina e si appella degli Stampi, non per altro, che per la stranissima tradizione che corre nel paese, che lassù vi sostasse, al cessar del diluvio universale, l’arca di Noè. D’onde mai traesse origine la fiaba, è presto detto. Su quel monte, nel masso, si ravvisarono impronte di zampe d’animali della grandezza perfino di trenta centimetri, come si [212] trovarono crostacei di tempi antidiluviani: ciò basta perchè il volgo, amante sempre del maraviglioso, sognasse che non sull’Ararat, ma su questo culmine posasse l’arca di quel patriarca.
Oltre le ville che ho rammentate nella escursione della Tremezzina, la Majolica non offre che meriti vedere e neppur nominare. La continuazione della via carrozzabile da Majolica a Menaggio è sempre ne’ pii desideri; ma noi pigliamo il canotto: — è così bello lo scivolare su d’esso quando è calmo il lago.
Nondimeno abbiatevi un avvertimento. Se anche un nuvoletto solo turba il sereno del cielo, non avventuratevi a traversare il lago da Bellagio alla Tremezzina; a più d’uno quel nuvoletto, non anco giunto a mezzo del lago, che, come dissi, qui è larghissimo, si dilatò, coprì tutto il cielo e apportò tempesta, naufragio e morte. Propriamente per dividersi il lago e formare i due rami, oltre che dalla valle di Menaggio, i venti vi soffiano e menano furibonda ridda e in nessuna parte del Lario come qui sono avvenuti tanti disastri.
Ma poichè ho ricordata la valle di Menaggio, se vi fermate nella Tremezzina alcun giorno, non lasciate di percorrerla e ne sarete contenti. Vi troverete su d’un poggio assidersi Loveno, colle belle villeggiature dei Pensa, dei Garovaglio, degli Alberti, degli Azeglio e dei Mylius-Vigoni. I Garovaglio vi tengono una copiosa collezione di pregevoli stampe, massimamente inglesi, e un giardino interessante pei botanici.
Nella sua villa Massimo d’Azeglio immaginò e scrisse parte del suo miglior romanzo Ettore Fieramosca, e raccolse alla sua volta buone stampe e buoni dipinti [213] con quel gusto che ognun conobbe all’illustre romanziere e paesista. Nel palazzo Mylius vedreste poi preziosità artistiche ancor maggiori. Intanto vi piacerà l’architettura sua semplice, opera del Besia: meglio poi le ricchezze dell’interno e la sua eccellente distribuzione. Non dirò degli arredi, nè di altre splendidezze: solo restringendomi all’arte, e nella casa e nel giardino si ammirano statue e gruppi di rinomatissimi scultori, come la Nemesi, di Thorwaldsen; l’Eva, di Baruzzi; la Ruth, dell’Himos; oltre la madre di Mosè, del Gandolfi; il David, del Manfredini; il gruppo insigne della Igea, dell’Argenti. Circa a pitture, ve n’hanno dell’Hayez, del Servi, del Canella, dell’Uaed; e ad incisioni, tutte le battaglie napoleoniche del Longhi, ritratte dai famosi affreschi di Appiani. Il giardino ha rarità di fiori e d’alberi e di prospetti.
Non lunge da Loveno, mette conto di vedere la bizzarra villa di Galbiati a Cardano, che non dovrebbe essere negletta dal suo attuale proprietario. Costò al barone Baldassare Galbiati assaissimo il far su quest’altura trasportare il gruppo della Clemenza di Tito, da lui acquistato allo scultore Comolli, ma non è opera che ne francasse la spesa. Piuttosto se visitate il sepolcreto domestico, vi ammirerete il monumento eretto dalla pietà del figlio Carlo al padre, collo scalpello di quell’esimio artista che è Antonio Tantardini. L’Angelo della Risurrezione che vi raffigurò è di un fortunatissimo ardimento, come d’una felicissima trovata. Maestra e sapiente ne è l’esecuzione.
Se amanti di natura alpestre, vi direi di percorrere la Val Cavargna e poi di spingervi anche a Porlezza a [214] vedervi la fabbrica di vetro de’ Campioni e a guardare il Ceresio che giunge fino al piede del borgo: ma io non vuo’ dimenticare il Lario che mi son proposto di farvi conoscere e però ritorniamo a Menaggio.
Sovra il paese torreggia il castello, da cui si ha superba la vista e dove un ricco che l’acquistasse vi troverebbe motivi di magnifica villa. In basso, viene a gittarsi nel lago la Sanagra, acqua che dev’essere medicinale, se gli etimologi ne fan derivare il nome da Sanat ægros, cioè sana i malati. Entrando poi nel grosso borgo, importante per belle case e per commerci ed anche per alberghi, fra cui primeggia quello del Piantanida, che da Bergamo qui trasportò i suoi penati e vi adattò da un pajo d’anni tutti i conforti de’ più sontuosi, ed è da contarsi tra i migliori del lago.
Sulla piazza è una delle lapidi massime dell’antichità, che così fu letta:
Minicius L. F. Ouf. Exoratus,
Flam. Divi Titi Aug. Vespasiani consensu Decurion. tr. mil. IIII vir. a. p. II. vir. i. d. præf. fabr. Cæsaris et consulis pontif. sibi et Geminæ q. f. Priscæ uxori et Miniciæ l. f. Bisiæ V. f.[25].
Usciti di Menaggio, tenendoci sempre al lago, incontriamo [215] Nobiallo. Il suo suolo abbonda di gesso, d’alabastro venato e di scagliola speculare. Levando lo sguardo al monte, scorgonsi i villaggi di Ligomana, Plesio e Naggio, dove dicono vi sieno vaghissime montanine. Non arrivai mai fin là, quantunque il bello facilmente mi seduca; ma d’altronde la comitiva tirava dritto, perchè la meta del nostro cammino di quel giorno era il Sasso rancio, e sarebbe stata poca creanza lasciare la compagnia.
Mentre passando per costì ci approssimavamo a questo Sasso, più d’uno mi chiese perchè rancio lo si nomasse, e mi tornò facile il darne la spiegazione: il colore che tutto copre questa parte di monte è prodotto dall’ocra di ferro che si contiene nella roccia e che infatti vien cavato in copia a Gaeta, lì presso. Una signora, che aveva di recente letto il sentimentale romanzo di Davide Bertolotti, che si intitola appunto Il Sasso rancio, spiegò allora la sua erudizione, ripetendone brevemente l’intreccio con tanta gravità come fosse stata pretta storia.
Giunti al Sasso, vi trovammo un’erta scogliera quasi a picco del lago, e vi si gode di là una magnifica vista. Vicino vi sono parecchie grotte che si sprofondano nelle viscere del monte.
Su pel difficile sentiero, che serba il nome di via della Regina, che è la prosecuzione di quella che costeggia tutta la sponda sinistra del lago, nel 1799, quando le nostre belle contrade erano infestate dalle orde russe, un drapello di cavalleria cosacca di Souwarow volle peritarsi; ma gli irrequieti cavalli, accostumati a liberamente scorrazzare per le lande dell’Ukrania, sbizzarrendo, [216] diruparono per que’ greppi, seco traendo nel precipizio anche molti de’ cavalieri.
Noi invece che v’andammo a piedi non corremmo alcun pericolo; ricordammo lo storico fatto, misurammo tutta l’altezza del precipizio e inorridimmo, e vi trovammo invece alla fine della nostra escursione tutto quel divertimento che desidero a’ lettori.
[217]
Rezzonico e il suo Castello. — Il Castello di Musso. — Il Medeghino. — Le Tre Pievi. — Villa Manzi. — Dongo. — Casa Polti. — Villa del vescovo di Como. — Chiese di S. Stefano e S. Maria. — Valle dell’Albano. — Le miniere di ferro. — I forni fusori. — Garzeno. — Brenzio. — Le Frate.
La manía de’ forastieri e villeggianti s’arresta per ordinario alla Tremezzina, nè più si cura delle altre bellezze del lago superiore. È ben vero che non c’è più quel sorriso continuo di ville che nella parte da noi già percorsa abbiam vedute; ma è vero altresì che v’hanno molte e molte ragioni a non dimenticare anche quest’altra parte del lago, che forse per l’artista riesce più interessante. Io ne dirò con sollecite parole de’ principali luoghi, acciò il libro non manchi al suo titolo.
Secondando sempre la sinistra sponda del lago, passato avanti il Sasso rancio e San Siro, vedesi su d’un promontorio il paese e il castello dei Rezzonico, famiglia d’onde uscirono quel Clemente XIII, al quale il Canova lasciò famoso monumento in Roma, e i conti [218] Gastone e Antongioseffo, buoni letterati. Il luogo ora è reso ameno per bellissimo parco fattovi all’intorno, per coltura e per magnifici limoni che vi fioriscono.
Proseguendo, scorgesi un altro promontorio che si spinge nel lago e che un dì portava un castello ed era quello famoso di Musso, che ricorda le gesta di quel formidabile filibustiere, che fu Gian Giacomo Medici, detto il Medeghino di Milano. L’ebbero prima i Visconti, quindi il maresciallo Gian Giacomo Trivulzio, e in fine, per inganno, il Medici suddetto, che, fatta incetta della peggior ribaldaglia, vi si stabilì come in nido sicuro di rapaci avoltoi. A renderla più inespugnabile, la circondò d’opere militari d’ogni maniera, al compimento delle quali coll’esempio incoraggiavano perfino le sorelle di lui, Clarina e Margherita, la qual’ultima, sposa, al conte Giberto Borromeo, fu poi madre di quel Carlo che divenne arcivescovo di Milano, cardinale di Santa Chiesa e canonizzato da ultimo come santo. Era da questa rôcca che il Medeghino, approfittando della debolezza del governo di Lombardia, che ora stava nelle mani de’ Francesi, or passava a quelle degli Spagnuoli, ed a tratti ben anco funestato dalle orde alemanne, colla flottiglia che s’era formata di sette navi grosse a tre vele e quarant’otto remi, ed aveva armata cadauna perfin di cento uomini, tutta schiuma di scellerati, spandeva il terrore pel lago e rendevasi tanto formidabile e potente, da tenere a segno i Grigioni, ai quali anzi toglieva Chiavenna; da oppor resistenza agli Sforza dapprima, quindi ben anco all’esercito cesareo, capitanato dal duca di Leyva, che soleva dire dargli maggior fastidio il Medeghino che non tutto l’esercito dello [219] Sforza; da trattar da pari co’ principi, battere moneta, e dopo d’avere assalito il territorio di Lecco, quello della Valtellina e la Valsolda, intitolavasi conte di Musso e di Lecco, governatore del lago e della Valsássina. Se Carlo V volle togliersi questa spina, gli fu giuocoforza venire a patti con lui, concedendogli forti somme di denaro, il feudo di Marignano col titolo di marchese e il comando di quell’esercito che gli affidava per abbattere a Siena l’ultimo avanzo di guelfa libertà. Ciò avveniva nel marzo 1532; e quando, in seguito a tali atti, egli abbandonava il suo castello di Musso, i Grigioni, che ne spiavano la partenza, inerpicavansi su per que’ greppi, impazienti di demolirlo; scortili il Medeghino, retrocedette, scese a terra e intimò rispettasser il castello finchè egli fosse in condizione di vederlo; e tanto imposero la sua presenza e la minaccia, che alla demolizione non si mise la mano che sol quando la sua nave non fu più veduta per il lago.
Ora il picco sopra cui il castello si elevava, costituendosi d’un marmo saccaroide dolomitico, somministra marmi alla fabbrica del duomo di Como; le molte mine che ne aprirono le viscere, dischiusero un varco che lascia veder tutta la vallata che riesce a Dongo, e i signori Manzi, a cui spetta, accomodaronlo come a parco.
Detto delle sorti di questo castellotto che meritamente servì a novellieri e romanzieri di largo e fantastico tema, avanzando, s’entra nel territorio delle Tre Pievi, che comprendeva nella sua giurisdizione Dongo, Gravedona e Sórico, e che ne’ tempi medievali costituiva di per sè una piccola repubblica, è vero, ma [220] tale da sapersi far rispettare. E la piccola repubblica ebbe pure l’istoriografo suo nel vivace Rebuschini.
Seguendo il parco dei signori Manzi che abbiam veduto a’ piedi delle rovine del castel di Musso, perveniamo in mezzo al seno dove sorge il palazzo di questi medesimi signori e dove siede il paese di Dongo. Altre case signorili qui vi sono, fra cui quella dei Polti: il vescovo di Como vi ha pure la sua villeggiatura, acquistata avendo il vescovo Romanò la villa che già fu di Antonio Cossoni, discendente di quel fra Daniele Cossoni che fu ministro di Filippo IV di Spagna.
Qui villeggiava il notajo Sormani di Milano, che si ebbe a’ nostri giorni la maggior riputazione e clientela, ed al quale i figliuoli eressero nella parrocchiale di Santo Stefano un monumento. In questa chiesa vi sono anche mediocri statue del Salterio; affreschi di Giovan Mauro, Gian Battista e Marco della Rovere, detti i Fiamminghini, vi sono nell’altra chiesa di Santa Maria.
Nella vicina valle dell’Albano vi sono ricche miniere di ferro e le si dan scoperte da un Giacomo di Desio nel 1460, che un’altra pure discoperse di rame presso Barbignano.
Nell’archivio de’ Trivulzio di Milano leggesi un documento in cui è scritto che lo stesso Giacomo di Desio rinvenisse in questa valle massi di smeraldo e di rubino, forse schisto di color verde e qualche pirite di rame, certo non di quella grossezza nè tale da farne tavole e colonne; onde in benemerenza il duca gli assegnasse dieci scudi il mese di pensione, purchè quelle pietre ad altri non offerisse prima che a lui, per un prezzo da misurarsi a norma di loro volume; diritto [221] poi da esso duca ceduto al maresciallo Gian Giacomo Trivulzio.
Colle miniere era facile immaginare che presto vi si sarebbero stabiliti forni fusorî, e infatti furono attivati nel 1465 e furono per lungo tempo posseduti dai conti Giuliani di Milano.
I Rubini per altro li acquistarono nel 1790 e vi portarono tali miglioramenti e incremento all’industria, da poter modellare la ghisa. Ma più ancora questa industria s’avantaggiò, quando nel 1839 venne costituita la società Rubini, Scalini e C. che le diè più ampio svolgimento; per modo che se ne’ primi quarant’anni del secolo producevano le cave per circa cinquantamila pesi, ora può dirsi che siasi il ricavo portato a diecimila quintali, di cui un terzo di ghisa, occupandovisi ben quattrocento operai.
Visitare queste ferriere deve essere un amenissimo scopo di escursione a chiunque, sia per chi di questa industria sia intelligente, sia per qualsiasi profano che pur si interessi all’attivo lavoro ed al curioso processo, onde la roccia si tritura, il metallo si fonde, si schiumano le scorie, e poi l’incandescente e liquido ferro trabocca e si distende come un igneo torrente per le diverse forme che gli si vogliano far assumere e che raffreddandosi ritiene.
Quelle terre che si mostrano sopra Dongo non sono indegne d’essere visitate per chi ama l’arte. Perocchè a Garzeno v’abbian pitture di Giovanni della Rovere suddetto, altro de’ Fiamminghini; ed a Brenzio ve n’abbian molte di Isidoro Bianchi da Campione, celebre pittore, allievo di Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone, e parecchie pure de’ Fiamminghini.
[222]
D’una particolarità ancora di questo monte, alle cui pendici è Dongo, intratterò, e poi per questa escursione imporrò freno allo scilinguagnolo; ed è che le sue donne, per un voto fatto nella peste del secolo XVI, vestono da cappuccine, quantunque abbelliscano il grossolano costume di ricche cinture e finissime trine. Queste contigie non vietano che attraggano la curiosità di chi visita la montagna, e che loro si dia il nome di frate, appunto per il fratesco abbigliamento.
[223]
Consiglio di Rumo e San Gregorio. — Pizzo di Gino. — Valle di Lesio. — Gravedona e la sua storia. — La chiesa di San Vincenzo. — S. Maria del Tiglio. — La Madonna sfolgorante. — Peglio. — Liro e i tre laghetti. — Il Sasso acuto. — Domaso. — Gera. — Sórico.
Quanto torto si ha a non comprendere fra la parte di lago, che si suol meglio ricercare da’ forestieri e villeggianti, questo territorio delle Tre Pievi, già dissi. Esso divide infatti, col resto che già percorremmo, i bellissimi prospetti e la ricca vegetazione, e forse forse, perchè protetta a settentrione dall’alta schiena de’ monti che la difendono dai soffii gelati, ha mitezza di clima maggiore degli altri inferiori bacini, sicchè i giardini vi abbiano agrumi e fiori, e la camelia perfino vi alligni e prosperi, l’inverno senz’uopo di stufe.
Noi, spiccandoci da Dongo, dove siamo restati nella nostra ultima escursione, e via trascorrendo Consiglio di Rumo e San Gregorio, giù scendendo, potremmo ammirare buoni dipinti del cavaliere Isidoro Bianchi, e salendo più in su, ove comincia il Pizzo di Gino, troveremmo la chiesuola di San Gottardo. Poi ci vediamo [224] davanti la Valle di Lesio, oltrepassata la quale si sparpaglia sul pendio del monte la grossa borgata di Gravedona.
Non fu solo il Rebuschini che ricordò nella sua Storia delle Tre Pievi gli avvenimenti di Gravedona: altro storico l’aveva preceduto, Anton Maria Stampa, che fu autore d’una Storia dell’insigne borgo di Gravedona, altre volte repubblica, da lui scritta a bandir la noja della prigione, perchè, sospettato di torbidi popolari, venne chiuso nel forte di Fuentes, che sta a capo del lago sulla via di Chiavenna e intorno al quale si potrebbero spendere molte parole, se dal mio soggetto non temessi di scostarmi soverchio. Non lasciò questo scrittore di rimontare a remotissimi tempi del suo insigne borgo, per isnocciolarne di grosse, e non so da qual codice infatti imparasse egli come prima Gravedona si appellasse Laricola; ma che poi, ivi stanziando, un Garbatone, figliuol d’un re Garibaldo anteriore a Brenno, vi imponesse il proprio nome e fosse il principio d’una serie di re e di eroi. Di tutto ciò si dispensa d’indicare le fonti: la tradizione è la sua autorità; ma invano anche questa voi domandereste a que’ della borgata.
Il Rebuschini attinge invece a più verosimili tradizioni, e ricorda che Gravedona sostenesse onorevole parte nelle guerre repubblicane; che nel tempo del Barbarossa,
Di cui dolente ancor Milan ragiona,
come diceva a’ suoi giorni l’Alighieri, nel soggettarsi Lombardia, preponesse al governo delle Tre Pievi un [225] Amizzone, uomo sanguinario e rapace, il quale, a togliere ogni motivo ad insurrezione, smantellava il castello di Gravedona e la Torre di Melia, e così inoltre operasse da tiranno, che stancati quegli alpigiani ne scuotessero il giogo ed egli fosse costretto a rifugiarsi in Valtellina. Rammenta pure come lo stesso Barbarossa, dopo la tregua di Venezia, tornando pel lago in Germania, venisse da que’ di Gravedona audacemente assalito, depredandolo delle bandiere e del corredo, e la corona stessa imperiale, tutta d’oro, caduta pur nelle mani loro, deponessero poi nella chiesa del Battistero, onde nella pace di Costanza volesse Federico esclusa dal parteciparne a’ beneficî Gravedona.
Già toccai della parte dalle Tre Pievi avuta nella guerra decenne; poi Gravedona divenne feudo del cardinale Tolomeo Gallio, facoltosissimo ed influente, e che nutrendo pensiero di farne la capitale della Valtellina, al cui conquisto agognava, vi fabbricò, su buon disegno del Pellegrini, un grandioso e turrito palazzo, il cui loggiato si vede da chi viaggia per il lago. È in esso che fu detto che si volesse trasferire il Concilio ecumenico di Trento; ma non se n’ha nella storia alcun documento che tale intento comprovi; onde siffatta pretesa de’ Gravedonesi è suffragata unicamente dalla circostanza che nel detto palazzo si conservino solenni seggioloni con iscritto su ciascuno il nome de’ cardinali.
Dal Gallio passò il feudo alla ducal famiglia d’Alvito di Napoli, che la più parte del ricco mobigliare, onde istruivasi il palazzo, si trasportò nella sua casa di questa città e in quella di Genova; ma a conservare gli [226] eredati diritti vi mantenne un commissario per amministrare la giustizia.
Merita qui esser veduta la chiesa parrocchiale di S. Vincenzo, che si vuole del secolo V, con cripta di stile lombardo, e dove si vede il sepolcro del dottissimo cardinale Michelangelo Ricci, e tra gli arredi una pianeta di forma greca a bei ricami, una pace d’argento del XIV secolo, un calice egregiamente cesellato con molti giri di santi raffigurati in ismalto, non che una croce grande con ornati e figurine, lavorata per Franciscum de Sancto Gregorio da Grabedona. Nè si dimentichi di osservare il battistero di Santa Maria del Tiglio, che si pretende eretto dalla pia regina longobarda Teodolinda, alla quale per altro si attribuiscono troppe cose, perchè vi si possa credere sulla parola. Esso battistero è quadrilungo, con tre absidi pentagone all’esterno e con campanile ottagono di bell’effetto, e internamente ha una galleria nella parte superiore che lo gira tutt’all’intorno, e le pareti lasciano intravvedere come già fossero tutte rivestite di pitture. È qui dove esiste dipinta una Vergine col Bambino, or tutta rovinata dal tempo, che l’Aimoin nel suo libro De Gestis Francorum, afferma essere stata un tempo per più giorni sfolgorante di celeste luce. — Oggidì sappiamo quanto valore si abbiano codeste storie e miracoli, che preti ignoranti e pinzochere accreditano fra le zotiche popolazioni, come che loro non paja bastevole la buona e sana dottrina del Cristo a persuaderne la santità della religione.
Agli amatori dell’arte si ponno additare altresì un buon quadro della scuola del Guercino nella chiesa de’ [227] Santi Gusmeo e Matteo; nella vicina terra di Peglio vi hanno i dipinti di Gian Mauro della Rovere, altro de’ Fiamminghini, che ho già mentovati, fra cui il proprio ritratto nel battistero; una Madonna del far di Bernardino Luini, una Santa Rosalia della scuola del Guercino, e minori pitture di un Antonio Scherino del 1635, di Giovanni Valerio, del Rodriguez, del Caracciolo di Vercana, terra di questi dintorni; oltre la Via Crucis e il Trionfo della Morte nell’ossario, dipinti nel 1715 da Alessandro Valdini; e a Liro, ne’ cui monti scopronsi a Darenco, Caprico e Ledi tre piccoli laghi; nella chiesa abbandonata di San Giacomo vi sono affreschi che portano la data del 1412 e il nome di Bernardo Somassi, al quale appartengono, e che metterebbe conto che fossero esaminati da chi avesse a ritessere la storia dell’arte italiana, massime ne’ suoi primi tempi.
Sovra Gravedona i buoni passeggiatori non lasciano di montare al Sasso acuto, picco, la cui forma è designata dal suo qualificativo, che ha la vetta rilucente, ed ha sparso il cammino di lucide tormaline.
Ma non volendoci adesso scostar dal lago, oltre Gravedona si distende, come in un semicerchio, Domaso, che si presenta più bello e seducente soggiorno se riguardi al suo vago prospetto ed all’attività de’ suoi commerci; ma chi non è avvezzo ai troppo vivi scorrazzamenti della breva, che sembra qui s’accolga, quasi l’antro di Eolo, per poi sprigionarsene sul lago, s’accorge presto che non è sì grato il dimorarvi. Da un’antica poesia di quell’Anton Maria Stampa che ho ricordato nella passata escursione, e che il Cantù ha [228] pubblicata, raccogliesi che a que’ di Domaso venisse a’ suoi giorni appiccicato vituperevole epiteto, per essere talun del paese trascorso ad alcun atto d’empietà. Ecco i versi che vi fanno allusione:
O signori, udite come
A Domaso sia rimaso
Quell’orrendo soprannome
Di cui fe’ poc’anzi acquisto,
Del mozzar le braccia a Cristo.
Più avanti si incontra Gera, sito di pescatori, e più avanti ancora Sórico; ma le scialbe faccie de’ suoi abitatori ne avvertono dell’aria malsana a causa d’acque che vi stagnano; onde sarà bene che noi retrocediamo, perocchè di malinconie il mio lettore non ha di certo bisogno, e d’altronde da qui i canneti che vediamo ci annunciano presso la fine del lago.
[229]
Olgiasca. — Piona e il suo lago. — Colico e i suoi padroni. — Dorio, Carenno e Dervio. — Bellano. — Grossi e Boldoni. — L’Orrido. — Il Sasso di Morcate. — Riva di Gittana. — Varenna. — Albergo e villa Venini. — L’Uga e la Capuana. — Il Fiume Latte. — Regoledo.
Poichè siamo a capo del lago, visitiamo rapidamente anche le altre terre della sponda opposta a quella che abbiamo veduta.
Prima si presenta Olgiasca; ma non ti rallegra: delle sue pietre calcaree silicee si fecero le colonne di S. Lorenzo di Milano, e al nostro tempo quelle dell’Arco del Sempione. Hai appena oltrepassato le case, che vedi addentrarsi il villaggio di Piona, forse da Peonia de’ Greci, che ha un piccolo ma pescoso lago, un vecchio ma bel monastero, ed una chiesa che si pretende esistere fin dal sesto secolo, perchè un’iscrizione che vi si lesse la disse consacrata da Sant’Agrippino nel 607.
A poca distanza schierasi sul lido il paese di Colico, e le febbri che vi dominano sembrano legittimare il suo nome. Ciò malgrado, è attivissimo scalo, quivi mettendo capo i piroscafi che muovono da Como e moltissime [230] navi di mercanzia e i molti viaggiatori diretti al paese di Chiavenna e di Valtellina; come le merci e i viaggiatori che si dirigono da questi luoghi a Lecco, Como e Milano. Un dì fu contea eretta dai Visconti pei Sanseverino; poi infeudata dal duca Lodovico Sforza al proprio cameriere Giovanni Casati, che dovette in seguito restituirla alla giurisdizione dei Comaschi, che provarono d’avervi diritto. I Caldarini l’ebbero poscia da Carlo V; e dopo passò prima ai Pusterla, quindi ad Anton Maria Quadrio e da ultimo a un Rubini di Dervio.
Si succedono a Colico tre altre terre con nomi grecanici, Dorio, Corenno e Dervio, corrotti forse da Dori, Corinto e Delfo; d’interessante, Corenno presenta un castello di spettanza dei conti Andreani, e Dervio pure una rôcca di pittoresco effetto.
Più assai offre argomento di intrattenerci la bella borgata di Bellano, che vi tien dietro e già fu corte degli arcivescovi di Milano, come ce lo fe’ sapere quel simpaticissimo ingegno, nativo di questo luogo, che fu Tomaso Grossi, nel suo Marco Visconti.
Ha bella chiesa del secolo XIV di stile lombardo, a fasce la facciata di marmo bianco e nero, con bel finestrone rotondo nel mezzo recinto di fogliami in terra cotta. Se ne dà merito a Giovan da Campione, Antonio da Castellazzo e Cornelio da Osteno, i quali la architettarono. Or s’è fatto un bel viale lungo il lago a comodo di passeggiata, e lo si denominò dal sullodato concittadino poeta e notajo Tomaso Grossi, che col Manzoni tenne per tanti anni in Milano il primato delle lettere italiane, alle quali, oltre al Marco Visconti [231] summentovato, che sarà sempre una bella e cara lettura, diede eziandio un poema dal titolo I Lombardi alla prima Crociata, e le novelle patetiche Ildegonda, La Fuggitiva e Ulrico e Lida, nonchè crebbe dicevolmente la collana de’ poeti vernacoli milanesi colla stessa Fuggitiva in dialetto, colla Prineide e colla Pioggia d’oro[26]. Milano eresse alla sua memoria una statua nel cortile del Palazzo di Brera, opera di Vincenzo Vela, perocchè l’ebbe come suo per lunghissimo soggiorno; e Bellano ne commise il busto allo scalpello di Antonio Tantardini, onde collocarlo a capo del detto viale. Ma vorrei che l’obolo de’ suoi compaesani e degli amici ed estimatori che già concorsero, affrettasse l’esecuzione di questo che poi non è costosissimo monumento. Son già molt’anni che se ne parla.
Era pure di Bellano Sigismondo Boldoni, medico ed egregio latinista e poeta del secolo XVII, avendo scritto in ottave la Caduta dei Longobardi, e latinamente intorno agli avvenimenti del suo lago.
Dalla Valsássina, che finisce a Bellano, giunge la Pioverna, torrente che qui, gettandosi da un’altezza di forse sessanta metri, produce un orrido cui traggon tutti a vedere. Quando il luogo di sua caduta apparteneva alla famiglia Fumagalli, dalla quale ero considerato ne’ miei giorni d’infanzia coll’affetto di figliuolo, e che io, dopo tanta lontananza di tempo ho [232] sempre nel cuore, su quell’abisso eravi un ponte sospeso a catene, sul quale essendo, anche perchè paresse malfermo e dondolasse, si rabbrividiva.
Io non lo vidi, perchè già rotto nel 1816 da un masso che vi era rovinato.
Ora il luogo divenuto proprietà dei signori Gavazzi, questi usufruttarono di quell’acqua per dar anima e moto ad officine, setificî, lanificî, cartiere, laminatoi e mulini, essendo ora Bellano uno de’ paesi del lago più industriosi.
Poichè vi siamo presso, andiamo ora a vedere Varenna.
Passiamo pel Sasso di Morcate, cui la mina ha squarciato le viscere, per continuarvi la strada militare, e giungiamo alla Riva di Gittana, di cui in addietro appena appena si sapeva da’ barcaiuoli il nome; non adesso che da tutte parti vi arriva la gente per ascendere a Regoledo, luogo silvestre non è gran tempo, divenuto oggidì uno de’ più popolati ritrovi termali.
Ma prima di ascendervi anche noi, proseguiamo a Varenna, che fu già nella dipendenza degli arcivescovi di Milano. Già fiorente un dì, non conta ora più di un migliaio di persone, ciò che non impedisce che viva tuttavia sul labbro de’ suoi abitatori il ritornello che stereotipa il carattere de’ suoi abitatori:
Varenna su uno scoglio,
Del mio non ho, del tuo non voglio;
Ma piena son d’orgoglio.
La grandiosa villa che quivi avevano gli Isimbardi fu ridotta ad albergo; i Venini ve l’hanno ancora; il [233] clima è più che proprio a mantenervi anche fiori e piante esotiche.
Poco discosta è la fonte Uga, che sgorga da un antro e trascorrendo sotto di un pergolato di allori, scende e s’unisce alla cascata artificiale della sottoposta Capuana.
Finalmente si giunge alla cascata del Fiume Latte, le cui acque, per un cammino lunghissimo entro le viscere del monte, si gittan poi spumeggianti e fredde per un’altezza di trecento metri pei dirupi, e dopo d’avere rumorosamente giovato a mulini, ad una fabbrica di vetri e ad un filatojo, si confondono coll’acque del lago.
Retrocediamo ora alla Riva di Gittana e saliamo a Regoledo.
Chi parlava prima di Regoledo? Francesco Maglia di Milano, fabbricatore di carta, ritrattosi dal commercio, che abbandonava a’ suoi figli, su questa deliziosa e facile altura, che è di soli 225 metri sul livello del mare, vi edificò coraggiosamente un vasto e comodo stabilimento idroterapico.
Superate le prime difficoltà che accompagnano sempre qualunque impresa ardita, Regoledo è divenuta ora una stazione estiva di moda. La sua posizione felice, il facile modo di giungervi, il buon trattamento, tutti gli apparecchi e le innovazioni dell’idroterapia, e l’assistenza d’un medico specialista, vi chiamano la più eletta compagnia, che anche rinnovandosi, non perde mai di suo valore.
Da qui si può muovere a stupende escursioni, oltre che sul lago, anche per la Valsássina, sul Moncodine [234] e sulla Grigna. La vegetazione che circonda Regoledo è bella e perfino lussureggiante, le acque son copiose, deliziosi i prospetti, l’aria pura ed eccellente; e però s’anco il medico non lo ordini, pellegrinate ne’ mesi di luglio e di agosto a Regoledo e vi ci starete, sotto tutti i riguardi, a meraviglia.
[235]
Vassena. — Limonta. — La Pietra Luna. — Civenna. — I Marroni. — Perledo e la Regina Teodolinda. — Lierna. — Olcio. — Villa Pini. — Mandello. — Abbadia. — La Gessima. — Lodovico Savelli. — Le Caviate e la Maddalena. — La strada militare. — Onno. — Parè. — Lecco. — Il Maglio. — Acquate e Pescarenico. — Il Galeotto. — Il Mercato di Lecco. — Le robiole. — Gli alberghi del Leon d’Oro e della Croce di Malta.
Noi coglieremo un bel giorno di sabato del mese d’ottobre per imbarcarci mattinieri sul piroscafo, che partito da Como, non va già, come d’ordinario, a Colico, ma a Lecco, perchè a chi villeggia lungo il Lario, come a chi villeggia nella Brianza superiore, il mercato che si fa a quella piccola ma leggiadra città, è una delle imperscrittibili mete alle eleganti escursioni.
Noi abbiamo già dimezzato il cammino, ritrovandoci già oltre la punta di Bellagio, ed entrati in quel ramo del lago che appunto s’incammina a Lecco.
E prima di scostarci da queste sponde, dopo la Sfondrata, oltre quel gruppo di povere case che si intitola Vassena, il romanzo di Grossi, che tutti abbiamo letto, ci suggerisce d’occuparci di Limonta, “terricciuola, — è [236] scritto nel Marco Visconti — pressochè ascosa fra i castani al guardo di chi, spiccatosi dalla punta di Bellagio per navigare verso Lecco, la cerca a mezza costa in faccia a Lierna. Cominciando dall’ottavo secolo fino agli ultimi tempi che fur tolti i feudi in Lombardia, essa fu soggetta al monastero di Sant’Ambrogio di Milano, e l’abate, fra gli altri titoli, aveva quello di conte di Limonta e di Civenna, terra più in alto, al lembo della Valassina.„ I geologi e gli archeologi ricordano sovrastante a Limonta un masso del volume di circa cinquanta metri cubi, che sembrerebbe rovinare ad ogni più lieve scossa, ma che è sorretto invece da tre pietre della medesima natura. Su questo trovante si leggono scolpite le lettere:
P. L. D. B.
che il chiarissimo archeologo cavaliere Bernardino Biondelli, interpretò per Pietra Luna di Bellagio. Infatti si denomina Pietra Luna un tale trovante e lo si pretende una reliquia del culto celtico, come qui dal linguaggio celtico si hanno più vestigia in molti nomi di paesi e monti, come Grianta e Grosgalli. Completerò le notizie intorno a questa minima terra, ricordando le cave di gesso che son proprio a lido, e quelle di marmo nero sul fianco del monte; onde gli scoppi delle mine destano frequentemente gli echi di quest’ultimo contrafforto delle Alpi; e per coloro che sono alquanto più epicurei, ricordando che il luogo è celebre pe’ suoi saporiti marroni. Anche la vicina terra di Civenna divide una tale gustosa particolarità, che un giorno era tutto a profitto dei detti monaci di Sant’Ambrogio. Qual [237] gaudente non si sarebbe fatto monaco allora? Le più belle ville, le leccornie migliori, privilegi d’ogni sorta, immunità, tutto era per essi.
La citazione del Grossi rammenta Lierna che sta in faccia a Limonta, ed è paese su’ cui greppi soprastanti si fanno vini che dicono buoni per chi patisce di gotta e di calcoli, mali oramai resi troppo comuni.
Più in alto è Perledo, da dove si ha una magnifica vista. Lassù, dicesi dalla tradizione che la Regina Teodolinda — la quale in tutta questa parte di Lombardia si ha tutti i momenti e per tutte le occasioni alla mano —, dopo d’avere abdicato in favore del figlio Adaloaldo, s’avesse a ritirare per ivi passare nella quiete i vecchi giorni[27].
Su questa riva orientale, dopo Lierna, si incontra Olcio, ove si scava pure marmo nero, del quale parte va alla fabbrica del duomo di Como; quindi si arriva a Mandello, grosso paese, dove il palazzo Airoldi, ora Pini, contavasi fra i più suntuosi del lago.
Oltre Mandello è l’Abbadia, così chiamata per una antica badia che fu prima de’ Benedettini, e quindi de’ Servi di Maria, e vi son case di villeggiatura. Più avanti, verso Lecco, è la Gessima, luogo brullo e sassoso, che trae forse il suo nome dalla roccia propria a far gesso, e va ricordato da Paolo Giovio pel fatto miserando intervenuto a Lodovico Savelli, che, essendosi inerpicato per questa scogliera, scivolatogli il piè, e giù [238] rovinando, potè nella caduta avvinghiarsi ad un ramo sporgente e colà vi stette, colla forza dell’istinto che ognuno ha della propria conservazione, per ben cinque ore; finchè, più non potendovisi sostenere e mancategli le forze, stremate vieppiù dalla sferza del sole, malgrado che que’ terrieri, inorriditi spettatori di quella scena, gli avessero disposto sotto letti di felci, di strame e di materassi, giù lasciandosi andare, prima di toccar terra s’era già reso cadavere. — Seguono le Caviate e poi la Maddalena, casali ultimi che rompono l’uniformità della strada militare, la quale da Lecco dirigesi a Colico e che corre tra il lago e la montagna brulla, cui di tratto in tratto ha squarciate, per aprirsi il varco, le pendici.
Sull’opposta riva, rimpetto a Mandello, sorge il paesello di Onno, dove a notte le ardenti fornaci ti dicono che vi si produce calce; poscia Parè, sovra cui spuntano que’ picchi che si chiamano i Corni di Canzo, perchè dall’opposto versante sogguardano la grossa borgata di Canzo, e che stando sui bastioni di Milano, in una limpida giornata, si veggono a incitamento de’ molti che vi traggono a passare alle lietissime falde le autunnali vacanze.
Ma ritraversiamo lo sguardo: Lecco c’è in faccia; la campanella del piroscafo ci annunzia che ci accostiamo al lido.
Entrati in questo bel bacino tutto recinto di monti, non è possibile non ripetere mentalmente il saluto a questi luoghi, che leggemmo nel capitolo VIII dei Promessi Sposi: “Addio, montagne sorgenti dalle acque ed erette al cielo; cime ineguali, note a chi è cresciuto [239] tra voi, e impresse nella sua mente non meno che lo sia l’aspetto de’ suoi più famigliari; torrenti, de’ quali egli distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branco di pecore pascenti; addio!„
Con questa soave reminiscenza di Manzoni vi ho invitato a guardare tutto l’ameno territorio, che sembra, pei tanti paesi che si succedono senza interruzione, una sola città, fin su a Laorca, da dove per un risvolto di via si entra nella Valsássina.
Ma che è codesto cupo e cadenzato rumore — potrà chiedere il lettore che mai non fu a Lecco — che s’intende lontano? — Gli risponderò coi superbi versi di Foscolo, che fu in questi luoghi ad ispirarsi, e ch’io spicco al Carme delle Grazie, e il quale tutto spira attica fragranza e venustà:
Come quando più gajo Euro provóca
Sull’alba il queto Lario e a quel sussurro
Canta il nocchiero, allegransi i propinqui
Lïuti e molle il flauto si duole
D’innamorati giovani e di ninfe
Sulle gondole erranti; e dalla sponda
Risponde il pastorel colla sua piva.
Per entro i colli rintronano i corni
Terror del capriol, mentre in cadenza
Di Lecco il maglio, domator del bronzo,
Fuma dagli antri ardenti; stupefatto
Pende le reti il pescatore, ed ode.
È dunque il maglio delle officine di ferro di Castello e San Giovanni, il cui martellare mi svegliava nel religioso efebeo a’ giorni della mia adolescenza.
[240]
È, fra tutti i paesi che vedete sparpagliati in questo bel pendio fiancheggiato dal monte di San Martino e dal Resegone, che stanno Acquate all’insù, a lido Pescarenico, ove seguirono tante interessanti scene del romanzo del sommo nostro Manzoni, fatto così popolare che non v’abbia persona che, giungendo a Lecco, non s’informi d’ogni luogo in quel libro mentovato. E così pure domanda ognuno dove sia il Galeotto, bella palazzina dove il Manzoni appunto dimorò tanto tempo quando attendeva a scrivere questa sua opera d’oro, e che sta a mano destra di Lecco, a poco più d’un quarto di miglia.
Ma via, scendiamo dal battello che è approdato, tocchiamo la terra che ha tenuto parola al vaticinio di questo illustre scrittore, affrettandosi a diventare città; e la è infatti per attività di commerci, se non per ampiezza, e mettiamoci nel mercato, che già ferve da più ore.
Gentili signore e molte nostre cittadine conoscenze lo percorrono su e giù. A che mai son venuti? Quale attrattiva li ha chiamati? Non è già la brama di ammirarne le derrate e le merci esposte; chi mai ad esse ha pensato? Per quanto siano peregrine le robiole o cacini di Introbbio, che Valsássina vi spedisce, non son esse di certo per cui sono accorse. Ma per che dunque? La voga. È detto che il mercato di Lecco sia una gran cosa, massime a’ sabati d’ottobre, e ognun vi corre che stia in villa, o lungo il lago, o nel vicino Pian d’Erba, o nella restante Brianza superiore. Gli è che ognuno serve di spettacolo all’altro: giugne una carrozza, ne giugne un’altra; gli uni attendono a vederne scendere [241] gli altri; son persone che si conoscono, che si salutano, che si stringono la mano, si baciano, si scambiano notizie e complimenti; poi a braccetto si passeggia a veder altri, poi si parla e si sparla di tutto; si ingombra il caffè; si impegna a fermarsi per la sera al teatro, che per consueto ha in autunno buona compagnia di canto; poi, se sì, si va all’albergo, il Leon d’Oro o la Croce di Malta, forniti d’ogni comodità; se no, dopo un pajo d’ore, chi rimonta in carrozza, chi riascende il vapore; gli uni vanno di qua, gli altri di là, tutti ritornano alle loro ville a diffondere alla loro volta le notizie e i pettegolezzi uditi, e a domandarsi spesso: ma infine, che cosa v’era a Lecco? Perchè vi ci si va? — e malgrado che la risposta che ognuno si dà a sè stesso non contenga grande costrutto, pure il sabato successivo vi si ritorna. Andatevi dunque anche voi, o miei cortesi lettori.
[243]
Malgrate. — Gli etimologisti. — Casa Agudio e i suoi ospiti illustri. — La chiesa parrocchiale e il pittore Cornienti. — Valmadrera. — La Chiesa. — Il trovante utilizzato. — Le Cappelle della Via Crucis. — La villa del signor Egidio Gavazzi. — La villa del signor Pietro Gavazzi.
Essendomi proposto di condurre il mio lettore dal lago di Como al Pian d’Erba, dopo il mercato di Lecco non l’obbligherò a rifar la via del lago; ma traversatolo in carrozza sul bel ponte di sotto il quale esce l’Adda, volgiam verso Malgrate che fronteggia Lecco, dove sono belle ville, e il colle o promontorio che si spinge nel lago, il qual si mostra tutto verdeggiante pei giardini che vi si adagiano. Sul vertice di esso si signoreggia tutto il vaghissimo territorio; e presso vi sono sparse altre case signorili e ville, e il tenere de’ Fate-bene-fratelli di Milano, che qui, come a Valmadrera, vi ereditarono dai Mandelli.
Sempre quegli eterni etimologisti pretendono far credere che Grato si chiamasse prima questa terra, ma che per una immane strage che vi fecero i Comaschi [244] nel 1126, mutasse in quello di Malgrate il nome; non altrimenti, per l’opposto, era accaduto a Malevento ne’ primi tempi della romana repubblica che una fortunata battaglia facesse alla città cangiare il nome in Benevento, che serba tuttavia.
In Malgrate han casa gli Agudio, ed era in essa che Giuseppe Parini, ospite del canonico Candido Agudio, scriveva gran parte del suo poema Il Giorno. Anche il poeta vernacolo Balestrieri, vi fu ospite festeggiato e vi conduceva la traduzione in versi milanesi della Gerusalemme del Tasso; nè certo vi sarà rimasta muta la musa del fecondissimo abate Passeroni, che pur vi conveniva.
Nella chiesa parrocchiale, che sta nella parte più alta del paese, cerchiamovi i due bei dipinti di Cherubino Cornienti, rappresentanti l’Annunciazione della Vergine e la Natività, e vedendoli, si sente maggiore il rammarico che sì giovane ne sia stato il loro autore rapito da morte.
Lasciato Malgrate, poco avanti si vede a man destra, ed adagiata sulle pendici boscose del monte, Valmadrera. È un grosso borgo industrioso per fiorenti setificî, massime quello de’ fratelli Gavazzi, e per ottima calce che vi si cava; e l’attenzione e curiosità vi son deste per una bella chiesa, sacra a Sant’Antonio, architettata nel 1814 da Simone Cantoni, con modificazioni dell’ingegnere Bovara di Lecco, e nella quale sono affreschi pregevolissimi di Luigi Sabatelli da Firenze, che vi dipinse la visione dell’Apocalisse, ed un quadro antico del Lomazzo; un Cristo e Sant’Antonio, scolture di B. Cacciatori; e per le magnifiche villeggiature [245] del signor Egidio e del signor Pietro Gavazzi, a non dir di qualche altra del pari interessante. Nè van dimenticate le cappelle della Via Crucis, di cui due condotte pure a buon fresco dall’egregio pittore Vitale Sala da Cernusco Lombardone, che in queste parti lasciò altre memorie del suo vigoroso pennello.
Nella chiesa, oltre i suddetti affreschi del Sabatelli, merita essere ricordato che le quattro colonne di granito, del diametro ciascuna di metri due e mezzo e dell’altezza di metri ventisette, che sorreggono il cornicione e la vôlta a mo’ di cupola o lucernario, si sono tratte da un trovante ch’era sul monte di Valmadrera, a 1200 piedi sul livello del lago, che equivale a 1854 su quello del mare.
Nella villa dei signori fratelli Gavazzi poi molte altre ragioni vi sono di curioso interesse.
A parte la bella posizione sua, che dovette indubbiamente costare assai al suo proprietario, per superare le difficoltà della roccia e l’ineguaglianza del terreno; tanto la casa, o grandioso palazzo che dir si dovrebbe, quanto il giardino, sono d’una vaghezza incomparabile. E siccome non tutto boscoso è il monte che serve di sfondo, ma v’è anche molta scogliera nuda; così tutta questa delizia si direbbe suscitata dalla magica bacchetta d’una benefica fata, e il vario genere vi crea il più grazioso contrasto.
L’arte addita nell’unito oratorio, che è una rotonda d’ordine corintio, un monumento eretto alla memoria di Giuseppe Maria Gavazzi, lodevole opera di Benedetto Cacciatori, e un quadro pure lodevolissimo di Giuseppe Sabatelli.
[246]
Nel giardino è un bel laghetto, perocchè l’acqua vi accresca vita e bellezza: vi sono profonde e spaziose grotte, chioschi eleganti e capanne da pastore, macchie d’alberelli, sabbiosi sentieri, tappeti erbosi, piante peregrine e fiori; tutto insomma disposto con meravigliosa sagacità e buon gusto.
Presso alla sala da pranzo e da essa, mediante un’acconcia vetriata, si vede il giardino detto d’inverno, dove sono adunate piante e fiori, che sappiano anche nella stagione inclemente fare di sè bella mostra. Abbandono il pensiero di venir passando in rassegna le varie peregrine vegetazioni per tema di voler parere botanico, non lo essendo. Noto per altro e le stufe opportunamente erette a grandi vetriate col sistema dell’ingegnere Balzaretti, che nel giardinaggio è veramente maestro, e la bella fontana.
Se, in una parola, il lettore vorrà veramente pellegrinare a Valmadrera, pria d’entrare al vicino Pian d’Erba, vedrà che la villa dei signori fratelli Gavazzi sorpasserà di molto quell’aspettazione che le mie povere e disadorne parole gli avranno per avventura ispirata.
Non si diparta allora da quella borgata senza visitare anche l’altra villa del signor Pietro Gavazzi. Dal suo belvedere, che domina il grazioso palazzo, gli verrà dato di ammirare un leggiadrissimo panorama, di genere affatto diverso da quelli che, dai culmini che già abbiamo insieme ascesi, ci accadde di vedere spiegati avanti di noi.
[247]
Bartesate, Villavergano, Figina. — La casa degli Umiliati. — Ello. — Ville Prinetti, Annoni, De’ Vecchi. — La villa Paolina. — La Bellavista del signor Cereda. — Galbiate. — Palazzi Brioschi e Ballabio. — La villa Sanchioli e l’eco polisillabo. — Case Curti e Riva. — La chiesa di S. Michele. — La lapide di piazza. — Il Monte Baro. — Fiabe archeologiche. — L’effigie immobile. — La Rôcca di Re Desiderio. — La fanciulla nel pozzo. — Il Monte delle Crocette.
Essere in questi dintorni, sentirsi di buona gamba e volontà di veder cose nuove e provar grate emozioni, e non ascendere a Monte Baro, è pressochè impossibile. Pellegriniamovi noi pure, amico lettore, più fortunati se avremo con noi, e meglio ancora se ci saranno compagne le signore, perchè allora più lieta, svariata e simpatica ci parrà la gita.
Eleggiamo la via di Galbiate, che tornerà men faticosa. E tuttavia questo bel paese è sul ciglio del monte; ma appunto per questo sarà più divertente l’escursione nostra.
Mano mano che si ascende, l’orizzonte si allarga. Il ridentissimo bacino dell’antico Éupili si distende innanzi a noi. È dall’alto che terrem conto di tutto; intanto le terre che su questo monte, o piuttosto collina [248] si veggono, sono Bartesate e Villavergano; più sopra Figina, ove si vede una casa che apparteneva agli Umiliati, e quindi Ello, che conta diverse villeggiature amenissime de’ Prinetti, dell’Annoni, del signor Pasquale de’ Vecchi, la villa Paolina, fabbricata dal general Pino, e quella dei Riva, che ha un giardino da cui si vede da una parte l’Adda e dall’altra il Pian d’Erba, e sovratutto quella che già fu del signor Bonomi ed ora è passata all’ingegnere Cereda, che per me ha la più simpatica postura della Brianza, come quella che sorga sulla parte più alta e libera del paese e domini tutto un meraviglioso orizzonte di monti e di colli, di laghi, di paesi. L’han detta La Bellavista; ma siccome è un nome affibbiato troppo comunemente tra noi a qualunque luogo che appena abbia una spanna di prospetto o di sfondo, così non rende tutto l’incanto che realmente possiede. Ben architettato e comodo ne è il palazzo, e stupendamente da natura mosso e accidentato il giardino, anzi parco che le sta intorno, ricco di boschetti e rarità botaniche; insomma un vero Eden.
Giunti a Galbiate, ci accorgiamo come questo colle separi la valle dell’Adda da quella dell’Éupili; perocchè dall’opposto versante veggasi appunto quel fiume, che uscito tale di sotto del ponte di Lecco, rasenta Olginate e va giù a Brivio. Il duplice orizzonte è pertanto un pregio di poche località; godiamolo nel mentre raccogliamo il vigore per compiere la gita montana che abbiamo intrapresa. Guardando giù per la parte donde siamo venuti, vediamo tutta una serie di laghetti: quel d’Oggionno e quel d’Annone, che ne è [249] appena diviso da una lingua di terra che chiaman Isella; quindi quel di Pusiano, poscia a mano manca quel più piccolo di Alserio. Senza molto dubitare si può essere indotti a credere che un dì fossero tutti uniti in un sol lago, che Plinio denomina l’Éupili, e dal quale esce il Lambro, ch’egli chiama il Flumen frigidum, fiume freddo, che ha le proprie scaturigini tra le montagne della Vallassina.
In Galbiate poi, passando innanzi a bellissime case e palazzi, si è tratti a chiedere a chi appartengano: e si sa che sono proprietarî i Brioschi d’un palazzo, che sta sulla piazza della chiesa, con magnifiche sale ed ampie cantine, e che già fu del barone Pietro Custodi, il continuatore della Storia di Milano di P. Verri e il dotto economista; d’altro i Ballabio, con magnifico giardino verso Oggionno, e dove si incominciarono scene dolorose di domestico dramma, nel quale era catastrofe l’affogamento d’un bambino e scena ultima la Corte delle Assise di Milano per lo snaturato suo padre; quindi la villa Sanchioli, dove esiste un eco polisillabo, che ripete persino un intero endecasillabo, e le case de’ Curti e dei Riva.
Se accadrà al lettore di tornare altra volta in Galbiate, perchè oggi siam diretti a Monte Baro, girando intorno al colle verso la parte della valle dell’Adda, non lasci di visitare la chiesa di San Michele che sta sul pendio verso Lecco. La sua fondazione è attribuita a Desiderio, l’ultimo re longobardo, e vi godrà di altro nuovo orizzonte, perchè si vedrà in faccia tutto il territorio di Lecco e il corso serpeggiante dell’Adda.
Prima di lasciare Galbiate, decifriamo la lapide che si vede sulla piazza della chiesa.
[250]
Essa suona così:
Libertas
Quæ toto non bene venditur auro
Labore lite prætio parta
Galbiatensi viciniæ ac finitimis oppidis
Regia concessione firmata tandem arrisit
Felix dies XVII junii anni MDCLXXI.
Que infeudationis ac omnis inferioris judicii
excusso onere
Populus hic sub potentiss. regis Hispaniarum
Vicaria potestate nempe mediolanensis Senatus
Se immediate redegit.
Tantæ exemptionis memoriæ
Quam Francisci Georgii Ottolini
Regiæ ducalis Cameræ notarii
Autentica scripta privatim asservant
Hujus lapidis retentivæ custodiæ
Publice resignantur
Die XVIII septembris anno MDCLXXI[28].
Così impariamo che Galbiate, ch’era una volta dipendenza del feudatario della Pieve d’Oggionno, ebbe a comperare a’ 17 giugno 1671 la propria emancipazione.
[251]
Ora ripigliamo la strada pel monte Baro. Essa è montuosa, ma non aspra, e presto vi si arriva.
Figuratevi quanto s’esercitasse l’erudizione intorno a questo monte! S’è detto prima che su questa sua vetta, dove noi ci troviamo adesso, vi fosse nientemeno che una città e che questa si denominasse Bara, i cui abitanti andassero poi a fondare Bergamo. Gli è tutto un sogno codesto, chè nulla rimase che dia presa soltanto ad argomentare che qualche fondamento avesse di verità, dove s’eccettui il nome del monte. Ma pure i barbassori che misero innanzi tal fiaba, sono nientemeno che Plinio il Vecchio, il quale per altro ciò afferma sulla fede di un vecchio autore, che dice essere Catone. E a Bara e da’ suoi abitatori si vuole discesa tutta la famiglia briantea.
Non so poi davvero di qual ragione possa valere a rafforzare questa pretesa la tradizione di quella vecchia e rozza effigie che si venerava quassù, e che essendosi tentata da’ divoti di rimovere, onde porla in luogo più dicevole ed accessibile, non solo non vi riuscirono, ma rimasero colpiti da cecità. Ciò riferirebbesi ad êra cristiana. Quella effigie fu rivolta a culto cristiano, e quei di Galbiate vi eressero anzi una chiesa, nel 1480, che poi ebbero i Francescani, i quali vi studiarono la riforma del loro ordine, e vi stettero finchè Giuseppe II, nel 1810, volle sbarazzarsi di frati e di conventi.
Qui sul monte vuolsi ancora che re Desiderio vi avesse una rôcca; e qui davanti alla chiesa, non fan più di quattr’anni, che in quel pozzo che vi si vede, precipitasse un’inconscia fanciulla, credendo riparare entro [252] il recinto di muro dalla furia d’una buféra. Dicono vi rimanesse inavvertita ben sette giorni, a capo de’ quali, venuti per cagion d’una festa gli apparatori e udendo ascendere da quella profondità un gemito, calati dentro vi rinvenissero viva ancora, sebbene intirizzita, la poveretta che sopravisse con meraviglia di tutti.
La vista da questa altura è maravigliosa, più che per la sua estensione — perchè da oriente è arrestata dalle vette de’ monti che le stanno in faccia, — per la sua vaghezza. Le digradanti colline che le stan sotto, i laghi che sembrano gli bacino i piedi, quel di Lecco e l’Adda da una parte, e quei di Oggionno e d’Annone dall’altra; gli altri leggiadri bacini, la miriade di paeselli e di casali disseminati per la valle dell’Adda e dell’Éupili, prestano allo sguardo uno di que’ panorami che a parole mal si sanno descrivere.
Una bella selva di faggi sussiste ancora, entro cui i buoni Francescani s’erano aperta un’incantevole via, che se serviva di delizioso passeggio a que’ frati, or vale a riposo di chi pellegrina a questa vetta.
Più su si sale al cocuzzolo del monte, dove furono infisse nel suolo tre crocette, che si veggono stando al basso della valle e che a quel più alto vertice fan dare il nome di Monte delle Crocette. Ivi naturalmente si allarga ancor più l’orizzonte e spazia vieppiù la vista.
Ma l’ora si è fatta alta, e la salita, l’aria sottile del monte ci hanno reso acuto l’appetito; mano alle provvigioni. Non dimentichi il lettore la purissima linfa del monte, e con Properzio gridi a chi lo serve:
Et puris manibus sumite fontis aquam.
[253]
Corni di Canzo. — Civate. — Il monastero benedettino. — Il re Desiderio e Adelchi. — La tradizione del miracolo. — La Valle dell’Oro. — Barzaguta. — La cascata.
Come già notai in una precedente escursione, anche dai bastioni orientali della nostra Milano, fra quella lunga fila di montagne di cerulea lontananza che contermina l’orizzonte, si distingue quel monte che elevandosi in due acute punte, vien detto dei Corni di Canzo, dal bel paese che loro dà il nome, e che divide la Brianza dalla Vallassina. Era ad essi che Giovanni Torti, il poeta della Torre di Capua e dei versi che Manzoni additava come pochi ma valenti, faceva cenno in questi:
O selvose montagne, o gioghi erbosi,
O di lontan sovreminenti al verde
Cornuti massi, o dolce aere vitale...
Come appendice di questo monte, si protende un bel declivio che vien morendo in riva al lago di Annone. Su questo allegro pendío si posa il villaggio di Civate, [254] o Clivate, come appellavasi in addietro, derivando la propria denominazione dalla sua stessa postura.
Fu già Civate una grossa terra, che v’ha chi pretende perfino essere stata una piccola città, argomentando da alcune vicinanze, come Borneu, che vorrebbe dire Borgo nuovo, Castello o Castelnovo e la Selva di Diana. Certo in tempi meno rimoti fu signoria degli Abbati Commendatori del monastero benedettino de’ SS. Pietro e Calocero, il quale sorge a mezzo del monte che sovraggiudica il paese stesso, e la storia e la tradizione hanno lasciato e all’eremo ed alla chiesa tutto ancora quell’interesse che pur l’avevano allorquando l’abbazia era nel pieno suo fiore.
Per chi amasse conoscere per filo e per segno della origine del cenobio e della chiesa, degli scrittori che ne han parlato, fra’ quali Tristano Calco ed il Fiamma, Bernardino Corio e Ripamonti, per non dire dei tanti altri, farà bene a consultare le Memorie storiche che pubblicava l’abate Longoni[29].
Tutti i cronisti, scrive codesto autore, citando il Corio, concordano quindi nell’affermare che Desiderio, l’ultimo re longobardo, innalzasse la chiesa di S. Pietro per compiere il voto per la guarigione del figlio Adalgisio od Adelchi, come lo chiama il Manzoni. Desiderio amava oltremodo questo suo figlio, che viene dipinto da Paolo il Diacono, da Varnefrido e da Manzoni [255] stesso come duce valoroso; e lo avea in tanta considerazione, da chiamarlo a parte del regno, dividendo con esso lui gli onori ed il peso della corona.
Il Corio narra come Desiderio, dopo la sconfitta avuta da Adriano a Spoleto, oppure, come meglio si vuole, dopo la fuga e la rotta de’ Longobardi dispersi dall’esercito franco, si ritirasse colle sue genti ne’ monti della Brianza ad un luogo detto Montebaro, dove si fortificasse in modo che di un monte solitario fosse divenuta una vera città opulenta. È quindi probabilissimo, inferisce il Longoni, che trovandosi in que’ luoghi andasse a caccia per quei circonvicini monti, che a quell’epoca erano per le folte selve abbondanti di selvaggina, e che abbattutosi Algiso in qualche fiera, che viene chiamata nelle cronache porco selvatico (cinghiale), o fosse assalito da essa, o nell’ucciderla restasse offeso dalle armi proprie o da quelle di altro cacciatore di lui seguace. Forse i monaci Benedettini, che si erano già sparsi nell’Italia e stabiliti negli eremi i più solitari, soccorsero il giovane Algiso o Adelchi nella sua sventura e lo curarono con affetto; per cui re Desiderio, mosso dalla premura da essi addimostrata, fece loro erigere una chiesa più vasta di quella di San Benedetto, che forse già esisteva, e la dotò di beni.
Ma il Corio stesso riferiva supposizione diversa, quella cioè che il Fiamma aveva diggià udito.
“Questo tempio fece edificare Desiderio a similitudine della Chiesa Pontificale in Roma. Et la cagione intervenne che, andando un dì Algisio, suo figliuolo, con assai comitiva et gran numero di carri alla caccia di porci (cignali) su quel monte dove è edificato il [256] tempio, a caso ferendo un porco, di subito, per divina volontà, divenne cieco. La qual cosa intendendo il padre il votò a S. Pietro ad honore di cui, al figliuolo essendo ritornato il vedere, nel monte predetto fece edificare il memorato tempio e quello dotò di honoranti redditi, siccome nei suoi privilegi si contiene e per li quali si vede ancora la indulgenza che Adriano pontefice gli concesse.„
La quale opinione dello storico milanese riceve il suo valore dalla popolare tradizione che ancora sussiste: perocchè i molti devoti che traggono a quella chiesa sogliano lavare gli occhi in una fonte di acqua viva che scaturisce presso alla stessa, e che pretendono sia pur quella che rese la vista all’infelice Adelchi.
Ma che c’entrano, chiederà il lettore, tutte queste leggende colla Valle dell’Oro, di cui vi siete proposto di dire?
— C’entrano sì, o discreto lettore.
Perocchè, se visitando il Pian d’Erba, piace a te per avventura fra le cose meglio interessanti salire a que’ venerabili avanzi dell’antico, dove tanta storia di nostra casa si può imparare, e sarà certo fra’ tuoi migliori partiti che ti allegrino il delizioso soggiorno, una delle due vie che vi conduce, transita appunto per la piccola Valle che si denomina dell’Oro; ed io, ponendoti al giorno della pietosa tradizione che ancor ripetesi dalla buona gente della montagna, ho pensato meglio invaghirti a salire per l’erta scabrosa, prendendo quel sentiero che parte da Civate, anzi che dal più agiato viottolo che dalla Croce così detta di Pieve mette fra dirupi e cespugli alla medesima meta.
[257]
L’orrido pittoresco della Valle dell’Oro è del più bello artistico che immaginare si possa. Perchè chiamata dell’Oro, non è presto detto, variando al proposito le sentenze. V’ha chi attribuisce questo nome alle molte piante d’alloro di cui tutta quanta era un tempo disseminata; v’ha chi pensa esistesse un giorno qualche aurifera miniera, ma di traccie non se ne riscontrano; v’ha chi poi lo vorrebbe derivare — e potrebbe essere probabile — dal cognome di alcuna famiglia che là ebbe un giorno a possedere. Ma di siffatte investigazioni non credo possa venirne utile a chichessia e però passo oltre.
Presso al poggio, designato da quei del paese col nome di Barzaguta (balza acuta), si discende verso un torrente, le cui acque nella caduta mettono in movimento mulini e filatoi. Poco dopo ne si para dinanzi una magnifica cascata, quella appunto di che or ti si offre il disegno. Il fondo di questa incantevole scena è costituito da due altissime e smisurate roccie, e le acque, precipitando spumeggianti e rumorose, formano nel letto del torrente un bel bacino. Al piede di esso l’occhio si perde in una gola oscura, attonito dapprima per le dirupate frane e pei pensili massi che sembrano ad ogni istante rovinare, e se mai ti piglia il talento di ascendere al sommo della cascata, una rozza gradinata praticata nella roccia ti agevola la salita.
Oh sì, fra tanto frastuono delle acque cadenti, e fatto maggiore dagli echi che si ripercuotono, l’anima nostra è compresa da un insolito sentimento fra la meraviglia e l’orrore; gli svariati effetti di luce, le tinte ora cariche, ora sfumanti della intera scena, e quelle ombre, [258] che i pittori chiamerebbero portate, e il cupo verde de’ cespugli, e il gruppo degli alberi, e l’enormità de’ macigni, ne ingigantiscono così quelle sensazioni che ognun si sente quasi incatenato al luogo e mal si sa togliersi di colà.
Il geologo poi in quest’orrido della Valle dell’Oro studia uno dei fatti più curiosi della sua scienza; cioè il gran banco madreporico, anzi muraglia di corallo che si stende per tutta la Lombardia, dove mal distinto dalla dolomia bianca e grigia che può dirsi azoica, dove conservando le forme di polipaio.
Valle dell’Oro è pur chiamato quel povero gruppo di capanne, al quale scorge il sentiero che percorre la costa della rupe, e se il cammino scabroso ti ha fatto stanco, una polla di limpida e fresc’acqua colà ritrovi che ti ristora dall’arsura e ti fa cuore a terminare l’aggradevole pellegrinaggio.
[259]
Annone. — La Squadra dei Mauri. — Suello. — Cesana e San Fermo. — Bosisio. — La Chiesa e l’Oratorio — Casa Banfi. — Monumento ad Appiani e Parini. — Uno stregone dei tempi antichi. — La casa del Parini. — Lapide commemorativa. — Onta lavata.
Discendendo dall’altura di Civate, rasentati i laghi d’Oggionno e di Annone, de’ quali il lettore s’è già intrattenuto per averli veduti dalle vette di Galbiate e di Monte Baro, pigliamo la via che mena a Bosisio, chè oggi la nostra escursione è un caro pellegrinaggio alla casa in cui nacque quell’intemerato intelletto di Giuseppe Parini, che fu tanto lume delle italiane lettere e che si recò a sommo di gloria il poter dire di sè:
Vediamo da lungi Annone, che dà nome al lago, ma che non ha importanza speciale, malgrado la bella [260] chiesa che vi sorge su disegno del Bovara, di stile jonico. E ad Annone dicono sia venuto il nome da uno dei trenta duchi longobardi. Se sul Monte Baro e in Civate la tradizione ricorda la presenza in questi luoghi di Desiderio e di Algiso, nulla di più facile che anche un altro duce di loro razza sia qui stato e abbia lasciato a’ posteri memoria di sè in questo paese.
A mano destra, e addossata alla montagna, è quella parte di territorio che si denomina ancora la Squadra dei Mauri, e anche qui la tradizione spiega la denominazione, pretendendo stabilita qui una colonia di Mori... ma in qual tempo? Se ne tolgono d’impaccio questi fabbricatori di storia, rispondendo: al tempo delle invasioni, che io mal saprei definire ancora quando fosse, ignorando davvero che i Mori facessero mai invasioni nelle nostre parti e molto meno in queste. Compresa in tale Squadra è Cesana o San Fermo, come più propriamente si nomina, terra vaghissima e ferace, e che si han più dati per ritenere che avesse un giorno una maggiore importanza.
Poi via trascorriamo Suello, e di contro a Cesana, pria di giungere a Pusiano, volgiamo a manca, e dopo breve cammino, girando pur alquanto intorno al lago di Pusiano, salutiamo Bosisio.
Un dì, e non è molto, era poverissima terra; ora il comune è de’ più ricchi, grazie alle torbiere che si trovano sul suo, e che gli fruttarono e fruttano tuttavia una ingente moneta. Ogni fuoco di questo paese ha diritto ad una parte di torba; nè avviene qui ciò che altrove di queste parti si lamenta, che cioè i nullatenenti e i vagabondi si caccino nell’altrui per i boschi [261] a far legna. E sovrabbonda in tanta quantità la torba, che ne può esser venduta con larghissimo ed annual beneficio.
Tuttavia, malgrado l’antica povertà, non era l’arte nome affatto straniero in Bosisio, se nella sua chiesa parrocchiale ti veniva mostrata come preziosità una tavola dipinta da Gaudenzio Ferrari, una tela di quel più recente ma esimio artista Vitale Sala, di cui vedemmo già a Valmadrera due freschi, ed un’altra del Narducci nell’Oratorio di casa Appiani, architettato dal valente Moraglia, dove era un bellissimo quadro del sullodato Vitale Sala, rappresentante l’Annunciazione di Maria Vergine; e finalmente nella casa del signor Banfi, dove io fui l’ospite benvenuto nel 1845, si trovava che il colto proprietario aveva nel suo grazioso giardino, che digradava al lago di Pusiano, eretto monumento a due illustri che da Bosisio eran partiti a far parlar alto di sè stessi il mondo; ad Andrea Appiani, giustamente chiamato il Pittor delle Grazie, ed a Giuseppe Parini. E siffatta reverenza dimostrava il Banfi quando non s’era per anco da alcuno pensato a mettere pure una pietra commemorativa là dove l’illustre Poeta era nato ed aveva abitato; e su di quel monumento scolpiva i versi di lui, ne’ quali entrambi sono così rammentati, e son questi:
Te di stirpe gentile
E me di casa popolar, cred’io,
Dall’Éupili natio,
Come fortuna variò di stile,
Guidaron gli avi nostri
De la città fra i clamorosi chiostri.
[262]
E noi dall’onde pure,
Dal chiaro cielo e da quell’aere vivo
Seme portammo attivo
Pronto a lavarne da le genti oscure,
Tu Appiani col pennello,
Ed io col plettro seguitando il bello[31].
Dirò di più a chiarire la noncuranza. In quell’occasione mi rammento che, visitato per la prima volta il Pian d’Erba, all’incantevole vista de’ suoi facili colli, de’ suoi ridenti paesi, de’ tranquilli suoi laghi, m’erano venuti spontanei sul labbro i versi del cantore del Giorno, della satira mordace e potente, ma elegante e in guanti gialli, che così questi suoi luoghi salutava, quando, stomacato della vita politica e cittadina, faceva ad essi ritorno:
Colli beati e placidi
Che il vago Éupili mio
Cingete con dolcissimo
Insensibil pendio,
Dal bel rapir mi sento
Che natura vi diè,
Ed esule contento
A voi rivolgo il piè[32].
E allora, trovandomi a Bosisio, andai percorrendo tutto il paese, cercando quale delle umili casette che lo costituivano sarebbe stata quella in cui schiuso aveva gli occhi alla vita il grande poeta; e come che nessuna [263] mi paresse tale da invitarmi a chiedere se quella fosse, una comare, cui finalmente mi rivolsi perchè il mio desiderio facesse pago, incominciò a sbarrarmi gli occhi in faccia, maravigliata dallo intendere il nome di Parini; poi, quasi vergognando ch’io, straniero, fossi di lei più esperto del paese, come se raccogliesse in quel punto tutte le sue memorie, finì col dirmi sbadatamente:
— Sì, sì; era uno stregone dei tempi antichi.
Quindi, crollando il capo, mi significò che di più non avrebbe saputo aggiungervi, e molto meno dove fosse la casa de’ suoi padri.
Povero Parini! Uno stregone!
Pure la natale casetta scoprii finalmente a furia d’inchieste e d’induzioni; nè presi errore, da che due anni dopo, quando il sentimento della italiana rigenerazione parlò potente al cuore di tutti, e cercavamo raffermarci ne’ propositi santi e generosi col rimettere in onore le glorie del paese, e massime quelle che avevano gittato negli animi nostri il germe di essi, nelle opere del loro ingegno a noi lasciate, si impose il nome di Parini alla via dove sorgeva, e su di essa, in una solenne festa, fra un concorso infinito di popolo e di villani che non avevano mai sognato prima chi si fosse e pur allora ne capivano verbo, e fra letture di prose e di versi in onore di lui, fu collocata una lapide che recava sculte le seguenti parole:
A GIUSEPPE PARINI
GLORIA DELL’INGEGNO LOMBARDO
CHE NUOVI SENTIERI APRÌ
ALL’ITALICA POESIA
[264]
E LA FE’ POTENTE INTERPRETE
D’ALTI PENSIERI E DI SDEGNI MAGNANIMI
DERISOR SUBLIME DE’ FIACCHI COSTUMI
BANDITOR SINCERO DELLE VERITÀ PIÙ UTILI
MAESTRO D’UNO STILE PELLEGRINO TEMPERATO
CHE OBBEDISCE AL CONCETTO E GLI CRESCE ENERGIA
ALCUNI ESTIMATORI
PERCHÈ QUI DOVE POVERAMENTE NACQUE
E PRIMA S’ISPIRÒ NEL RISO
DI CIEL SÌ LIETO
ABBIA IL NOME DI LUI PERENNE OSSEQUIO
P. NEL MDCCCXLVII.
L’iscrizione, a mio avviso, avrebbe fatto meglio ad essere più concisa, e ricordar invece il dì in cui il grande cittadino e poeta nasceva. Avrebbe almen giovato a qualche cosa.
Ad ogni modo la generazione presente ha lavata l’onta che Foscolo gittava al volto della città che l’ospitava, ch’egli acremente chiamava ne’ Sepolcri
lasciva
D’evirati cantori allevatrice,
perchè non ombra, non pietra, non parola avesse posto a Parini: Milano, nel suo palazzo di Brera, rizzavagli maestoso monumento, affiggeva memore lapide sulla casa che l’aveva albergato e dava il nome di lui ad una nuova sua via.
[265]
Il lago di Pusiano. — Il primo battello a vapore in Italia. — Un mio processo. — Armi di pietra e palafitte lacustri. — Pusiano. — Villa Conti. — Scene di superstizione. — La Processione del Venerdì Santo. — L’Isola de’ Cipressi. — Il romanzo di Bertolotti.
Se vivo ancor fosse quell’eccellente uomo di Banfi, presso cui, vi dissi, ospitai nel 1845, non rifacendo più la via che ne condusse a Bosisio, dal giardino suo saremmo montati nella barchetta che vi stava legata, per pigliare il largo su questo lieto e tranquillo lago di Pusiano, onde condurci al paese che sta quasi di fronte e che gli diede il nome; ma di lui non resta che la buona memoria in chi lo conobbe d’anima aperta e cortese. Qui s’era ritirato a fruire d’una vita calma, dopo aver assistito a’ burrascosi avvenimenti che chiusero l’êra napoleonica e condussero sciaguratamente in Lombardia l’austriaca dominazione, che le pesò sul collo per quarantacinque anni; qui gli consolava gli estremi giorni l’amore d’una figliuola e qui costei vi soggiorna ora colla corona de’ suoi figliuoli.
Ritorniamo adunque per la strada primitiva. In pochi minuti il lago ci riappare.
[266]
Il suo bacino non è grande siccome un giorno, quando abbracciava tutto quello spazio che segnano da una parte il lago, ora detto d’Oggionno, e dall’altra quello d’Alserio; esso è quanto avanza del vecchio Éupili; ma se ha perduto in vastità, ha guadagnato, a mio credere, in vaghezza. Dall’una sponda corre l’occhio all’altra, e tutti si veggono e contano i paesi che vi seggono in riva e lo circondan dappresso.
È inoltre pescoso, e vi si raccolgono specialmente anguille e lucci, tinche e barbi, arborelle e carpi, e vi si potrebbe ottenere di meglio, se la piscicoltura non fosse tra noi sì poco curata, o se fosse vissuto più a lungo quel Giuseppe Conti, che qui con molto amore la coltivava.
Fu su questo lago che, nel 1820, per la prima volta in Italia fu visto un battello a vapore; ma al sospettoso governo d’allora, a quel governo che giunse a farmi sul serio un processo criminale nel 1855, per perturbazione della pubblica tranquillità contro il nesso politico dell’impero (!), per avere scritto che il finale del terzo atto del Profeta di Meyerbeer era una ladra cosa, essendosi capito ch’io aveva voluto alludere all’inno nazionale austriaco di Haydn, da cui quel finale aveva tolto qualche nota; a quel governo parve che il battello a vapore potesse essere invece qualche macchinazione che coprisse mene di carbonari; e il battello un bel dì fu riportato via.
La scienza ha intorno a questo lago fatto qualche scoperta importante. Da un opuscolo pubblicato da quel dotto naturalista che è Antonio Villa, e che ha per titolo: Gite malacologiche e geologiche nella Brianza e [267] nei dintorni di Lecco, negli Atti della Società italiana di scienze naturali (vol. IV, fasc. 6, 1863); non che dal Fotografo del 2 agosto 1856, in un articolo dei fratelli Antonio e G. B. Villa, rilevai come nella torba di Bosisio venne trovata dal signor Federico Landriani, alla profondità di circa tre metri dalla superficie, una scure riferibile, secondo l’archeologo prof. Biondelli, ai tempi del primo secolo dell’Impero Romano, di buon metallo e ben lavorato; e meglio ancora si rinvennero diverse punte di freccia, dell’epoca dei Galli Celti, di silice, e quindi della più remota antichità, quando cioè ancora non si conosceva l’arte di lavorare in ferro. Freccie di pietra silice si rinvennero anche nelle torbiere del lago, nel luogo detto Comarchia, assieme ad altri arnesi; e l’abate prof. Antonio Stoppani, presso a quest’Isola de’ Cipressi, nello stesso bacino del lago, trovò indizi di palafitte, ciò che potrà fornir lume a chi s’intrattiene intorno alle abitazioni lacustri degli antichi popoli.
A capo del lago siede la terra di Pusiano. Il palazzo che vi si vede d’una architettura secentista, apparteneva ai marchesi Carpani; poi fu comperato dall’Arciduca Ferdinando d’Austria, che di questi luoghi si piaceva e vi veniva a villeggiare; e da ultimo venne alle mani de’ signori Conti, che vi aprirono una capace filanda. Apparteneva ad essi anche il lago, dal quale ho già detto esce il Lambro presso Mojana, che poco prima vi si era intromesso, ed ora è stato acquistato dal Comune di Bosisio.
Altro d’interessante non saprei trovare in Pusiano oltre i suoi bellissimi dintorni, dove non fosse che per [268] segnalare la buona fede e l’ignoranza de’ suoi terrieri sfruttata da’ chiesastri, che alle spalle d’una Teresotta, volgarmente conosciuta sotto il nome di Calimera e d’una sua sorella, Angiolina, che danno a bere d’essere ispirate da Dio, e tenute per sante, le si lasciano catechizzare in piazza e nella parrocchia, e per le quali traggono credenzoni da tante parti a portarvi regali e denaro, che scialano in pranzi ed in gallorie. Qual meraviglia allora che ivi pure si creda alla ciurmeria d’un’altra santocchia, nomata Peppinetta, che fa credere di vivere senza bisogno di nutrimento? Di queste tre, la più astuta è la santa Calimera (la serva del Curato), e come tale è anche la prediletta, ed ogni anno viene, con pubblica solennità, sposata a Gesù Cristo. Ella è poi quella che ha saputo e sa infondere tale fanatismo nelle masse ignoranti, che guai a chi osasse dir male di lei: quello sarebbe un uomo perduto, come lo fu un certo Bosisio, di Morchiuso, che, ad istigazione degli aderenti di quella santa, molti vogliono che sia stato ammazzato in mezzo ad una campagna, quantunque i partigiani della santa andassero, come vanno tuttavia gridando che sia morto di coléra fulminante. Tanto è vero quanto cantò Lucrezio:
Religio peperit scelerosa atque impia facta.
Compirò il quadro della superstizione che qui ha attecchito, riferendo i particolari fornitimi da un mio caro amico della processione del Venerdì Santo, da lui veduta nell’anno 1870, e che ha la somiglianza tutta d’una indecente mascherata.
La processione veniva aperta da un picchetto di [269] guardia nazionale, che a giusto titolo dovrebbe chiamarsi guardia del sepolcro, perocchè all’infuori di questo giorno essa non esista che sui ruoli. — La musica d’Asso, dall’uniforme inglese, dalle spalline di maggiore, dall’elmo polacco e dalla durlindana di dragone, la seguiva facendo risuonare l’aere di mesti concenti e di marcie funebri. — Subito dopo veniva la Confraternita di bianco e rosso vestita, tenendosi in mezzo qual prigioniero un eremita, che, mi si dice, rappresenti S. Miro. — Poi una miriade di angioletti, portanti ciascuno una lunga asta, in cima alla quale vi sono i diversi arnesi della passione, vale a dire, tamburo, dadi, martello, tenaglie, chiodi, corona di spine, spugna, ecc. ecc., insomma una bottega ambulante di giocattoli. — Coperta la faccia di un fitto velo, ed a piedi nudi imbrattati di fango, e di qualche altra cosa, un ex gendarme austriaco faceva da Cireneo, portandosi sulle spalle una pesantissima croce.
Qui faccio una digressione per dire che per avere l’onore di rappresentare il Cireneo e portare la croce, si tiene un’asta pubblica, che in quest’anno subì un forte ribasso, e fruttò alla Santa Bottega soltanto L. 5.20, ultima offerta fatta dall’ex gendarme, mentre l’anno antecedente fu deliberata ad un pizzicagnolo per lire 20.
Ora torniamo alla processione. — Il Cireneo ex gendarme, che un tempo scortava gli altri, quel venerdì era egli scortato da molti Giudei, faccie proibite, dalla barba posticcia, e vestiti alla spagnuola con elmo romano, meno uno che invece dell’elmo ha creduto meglio mettersi un kepì della nostra artiglieria. Alcuni [270] di questi moderni Giudei tenevano le loro lancie rivolte con posa comica, mimica e tragica al Cireneo, nella tema che fuggisse per le campagne col dolce peso dei due travi formanti una croce; ed il rimanente appuntava le proprie lancie contro un uomo tutto vestito di rosso, dai capegli e barba di canapa, dai piedi scalzi trascinantesi una grossa catena, che, se non vado errato, doveva essere tolta poche ore prima dalla greppia di una stalla. Costui raffigurava il Cristo che saliva il Golgota, ma non era il Cristo falegname, bensì un Cristo ciabattino.
Seguiva il Cristo un’altra Confraternita con alla testa S. Carlo in abito vescovile ed armato di pastorale. Alla Confraternita tenevan dietro alcuni vessilli neri, ed il Velo del tempio, portati da uomini vestiti in nero.
Un’altra musica, quella del signor Perego di Cremnago, faceva eco alla prima coi suoi funerei concenti. Intanto i preti esilarati da quella musica intuonavano e cantavano il Vexilla regis prodeunt.
Sotto poi un elegante baldacchino veniva portato da quattro uomini, vestiti alla foggia di sacerdoti pagani, il cadavere di Cristo, di modo che nella stessa processione vi si vedevano due Cristi: vivo l’uno, l’altro morto.
Le tre Marie seguivano la bara, e dietro ad esse si scorgeva un nugolo di Santi, tutti in costume, e tra questi qualcuno di mia conoscenza, cioè, S. Luigi Gonzaga, S. Ambrogio, S. Maria Maddalena, S. Caterina da Siena, S. Margherita da Cortona, ecc. ecc.
Quella però che ha fatto destare maggiore ilarità [271] nel pubblico profano, e che, incredibile dictu, ha fatto ridere la stessa Madonna Assunta che le stava di dietro, fu Santa Rita, la quale sentendosi pungere le tempie dalla corona di spine che cingevale la testa, dimenticava la propria santità, e, come gli altri mortali, mandò acuti lai, infino a che gliela accomodarono per benino ed in modo da non risentirne più dolore.
Chiudevano il corteo tutte le Madonne e gli Angeli d’ogni specie. L’Assunta la vedevi colle braccia alzate ed in atto di volare al cielo. L’Addolorata, con sette pugnali nel petto, teneva lo sguardo rivolto a terra, ed era immersa in profondo dolore. L’Immacolata tutta sorridente mostrava d’essere in un’estasi paradisiaca.
La processione ritornò in chiesa, e poco dopo il Cireneo, il Cristo, i Giudei, gli Angioli, i Santi e le Madonne ridiventarono semplici mortali, contenti di aver dato alla Santa Bottega il loro obolo per aver fatto la loro parte in commedia.
Innanzi a tutte queste giullerie, indegne dell’età presente, d’una cosa almeno si ha diritto di chiedere: e l’autorità intanto che fa?
Era peccato che su queste sponde del lago non vi fossero belle imbarcazioni, onde mai non vi si vedessero sopra signori a diporto. Era appena se si poteva trovare qualche barchetta da pescatore per remigare all’isola de’ Cipressi, che unica sta nel mezzo di esso e che abbiamo eletta per iscopo della presente escursione. A cotale difetto pensò rimediare il Comune di Bosisio, che, volgendo la ricchezza procacciatagli dalla torba a migliorare le proprie sorti, vi stabilì eleganti navicelli che invitano ad ascendervi.
[272]
Voghiamo quindi adesso a questa graziosa isoletta. Non ha che l’estensione di ventiquattro antiche pertiche. Gli alti cipressi e pioppi, che si vedono sorgere come dall’onde, vi vennero piantati verso il 1770 dal proprietario di essa, marchese Molo, onde assunse il nome da quelli alberi, l’Isola de’ Cipressi. Il sullodato signor Giuseppe Conti, che vi fu dopo il proprietario, non son molt’anni ne aveva all’estremità praticato un taglio per istabilirvi un vivajo di pesci, studiosissimo com’era, e come più sopra ricordai, di piscicoltura. Nell’isola, del resto non si vedono ora particolarità maggiori delle ombre amiche che invitano a riposo nelle ore più calde del giorno: frigus captabis opacum, e dell’indistinto piacere che si prova di ritrovarsi in piccol luogo tutto recinto dalle acque.
Da qui tuttavia, Davide Bertolotti, sentimentale scrittore e poeta, immaginò un suo gentile romanzo, che intitolò appunto L’Isola de’ Cipressi.
Il Comune di Bosisio non farebbe, credo io, opera vana ed infeconda, traendo maggior profitto dalla bella isoletta, erigendovi qualche casetta e trattoria. Sarebbe certo attrattiva maggiore a visitarla, sarebbe richiamo pei villeggianti, che ne farebbero meta di passeggiata e di divertimento. Sapere, come adesso si sa, che nell’isola non c’è albergo, a pochi entra in capo di andarvi. Le vaghissime isole del Verbano, perchè fornite di case e di alberghi, sono da tutti frequentate e levate a cielo, come gemme di quelle acque; e perchè non lo potrebbe essere di queste l’Isola de’ Cipressi?
[273]
Corneno. — La Cà di strii. — Villa Besana. — Galliano. — Carella. — Mariaga. — Alpe di Carella. — Il Bel Dosso. — Villa Graziani. — Longone. — Osteria. — La Malpensata. — Penzano. — Bindella. — Villa Galimberti. — Proserpio. — Villa Baroggi. — Inarca.
Or lasciamo la vettura e camminiamo su queste magnifiche alture che seguono dopo Pusiano.
Il primo paese che veggiamo è Corneno. Bella è la sua posizione e con qualche buona casa. Isolata ne sorge una, proprietà dei signori Conti, intorno alla quale corrono le più strambe dicerie. Vuolsi dal volgo che il diavolo vi faccia a fidanza, che s’odan la notte strascico di catene e lamenti; chi ne fornisce una storia, chi l’altra: certo si è che rimase il palazzo, a cui fu appiccicato il nome di Palazzo del diavolo, od anche di Cà di strii, molto tempo senza essere abitato, malgrado la felicissima sua situazione e la vista che vi si gode.
Io raccolsi la tradizione, e ne feci subbietto d’un racconto nella mia opera delle Tradizioni e leggende di Lombardia; epperò, a non copiarmi, rimanderò il lettore a quel mio libro, s’egli ne voglia sapere di più. Anche adesso la Cà di strii non è abitata, ma mi fu [274] detto che i suoi proprietarî abbian di meglio per villeggiare, nè quindi si cerchino di dare una smentita, col soggiornarvi, alle vecchie ed insulse ubbíe del paese. Nella villa Besana, ora proprietà del dottore Strambio, ed un tempo del pittore Andrea Appiani, su d’un camino, in una sala, l’illustre pittore disegnò col carbone Amore che incatena il Tempo colle rose, il qual disegno si conserva tuttavia difeso da cornice.
Segue Galliano, terricciuola ove son case e giardini signorili. Nel grandioso giardino attinente l’ampia casa del milanese Paolo Biffi, notabilità della confetteria e pasticceria, che qui or passa i suoi vecchi giorni, veggonsi vecchie torri, istoriate da Giovanni Biffi nella sua narrazione La Ghita del Carrobio. In molta prossimità di Galliano trovansi i villaggi di Carella e Mariaga, pur onorati di case di villeggiatura. Dietro a questi si distendono ridenti valli intersecate da acque correnti, ed è in mezzo d’una di esse che la sua vita d’artista e di poeta passò qualche tempo quel vivace scrittore che è Antonio Ghislanzoni, togliendo a pigione una villetta, cui veramente poteva dire parva sed apta mihi; e là fui a trovarlo, sempre constatandogli il buon umore e la vena pronta ai motti, ai frizzi, alle piccanti osservazioni. È di là che mandava a Verdi, a Petrella e ad altri maestri i suoi libretti, di là i suoi articoli di critica musicale al giornale di Ricordi; di là i suoi romanzetti scherzevoli che ne han fatto di lui il nostro ameno Paul de Kock.
Sopra queste alte vallate s’alza l’Alpe di Carella, che si può senza molta fatica ascendere e da dove si corre coll’occhio per un piano tutto sparso di paesi e [275] di ville, fino a distinguere la freccia dell’aguglia del Duomo milanese, e più in là tutta la valle del Ticino.
Io invece non abuserò delle gambe del lettore e, fattolo uscire da Galliano a una decina di minuti di cammino, batteremo alla porta del Bel Dosso, alla villeggiatura principesca di Francesco Graziani, il baritono dalla simpaticissima voce, che adoperò a raggranellar un’ingente fortuna, massime cantando per molti anni di seguito a Pietroburgo e Londra, e per la quale potè comperarsi questo superbo ritiro, che prima aveva appartenuto a due miei amici, che morte rapì nel fiore della loro età e delle speranze, voglio dire Giuseppe Galli e l’avvocato Paolo Emilio Beretta. Il Graziani vi spese d’aggiunta un’ingente somma ad abbellirla, a dotarla d’ogni comodità; dirò di più, a fregiare la casa di ricca e preziosa suppellettile, perocchè, fra le altre sale, una ne vidi con mobili intarsiati di malachite e con tavolo tutto di questa pietra; ma il meglio della villa esisteva già, e questo meglio è la sua posizione che la rende superiore a tutte l’altre, è l’essere sulla punta di un promontorio, per il che le è dato di tutte ammirare da un lato le bellezze del bacino dell’Éupili, ossia de’ laghi che già abbiamo veduti, e dall’altro quelle non minori del Pian d’Erba.
Dal Bel Dosso si entra nel paese di Longone, dove qualche tempo fa si trovò un’ara coll’iscrizione: Herculi invicto V. S. L. M; L. Domitius Germanus salvo patrono. Essa fu portata nel giardino della villa Traversi a Desio. Qui a Longone raccomando l’osteria del paese, dove chi cerca appagar l’appetito con cibi casalinghi vi è di certo soddisfattissimo. Spesso l’osteria [276] di Longone è il convegno de’ signori del Pian d’Erba, a colazioni e pranzi, massime se si possa contare su qualche lepre che vi si cucina a perfezione. Più sotto è Bindella con migliore orizzonte, di poco diverso da quello del Bel Dosso, con villa de’ Galimberti. Nel vicino Penzano due altri egregi artisti, i conjugi Agostino Dell’Armi e Luigia Ponti, si procacciarono una comoda villa.
La strada di Longone, che dovremo rimontare per fare una corsa a Canzo ed Asso, ha principio alla Malpensata, dove riesce la strada provinciale che viene da Inverigo, per tripartirsi, procedendosi per un ramo a Pusiano e Lecco, per un altro ad Erba e per il terzo alla Vallassina. Qui presso al ponte della Malpensata si rinvennero sepolcri romani colla marca del figulino R. I. D. e vasi di terra contenenti uno specchio metallico, armille, braccialetti e monete dell’epoca imperiale.
Arrestandoci per questa escursione a Longone, è impossibile che non montiamo al vicino villaggio di Proserpio, dove han villa gli Staurenghi, ora de’ Baroggi. Di qui era l’avv. Pietro Staurenghi, presso il quale crebbi all’avvocatura, e dove più d’una volta ebbi cortese ospitalità.
Facile è correre colla mente a pensare che Proserpio derivi da Proserpina, la Iddia infernale, che gli scrittori dicono avesse qui delubro e culto.
Rammento che il mio maestro ed amico, quando mi ebbe in sua casa, mi condusse alla non lontana Inarca, breve accolta di casolari che riguardano verso il lago Segrino, ma che nondimeno ha un superbo orizzonte.
[277]
Il lago Segrino. — Canzo. — Il Vespetrò. — I Corni. — La fontana del Gajumo. — La cascata della Vallategna. — Il torcitojo Verza. — Scarenna. — La Casa dell’eremita. — Asso. — Lapide antica. — Arte. — La via al Pian del Tivano. — Pagnano, Fraino, Caglio, Gemù. — Il Ponte Oscuro. — Lasnigo. — Le donne della valle. — Le serve. — Onno. — San Carlo e la sua mula.
Lasciato addietro Longone, e mettendoci per la bella e spaziosa via, che da pochi anni fu compiuta, che scorge alla Vallassina, vediamo subito il Segrino e lo rasentiamo in tutta la sua lunghezza, che non è molta. Questi eterni chiaccheroni, che sono gli etimologisti, vorrebbero che il nome venisse a questo lago dal francese chagrin, affanno, quasi che il bacino sia tristo e malinconico. Piacemi rispondere ad essi anzi tutto che non potei mai comprendere per qual ragione si ostinino a dir tristo questo lago. Se non è tutt’all’intorno popolato di villaggi e palazzi, solo a capo del medesimo vedendovisi abitato, non significa per ciò solo che lo si debba condannare. Se in luogo del dosso verde e boscoso, che sta dalla riva opposta a quella che noi percorriamo, sorgessero picchi nudi e [278] ferruginosi, potrebbesi aver ragione; ma quando invece questo bacino è tutt’all’intorno lieto di verzura, quantunque solitario, non può dirsi tale da meritarsi titolo di affannoso. Oltre di ciò, qual bisogno vi sarebbe stato di tôrre a prestanza al linguaggio francese un vocabolo per battezzarlo? Segrino finalmente si legge scritto in documenti antichi assai più della venuta de’ Francesi in Lombardia ai tempi di Carlo VIII, e quindi Segrino sarà un nome come qualunque altro, e se si sottrae diversamente all’interpretazione, segue la sorte della maggior parte degli altri nomi di laghi e di paesi.
Oltre questo lago ci troviamo a capo del bivio in cui si scinde la strada della Vallassina; perocchè vediamo l’altra via che mette a Pontelambro, e che faremo noi pure al ritorno della presente escursione.
Dopo due corte miglia da Longone, ci si affaccia Canzo. È borgata abbastanza grossa, che ha molte case di villeggiatura, sì che in questo tempo di autunno vi si vegga una vera colonia milanese; tanto così che venne eretto un teatro, dove si canta l’opera o si recita la commedia con affluenza di pubblico, e vi si fanno liete feste di ballo. Così popolato è sempre a sera il caffè, come di giorno frequenti sono gli equipaggi che da’ paesi circonvicini traggono a scopo di visita o di passeggiata. Famoso è poi il vespetrò che vi si fabbrica, liquore che arieggia la chartreuse di Grenoble, la quale ci giunge di Francia e che è sì ricerca e gustata.
Succedono, al fianco destro di Canzo, i Corni, acuti picchi altissimi, a metri 1385 sul livello del mare, che [279] a Milano, come già notai, si veggono; ma colla loro nudità non aggiungono tristezza, e solo formano contrasto col resto, che è tutto lussureggiante di vegetazione.
Erano un dì rinomate le saje di Canzo che vi si fabbricavano; poi prevalse la seta, e vi ebbero e vi hanno filande e filatoj i Verza ed i Gavazzi.
Traggono quei del paese, a titolo di divozione, a San Miro, che fu nativo di questo borgo, nella prima domenica di agosto, alla sagra che in onore di questo santo si celebra nel luogo solitario e alpestre che vien detto la Fontana del Gajumo. Come accade in simili circostanze, si merenda colà allegramente e la divozione si muta in un vero divertimento.
Dopo Canzo, seguendo il corso della via che conduce ad Asso, il tuo cuore si esilara subito in questa nuova e vaghissima valle, dove si presenta al manco lato Asso, il non men bello paese da cui prende il nome tutto quell’importante territorio che si appella appunto Vallassina, e che si vede, come scena teatrale, posar sul fianco del burrone entro cui rumoreggia il Lambro, che non vi ha molto lontana la sua scaturigine.
La cascata della Vallategna, balzante a picco da erta rupe, sulla cui vetta fa leggiadramente capolino il grande torcitojo dei signori Verza, spruzza nella sua caduta, colle sue spume minutissime come atomi di polve, a molti passi i viandanti. Altre cascatelle scendono giù dai monti selvosi, che quantunque restringano l’orizzonte, pure non tolgono bellezza alla graziosa valle, i cui facili e verdi declivî si avvivano [280] di grotte e di abituri, di ville e casali, ed è dimezzata dal Lambro che vi scorre. Dall’opposta sponda è Scarenna, sopra la quale vi viene additata la Casa dell’eremita, ove è fama che sul finir del duodecimo secolo vivesse appunto un sant’uomo che s’era dato ad istruire la puerizia e contasse fra i suoi alunni anche quel Miro, che fu poi santo egli pure e che ho mentovato più sopra.
Pochi passi e siamo ad Asso, il cui nome si suol dedurre dal celtico as, significante sorgente. Ebbe, ne’ tempi efferati, castello di cui non esiste che la torre in rovina. Un’altra torre, arnese di guerra, era quella che fu poi convertita in campanile della chiesa prepositurale.
Era Asso una delle Pievi che componevano la Martesana; a’ tempi pagani ebbe culto per Asclepio, nome greco di Esculapio, e forse da Asclepio derivò il nome suo, avendosene dagli antiquarî ad argomento l’iscrizione romana trovata in Vallassina fra Onno e Vassena, e che fu letta così dal dotto archeologo Giovanni Labus
Genio Asclepii
Lucius Plinius
Burrus et F. Plinius
Ternus votum solvunt.
Nel medio evo fu Asso, come tutta la Vallassina, della mensa arcivescovile di Milano. Allo spirare della signoria de’ Visconti ne appare infeudato Facino Cane, celebre capitano di ventura e primo marito della sventuratissima Beatrice di Tenda, poi l’altro capitano [281] Luigi del Verme e via via altri. Ebbe però governo proprio e statuto indipendente sino all’editto 16 maggio 1765, in cui la Vallassina venne incorporata al ducato di Milano.
Visitando Asso, veggasi la prepositurale, dove son dipinti egregiamente i Misteri del rosario, ed è di Giulio Cesare Campi una pala rappresentante l’Annunciazione. Qui pure sonvi signorili famiglie, tra cui i Romagnoli, i Magnocavallo, i Merzario, i Mazza, per non dire di tutti, ecc.
Gli è da Asso per Sormanno e per Rezzago che le allegre comitive, messe insieme dai paesi circonvicini, precedute da fanfare e ribechini, ascendevano, più frequenti in passato, per il piano del Tivano, e correvano a vedere quell’imbuto conosciuto sotto il nome del Buco della Nicolina, dove, provenienti dalle ville del lago di Como, pur salivano per l’opposto versante altre liete brigatelle a convegno concertato alla città, e da cui entrambe non si toglievano che a notte fra lo splendore delle faci resinose, come ho già fatto noto nell’apposita escursione.
Fuori appena di Asso, il pittorico è ancor maggiore; perocchè, oltre le diverse intonazioni risultanti da’ caseggiati civili a’ rustici commisti, oltre le torri ed i villaggi sovrastanti di Pagnano e di Fraino ed i verdi altipiani di Caglio e di Gemù, ti si para subito davanti una scena di bell’effetto nella vista del Ponte Oscuro, che a certa altezza si gitta da un masso all’altro della roccia, su cui corre la via che scorge a Valbrona e sotto cui, tra grossi ciottoli e pietre staccate dalle pareti o rotolate dalle acque, scorre il Lambro, [282] dinanzi al quale sembra la roccia si sia aperta e divisa per aprirgli il passaggio.
A che i pittori e i toristi nostri, domando io, vanno cercando alla Svizzera scene e paesaggi per i loro quadri, per le loro impressioni, se la nostra Lombardia e i monti dell’alta nostra Brianza ponno loro offerirne di solenni e di belle, di svariate, e di ispiratrici egualmente?
A chi volesse deliziarsi di maravigliosi punti di vista; a chi amasse gli erbosi altipiani alternare a’ villaggi, e a’ rugiadosi e impervi sentieri preferisse ampio e regolare cammino, io consiglierei volontieri di eleggere la recente strada che traversa tutta la Vallassina per il corso di ben dieci miglia e riesce a Bellagio, uno de’ più ameni paesi del Lario. Uscita appena dagli anfratti di Asso, quella strada ritorna ampia e comoda per Lasnigo, ove hanno villa i Rusconi ed altri, ed è prosecuzione di quella che dalla Malpensata conduce, per Longone, a Canzo ed Asso.
Visitando la Vallassina, a questa vaghezza di natura inanimata, altre ne troverà della animata il lettore; e senza dire degli uomini d’un ingegno svegliato, industriosi ed ospitali, i quali più spesso cercando fortuna al di fuori e colà eziandio stabilendosi, non crebbero guari fortuna al loro luogo nativo, accennerò delle donne col giudizio che ne reca un non sospetto autore, l’oblato prevosto Vincenzo Mazza di Lasnigo, autore d’una storia manoscritta della Valle, veduta dal Cantù. Esse gli parvero modelli, come di avvenenza, così di costumatezza; sobrie, pudiche, casalinghe, matronali sì da rimovere qualsiasi licenza d’atti [283] e di parole, e le fanciulle sanno all’uopo difendersi cogli zoccoli, con sassi e colle spadine che portano come un’aureola in capo. E poichè e alla città e altrove si ha tanto difetto di buone serventi, il buon prevosto vi fa sapere come le donne della Vallassina sieno ricercate come fantesche, nè v’abbia esempio che una sia stata espulsa da una casa. Non ho voluto dimenticare questa particolarità della Vallassina, perocchè ogni dì più cresca il lamento per la mancanza di buone serventi. Gli aumentati opificî e la corruzione cittadina e campagnola hanno distratto moltissime di queste donne dal mestiere del servire che un dì pareva loro sì profittevole cosa.
Se a riposarsi di tratto in tratto dal cammino avvenga di interrogare quella buona gente alpestre, s’odono storie e tradizioni, leggende e fiabe a illustrazione di castelli e di paesi, di genti e di famiglie; e se non istessi io sull’avviso contro me stesso che di tradizioni e leggende parecchie son già stato narratore, potrei qui cingermi la giornea e ripetere quello che ho appreso nella Vallassina, nè il lettore sarebbe certo sì fortunato di finirla così presto d’esercitar meco la sua pazienza. Non tacerò tuttavia d’accennar ciò che i terrieri non chiamano fiaba o tradizione, ma pretta storia e miracolo. Già toccai alla sfuggita di Onno, terricciuola della Vallassina che siede sul versante del lago di Lecco; or bene raccontasi che quel vigile arcivescovo che fu San Carlo Borromeo, nel visitare tutta la sua diocesi onde conoscerla per l’appunto e recarvi i saggi suoi povvedimenti, percorrendo questi luoghi aspri e montani, qui presso ad Onno, cavalcando [284] una mula, precipitasse con essa dentro un profondo precipizio, ma che per sommo di ventura — essi dicon miracolo — ne uscisse incolume.
Ma io debbo, cortese lettore, qui arrestarmi, nè proseguire nella Vallassina, per non discostarmi troppo dal Pian d’Erba, nei confini del quale deve restringersi il mio libro.
[285]
Val di Giano. — Caslino e suoi cacini. — Mulino S. Marco. — Fabbrica di coltelleria. — Setificî Invernizzi, Castelletti, Prina e Mambretti. — Ademprivo. — Castelmarte. — Ville Bertoglio, Parravicini, Biondelli. — Fu Castelmarte capo della Martesana? — Castrum Martis. — Giunteria archeologica. — Reliquie antiche.
Ritornando per la strada percorsa venendo da Longone, giungendo ora dopo Canzo al bivio che ho già avvertito nella passata escursione, pigliam la via alla mano destra e presto ci saremo introdotti in una valletta amena, che il paesano denomina Val di Giano.
È qui che ci si offre sull’altura a mano destra il paese di Caslino, che ora fa parlare di sè pe’ suoi cacini, e a cui si va per una bella strada, presso al luogo detto Mulino San Marco, dove c’è, oltre un recente filatojo e un mulino, una fabbrica di coltelleria di Dionigi Carpani, che gode assai credito, massime per certi coltelli da cucina.
Caslino ha la sua storia, e il prevosto Carlo Annoni ne dettò una dotta Memoria. Ora vi sono altre filande e filatoj degli Invernizzi, dei Castelletti, Prina e Mambretti. Bella è la vallata erbosa del comune che sta dietro il paese, e dove per una specie di ademprivo, [286] quelli abitanti pascolano le capre del cui latte si fanno i cacini suddetti.
Dalla strada che seguiamo di Canzo, avanzando qualche passo, ci troviamo ai piedi del colle su cui pompeggia Castelmarte.
In attesa che si faccia da Pontelambro la strada più ampia e più comoda, come se ne fa ora iniziatore quell’egregio uomo e rinomato operatore chirurgico che è il dottor cav. Lamberto Parravicini, inerpichiamoci per questo boscoso declivio.
Non lungo è il cammino, e però presto ci troviamo in mezzo al paese.
Dalle ville degli eredi Bertoglio, del dottor Parravicini sullodato, che acquistò il luogo che prima era di don Giulio Ferrario, l’autore del Costume antico e moderno di tutte le nazioni e d’altre opere dotte, non che da quella del ch. archeologo cav. Bernardino Biondelli si può godere il più superbo panorama. Distendesi avanti allo sguardo tutto il Pian d’Erba non solo, ma giù giù la Brianza inferiore co’ suoi mille paesi e ville; di qui il lago d’Alserio, di là quello di Pusiano, poi la lunga linea che segna il corso del Lambro, quindi un confine d’orizzonte che si perde nell’azzurro ondeggiante dei monti, che del resto non è difficile scernere e nominare. Una volta si montava a Castelmarte per ammirare le pitture de’ più rinomati artisti moderni nella villa Bertoglio e la raccolta completa di stampe in quella del Ferrario; ora invece la ragione principale di curiosità è nella villa del Biondelli, ove, fra tante pregevoli opere di pittura, di scoltura e d’incisione, è degno d’osservazione un gabinetto tutto di leggiadrie e lavori chinesi.
[287]
L’amore che a questi luoghi indusse il dottor cav. Parravicini a far sua la villa che fu del Ferrario, fa credere che la ridurrà a quella proprietà e comodità dalla quale s’era venuta discostando per l’abbandono in cui per tant’anni s’era da eredi e da acquirenti lasciata.
In quanto al paese, che dire? Dell’antico non avrei a ripetere che ciò che sembra una favola, perchè nulla nulla si ha che autorizzi a crederla una verità, che Castelmarte, cioè, sia stato il capoluogo della Martesana, che si sa comprendere molte pievi. Chi lo affermò non lo provò, nè mi fermerò oltre su questa maggiore importanza che a questa minima terra si vorrebbe aggiungere, cui solo dal nome (Castrum Martis) puossi a maggior ragione arguire che fosse un dì una rôcca e che vi avesse culto speciale Marte, il Dio della guerra. La sua eccelsa posizione rendevala propria a vedetta militare ed a luogo di difesa.
Quanto piglierebbesi volontieri per le orecchie quell’inventore di fatti e glorie storiche, che, cancellando l’iscrizione della pietra che si vede incastrata nel muro esterno della parte posteriore della chiesa, e che forse un giorno avrà coperto una sepoltura, vi sostituì la seguente menzogna:
D. O. M.
Ugone Franc. Functo
Esecrandi hostis
Aerumnis Ecclesiæ
Ineundo bello
Hierosolyma red.
Ucitur jam Nicea
Nicomedia Antiochia
Bisantio Vanei Fin.
Boemon Tane. Bald.
[288]
Redeun. Trand. com.
Goffredus regens
Palestina gloria
Onusto mortuo in
Sanguine patriæ
Ossibus restitutis
Ubaldo Prinæ
Duci fido socio
Rinaldo Estensi
Ferrariensi principi.
M
È facile accorgersi dal dirsi l’Ubaldo Prina fido compagno del Rinaldo da Casa d’Este, personaggio imaginario della Gerusalemme liberata del Tasso, come anche esso Ubaldo sia figlio della fantasia e della boria di qualche Prina, de’ quali abbondano questi paesi, e che a costui sia entrato il matto pensiero di giuntare gli archeologi dell’avvenire e farsene beffa, per altro non di buon genere.
Piuttosto segnalerò l’esistenza di altri avanzi antichi incastrati nei muri esterni della detta chiesa parrocchiale, fra cui, sopra la porta interna del campanile, un leone in bassorilievo e due tirsi per istipiti di essa porta, poi nell’alto del campanile un busto di donna frammezzo a due d’uomini, con sotto alcune parole che si lessero Ma.... conisi maximus e che appajono di colore oscuro.
Visto Castelmarte, fra le case Bertoglio e Parravicini evvi una stradicciuola che ci porta ad una stradetta o scala di ben quattrocento scaglioni a più riparti, per i quali, a guadagno di tempo, mettiamoci noi per condurci a Mazonio e Ponte, cui è destinata la ventura nostra escursione.
[289]
Mazonio. — La sua chiesa — Il pittor Ferrabini. — La Fusina. — Filatoio Ohli. — Zocco Romano. — Zocco Battista. — La Bistonda. — L’annegato. — Pontelambro. — Case Guaita e Carpani. — Una lapide nel Camposanto. — Filatojo Bressi. — Villa Matilde. — La Plejade de’ poeti politici moderni, sonetti. — Affresco luinesco distrutto. — Villa Carpani. — Lezza. — Carpesino. — Arcellasco. — Resica. — Filatoj Ronchetti e Mambretti. — Brugora.
Scesi i quattrocento gradini della scala di Castelmarte, eccoci sulla via che ne adduce a Mazonio, gruppo di quattro case da contadini, a capo delle quali è la chiesa della parrocchia, che comprende, oltre Mazonio, Ponte, Lezza e Carpesino.
La chiesa è bella, architettata da Simone Cantoni, sebbene non abbia ancora compiuta la facciata. Non ha quadri di valore, dove eccettui una tela del milanese Giuseppe Sogni raffigurante Sant’Anna. I freschi laterali all’altare sarebbero stati rinnovati da Pietro Ferrabini da Lodi, prospettico e frescante eccellente della scuola del celebre Sanquirico; ma mentre attendeva a disegnarne i cartoni e ad un tempo frescava la chiesa a Rancio di Lecco, cadeva da un ponte eretto nella chiesa, colpito da apoplessia. La posizione della [290] chiesa di Ponte è piuttosto alta, e dal suo piazzaletto si ha un’allegra vista. Da questo si discende per una lunga scalea cordonata. Volgendo a destra, si va a Caslino, incominciando la via a montare.
La Fusina è un cascinale, ove è cartiera, molino e torchio, che si presenta da questa parte dopo una casa incompiuta che siede su d’una specie di dosso, che sarebbe buon sito a casa di campagna, se non fosse signoreggiata dal vento, ma che non toglie sia nomata Bel Dosso. Fuor del cascinale, il Lambro ha il suo letto sassoso, e il più spesso con poc’acqua, sì che si passa a guado, tutt’al più facendo appoggio al piede di qualche ciottolo più grosso.
È qui che dirompendosi il letto del torrente nella roccia del suolo lascia scoperto il fondo granitico, e l’acqua, raccogliendosi in un canale, va più rapida a mettere in movimento il bello stabilimento di filatura di seta del signor Ohli, condotto con tutta l’intelligenza e proprietà d’un vero prussiano, com’egli è. Questo punto chiamasi il Zocco Romano; ma perchè così si chiami non lo chiedete: nè io, nè quei del paese ve lo sapremmo dire. Certo è di una sua propria alpestre bellezza il luogo. Varcato il Lambro, s’entra come in una selva, dove, a mano manca, da un dirupo scende lungo la nuda roccia una vena sottile d’acqua che forma bacino, d’onde esce un rivolo, e il romantico sito è designato col poco romantico nome di Zocco Battista. Migliore è la cascata che a qualche centinaio di passi di distanza, a mano destra, si precipita da un’altezza di forse una sessantina di metri dentro un bacino assai più vasto e profondo e che s’incaverna di [291] sotto il masso, e vien detta la Bistonda. Poetico è il ritrovo e quasi incamerata appare la cascata, e il raggio di sole che vi penetra vi si rifrange bellamente. Narrasi d’un garzone che venuto a bagnarsi in quest’acqua freschissima, inoltrando di troppo, vi sarebbe perito. Un poeta sentimentale vi troverebbe il soggetto d’un amore di Ondina, cui il nuzial talamo sarebbero state le liane della roccia galleggianti sulla superficie del limpido laghetto.
Tutto questo tratto solitario che s’addossa al monte, alla metà del quale corre l’alpestre via che da Caslino guida a Pontelambro, fiancheggiata da un rigagnolo che lascia parte delle sue linfe acciò si gittino a dar vaghezza al paesaggio in spumeggianti cascate, è d’una silvestre bellezza, e le ombre che presta giovano d’assai nella estiva calura.
Or ritorneremo sui nostri passi, e dalla scalea della chiesa volgiamo all’opposto lato che or percorremmo per entrare in Ponte. A distinguerlo da Ponte di Valtellina gli si aggiunse il nome del fiume sulla cui sponda siede e che qui lo attraversa con un ponte, da cui certo il paese si nominò, e che è di un bello e ardito arco ristaurato in questi ultimi tempi, rendendosene più facile l’accesso col diminuirne la pendenza verso il paese; il quale va ognor più allargando la sua via principale che gli corre in mezzo, a scemare i pericoli de’ rotanti nello scambio ed a rinsanire ognor più le abitazioni. Continuandosi nelle migliorie, di cui vuol darsi lode al già suo sindaco, il cav. Giuseppe Guaita, che per esse affrontò ben anco l’impopolarità, è a sperare che sparisca la brutta fama guadagnatasi [292] dal paese, che passa per essere copioso di gozzuti, che per altro io non vidi mai.
Oltre la casa del predetto signor Guaita, ve n’ha pure altra signorile del signor Cesare Carpani, al quale molto è debitore il paese per aver concesso che da’ suoi fondi si derivasse l’acqua eccellente della quale è ora abbondevolmente fornito; ed altra casa della signora Erminia Carpani. Dalla prima si gode il prospetto severo della vallata di Caslino, degna dello studio e del pennello d’un artista. Qui infatti venivano negli anni scorsi e lo Stefani e il De Albertis e il Castoldi, che nell’autunno del passato 1871 vi perdette la buona e affettuosa moglie. Nel camposanto vi fu da lui collocato il monumento, pel quale io dettai, a memoria della egregia donna, la seguente iscrizione:
A Giovanna Castoldi-Villa
Che dalla natia Milano
Venuta invano a chiedere
Alla purezza di questo aere
I consueti conforti
Vi moriva addì XVI ottobre MDCCCLXXI
Il marito Guglielmo Castoldi pittore
E i giovanetti figli Romeo e Cesare
Seco portando ovunque
La santa memoria di sue miti virtù
Qui
Dove ne deposero inconsolabili le spoglie
P. Q. P.
Presso il ponte e lungo il fiume sorge lo stabilimento a filatojo di seta già del Bonsignori, ora del Bressi; e a notte, allorquando vi si lavora, quelle tante finestre illuminate in quell’avvallamento in cui si trova [293] servono di fantastico effetto alla villa Carpani ed alla villa Matilde, che stanno sulla sponda opposta, le quali s’uniscono ai voti delle case Cesare Carpani e Guaita, perchè il camino del vapore venga alzato e sia tolto l’incomodo fumo e il puzzo che in densa colonna si svolgono da esso.
Nella primavera del 1863 io era ospite del signor Carlo Carpani, e nel passare questo ponte, rivolgendomi ad ammirare la pittoresca scena del Lambro dalla parte appunto di Caslino, meravigliavo come mai nessuno avesse mai pensato a tramutare in villa il brutto casolare che s’ascondeva tra i peschi e mille altre piante; perocchè la postura fosse fra le più invidiabili, essendo su facile poggio, avente a ridosso la montagna boscosa che gli serviva di sfondo magnifico, e al piede gli si sprofondava il Lambro col più pittoresco effetto; e sì mi invaghii dell’idea, che in breve ora ne conchiusi per me l’acquisto, e nel successivo anno s’elevava già su quell’eminenza la piccola mia villa, cui, in omaggio alla mia sposa, imponevo il nome di villa Matilde.
Perdonerà il lettore, se l’affetto ch’io porto a questo loghicciuolo, al quale ebbi la presunzione d’essere io medesimo architetto, mi trasse qui a fornirgli il riscontro di sua veduta; nè poi, permettendo ch’io dica dell’opera mia, concederà che ne parli, togliendo alcuni brani da un’appendice a stampa del giornale La Fama, di quel mio dotto e dilettissimo amico che è Pietro Cominazzi, e che egli riprodusse a parte nell’accompagnarmi sette sonetti ad illustrazione di altrettanti medaglioni di marmo de’ quali decorai, per un mio concetto patriottico e letterario ad un tempo, la terrena sala.
[294]
“E poichè parlasi del Pian d’Erba non vuole chi traduce[33] lasciarsi sfuggire il destro di ricordare la Villa Matilde, proprietà dello scrittore di queste lettere, un Casino Svizzero che, quasi grazioso nido d’augelli, si addossa al monte di San Salvatore non lungi dalle scaturigini del Lambro e sovrasta al popoloso ed industre borgo di Ponte. Coll’intuizione del poeta, il Curti scoperse quel sito, sebbene nascosto tra fittissime piante, e coll’ingegno dell’artista architetto il cangiò da umile abituro in leggiadra dimora, non angusta, ma comodissima, sebbene ristretta, togliendo ai massi della montagna lo spazio che facea d’uopo ad ampliarla ed a compierne la salita ed il giardino. L’amore alle arti, che il guidò nell’opera bella e sagace, e diresse ogni cosa dalle bisogne più ricercate alle più umili, il trasse ad arricchire l’amenissimo soggiorno di squisiti dipinti e di pregiate scolture, sette delle quali, a bella posta trattate in medaglioni con cui adornar si piacque un’ampia sala, recano, effigiate dallo scalpello del Tantardini, del Magni e del Buzzi-Leone, le sembianze dell’Alfieri, del Monti, del Foscolo, del Parini, del Niccolini, del Leopardi e del Giusti; oltre un bel gruppo di Giovanni Cabialia, cresciuto alla scuola di P. Marchesi. Una copiosa biblioteca conforta, nei riposi del corpo, lo spirito del Poeta, lo ristora delle assidue ed onorate fatiche del Foro e del Parlamento, e giova a rinvigorire la memoria dell’erudito, che da quel suo [295] tranquillo e beato asilo scopre ne’ villaggi circostanti le grandi orme del Popolo Re. Fra i molti dipinti primeggiano un Salvator Rosa, un Maratti ed un Poussin, e recano fede del buon gusto e dell’amore del Curti allo stile classico ed immortale, e fra le opere moderne ha i primi onori un bel ritratto di donna, di Cesare Poggi e una bella tela del Castoldi, testè ammirata alla pubblica mostra nel Palazzo di Brera, nella quale si raccoglie e compenetra il bello per arte e per natura, esternamente visibile, della villa che abbiamo in guisa rapida e succinta imperfettamente descritta.„
Più tardi, cioè nell’agosto 1870, il medesimo Cominazzi, regalandomi d’una sua pubblicazione Plejade dei Poeti Politici Italiani moderni, medaglioni in marmo nella villa Matilde[34], ristampando la lettera suddetta, vi soggiungeva:
“Ora risalutando la villa e le sembianze dei Poeti, Plejade gloriosa da te riunita a ricordo di quegli illustri che fecero famosa ai nostri giorni o poco addietro nel politico arringo l’età che viviamo, pensai di tributare a ciascheduno di loro, col mio povero verso, l’omaggio di chi sente e non dimentica,
VITTORIO ALFIERI.
Dello scultore cav. Pietro Magni.
Onta e sprezzo a colui che te maestro,
Te non saluta libero poeta,
E nell’opra del tuo terribil estro
L’ingegno reverente non accheta!
[296]
Tu per cammino al cieco volgo alpestro
Traevi ardito a generosa meta,
E noi guidavi, tu vigile e destro,
Al raggio singolar del tuo Pianeta:
Di Libertà il Pianeta, e di quel lume,
— Fiaccola ai vivi, eterna gloria ai morti, —
Inconsumabil fiamma è il tuo volume.
Or che stupir se Libertà traligna
Quando Italia, non più popol di forti,
Al suo grande Astigian fatta è matrigna!
GIUSEPPE PARINI.
Dello stesso.
A te del vizio correttor sagace,
Gentil cantor del nobile Mattino,
Cui diede amico il Ciel del Venosino
Arguzia, grazia, fantasia ferace;
A te la moda, petulante, audace,
Fronda non tolse dell’allôr divino;
Chè fra l’ira di parte è tuo destino
Agli avversi vessilli intimar pace.
Tu l’aureo stil, le immagini venuste
Chiedi al passato e del saver la fonte,
Chiedi alla nuova età le idee robuste.
Così d’Arte sovrana il magistero
Stringe, di tempo e d’uom sfidando l’onte,
In connubio immortale il Bello e il Vero.
VINCENZO MONTI.
Dello scultore cav. Antonio Tantardini.
Solo una volta il vidi, e ancor mi suona
Dentro la mente quella voce amica:
Non può l’età, che pur nulla perdona,
La sacra cancellar memoria antica:
[297]
Che splendida risorge e par mi dica
Nell’immagine sua: “Fa core e tuona
Contro una gente, che al ben far nimica,
Coll’insulto e l’oblio mi guiderdona.
Me cantor di Prometeo e di Bassville,
Redivivo Allighier me plaudía Roma,
Chè in quel Sol fisse io primo ho le pupille.
Per me, per me nell’italo idïoma
Men famosa non è l’ira d’Achille....
Or si nieghi l’alloro alla mia chioma!„
UGO FOSCOLO.
Dello scultore Luigi Buzzi-Leone.
Spirto inquieto, indomito, iracondo,
Dei mali altrui più che de’ tuoi profeta,
Disdegnoso degli uomini, profondo
Critico e pensator, divin poeta:
Ond’è che il verso, onde il tuo stil fecondo
D’una tant’aura popolar si allieta?
Ond’è che tu, forse ad altrui secondo,
Della gloria primier tocchi la meta?
Libertà e Patria, che un amor congiunse,
— E di lor sole poche menti han sazie, —
Le magnanime idee t’ebber dischiuse.
Quando sull’urna tua scrisser le Muse:
“Al Cantor de’ Sepolcri e delle Grazie,„ —
“Alla Fede immutata„ Italia aggiunse.
GIAN. BATT. NICCOLINI.
Dello scultore cav. Antonio Tantardini.
Veglio, che pensi? Dal sembiante austero
Quanta spirar profetic’aura io miro,
L’aura che un tempo all’italo deliro
L’altrui scoverse menzogner pensiero?
[298]
“Non credete a costei![35] Sogna l’impero,
Sogna e cova nel petto onta e raggiro:
A Libertà, dei Popoli sospiro,
Può il varco aprir la cattedra di Piero?„
E il ver dicevi, o generoso Vate;
Colei tradiva, e lo stranier ribaldo
Ribadia le catene a Libertate.
Col verso intanto vigoroso e caldo
— Tremendo esempio alla più tarda etate —
Tu evocavi la grande ombra di Arnaldo.
GIACOMO LEOPARDI.
Del medesimo.
Sofo e Poeta, Te l’Italia inchina
Sublime ingegno, e non bugiarda fama
Di tre favelle imperador ti chiama,
E tre corone al tuo capo destina.
Di Libertà, che indocile si ostina
Spezzare i ceppi della patria grama,
Svegli nei cor la generosa brama
Colla splendida tua mente indovina.
Ecco, libera Italia, ed i nepoti
Alzare i marmi al Ghibellin sdegnoso,
Che scopria del futuro i mondi ignoti.
Ma l’opra è monca... e Tu dal tuo riposo
Sorgi e un inerte popolo riscuoti,
Ad osar pronto ed a compir ritroso.
GIUSEPPE GIUSTI.
Dello scultore cav. P. Magni.
D’Archiloco lo strale e d’Aristarco
Il flagello tu vibri acre, temuto,
E collo stil sprezzatamente arguto
Facile t’apri agli intelletti il varco.
[299]
Se il colpo aggiusta l’infallibil arco,
Punge e vellica a un tempo il ferro acuto,
Chè tu mai non obblii, prudente e astuto,
D’ammonir dilettando il doppio incarco.
Come, o Cantor di Gingillino, il verso,
Che dal semplice trae forma e vaghezza,
Nella mente s’addentra e vi si chiude!
Tal che il tuo dir, sì dall’altrui diverso,
Più volontier s’ascolta, e più s’apprezza,
Quanto si mostra men, la sua virtude.
Su Ponte, sotto l’arco presso la casa de’ Bonsignori, ora Bressi, eravi un fresco, riconosciuto come indubbiamente di Bernardino Luini; ma con imperdonabile incuria di tutti, abbandonato alle ingiurie del tempo e delle stagioni, in questi ultimi anni deperì e si scrostò talmente, che l’ultimo resto, fattovi sparire dal signor Bressi, non gli può essere ascritto a colpa.
Ora non lasceremo Pontelambro senza ascendere la vicina e magnifica villa del signor Luigi Carpani, che l’eredò dal padre Carlo, e che fu già architettata dal Moraglia, con giardino eseguito su disegno di quel grande prospettico che fu Alessandro Sanquirico.
Vi precede come una specie di parco, che le aggiunge grandiosità, con ampio viale fiancheggiato di alti alberi e roseti e tuje, e pel quale si monta in carrozza alla casa. In essa poi vi sono pregevoli quadri d’animali, del Londonio; qualche buon Fiammingo; due battaglie, del Borgognone; una tela d’Arienti ed una del Migliara. Recentemente il suo attuale proprietario vi recò altri pregevolissimi dipinti di scuole antiche, come lo Sposalizio di S. Caterina col Bambino, del Padovanino; una tavola di Cima da Conegliano [300] rappresentante S. Giovanni Battista e S. Pietro Martire; una figura veneziana, di Gentile Bellini; quattro quadri di Santi Benedettini, di Daniele Crespi, e due tele di Brill, una testa del Velasquez, ecc. ecc. — Dallo spiazzo avanti la casa si ha una superba vista del Pian d’Erba.
Uscendo dalla villa Carpani, in due passi s’è al paesello di Lezza, dove era un tempo un convento di Serviti, che il tennero dal 1508 al 1510 e che ora è abbandonato al nitro che ne invade i bei sotterranei. La piscina che vi fu eretta e coperta di portico, raccoglie l’acqua fresca e salubre che vi scende dal monte sovrastante.
Lezza ha estremo bisogno di imitare Pontelambro e di dar mano al piccone ed al martello e allargare la sua unica via, così angusta da passarvi appena una carrozza, e causa che i diretti per la Vallassina abbandonassero affatto questa parte ed eleggessero esclusivamente la strada di Longone.
Oltre Lezza, al di là del Lambro, siede Carpesino, che taluni presumono tragga il nome da Carpe sinum, piglia il porto; e se ciò fosse, sarebbe memoria che sin qui si estendesse l’Éupili. Vi hanno ville i Nava e i Caldara; più su vi è Brugora come sul ciglio di un pendío, e per istrade praticate fra’ boschi si va a Proserpio e Longone, che noi già abbiamo conosciuto; mentre progredendo per la via che qui ne condusse, si trova Arcellasco, poi la Resica, ove è un filatojo già de’ Carpani di Ponte, ora dei fratelli Ronchetti; e un altro dei Mambretti; e finalmente si giugne al ponte della Malpensata.
[301]
I Geritt. — Mornico. — Crevenna. — Ville Bressi e Genolini. — Il torrente Bova. — La dara. — San Salvatore. — Il convento. — Il signor Boselli. — Giovanni Biffi. — Il tronco mellifero. — La villa Righetti.
Da Lezza, per una via ampia sì ma acclive e che mano mano si ascende scopre miglior orizzonte, perchè rivela da una parte il lago di Pusiano e dall’altra quello d’Alserio, e con essi i loro vicini paesi, si arriva a Mornico, villaggio che si confonde con quel di Crevenna, sì che il nome del primo, più che sulla pietra miliare, non è ripetuto da alcuno.
A mezzo per altro di quest’ampia via dove si volge, formando angolo, s’apre una tal vista, che chi vi avesse a fabbricare una casa vi troverebbe certo a deliziare lo sguardo.
Invece meno accorti speculatori, nel sottoposto vallone, vi eressero casini, tra cui quello detto dei Gerini (Geritt), nel quale già prendeva riposo dalle teatrali fatiche il tenore di bella fama Bulterini, e da qualche anno quella esimia artista soprano, che è la signora [302] Enrichetta Berini e il di lei marito Osmondo Meini, basso cantante di egregia riputazione. In compenso della limitata vista, vi si gode della piena libertà, perchè fuor dell’accesso e dello sguardo comune.
In Crevenna vi sono le ville dei signori Bressi e dei Genolini, e presso il paese si dirupa in profondo vallone il torrente Bova, che poi, quando mena le sue acque tumultuose, le gitta nel Lambro poco disotto a Carpesino.
Nella villa de’ Genolini, quando apparteneva ai signori Fontana, traeva frequente ospite amatissimo quel gentile scrittore e poeta, che ognun conosce in Giulio Carcano, e quivi ispiravasi egli ad inni leggiadri, de’ quali alcun breve saggio reca il presente mio libro.
Sul piazzale della chiesa parrocchiale s’apre la via che guida a San Salvatore. Quantunque essa sia abbastanza erta, pure è ampia e tale da potersi valere della dara, specie di veicolo primitivo trascinato da’ buoi, di che i proprietarî delle ville che vi sono a quell’altezza si valgono bene spesso.
Merita di salire a San Salvatore, che, stando al piano vedesi poggiare a mezzo la montagna, cui dà il nome, come un nido di aquile.
Quando si è giunti colà, si trova soddisfatti, perchè dal viale che sta innanzi al caseggiato si ha uno stupendo panorama, tale da far riscontro alla cima di Galbiate che gli sta di fronte sull’ultimo confine del bacino dell’Éupili antico.
Pervenuto a quell’altezza, al cospetto di sì maravigliosa natura, a voi, come già a me, correrebbero al labbro i versi del buon Parini:
[303]
Oh beato terreno,
Del vago Éupili mio,
Ecco alfin nel tuo seno
M’accogli; e del natio
Aëre mi circondi,
E il petto avido inondi![36]
San Salvatore è un convento che già fu de’ Cappuccini, e che dalla loro soppressione fu tramutato in villeggiatura. L’ebbe il signor Boselli, rinomato istitutore di Milano, che qui conduceva i suoi convittori a ritemprare la salute, nelle vacanze autunnali, coll’aere puro che vi regna; ma sorvenuto il 1848, nelle memorande cinque giornate, caduto vittima del piombo austriaco, la villa venne dalle leggiadrissime sue figlie tenuta.
Visitandola, più d’una volta vi trovai, come vi trovano tutti, il più grazioso ricevimento dalla gentilissima signora Irene Boselli, moglie a quel colto scrittore che è Giovanni Biffi, l’autore della Ghita del Carrobio e del Prina, il quale una volta mi fu anche cicerone del luogo, e mi mostrò parte a parte ogni sala, ogni cella, e la chiesa, a cui traggono i devoti di Crevenna in certe solennità, e sulla quale, non saprei con quanto diritto, spiega il Comune pretesa ab immemorabili, additandomi la stanza dove venne ospitato San Carlo Borromeo e i mobili da lui usati, e via via l’orto, il cascinale e il viale che poi mette al sentiero che percorre la montagna fino a Caslino. Quel giorno, sorridendo, dopo avermi condotto presso un gran tronco [304] d’albero che giaceva in terra, mi ripeteva i versi del Manzoni:
Stillano miele i tronchi:
Ove copriano i bronchi,
Ivi germoglia il fior;
ed accennando a quel tronco abbattuto, dicevami come il dì prima avesse trovato essere stato tutto cavo e pieno del più eletto miele, che estraeva in due ben capaci recipienti. Da qui egli poi muoveva, infaticabile Nembrod, a cacciar lepri pei monti, delle quali prese frequenti fa parte agli amici.
Il convento di San Salvatore è ora esclusiva proprietà della signora Boselli-Righetti, figliuola al sullodato istitutore milanese.
Le comitive allegre ed instancabili, a San Salvatore non fanno spesso che una prima sosta; perocchè si dirigano sovente dopo per aspro sentiero al Buco del Piombo, cui ho riservata la ventura escursione, o alla Colma, che altro non è che il vertice del monte, dal quale è dato di spaziare per gli opposti versanti; e lo sguardo, signore da una parte del Pian d’Erba e della Brianza, dall’altra segue tutta la linea non meno superba del lago di Como. I coraggiosi son molti, e fra questi non mancano mai le gentili signore.
[305]
La strada. — Il Buco del Piombo. — Onde il nome? — Aneddoto. — Esterno. — Scopo. — Interno. — Iscrizione. — Concorso di gente. — I versi di Torti.
E noi, poichè siamo già a San Salvatore, continuiamo la via pel Buco del Piombo. È lunga, è aspra, ma retrocedere per pigliar l’altra dell’opposto ciglione del monte non ne pare conveniente.
È però cammino ameno e pittoresco, e se i piedi faticano, lo sguardo si diverte e gode.
Sorpassiamo gli incidenti del cammino, ed eccoci di sotto al Buco del Piombo.
Anni addietro abbisognava di certo coraggio per inerpicarsi fino al punto, dal quale, per mezzo d’una scala a mano, si poteva penetrare nell’antro; ma dopo che tutte queste Alpi, come le chiamano quei del paese, vennero in proprietà del conte Turati, che su di esse vi stabilì una razza di cavalli, la bisogna è mutata: l’accesso è reso più praticabile e comodo.
Non creda il lettore che la caverna per la quale entriamo tenga fede al suo nome; traccia di piombo [306] non vi si riscontra, nè pare vi sia stato mai; non diamo però le spese al cervello per indovinarne la ragion del nome; vi chiaccherarono intorno e scrissero assai e assai, ed un costrutto non se n’è per anco cavato. Narrasi anzi, a tale proposito, un aneddoto. Nel vicino convento de’ Cappuccini di San Salvatore, che abbiamo testè veduto, nella biblioteca del chiostro, stava un volume legato, sul cui dosso leggevasi il titolo: Origine del Buco del Piombo. La mano d’ogni visitatore correva a togliere il volume dallo scaffale, curioso di leggervi una tale origine; ma ne rimaneva scornato: il volume non era che un pezzo di legno foggiato a libro, fratesco scherzo, del quale si trova il riscontro in Venezia ai Frari, dove è consimile volume lavorato dal celebre Brustolon.
Sull’ingresso dell’antro veggonsi avanzi di muraglie e d’arpioni, onde s’ha a credere che vi fossero applicate porte e che però vi abitasse gente. Serviva a vedetta militare od a presidio? era rifugio di predoni o di banditi? ricoveravan qui, com’altri presumono, i Longobardi cacciati dall’ira de’ Franchi? Non v’è memoria o scritto che il dica. L’atrio che sarebbe stata la parte abitabile, è spazioso: ha la larghezza di metri 38, l’altezza di 42 e la lunghezza di 55, ed è sempre qui che le brigate che vi montano si rifocillano colle provvigioni di bocca mandate innanzi.
Ma la caverna si interna e sprofonda per un vano quasi continuo della larghezza di metri nove e dell’altezza di otto, e vi si può camminare per circa 188 metri coll’aiuto della luce del giorno; più avanti si va, si va accendendo qualche torcia, e dopo 18 metri di [307] cammino, si giunge a un punto dove a destra s’apre altra caverna larga circa metri 1,30, ed avanzando per una trentina d’altri metri, leggesi una lapide che vi fu messa, del tenore seguente:
S. A. I. il Princ. Raineri Vicerè
Consigliere De-Capitani
Ciambellano conte Paar.
Gli 8 maggio 1819.
Altri si spinsero più in là; trovarono che lo speco ora abbassavasi, ora rialzavasi; che acque vi correvano in ruscelli o formavano pozze; finchè non parve andare più avanti, forse essendo anche ciò pericoloso.
Ho già detto a suo luogo come vi abbia chi opini che questa caverna vada e s’inoltri fin presso la fonte Pliniana del lago di Como; ma non sono che pure supposizioni, alle quali nulla porge fondamento.
Sotto dell’antro, o Buco del Piombo, corre il torrente Bova, per mezzo a un letto franato e fra roccie, che ne fan quasi un orrido d’artistico effetto; ma pur di questo torrente ho parlato nella passata escursione.
La curiosità chiama moltissimi visitatori al Buco del Piombo; dirò di più: non v’ha villeggiante o forestiero che sia venuto nel Pian d’Erba, il quale non l’abbia una volta almeno fatto scopo di una sua pellegrinazione.
Così lo ricordava il Torti in que’ versi che dal Pian d’Erba dettava:
O selvose montagne, o gioghi erbosi,
O di lontan sovreminenti al verde
Cornuti massi, o dolce aere vitale,
O dal sol di settembre illuminate
[308]
Felici rive, umili poggi e sparsi
Casali e ville, e pascoli e vigneti
Dell’Éupili ridente; o vasto speco
Di nome senza origine, su in alto
A mezzo monte dalle curve strade
Per gran paese riveduto sempre;
O collinetta sovra l’altre amica
Ov’io sedeva a contemplar la mesta
Valle del mio Segrin; voi già mia prima
Delizia e voluttà, di tutto l’anno
Speme e pensier...
Oh! veramente son questi luoghi tali da ispirare e da accendere gli estri del poeta; nè vi fu amico delle Muse che a queste delizie del Pian d’Erba traendo, non se ne sia ispirato, non ne abbia poi ne’ carmi espresse le soavi dolcezze.
[309]
La villa Amalia. — Guido Carpano e il convento di S. Maria degli Angeli. — L’avv. Rocco Marliani. — Il palazzo, il giardino e il bosco. — Il monumento a Parini. — Monti e Foscolo ospiti. — Episodio della Mascheroniana. — La torre.
Ridiscesi a Crevenna, proseguiamo la via che ci condusse da Lezza, e dopo qualche centinaia di passi, ci ritroviamo ad Erba superiore.
Noi riserbandoci a veder il paese, per ora arrestiamoci qui davanti alla villa Amalia, che ha innanzi vaghi tappeti d’erba e vasto piazzale. Due facciate ha la villa; l’una riguarda al giardino, l’altra alla corte: a quella cresce grandiosità una gradinata e un padiglione; a questa bellissimi bassorilievi in terra cotta; ma l’ingresso è per un cancello da questa parte che sta di fronte ad Erba. La chiesa laterale ti rammenta subito che un dì potesse essere questo luogo un convento. Infatti vi fu fabbricato da Guido Carpano e dalla chiesa fu detto di Santa Maria degli Angeli.
Francesco Del Conte vi stabilì i Cappuccini; passò di poi ai Filippini; finchè al principiar del secolo corrente, [310] l’avvocato milanese Rocco Marliani, consigliere della Corte d’Appello, l’acquistò, e su disegno di quel valente architetto che fu Leopoldo Polak, vi eresse la sontuosa villa che, dal nome della propria sposa, appellò Amalia.
Nel cortile di essa lasciò memoria di ciò nell’iscrizione seguente:
Rochus Petri Fil. Marlianus
Domo Mediolano
Cœnobi veteris operibus a solo ampliatis
Villam extruxit ornavit
Amaliam
Ex conjugis karissimæ nomine appellandum
Anno 1801[37].
E dirimpetto a tal lapide stanno i seguenti versi d’Orazio:
Hoc erat in votis: modus agri non ita magnus
Hortus ubi, et tecto vicinus jugis aquæ fons,
Et paulum sylvæ super his foret. Auctius, atque
Dî melius fecere. Bene est. Nihil amplius oro[38].
Vi condusse il Marliani artisti ad abbellirla, e di [311] Giuseppe Bossi infatti vedesi un’Aurora, dipinta nella sala di mezzo del palazzo; e nel giardino, o a meglio dire, nel bosco che vi fa parte, rizzò un tempietto sacro alla Prudenza, rappresentata da una statua che vi sorge nel mezzo, e poco appresso collocò due statue, Diana ed Atteone. Dove poi l’ombra è più oscura del bosco, eresse un monumento con un busto, opera di Giuseppe Franchi, tutto recinto di macchie d’alloro, fiancheggiato da funereo cipresso, e lo consacrò alla memoria di Giuseppe Parini, che fu sovente ospite venerato del Marliani; e comechè nel sottoposto sotterraneo ei vi avesse collocato un organo che, tocco, mandava una mesta armonia, così aveva fatto scolpire sulla base del monumento a Parini i quattro versi di lui, tolti all’ode All’inclita Nice:
Qui ferma il passo, e attonito
Udrai del pio cantore
Le commosse reliquie
Sotto la terra argute sibilar.
E come Parini, qui venivano accolti dalla cordialità e dall’affetto riverente del Marliani anche Foscolo e Monti, il qual ultimo raccomandò alla imperitura memoria dei posteri il nome della villa, illustrando la tomba del grande poeta che vi è conservata, nelle seguenti terzine della sua Mascheroniana:
I placidi cercai poggi felici
Che con dolce pendío cingon le liete
Dell’Éupili lagune irrigatrici;
E nel vederli mi sclamai: Salvete,
Piagge dilette al ciel, che al mio Parini
Foste cortesi di vostr’ombre quete!
[312]
Quand’ei fabbro di numeri divini
L’acre bile fe’ dolce, e la vestía
Di tebani concenti e venosini,
Parea de’ carmi suoi la melodia
Per quell’aura ancor viva; e l’aure e l’onde
E le selve eran tutte un’armonia.
Parean d’intorno i fior, l’erbe, le fronde
Animarsi e iterarmi in suon pietoso:
Il cantor nostro ov’è? chi lo nasconde?
Ed ecco in mezzo di recinto ombroso
Sculto un sasso funebre che dicea:
Ai sacri Mani di Parin riposo...
Ed una non so ben se donna o dea
(Tese l’orecchio, aguzzò gli occhi il vate
E spianava le rughe e sorridea)
Colle dita venia bianco rosate
Spargendolo di fiori e di mortella,
Di rispetto atteggiata e di pietate!
Bella la guancia in suo pudor; più bella
Sulla fronte splendea l’alma serena
Come in limpido rio raggio di stella.
Poscia che dati i mirti ebbe a man piena,
Di lauro, che parea lieto fiorisse
Tra le sue man, fe’ al sasso una catena;
E un sospir trasse affettuoso e disse
Pace eterna all’amico; e te chiamando
I lumi al cielo sì pietosi affisse,
Che gli occhi anch’io levai, fermo aspettando
Che tu scendessi, e vidi che mortale
Grido agli Eterni non salía più, quando
[313]
Il costei prego a te non giunse; il quale
Se alle porte celesti invan percote,
Per là dentro passar null’altro ha l’ale.
Riverente in disparte alla devota
Ceremonia assistea, colle tranquille
Luci nel volto della donna immote,
Uom d’alta cortesia, che il ciel sortille
Più che consorte, amico. Ed ei che vuole
Il voler delle care alme pupille,
Sol per farle contente eccelsa mole
D’attico gusto ergea, su cui fermato
Pareami in cielo, per gioirne, il sole.
E Amalia la dicea, dal nome amato
Di colei che del loco era la diva,
E più del cor che al suo congiunse il fato.
Al pietoso olocausto, a quella viva
Gara d’amor mirando, già di mente
Del mio gir oltre la cagion m’usciva.
Mossi alfine, e quei colli ove si sente
Tutto il bel di natura abbandonai
L’orme segnando al cor contrarie e lente[39].
Fu lunga la citazione, ma in compenso splendida, come splendidi sono sempre i versi di Vincenzo Monti, al quale l’età più prosaica osa temeraria levarsi e contendere il lauro di poeta.
La villa Amalia passò dopo a diversi signori, finchè pervenne al marchese Massimiliano Stampa Soncino, che vi aggiunse bellezze a bellezze.
[314]
Dalla torre che vi sta, si può abbracciare collo sguardo il più stupendo orizzonte ed estasiarsi alla vista di monti e colli, di laghi e fiumi, di paesi e ville infinite e campagne e boschi.
Gli amatori di botanica avrebbero per più d’un’ora a deliziarsi ammirando le infinite camelie di più qualità, boschetti di fusaria del Giappone, cespugli di azalee e di rododendri, e rose magnifiche, e mazzi di olea fragrans, per non dir d’altri molti e fiori e piante peregrine, che di loro vaghezza e profumo imparadisan la villa, degna della ricchezza e nobiltà del suo cortese proprietario, e però va meritamente tra le più splendide e deliziose della Brianza annoverata.
[315]
Erba Superiore. — Il suo panorama. — La sua storia. — Il castello e la villa Valaperta. — Pravalle. — Il torrente Bocogna. — Villa Conti. — Erba Inferiore. — Pretura, ufficio telegrafico, albergo e botteghe. — Il caffè e gli amaretti. — Il teatro. — Ville Clerici e Brivio. — Vill’incino. — Mercato d’Incino. — Liciniforum. — Lapidi. — Ninfeo antico. — Fatti storici. — Il mercato del giovedì.
Questa borgata, che dà il suo nome al bellissimo territorio che vengo dichiarando al lettore, distendendosi su d’una eminenza a mo’ d’anfiteatro per quelli che la riguardano venendo dalla Malpensata, fa sì che alla parte più alta si assegnasse il nome di Erba Superiore, ed è certo la migliore, perocchè domini una quantità maggiore d’orizzonte, potendosi spingere l’occhio sin là presso Cesana e Galbiate, e vedere il Monte Baro, e via via quelle ridenti colline che finiscono alla Montevecchia, e quella ridente estensione della Brianza co’ suoi infiniti villaggi; mentre poi da sinistra si posa sui colli placidi e d’insensibil pendío di Proserpio, colla biancheggiante sua chiesa che s’avanza fin sull’estremo limite d’un promontorio, su Castelmarte e sui denti o corni di Canzo e sull’Alpe di Carella che, massime all’ora del tramonto, si veste [316] delle più calde tinte che mano mano si vengono trasformando in auree, poi in porporine, quindi in violacee, finchè l’ombra notturna non le abbia confuse nell’uniforme bruno.
Era certamente nell’ammirazione di questo stupendo panorama che lo scrittore d’Angiola Maria esclamava:
O monti, o vette aeree,
O piani d’Erba, addio!
O valli, o poggi placidi
Dal fertile pendío,
Asil soave e muto
Di rustica beltà;
Io v’amo, io vi saluto
Con mesta voluttà.
Salvete, o voi tranquille
Innumere borgate,
Liete cosparse ville,
Campagne invidïate!
Io v’amo, e in cor vi sento
Com’inno del mattin,
Come il primiero accento
Dell’italo bambin.
Erba non può contare, è vero, una storia ricca di avvenimenti; ma per l’aiuto dato all’armi milanesi alla battaglia da questi ultimi combattuta contro gli aderenti del Barbarossa nel nove agosto 1160 — fu una nobile e generosa azione — s’ebbe il diritto di cittadinanza, che le fu mantenuto anche in seguito e da Ottone Visconti, e dagli Spagnuoli e dai Tedeschi. Di più ne dice il prevosto Annoni nella sua Memoria storica e archeologica intorno al Pian d’Erba, cui rimando [317] il lettore, per non essere tratto dall’amore degli storici studî a cingermi la giornea e mettere a cimento la pazienza di lui.
Attivamente poi partecipa il suo territorio all’industria che meglio si fa alla Brianza, alla serica vo’ dire, potendo contare oltre quaranta filande e quaranta filatoi, e così vien presso agli altri distretti di Oggionno, di Vimercate e di Lecco, che si additano come i meglio dotati in Lombardia di congeneri stabilimenti.
Sull’angolo sinistro d’Erba Superiore sorgeva un tempo, come del resto si riscontra in ogni terra di qualche importanza, il castello, ora convertito alla più felice villeggiatura de’ signori Valaperta, dove più d’una volta vidi ospite quel valoroso campione dell’arte pittorica moderna che è Francesco Hayez.
Di sotto al castello si avvalla con grazioso effetto il terreno, epperò vien detto Pravalle, pel quale un dì precipitavasi il torrente Bocogna, menando i soliti guasti de’ suoi pari; ma i Valaperta ne rivolsero a bene le acque, facendole servire ad una filanda o filatoio.
Sul ciglio dell’opposta eminenza, al di là di Pravalle, si pavoneggia la elegante villeggiatura de’ signori Conti, che divide coi Valaperta i vantaggi della fortunatissima posizione.
Erba Superiore è occupata per lo più da ville o case da villeggiatura: il movimento principale è nondimeno in Erba Inferiore. La borgata è dotata di Pretura, di ufficio telegrafico e di albergo: ha tutte le botteghe occorrevoli al vitto, come in una città; massime le carni vi si trovano eccellenti dai villeggianti; al suo [318] caffè, elegantemente riaddobbato di fresco e famoso pe’ suoi amaretti, sorta di pasticcini torrefatti e che contendono il primato con quelli di Saronno, nelle ore pomeridiane d’autunno vi convengono i signori e le eleganti dei dintorni, sia venendovi a piedi, sia cogli equipaggi, felici del vedersi gli uni gli altri; perocchè, del resto, la sosta avvenga in una via ristretta e senza attrattiva di sorta.
Sulla vetta dell’eminenza su cui seggono le sue case, il pittor Rosa, nel grandioso caseggiato da lui fabbricato e che affitta nelle ferie autunnali a famiglie per lo più milanesi in distinti e ammobigliati appartamenti, costruì un teatro, nel quale in quella stagione recita talvolta qualche drammatica compagnia sviata.
O per la postale, o per sentieri si discende nel sottoposto piano a Vill’Incino, dove sorge la prepositurale nella cui giurisdizione è Erba. Scendendo per la prima, al risvolto trovasi la villa già Clerici, ora Mazzucchetti, che ognun veggendo augura veder tramutato in albergo, tanto se ne sente il bisogno e propizia ne appaia la posizione; ed a fianco di essa al principio della via che si interna e guida a Lezza sorge altra villa de’ signori Brivio ed un filatoio. Proseguendo invece per la postale, dopo la Clerici, a un centinaio di passi si è alla suddetta prepositurale. Alquanto più in là è Incino, o Mercato d’Incino, che, comunque spopolato tutti i dì della settimana all’infuori del giovedì, in cui v’è l’antichissimo mercato con opportuni portici e che diè nome al paese, pure ha memoria di fatti storici. Eravi certo una colonia romana e vi si trovarono sepolcri e ossa giganti e armature dell’epoca. [319] Chiamavasi allora Liciniforum, ossia foro o mercato di Licinio, dal nome di qualche pretore o patrono che vi comandava la stazione militare, o la colonia; onde il conservato nome di per sè vale a scalzare d’ogni fondamento la pretesa di chi volle collocare Liciniforum nel luogo del poco discosto Parravicino.
Del tempo romano qui si sterrarono e lessero due lapidi.
La prima:
Herculi
C. Metilius
Secundus
Votum Solvit Libens Merito.
La seconda:
Jovi Optimo Maximo
Cœsia Tullii Filia
Maxima
Sacerdos
Divae Matidiae[40].
Una terza lapide importa poi di qui riferire, come rinvenuta in alcune escavazioni, perchè forse fa cenno di un ninfeo qui esistito:
Lymphis Viribus Quintus Vibius
Severus votum solvit.
Anche più tardi, nel medio-evo, da Landolfo da Cardano, arcivescovo di Milano (979-998), venne Incino eretto in capitanato, investendone della suprema autorità un suo fratello, come aveva egualmente fatto [320] degli altri due capitanati di Carcano e Pirovano con Missaglia. I Comaschi e i Torriani, combattendo Ottone Visconti arcivescovo di Milano e capo di parte nobilesca, lo diroccarono. Su queste terre, in età più inoltrata, fervendo le lotte guelfe e ghibelline, la fazione guelfa portò desolazione e morte, soqquadrando ogni avere e commettendo i più infami assassinî.
Era poi Incino la pieve più vasta ed importante dell’arcivescovato di Milano, e fino dal 1288 contava sotto la propria giurisdizione sessanta chiese. Alla sua prepositurale andava inoltre aggiunta una collegiata di più canonici, che San Carlo, nel 1584, trasferì alla, prossima chiesa di Vill’Incino, avendo trovato spopolato il paese. Quella chiesa antica è per altro degnissima, per la sua vetustà, di osservazione.
Il giovedì, frequentatissimo è ora il mercato anche da’ villeggianti de’ dintorni; ma verso il meriggio si dirada il concorso, e poco poco il vecchio mercato di Incino ricade nel primitivo silenzio e nella solitudine.
Con tutto ciò vi sono due decenti alberghi, dove trovan alloggio benestanti famiglie sempre nella stagione autunnale, e alle quali appunto la quotidiana solitudine toglie soggezione e aggiunge quella maggiore tranquillità che si accorre appunto dalla città a ricercare in campagna.
[321]
Villa Maria. — Bucinigo. — Pomerio. — Villalbese. — Parravicino. — Ville Parravicini, Belgiojoso e Gariboldi. — La torre pendente. — Casiglio. — Carcano. — Battaglia contro il Barbarossa. — Orsenigo. — Il Carudo. — Le Lische Amare. — Alserio. — Castellazzo. — La Ca’ de’ ladri. — La Retusa. — Tassera. — La villa Adelaide.
Da Erba, salendo la via che corre sotto l’antico castello, ora villa Valaperta, e volgendo a manca, dietro la villa Conti è la strada che va a Parravicino e subito s’incontra la villa Maria, della contessa Maria Lurani.
Solo prima dirò una parola di Bucinigo e Pomerio, che si comprendono nel Pian d’Erba; perocchè dopo segua Villalbese, celebre per ottime castagne e per freschissimi crotti, a cui gli amatori del buon vino corrono ad ogni lieta occasione, ma che entra in una diversa circoscrizione da quella del Pian d’Erba; onde avanti di esso mi convenga arrestarmi, perchè, tratto dalle bellezze dei luoghi, facilmente sarei fuorviato dal mio cómpito e arriverei presto per quella via a Como.
Bucinigo, terricciuola resa vivace da filande e incannatoî, ha più d’una villa, e fra queste quella de’ signori Vidiserti, che giovami specialmente ricordare perchè famosa per la sua patriarcale ospitalità, ivi i moltissimi [322] amici rinvenendo sempre la più graziosa accoglienza. A noi poco importa di discettare sulla pretesa di coloro che il nome al paese sia stato lasciato da un buco iniquo, che dicono esistere tuttavia in un giardino, e così appellato perchè nei tempi delle prepotenze feudali ivi si desse martirio agli infelici che non entravan nel genio de’ padroni; o sulla contraria opinione di chi invece dalla terminazione presume aver il nome radice celtica: lasciamo ai dotti il trarsi d’impaccio. La torre, di cui son superstiti pochi ruderi, rammenta le lotte fra loro sostenute dalle famiglie Sacco e Parravicino.
A Pomerio, vicinissimo, veggonsi avanzi di fortificazioni, che dovevano esservi necessariamente per rispondere al nome di post murum, il quale d’altronde era nella terminologia militare d’allora.
A Parravicino, vediamo seguitarsi tre o quattro ville graziose dei Parravicini, dei Belgiojoso e dei Gariboldi.
Nel giardino de’ Belgiojoso vedesi una torre pendente, come il campanile di Pisa e la Carisenda di Bologna, ricordata da Dante nel canto XXXI dell’Inferno.
Segna essa la dimora de’ Parravicini, che, sbandeggiati dai Rusconi di Como, qui venuti, diedero origine al villaggio.
Di Casiglio non vale far cenno, che per dire essere nella sua chiesa il sepolcro di Beltramino Parravicino, il qual fu vescovo di Como e poi di Bologna.
Fuor della strada, è Carcano, che fu già castello forte e sostenne più assedî, e diè origine alla patrizia famiglia de’ Carcano. In queste campagne fra Carcano, Orsenigo e Tassera, nel nove agosto 1160 fu combattuta una fiera battaglia fra gli aderenti di Federico [323] Barbarossa e quelli de’ Milanesi, e che altri chiamano di Tassera, altri di Carcano, altri di Orsenigo; ma non importa il nome, mentre giovi invece conoscere come ne fosse felicissimo risultamento la sconfitta del Barbarossa e il pieno trionfo de’ Milanesi, determinato dall’improvviso intervento di quei di Orsenigo ed Erba, ai quali fu in guiderdone concesso di poi il diritto di cittadinanza. In mezzo a questi campi, l’arcivescovo Uberto da Pirovano, cantato aveva allora sul carroccio milanese la messa e tenuta una sacra arringa a’ soldati onde eccitarli alla pugna contro l’invasore straniero. Nel primo scontro, che fu terribile, quel sacro carro caduto nelle mani nemiche, veniva distrutto nel luogo detto il Carudo; ma poi, per l’insperato soccorso, ristorate d’un tratto le sorti della battaglia, i Milanesi s’erano presa la rivincita gloriosa.
L’oste nemica si era spinta fino al lago d’Alserio, breve bacino di un miglio e un quarto di lunghezza e di mezzo di larghezza, sulla cui sponda è Alserio piccol paese che gli dà il nome. Era nel pantano delle Lische Amare che vuolsi s’impigliasse il corsiero del Barbarossa, onde il tempo perduto a districarsene gli avesse a riuscire fatale. — Castellazzo, paesello, su d’una facile eminenza, fu così detto da un forte che i Milanesi vi costrussero nel luglio del 1162 per contrapporre a quello di Carcano, ove si erano rifugiati, pronti a rinnovare le offese, i fautori dell’Enobarbo.
Al piede di questa bella eminenza evvi un casale ed un’osteria, detta la Ca’ de’ ladri: è facile indovinare come la brutta denominazione le venisse dall’essere il luogo isolato e proprio, massime in addietro, a ricoverarvi siffatta genìa.
[324]
Tutti questi paesi or sono animati da ville ed opificî, e nella parte più elevata di questo punto, vicino al lago, evvi la Retusa, fonte limpida, salubre e perenne, usufruttata a muovere macine, e ad animare stabilimenti di serica industria.
Affrettiamoci invece a visitare la villa Adelaide, che sorge a Tassera e presso alla riva del lago d’Alserio.
Dapprima l’ebbe la famiglia Imbonati, della quale fu ultimo rampollo quel marchese Carlo, alla cui memoria consacrò Manzoni splendidissimi versi sciolti, che ora ha il torto di respingere dalle edizioni fatte sotto gli auspicî suoi; poi l’ereditò il barone Patroni, che, fattala dall’architetto Clerichetti di Milano ultimare, riducendola a stile nordico, forse scozzese, diventò fra le più splendide che si conoscano anche per ricchezza degli interni adornamenti. I giardini sono egregiamente ordinati; getti d’acque perenni la ravvivano, comunque non sia tutto ciò giunto, per sentimento degli schifiltosi, a togliere quell’aria poco allegra che quel seno del lago vi dà. Morto il Patroni e legata ai Calvi la villa, questi la tennero per poco, vendendola a un commerciante genovese che volle lucrare togliendovi molti alberi; ma essa fortunatamente, fin allora chiamata Patroni, dal suo più generoso proprietario, venne di recente alle mani del cav. Domenico Basevi, che, profondendovi egregie somme, non solo la restituì al primitivo splendore, ma ne lo aumentò d’assai.
Figuri quindi il lettore se non avessi allora ragione di dedicarle una speciale escursione.
Oggi essa ha nuovo battesimo, e dal nome della sposa dell’attuale proprietario, si intitola Villa Adelaide.
[325]
Pontenuovo. — Merone, Mojana, Rogeno, Casletto e Garbagnate Rota. — Nobero. — Le sue pesche. — Il Cavolto. — Le fornaci. — Monguzzo. — Il suo castello e la sua storia. — I marchesi Rosales. — Villeggiatura Mondolfo.
Tanto da questa parte ove ci troviamo, quanto dall’altra parte del lago d’Alserio, per la via che dalla Vallassina si va ad Inverigo, si può ascendere sulla vetta del colle su cui signoreggia Monguzzo: noi attendendo di continuare per la via di Parravicino nella ventura escursione, scegliamo adesso la seconda.
Esciti da Vill’Incino, che già vedemmo, ci troviamo, dopo avere attraversato una strada che si chiude fra i campi, alla via provinciale della Malpensata, e, volgendo a ritroso di essa, cioè a destra, in poco tratto di cammino ci troviamo a Pontenuovo, da dove una via riesce a Merone, quindi a Moiana, Rogeno, Casletto e Garbagnate Rota, paesi tutti rallegrati da signorili villeggiature, che di poco discosti da Bosisio chiudono da una parte, all’intorno al lago di Pusiano, quel territorio che abbiam percorso del Pian d’Erba. Proseguendo poi per quella onde siam venuti, ci vediamo a Nobero, o Nobile, come altri chiama questo [326] quadrato di caseggiati aperto da un lato, che, tinto per la più parte in roseo, ti accenna com’esso appartenga ad un solo proprietario, al signor dottor Domenico Porro, che personalmente attendendo alla sapiente direzione dei suoi fondi, ne ottiene i più fecondi risultamenti. Particolarità di questo villaggio sono le più eccellenti pesche, sulle quali conta il colono fra i prodotti a sè dovuti: diritto cotesto limitato a questi terrieri, onde moltiplicate se ne veggano le piante.
Prima però d’entrare in Nobero, non sarà inopportuno dare uno sguardo al Cavolto, specie di serbatoio del Lambro, da cui si deduce l’acqua che va ad irrigare il real parco di Monza, dopo avere percorso una quindicina di miglia.
Alle fornaci presso Nobile si fanno mattoni marmorati, valendosi di un’argilla che si cava dal pendío orientale d’un poggio, che ha un color plumbeo, e mescendola con altra ordinaria gialla.
Per una strada praticata nel colle, si monta a Monguzzo.
Il paese è in felicissima postura, perchè a mattino vede il Pian d’Erba, a mezzogiorno domina il bacino dell’Éupili, a ponente la Brianza, e a sera la villa del Soldo, Fabbrica e infiniti altri paeselli, tutto recinto poi l’orizzonte da una corona azzurra di montagne, colle onde del lago d’Alserio che gli baciano le pendici del colle su cui posa.
In antico fu paese nella podestà dell’arciprete di Monza, che vi esercitava giurisdizione feudale, come su molte altre terre; quindi parve luogo a fortilizî, e vi fu fabbricato un acconcio castello, e Francesco II [327] Sforza lo concedeva in feudo ad Alessando Bentivoglio, spodestato signore di Bologna e governatore del Milanese, della cui famiglia è la cappella che in Milano si vede nella chiesa di San Maurizio del Monastero Maggiore sul corso di porta Magenta.
Ma quel famigerato prepotente del Gian Giacomo De’ Medici, detto il Medeghino, del quale già narrai in una passata escursione le ribalde gesta, lo lasciò per poco godere degli ozî di Monguzzo; perocchè, parendogliene la rôcca assai propria a’ suoi disegni, un dì, nel 1533, assalitola alla sprovvista, ne cacciò quelli che la presidiavano pel Bentivoglio, e se ne installò padrone, spargendo d’ogni intorno per le terre della Brianza, e massime per la Valsorda, il terrore. E taglieggiava da qui non i massai soltanto, ma anche i signori, che cercava di imprigionare e non rilasciare che contro enormi riscatti e teneva in allarme la fortezza di Brivio e massime di Trezzo di più grande importanza.
Il Missaglia, amico di questo fiero capitano di ventura e storico di sue gesta, lo scagiona dall’aver tolto al Bentivoglio il castello, narrando come all’occupazione di esso fosse stato dallo Sforza medesimo ordinato, e fornendone le ragioni. “Possedeva, scrive egli, in quel tempo il castello di Monguzzo come suo proprio Alessandro Bentivoglio, figliuolo di Giovanni, già signore di Bologna, parente del duca e di molta autorità appresso lui, uomo di gran sincerità, ma poco inclinato all’armi. Il castellano, visto con che poca cura e guardia era tenuto quel luogo dal Bentivoglio, per sue lettere e col mezzo d’amici suoi, fece intendere [328] al duca con quanta facilità e con quanto suo danno quel luogo, mal guardato, poteva capitare in mano degli imperiali (gli Spagnuoli di Carlo V comandati da Antonio De Leyva), offrendosi quando fosse rimesso alla sua custodia non solo di ben guardarlo, ma eziandio con la comodità di quello, danneggiare molto i nemici, ed assicurare quella parte del ducato dalle invasioni degli Spagnuoli; il che sarebbe stato come un freno a Lecco, tenuto da essi. Il duca, che, reso il castello di Milano, si trovava in Lodi, tolto dalle mani degli imperiali e dato alla lega da Lodovico Vistarino, benchè dopo la prigionia del Morone gli mostrasse poca inclinazione e poco fidasse di lui, pur conoscendo vere le sue ragioni e dubitando di peggio, e anco come quel ch’era posto in gran necessità di denari, sentiva volentieri che quel castello si avesse a guardare senza suo costo. Scrisse al Bentivoglio che rimettesse il castello alla guardia del Medici, e le lettere furono inviate a lui stesso, perchè le presentasse al Bentivoglio. Il Medici accortissimo, conoscendo quanto fosse per spiacere questo al Bentivoglio, e quanto egli potesse appresso il duca, dubitò, e ragionevolmente, che se gli mandava le lettere fosse per riuscire vano il suo disegno; onde con l’aiuto di molti principali del paese suoi amici fatta una buona raccolta di gente, accostastosi una notte a Monguzzo, e scalatolo, si appresentò alla rocchetta ove era il Bentivoglio con la sua famiglia e con le lettere ducali, e con la forza strinselo ad uscire dal castello[41].„
[329]
Quando il De Leyva ebbe contezza della caduta di Monguzzo nelle mani del Medeghino, così se ne dolse, perchè da lui si attendesse maggior travaglio che non dal Bentivoglio, vi spacciò il conte Lodovico Belgioioso con buon nerbo di forze onde ritorglielo; ma questi, dopo varî assalti e perdita d’un centinaio d’uomini, disperando venire a capo del suo proposito, si levò di là.
Certo Martino da Mondonico, animoso, ma avido di ricchezza, aveva saputo entrar nelle grazie del Medici ed ottenuto aveva da lui il commissariato di alcune tasse e contribuzioni che con durezza esigeva. Parve al De Leyva di poter guadagnar coll’oro il Mondonico, onde agevolarsi il conquisto di Monguzzo che gli intercettava la strada da Lecco a Milano, ed infatti se l’ebbe facilmente a’ suoi interessi. Ma l’ingordo traditore volle dapprima di compiere il tradimento arricchirsi, ed abusando del nome del Medici, si impadroniva un bel dì del castel di Perego. Poichè vi fu penetrato, buttata la maschera, vi prosciolse i prigionieri e si chiarì al servizio del De Leyva. Il Medici mandò subito il capitano Pellicione a riprendere il castello, e l’ebbe coi traditori, i quali condotti a Monguzzo vi vennero appiccati per la gola, e il Mondonico, posto prima a’ tormenti, fu poi vivo, siccome si meritava, inruotato.
Poneva allora il Medeghino in suo luogo castellano di Monguzzo il fratello Battista; ma poi, quando gli parve trasferirlo a comandare la più importante fortezza di Lecco della quale s’era insignorito, vi sostituì il suddetto capitano Pellicione.
Non mi so che il castello di Monguzzo fosse teatro [330] a ulteriori fatti di guerra; perocchè buttata, a questo cerbero dalle tre gole, intendo dire del Medeghino, l’offa da Carlo V, col crearlo marchese di Marignano e coll’inviarlo altrove a portar guerra, spulezzò il Medeghino pur da questi luoghi.
Più tardi il castello apparve tramutato in amenissima villeggiatura, mercè le cure dei marchesi Rosales alle cui mani pervenne; ma l’ultimo di essi, che molto di sua fortuna adoperò a pro dell’italiana indipendenza, nel 1853 la vendette al conte e banchiere Sebastiano Mondolfo, delle cui sapienti liberalità m’avvenne già di intrattenere, quando m’ebbi ad occupare dell’altra sua villa in Borgo Vico a Como.
E liberalità sapienti operò anche qui in questa sua villeggiatura di Monguzzo, perocchè aprisse a sue spese una scuola, e nel cascinale che fe’ erigere introducesse molte comodità, per le quali mostrò come pur i poveri coloni chiamar si debbano, per migliorarli, a partecipare alle inevitabili esigenze del vivere sociale moderno.
È una consolazione quando si vede alcuno de’ privilegiati dalla fortuna, in mezzo agli agî, rammentarsi che v’ha chi soffre e penuria e gli stende misericorde la mano. Sebastiano Mondolfo ha provato in tante occasioni d’essere uno di costoro.
[331]
Il casolare del Monastero di Sant’Ambrogio di Cantù. — Il Soldo degli Appiani. — Villa Turati. — La casa, il giardino e il parco. — Gli acquedotti. — Casino rustico. — Orsenigo. — Casa Carcano. — Anzano. — Villa del marchese Carcano. — Piccolo albergo. — Alzate. — Vecchio castello. — Palazzo Clerici. — Fabbrica. — Brenna e don Antonio Daverio.
A stretto rigore, il colle di Monguzzo, a parer mio, chiuder dovrebbe il bacino del vecchio Éupili, o, come suolsi oggi dire, del Pian d’Erba; ma siccome è assai indeterminato anche nella mente di que’ del paese il confine di questa ridentissima porzione di territorio che designasi sotto la denominazione di Pian d’Erba, io credo non uscir da’ limiti che s’è prefisso il mio libro spingendo questa volta la nostra escursione da questa parte insino alla stupenda villeggiatura del Soldo.
E d’altronde fosse anche fuori affatto della cerchia de’ paesi che dall’universale si assegna approssimativamente al Pian d’Erba, siccome al Soldo ci va ognuno che venga al Pian d’Erba; così anch’io non posso a meno che condurvi il mio lettore.
[332]
Vi arriveremo dalla via di Parravicino, alla quale facciamo ritorno, oltre la Ca’ de’ ladri, che abbiamo veduta.
Lo si scorge presto, perchè esso s’alza tronfio sulla cima della più lieta eminenza e di là sembra accivettare quanti necessariamente percorrendo la via che mena alla Valsorda, vi rivolgono lo sguardo. Altri poggi vi stanno presso, tutti diligentemente coltivati, e di pertinenza del medesimo signore, del conte Turati, salito per operosi commerci in filati di cotone a sterminata ricchezza e al patriziato italiano.
Allorquando si è sotto la collina del Soldo, vi pare di avere davanti una scena teatrale: mulino a vento, chioschi e padiglioni, chalets e cottages, introduzioni leggiadre di cose forestiere, viali, telegrafo, una ben ordinata e splendida vegetazione, il tutto incoronato dal palazzo che sta in cima. La prima impressione ci avverte subito che la villa gode di meritata fama.
Molti rammentano ancora come quivi non fossero prima che una meschina sodaglia, borri profondi e frane, rovi ed arbusti inutili: non vi aveva infatti alla sommità del colle che un casolare di ragione del monastero di Sant’Ambrogio di Cantù. Chi mai avrebbe detto allora che si sarebbe tramutato tanto squallore nella più gioconda plaga? Questa metamorfosi prodigiosa, iniziata da don Giacomo Appiani d’Aragona, che ridusse quell’aspro colle a villa su disegno dell’egregio architetto Moraglia, del senno del quale già ammirammo in queste nostre escursioni non poche opere, fu perfezionata dal conte Turati.
E veramente scrissero i signori Zoncada e Garovaglio [333] nella loro opera I giardini dell’alto Milanese e del Comasco, levando a cielo il Soldo[42]. Sarebbe difficile, sentenziaron essi, trovare altrove più stupenda varietà di scene, più ampie vedute, più diverse, e nel tempo stesso, e qui è il merito dell’uomo, una struttura, un disegno meglio ideati, più acconci alla qualità del sito, più rispondenti agli ultimi progressi dell’arte de’ giardini, una coltivazione più ricca, più lussureggiante, e per certe parti più degna che si pigli ad esempio. Sono pregi e bellezze che a comprenderle non arriva che la vista; per la parola è molto ancora se le riesca di lasciarle indovinare. Que’ viali, que’ passeggi, che larghi, agevoli, spazzati, girano il poggio serpeggiando con sì dolce movenza e dominando sempre l’immenso orizzonte; quelle costiere che verdi, fiorite, sparse d’ogni maniera di piante, si prolungano di qua, di là sì pittoresche fin giù nella valle; que’ prati, que’ piani ameni dove l’occhio si riposa sì tranquillo e beato; quel contrasto tra il semplice e il grandioso, il ridente e l’austero, tra l’arte e la natura, per cui passi dalla rigida vegetazione delle Alpi alla sfoggiata delle zone più favorite dal sole; che li vedi affratellarsi, dal vivace padiglione Chinese al chiosco orientale e al positivo casolare dello svizzero o dell’olandese, dal ponte di legno che ricorda la primitiva età de’ pastori alle fontane marmoree, alle statue, opera di famosi scalpelli e documenti della più alta civiltà; bisogna vederli chi voglia farsene il giusto concetto: noi non possiamo che rammentare così a [334] sbalzi, come la memoria ci soccorre, di tante meraviglie quelle pochissime delle quali ci è rimasta una impressione più profonda, e che per la qualità delle cose torna meno difficile a comunicarsi altrui.
Così, per esempio, potrà di leggieri, pare a noi, anche chi mai non la vide, imaginare quale debba essere il magico effetto di quella serie di stufe tutte eleganti, tutte magnifiche, che giù giù pel dosso della collina discendono a gradinata, quasi emiciclo di vasto anfiteatro. Vi aggiunga colla fantasia i grandi balaustrati che la riparano per davanti con vasi di classica forma, con piante di rara bellezza; vi aggiunga grandi e piccole fontane in marmo ai diversi ripiani, belle tutte, bellissima qualcuna, quella vogliamo dire che raffigura le tre Grazie, opera di egregio scalpello, che ritrae quanto di più puro seppe mai creare il cinquecento; vi aggiunga appiè di quel dosso a disuguali distanze le spelonche, le grotte di vario genere, alte, spaziose, tortuose, foggiate a galleria, a labirinto, fornite a dovizie d’ogni comodità, con polle, zampilli, giuochi d’acqua d’ogni sorta, con istipi a tarsia, busti, are, idoletti, medaglioni, con seggiole, scannelli, divani, lettucci, tavoli e tavolini d’ottimo gusto; e tutto questo sotto il più bel cielo che occhio d’uomo possa vedere, e dovrà farsi certamente un concetto grande di questo luogo incantato. E sempre maggiore si farà chi consideri le difficoltà senza numero che bisognò superare per tramutarlo, di selvaggio che era, nella forma e stato presente. Una sola vogliamo qui accennare che valga per molte, tanto è grave; vedete quella copia d’acqua volta dall’un capo all’altro de’ giardini [335] a sì diversi usi in forma qui di fontana, là di ruscello o di torrente, più giù di lago solcato da gai navicelli? Sul luogo in origine non se ne avea pur stilla; tutta, tutta quanta si derivò da lontani monti, e per magnifici acquedotti si condusse per mezzo a queste terre riarse dal sole con ingente dispendio.
Essa infatti si condusse con ingente spesa fin dai monti d’Albese, facendola viaggiare per 9000 metri di tubi di ghisa.
Lascio agli intelligenti di botanica il tener conto delle ricchezze d’alberi e fiori d’ogni clima e paese che qui son disseminati, e di estasiarsi davanti alle loro peregrine specie; io m’accontento di ammirare i leggiadri colori, di aspirare i soavissimi profumi: accetto i soli risultamenti e sarà meglio anche pel lettore, che certo non cercherà al mio libro un trattato di quella scienza.
Piuttosto non lascerò di accennare che il palazzo, se non è forse corrispondente in vastità al giardino e parco, ha tuttavia da ospitare una cinquantina di persone. Il casino rustico che gli sta accanto è forse migliore nella sua semplicità; presso al casino svizzero vi è poi uno steccato che racchiude alcuni dei più rari animali indigeni e forestieri, fra cui primeggiano bellissimi merinos.
Ah veramente aveva dunque ragione il nostro povero Raiberti, quando diceva di questa villa essere un Sold che var un milion!
Fra le terre circostanti ho già nella precedente escursione nominato Orsenigo, quella terra che con Erba trasse in aiuto dell’armi milanesi contro quelle [336] del Barbarossa: quivi adesso ricorderò la bella casa Carcano, architettata dal bravo Moraglia.
Tirando dritto sulla via per la quale siamo venuti, tocchiamo Anzano, bello per la sua elevata postura e per la villa e grandioso parco del marchese Carcano; a man destra poi di questo paese, v’è la via che conduce ad Alzate al principiar della quale or si eresse un piccolo albergo. In Alzate poi, oltre qualche ricca casa, meritano osservazione un vecchio castello che si volle reliquia di romana potenza ed il palazzo Clerici.
Ma, come che l’escursione nostra fosse bastevolmente lunga per le tante cose ammirate al Soldo, chiudiamola a Fabbrica, dove sulla eminenza sorge la villa dei conti Durini, che fruisce di bellissima vista e dalla, quale, vedendo a destra sul ciglio della collina che per l’opposto versante sogguarda al lago di Montorfano il paese di Brenna, ivi sapendo come vi sia stato dimenticato parroco quel fior di dottrina, di patriottismo e di bontà che è Antonio Daverio, mio maestro di latine ed italiane lettere, mi felicito della diversa e libera carriera da me poscia nella adolescenza abbracciata.
[337]
Lurago. — Villa Sormani-Andreani. — Lambrugo. — Ville Galli e Venini. — Inverigo. — L’arcivescovo Ariberto. — Bacco di Brianza. — L’albergo. — La Rotonda. — Il castello e la villa Crivelli. — Il Gigante. — L’Orrido. — S. Maria della Noce. — Cremnago. — Villa Perego. — Il Cimitero.
Se ci siamo alquanto spinti al di fuori del Pian d’Erba dalla parte di Parravicino per vedere il Soldo de’ Turati, perchè non ci spingeremo ora oltre Nobero per ammirare la famosa Rotonda d’Inverigo e l’Orrido dello stesso paese, che chiamano da ogni dove dalla Brianza brigate di villeggianti e di curiosi; e la villa Perego di Cremnago?
Centro Inverigo di tutta la Brianza, sarà per noi il limite ultimo delle escursioni che ci siam proposti di fare durante gli ozî autunnali.
Da Nobero, che abbiam già visitato, per una bella strada si arriva a Lurago. Quivi è la villa del conte Sormani-Andreani, con bel giardino a pineti. Dapprima spettava alla patrizia famiglia Crivelli, che vi risiedeva ed era feudataria d’Inverigo. Posta nella [338] parte alta del paese, la villa vi pompeggia e chiama lo sguardo di ognuno che passi.
Poco fuori di Lurago, la via intristisce e si fa fangosa e trascurata fin oltre Inverigo e puossi dire fino ad Arosio, onde infiniti e generali i reclami dai moltissimi obbligati a percorrere questo stradale importante. E se ne riscossero finalmente i comuni limitrofi e l’autorità, e una nuova strada e più diretta fu ordinata ed appaltata, e comunque le opere ne procedano lentamente, fra breve sarà tuttavia un fatto compiuto. A sinistra di Lurago, prima d’arrivare ad Inverigo e sul ciglio della valle del Lambro, è Lambrugo, ov’era prima un chiostro di monache, tramutato poi in villa dalla famiglia Galli. Vi villeggia anche la famiglia Venini.
Eccoci ad Inverigo. I soliti antiquarî vorrebbero originato il nome dalle due parole latine in aprico, come a dire un luogo situato all’aperto ed al sole; ma altri invece pretendono sia nome celtico: non ci frapponiamo noi a dir la nostra opinione, meglio sembrandoci d’accettarlo qual è. Piuttosto non sarà privo d’interesse il sapere come qui nel 1023 l’arcivescovo di Milano, Ariberto d’Intimiano, celebre nelle nostre storie per la parte presa nelle accanite contese surte pel celibato de’ preti, possedesse beni, ch’egli poi assegnò al rinomato monastero di San Dionigi da lui fondato in Milano.
I colti gaudenti rammentano con maggior piacere che il vino d’Inverigo godeva fino in antico una tal quale riputazione fra i migliori, e appoggiano l’erudizione loro coll’autorità d’un poeta di nome Bertucci, [339] che, arieggiando il Ditirambo del Redi, che ognun comosce, del Bacco in Toscana, scrisse alla sua volta un Bacco di Brianza, nel quale si leggono i seguenti versi, che pone in bocca allo stesso Nume:
Il terzo infine colma d’Inyerigo
Valentissimo vin, la cui mercede
Al par di Siracusa
Vanta Milano ancora il suo Archimede[43].
Ma per associazione di idee, dal buon vino ricorre il pensiero all’albergo d’Inverigo. Quest’albergo, se non presenta i conforti tutti dell’eleganza e dell’esigenza forastiera, è nondimeno il migliore di tutta questa parte della Brianza, onde l’autunno vegga più famiglie di conto prendervi stanza ed esservi arcicontente. Sostiamoci quindi, amico lettore, e dopo esserci rifocillati, potremo pigliare le mosse per ascendere alla Rotonda.
S’innalza essa sulla parte più elevata della collina, sotto cui si distende bellissima una valle, come tale pur ricordata nelle sue opere da Sant’Agostino, disseminata di paesi; la sua facciata, che giustamente fu detto rassomigliare a’ propilei d’Atene, è però rivolta a tramontana.
La fabbricò il marchese e architetto Luigi Cagnola di Milano nell’anno 1813, — quegli cui è dovuta l’architettura [340] dell’Arco del Sempione di Milano, — e vi spiegò tutta la grandiosità e il gusto classici, profondendovi egregie somme, a smentita di que’ cialtroni ch’erano venuti accusandolo d’architettar sempre grandiosamente quando si fosse trattato di non ispendere danari proprî.
Il fabbricato ha nel mezzo un’ampia sala circolare, che s’alza gigante con cupola che costituisce la Rotonda; quindi tutto l’edifizio è esteriormente riquadrato, poste essendosi agli angoli le camere della restante abitazione. Il concetto d’una rotonda maestosa fece sì che gli altri locali fossero ad essa sagrificati. Fu compiuta così un’opera del più perfetto classicismo, se si vuole; ma dopo ciò, si domandano molti, cosa vuole, a che serve, perchè qui collocato questo gigantesco edificio? Come villa ha l’esteriore principesco; ma l’interno, a parte la sala principale della Rotonda, non vi corrisponde.
Come nella facciata, così pure nella parte postica, a mezzogiorno, e che sogguarda la superba valle, vi sono ampie scalee; quella della facciata poggia sopra un sotterraneo; l’altra su d’un terrazzo recinto di balaustrata e sorretto da sei gigantesche cariatidi, che sono dello scalpello di Pompeo Marchesi.
Fu da esso che il re di Napoli, Ferdinando II, padre dello spodestato, venuto tra noi, ammirando la sottoposta valle, di non so quante miglia di circuito, così ben coltivata e ordinata quasi ad aiuole di fiori, ebbe a chiedere bonariamente al marchese Cagnola, se tutto quel che si vedeva fosse giardino della sua villa.
[341]
Se la collina su cui posa la Rotonda si digrada al paese, dall’opposto lato risorge ad eminenza, sovra cui è il castello, ora palazzo e giardino del marchese Luigi Crivelli, che ognun desidera veder meglio curati, perchè abbian tutte le forme per costituire una delle più grandiose ville. Ha molti ed annosi cipressi, e su d’un altipiano a sinistra del palazzo vedesi una colossale statua di Ercole, alquanto offesa dagli anni, che da’ terrieri si designa col nome di Gigante.
Discendendo la collina de’ Crivelli, pei loro campi si va al bosco, dove la natura e i cataclismi hanno prodotto siffatte spaccature di roccia, per dove filtrano e scorrono limpide e fresche acque, che formano un Orrido dell’effetto il più pittoresco.
E meglio ancora il produrrebbero, se l’acque più riunite scorressero; ma come l’età piega al positivo, così parte furono deviate a mettere in movimento mulini.
Con tutto ciò all’Orrido d’Inverigo, di proprietà del marchese Luigi Crivelli suddetto, non v’ha chi venga al paese e che non tragga a vederlo, sovente convegno ad amiche brigatelle che lo eleggono a luogo di refezioni e riposo.
A ponente della villa Crivelli si discende per uno stradone alla Madonna della Noce, luogo piacevole assai e al quale convengono a settimanale mercato da tutti i circonvicini paesi.
Chi ama conoscere le migliori villeggiature e farsi adeguato concetto della ricchezza de’ loro proprietarî, essendo in Inverigo, non lascia di fare una scarrozzata a Cremnago, dove sorge il magnifico palazzo della famiglia [342] Perego. Se gliene è dato l’accesso, potrà il lettore ammirarlo nelle sue parti tutte; e se nelle ampie scuderie vedrà molti cavalli e taluni anche pensionati a riposo perpetuo, sorretti persino da cinghie, potrà cavar argomento del cuore del ricchissimo padrone, il quale del resto non restrinse alle bestie sole gli effetti della sua bontà, prima avendola addimostrata nel dotare i suoi coloni di belle e comode case.
Il cimitero del paese merita pure di essere veduto. È buona architettura di Giuseppe Chierichetti, e in esso è il sepolcreto della famiglia Perego. È questo un’edicola di forma quadrangolare e cilindrica, e alla parte superiore con gradinata e cupola d’ordine dorico, colle pareti laterali fregiate di colonne, quattro delle quali formano il pronao con cornice, architrave e frontone, entro cui leggesi scolpito Hypogeum, e tutto condotto in miarolo rosso. Le pareti interne sono a stucco lucido, la luce piove dal lucernario della cupola, e nel fondo è l’altare marmoreo, con un bel gruppo in marmo di Carrara, rappresentante la Maddalena a’ piedi della Croce, lodevole opera dello scultore Labus.
Per ritornare ora al nostro Pian d’Erba, rifacciam la medesima via di Lurago e Nobero: è più agiata e vi giungeremo più presto.
[343]
Altri paesi, altre ville, altre meraviglie di natura e d’arte ci solleticherebbero ad altre escursioni; ma invaderei la Brianza, della quale già qualche lembo abbiam tocco, e allora mi ci vorrebbe un altro volume; perocchè per essa a buon dritto potrebbesi citare del pari quanto l’Ariosto cantò de’ dintorni di Firenze:
A veder pien di tante ville i colli
Par che il terren ve le germogli, come
Vermene germogliar suole e rampolli:
Se dentro a un mur sotto un medesmo nome
Fosser raccolti i tuoi palagi sparsi,
Non ti sarian da pareggiar due Rome.
E Baretti, proprio del suolo della nostra Brianza parlando, lo chiamava “il più delizioso paese di tutta Italia per la varietà delle sue vedute, per la placidezza de’ suoi fiumi, per la moltitudine de’ suoi laghi, ed offre il rezzo dei boschi, la verdura dei prati, il mormorio delle acque, e quella felice stravaganza che mette la natura ne’ suoi assortimenti; insomma in questo vaghissimo paese, ovunque si porti lo sguardo, non si scorgono che paesaggi ornati di tutte le grazie campestri, la cui contemplazione produce quei momenti di dolce meditazione, che tengono l’animo in grato riposo.„
Io ho promesso condurre il lettore con me lungo le rive del Lario e al Pian d’Erba; credo avergli attenuta la promessa, mostrandogli quanto di meglio mi è [344] sembrato. Che se alcuna cosa ho lasciato, se passai avanti qualche villa, senza farvi entrare il lettore, o, fors’anco senza pur nominarla, consideri che nell’imbarazzo di ricchezza di luoghi e di meraviglie in cui ci trovavamo, l’ommissione era agevole a commettersi, molto più che v’abbian di molti che si ricusin perfino a rivelar le più semplici cose, quasi che si tratti di violar, parlando, i loro domestici lari; epperò non mi resta che invocarne la sua indulgenza.
Ho avuto il pensiero, unendo il mio dire intorno al Pian d’Erba a quello intorno al lago di Como, di chiamare più specialmente la curiosità del forastiero sul primo e d’invogliarlo a farne soggetto delle proprie escursioni; perocchè mi fosse sembrata non troppo nota questa parte sì bella di nostra Lombardia; e se avrò raggiunto in qualche modo l’intento, io mi chiamerò soddisfatto.
[345]
| Introduzione | Pag. 5 |
| Escursione prima. — IL BARADELLO | 9 |
| Il Castello. — Uno sproposito di geografia. — Etimologia del Baradello. — Un cenno geologico. — La storia del castello. — Liutprando. — Barbarossa. — Camerlata. — Scopo del Baradello. — Napo della Torre. — La chiesa di San Carpoforo. — Lapide. — Villa Venini ora Castellini. — Il collegio alla Camerlata. — Opificî industriali. — Ville Larderia, Martignoni, Prudenziana e Carloni. | |
| Escursione seconda. — IL GENEROSO | 21 |
| La città di Como. — La chiesa di S. Fedele. — La basilica di S. Abbondio. — Il Teatro. — Il Camposanto. — L’albergo Volta. — Chiasso. — Il Crotto e le polpette della Giovannina. — L’albergo di Mendrisio. — Dottore e albergatore. — Il Monte Generoso. — Salita. — L’albergo del dottor Pasta. — La cura dell’aria. — Geologia, fiora e fauna. — Il dottor Pasta. — L’albergo del Generoso. — Il tramonto. — Il Dosso-Bello. — La vetta. — Panorama. — Ancora l’albergo di Mendrisio. — Le Cantine di Mendrisio. — L’Ospizio. — Vincenzo Vela. — Ligornetto. — Le cave di Arzo. — Le acque solforose di Stabio. — San Pietro di Castello. — Romanzo storico. | |
| Escursione terza. — IL NINO | 45 |
| Brunate e la leggenda di Guglielmina. — La Grotta del Mago. — Le ville Castiglioni, Sessa, Pertusati e Cornaggia. — Villa Angiolini. — Villa Rattazzi. — U. Rattazzi e Maria Bonaparte Wyse. — Villa Pedraglio. — Le ville Trubetzkoi, Ricordi e Artaria. — La villa Carena inabissata. — Blevio. — La villa Bocarmé e la Comton, ora Lattuada. — Il Pertugio di Blevio. — Il Buco del Nasone. — Le ville Taglioni, Schuwaloff, Vigoni e Sparks. — La Roda e Giuditta Pasta. — Adele Curti. — Il Nino. | |
| [346] | |
| Escursione quarta. — L’OLMO | 53 |
| San Fermo e i volontarî di Garibaldi. — Borgo Vico. — Villa Barbò. — Il Museo di monsignor Giovio e la villa Gallia. — Villa Saporiti, già Villani. — Bonaparte e i deputati di Como. — Palazzo Resta. — Ville Salazar, Bellotti, Mancini, Brivio, Belgiojoso, D’Adda e Pisa. — Villa Mondolfo. — L’Olmo del marchese Raimondi. — Caninio Rufo e Plinio il Giovane. | |
| Escursione quinta. — IL PERTUGIO DELLA VOLPE | 59 |
| Gite montane. — Il trovante dell’Alpe di S. Primo. — Il Sarizzo. — Grotte e Caverne. — Grumello. — Villa Celesia. — La Zuccotta e I Tre Simili. — Il signor G. B. Brambilla. — Villa Caprera del signor Loria. — La Tavernola e l’Albergo. — Villa Gonzales. — Il capitano De Cristoforis. — La Villa Bignami. — La Villa Blasis. — A Carlo Blasis. Versi. — Il Bisbino. — Il Pertugio della Volpe. — Marmi e pietre. | |
| Escursione sesta. — LA VILLA D’ESTE | 69 |
| Cernobbio. — Debitori e Monache. — Villa Bolognini. — Villa Lejnati. — Villa Belinzaghi. — Garrovo. — Il general Pino. — La villa d’Este. — Giorgio IV d’Inghilterra. — La principessa di Galles. — Suo processo. — Sua morte. — Sue opere alla villa d’Este. — L’Albergo della Regina d’Inghilterra. — L’acqua della Coletta. | |
| Escursione settima. — IL PIZZO | 89 |
| Madama Musard. — La villa il Pizzo. — G. B. Speziano la fabbrica. — I conti Muggiasca. — Il Vicerè del Regno Lombardo-Veneto. — Migliorie. — La villa Curié. | |
| Escursione ottava. — LA CASCATA DI MOLTRASIO | 93 |
| Il bacino di Moltrasio. — L’osteria del Caramazza. — Un mio episodio. — Villa dei signori Nulli. — La leggenda della Ghita. — Perchè si nomi Moltrasio. — La Vignola dei Passalacqua. — E la villa Durini? — Geologia. — La cascata. | |
| Escursione nona. — MOMPIATTO | 105 |
| Perlasca. — Tradizione. — Villa Tanzi ora Taverna. — Torno. — Storia. — Gli sposi annegati. — Ville Croff, Righini, Antonelli. — La chiesa di S. Giovanni e pia leggenda. — Mompiatto. — Le sue monache. — La Pietra pendula e la Nariola. | |
| Escursione decima. — LA PLINIANA | 111 |
| Le vittime del lago. — La villa Matilde dei signori Juva. — Villa Canzi. — La Pliniana. — Plinio il Giovane e il flusso e riflusso. — Spiegazione del fenomeno. — La Breva e il Tivano. — L’assassinio di Pier Luigi Farnese. — Giovanni Anguissola. — La villa e l’attuale proprietaria. | |
| [347] | |
| Escursione undecima. — DA MOLTRASIO A TORRIGIA | 123 |
| Orrido di Molina. — Lemna e la Colonia greca. — Una sventura nel 1163. — La villa Buttafava. — Pognana e Palazzo. — Premenù. — Ancora a Moltrasio. — Ville Salterio, Invernizzi, Tarchini-Bonfanti, De Plaisance. — Pensiero. — Rosiera. — Villa Pavia. — La Partenope. — Igea. — Villa Savoja. — La Minerva, ora villa Elena. — Villa Ostinelli-Turati. — Urio. — Ville Melzi, Jenny, Calcagnini, Taroni. — Sofia Fuoco. — G. B. Lampugnani. — Sonetto a Katinka Evers. — Ville Rocca, Tarantola, Ottolini, Battaglia, Viglezzi. — Villa Sangiuliani. — Ville Lavizzari, Porro e Longoni. — Cantiere dei fratelli Taroni. — Laglio. — Monumento a Giuseppe Franck. — Villa Galbiati. — Torrigia. — Villa Cetti. — La punta. | |
| Escursione duodecima. — IL BUCO DELL’ORSO | 131 |
| Il dottor Casella di Laglio. — La brigatella. — La vista. — Il cammino. — Il Buco dell’Orso. — Sua scoperta. — Descrizione. — Visite di dotti. — Le scarpe di S. Pietro. — Questioni geologiche. — Paleontologia. — Gallerie o pozzi scoperti dopo. — La discesa. | |
| Escursione decimaterza. — IL PIANO DEL TIVANO | 155 |
| La Cavagnola. — Careno e Quarsano. — La Grotta della Masera. — Nesso. — Erno, Veleso, Gerbio. — Il Piano del Tivano. — La brigata del Pian d’Erba. — Il Buco della Nicolina. — Vallombria. — Il palazzo di Andefleda. — La marcia della partenza. | |
| Escursione decimaquarta. — LA VALL’INTELVI | 161 |
| Brienno. — Archigene fonda Argegno. — La Vall’Intelvi. — Sua parte nella guerra decenne. — Diventa feudo. — La rivolta del 1806. — Cospirazione del 1833. — Insurrezione nel 1848. — Andrea Brenta. — I cospiratori del 1854. — L’insurrezione e i volontarî del 1859. | |
| Escursione decimaquinta. — L’ISOLA COMACINA | 177 |
| Le cascate di Camoggia. — Colono. — Sala. — Villa Beccaria. — Zocca dell’Olio. — Isola Comacina. — La sua storia. — La processione e la Scorobiessa. — Isola. — La torre del Soccorso. — Campo. — La villa Delmati. — Dosso di Lavedo. — Balbianello e la villa Arconati. — Il torrente Perlana. — La Madonna del Soccorso. | |
| Escursione decimasesta. — LA TREMEZZINA | 185 |
| Le bellezze della Tremezzina. — Versi. — Villa. — Villeggiatura Carove e la Commedia di Plinio. — Ville Torri e Vacani. — Lenno. — Lapidi antiche. — L’abbazia dell’Acquafredda. — Il chiostro di S. Benedetto. — Ville Litta, Barbavara, Carmagnola e Carcano. — Bolvedro. — Villa Busca. — Le ville Spreafico, Scorpioni, Kramer, Gerli, Della Tela, De Orchi, Campagnani, Sala, Mainoni, Guy, Giulini. — Il caffè di Tremezzo. — Albergo Bazzoni. — Hôtel garni. — Grianta. — La grotta. | |
| [348] | |
| Escursione decimasettima. — LA VILLA SOMMARIVA | 193 |
| La villa Sommariva. — Suo primo proprietario. — Opere d’arte. — Giardino. — Carlotta di Prussia e il principe di Sax-Meiningen. — La Cadenabbia. — Albergo di Belvedere. — Ville Brentano, Noseda, Piatti, duca di Sangro e Seufferheld. — La Majolica. — L’albergo Righini. — Villa Ricordi. — Maxime Lari. — Questione filologica. | |
| Escursione decimottava. — LA BELLAGINA | 201 |
| Lézzeno. — Villa Vigoni. — Villa e Cappelletta. — I Sassi Grosgalli. — Il Buco de’ Carpi. — Pietosa istoria. — Villa Besana. — S. Giovanni. — Ville Ciceri, Trotti e Poldi-Pezzoli. — Villa Luppia. — Villa Melzi. — Bellagio. — La Tragedia, villa di Plinio. — Il castello di Bellagio. — Marchesino Stanga vi edifica la villa e que’ della Cavargna la distruggono. — Ercole Sfondrati la riedifica. — La Sfondrata. — La Contessa di Borgomanero, tradizione. — La villa passa ai Serbelloni. — Parini vi ospita. — Ora mutata in albergo. — La Crella dei Frizzoni. — Pescaù. — La villa Giulia, ora albergo. | |
| Escursione decimanona. — IL SASSO RANCIO | 211 |
| Il Monte degli Stampi e l’Arca di Noè. — Ville di Menaggio. — Loveno. — Ville Pensa, Garovaglio, Alberti, Azeglio, Mylius-Vigoni. — Cardano. — Villa Galbiati. — La Val Cavargna. — Porlezza. — Fabbrica di vetro. — Il Castello di Menaggio. — La Sanagra. — Lapide romana. — Nobiallo. — Ligomana, Plesio e Naggio. — Il Sasso Rancio. — I cosacchi al Sasso Rancio. | |
| Escursione ventesima. — LE FERRIERE DI DONGO | 217 |
| Rezzonico e il suo Castello. — Il Castello di Musso. — Il Medeghino. — Le Tre Pievi. — Villa Manzi. — Dongo. — Casa Polti. — Villa del vescovo di Como. — Chiese di S. Stefano e S. Maria. — Valle dell’Albano. — Le miniere di ferro. — I forni fusori. — Garzeno. — Brenzio. — Le Frate. | |
| Escursione ventesimaprima. — GRAVEDONA | 223 |
| Consiglio di Rumo e San Gregorio. — Pizzo di Gino. — Valle di Lesio. — Gravedona e la sua storia. — La chiesa di San Vincenzo. — S. Maria del Tiglio. — La Madonna sfolgorante. — Peglio. — Liro e i tre laghetti. — Il Sasso acuto. — Domaso. — Gera. — Sórico. | |
| Escursione ventesimaseconda. — REGOLEDO | 229 |
| Olgiasca. — Piona e il suo lago. — Colico e i suoi padroni. — Dorio, Carenno e Dervio. — Bellano. — Grossi e Boldoni. — L’Orrido. — Il Sasso di Morcate. — Riva di Gittana. — Varenna. — Albergo e villa Venini. — L’Uga e la Capuana. — Il Fiume Latte. — Regoledo. | |
| [349] | |
| Escursione ventesimaterza. — IL MERCATO DI LECCO | 235 |
| Vassena. — Limonta. — La Pietra Luna. — Civenna. — I Marroni. — Perledo e la Regina Teodolinda. — Lierna. — Olcio. — Villa Pini. — Mandello. — Abbadia. — La Gessima. — Lodovico Savelli. — Le Caviate e la Maddalena. — La strada militare. — Onno. — Parè. — Lecco. — Il Maglio. — Acquate e Pescarenico. — Il Galeotto. — Il Mercato di Lecco. — Le robiole. — Gli alberghi del Leon d’Oro e della Croce di Malta. | |
| Escursione ventesimaquarta. — VALMADRERA | 243 |
| Malgrate. — Gli etimologisti. — Casa Agudio e i suoi ospiti illustri. — La chiesa parrocchiale e il pittore Cornienti. — Valmadrera. — La Chiesa. — Il trovante utilizzato. — Le Cappelle della Via Crucis. — La villa del signor Egidio Gavazzi. — La villa del signor Pietro Gavazzi. | |
| Escursione ventesimaquinta. — IL MONTE BARO | 247 |
| Bartesate, Villavergano, Figina. — La casa degli Umiliati. — Ello. — Ville Prinetti, Annoni, De’ Vecchi. — La villa Paolina. — La Bellavista del signor Cereda. — Galbiate. — Palazzi Brioschi e Ballabio. — La villa Sanchioli e l’eco polisillabo. — Case Curti e Riva. — La chiesa di S. Michele. — La lapide di piazza. — Il Monte Baro. — Fiabe archeologiche. — L’effigie immobile. — La Rocca di Re Desiderio. — La fanciulla nel pozzo. — Il Monte delle Crocette. | |
| Escursione ventesimasesta. — LA VALLE DELL’ORO | 253 |
| I Corni di Canzo. — Civate. — Il monastero benedettino. — Il re Desiderio e Adelchi. — La tradizione del miracolo. — La Valle dell’Oro. — Barzaguta. — La cascata. | |
| Escursione ventesimasettima. — LA CASA DEL PARINI | 259 |
| Annone. — La Squadra dei Mauri. — Suello. — Cesana e San Fermo. — Bosisio. — La Chiesa e l’Oratorio. — Casa Banfi. — Monumento ad Appiani e Parini. — Uno stregone dei tempi antichi. — La casa del Parini. — Lapide commemorativa. — Onta lavata. | |
| Escursione ventesimottava. — L’ISOLA DE’ CIPRESSI | 265 |
| Il lago di Pusiano. — Il primo battello a vapore in Italia. — Un mio processo. — Armi di pietra e palafitte lacustri. — Pusiano. — Villa Conti. — Scene di superstizione. — La Processione del Venerdì Santo. — L’Isola de’ Cipressi. — Il romanzo di Bertolotti. | |
| Escursione ventesimanona. — IL BEL DOSSO | 273 |
| Corneno. — La Ca’ di strii. — Villa Besana. — Galliano. — Carella. — Mariaga. — Alpe di Carella. — Il Bel Dosso. — Villa Graziani. — Longone. — Osteria. — La Malpensata. — Penzano. — Bindella. — Villa Galimberti. — Proserpio. — Villa Baroggi. — Inarca. | |
| [350] | |
| Escursione trentesima. — LA VALLASSINA | 277 |
| Il lago Segrino. — Canzo. — Il Vespetrò. — I Corni. — La fontana del Gajumo. — La cascata della Vallategna. — Il torcitoio Verza. — Scarenna. — La Casa dell’eremita. — Asso. — Lapide antica. — Arte. — La via al Pian del Tivano. — Pagnano, Fraino, Caglio, Gemù. — Il Ponte Oscuro. — Lasnigo. — Le donne della valle. — Le serve. — Onno. — San Carlo e la sua mula. | |
| Escursione trentesimaprima. — CASTELMARTE | 285 |
| Val di Giano. — Caslino e suoi cacini. — Mulino S. Marco. — Fabbrica di coltelleria. — Setificî Invernizzi, Castelletti, Prina e Mambretti. — Ademprivo. — Castelmarte. — Ville Bertoglio, Parravicini, Biondelli. — Fu Castelmarte capo della Martesana? — Castrum Martis. — Giunteria archeologica. — Reliquie antiche. | |
| Escursione trentesimaseconda. — PONTELAMBRO | 289 |
| Mazonio. — La sua chiesa. — Il pittor Ferrabini. — La Fusina. — Filatojo Ohli. — Zocco Romano. — Zocco Battista. — La Bistonda. — L’annegato. — Pontelambro. — Case Guaita e Carpani. — Una lapide nel Camposanto. — Filatojo Bressi. — Villa Matilde. — La Plejade de’ poeti politici moderni, sonetti. — Affresco luinesco distrutto. — Villa Carpani. — Lezza. — Carpesino. — Arcellasco. — Resica. — Filatoj Ronchetti e Mambretti. — Brugora. | |
| Escursione trentesimaterza. — SAN SALVATORE | 301 |
| I Geritt. — Mornico. — Crevenna. — Ville Bressi e Genolini. — Il torrente Bova. — La dara. — San Salvatore. — Il convento. — Il signor Boselli. — Giovanni Biffi. — Il tronco mellifero. — La villa Righetti. | |
| Escursione trentesimaquarta. — IL BUCO DEL PIOMBO | 305 |
| La strada. — Il Buco del Piombo. — Onde il nome? — Aneddoto. — Esterno. — Scopo. — Interno. — Iscrizione. — Concorso di gente. — I versi di Torti. | |
| Escursione trentesimaquinta. — LA VILLA AMALIA | 309 |
| La villa Amalia. — Guido Carpano e il convento di S. Maria degli Angeli. — L’avv. Rocco Marliani. — Il palazzo, il giardino e il bosco. — Il monumento a Parini. — Monti e Foscolo ospiti. — Episodio della Mascheroniana. — La torre. | |
| Escursione trentesimasesta. — ERBA | 315 |
| Erba Superiore. — Il suo panorama. — La sua storia. — Il castello e la villa Valaperta. — Pravalle. — Il torrente Bocogna. — Villa Conti. — Erba Inferiore. — Pretura, ufficio telegrafico, albergo e botteghe. — Il caffè e gli amaretti. — Il teatro. — Ville Clerici e Brivio. — Vill’Incino. — Mercato d’Incino. — Liciniforum. — Lapidi. — Ninfeo antico. — Fatti storici. — Il mercato del giovedì. | |
| [351] | |
| Escursione trentesimasettima. — LA VILLA ADELAIDE | 321 |
| Villa Maria. — Bucinigo. — Pomerio. — Villalbese. — Parravicino. — Ville Parravicini, Belgioioso e Gariboldi. — La torre pendente. — Casiglio. — Carcano. — Battaglia contro il Barbarossa. — Orsenigo. — Il Carudo. — Le Lische Amare. — Alserio. — Castellazzo. — La Ca’ de’ ladri. — La Retusa. — Tassera. — La villa Adelaide. | |
| Escursione trentesimottava. — MONGUZZO | 325 |
| Pontenuovo. — Merone, Mojana, Rogeno, Casletto e Garbagnate Rota. — Nobero. — Le sue pesche. — Il Cavolto. — Le fornaci. — Monguzzo. — Il suo castello e la sua storia. — I marchesi Rosales. — Villeggiatura Mondolfo. | |
| Escursione trentesimanona. — IL SOLDO | 331 |
| Il casolare del Monastero di Sant’Ambrogio di Cantù. — Il Soldo degli Appiani. — Villa Turati. — La casa, il giardino e il parco. — Gli acquedotti. — Casino rustico. — Orsenigo. — Casa Carcano. — Anzano. — Villa del marchese Carcano. — Piccolo albergo. — Alzate. — Vecchio castello. — Palazzo Clerici. — Fabbrica. — Brenna e don Antonio Daverio. | |
| Escursione quarantesima. — INVERIGO | 337 |
| Lurago. — Villa Sormani-Andreani. — Lambrugo. — Ville Galli e Venini. — Inverigo. — L’arcivescovo Ariberto. — Bacco di Brianza. — L’albergo. — La Rotonda. — Il castello e la villa Crivelli. — Il Gigante. — L’Orrido. — Cremnago. — S. Maria della Noce. — Villa Perego. — Il Cimitero. | |
| Conclusione | 343 |
1. Questo è il mordace epigramma od epitaffio che al vescovo di Nocera preparava quell’indemoniato:
Qui giace il Giovio storicone altissimo,
Che di tutto sparlò, fuor che dell’asino,
Scusandosi col dir: egli è mio prossimo.
Ma il Giovio era stato primo a scrivere di lui:
Qui giace l’Aretin poeta tosco,
Di tutti parlò mal, fuor che di Dio,
Scusandosi col dir: non lo conosco.
2. “Chi ricerca le sante spoglie, qui venga e le ritroverà. Questo altare le chiude in numero di sei che splendono di immensa luce. Qui sono Carpoforo, Cassio e Secondo, unitamente ad Esanto, Licinio e Severo. Costoro, dispregiando pel nome di Cristo la morte, nè temendo morire, vollero qui essere collocati. Nessuno potè mai dividerli nella tomba: santo e molto venerando essendo questo luogo, che ognuno rispetti ed anzi onori di doni. Qui da divino consiglio fu pur trasferito Felice, che pel primo predicò la divina parola; perocchè egli fu il primo patrono di Como; onde tenendo fede al nome di Felice, è meritamente felice su nei cieli.„
3. Promessi Sposi, Cap. VIII.
4. Vedi Bullettino del Club alpino Italiano (che si pubblica, in Torino), N. 13 del secondo semestre 1868, in un articolo dell’ingegnere Edoardo Kramer. Nello specchio delle ordinate che si vede in fine, oltre la misura fattane dal De Welden, si dà quella di Dufour, che è di soli metri 1698; di Oriani, che è di metri 1738, e del Lavizzari, che è di metri 1739.
5. Lavizzari, pag. 14.
6. Il Monte Generoso ed i suoi dintorni, del dottor Luigi Lavizzari. Lugano, tipografia Veladini, 1869.
7. Nato nel 1490, in Belluno, fu uomo erudito nelle lettere greche e latine. Secondo il costume de’ letterati di que’ tempi, si impose questo nome togliendolo dalla famiglia Da Ponte quivi illustre. Fu precettore de’ figli di Lodovico Sforza, compose molte opere in greco e latino, che ignoro se pubblicate, e si meritò che Belluno gli decretasse una statua di bronzo.
8. Sussiste tuttavia in Lombardia una frase imaginosa, che riesce identica a questa simbolica tradizione del gomitolo di refe consegnato da Margherita al figliuolo Giorgio. Va distante un gomitolo di refe significa appunto presso noi: va molto e molto lontano.
9. C. Plinii. Epistol., Lib. 1-3.
10. Ne dettai la biografia nell’Ingegnere Architetto, giornale che si pubblica in Milano da B. Saldini.
11. I Misteri del Lario, Racconto di Giuseppe Arnaud. Milano, 1867, pubblicato nel giornale La Lombardia.
12. Una lapide incastrata nel muro di cinta d’un giardino ricorda il dolorosissimo caso di Enrico Lok, annegato in cospetto de’ proprî parenti e della moglie, che nulla poterono fare per lui!
GULIELMUS LOK
ANGLUS
SUBMERSUS
IN CONSPECTU
PARENTUM
ET CONJUGIS
14 SEPT. 1832 AET. 33
13. C. Plinii Cæcilii Secundi. Epistol. Lib. IV, Cap. XXX.
14. Tivano è così detto sul lago il vento boreale o di tramontana. Ordinariamente è regolare, facendosi sentire in tempo di notte e cessando alla mattina poco prima dell’alzarsi del sole. Cessa egualmente la sua regolarità a mezzo il settembre. Lo stesso dicasi della Breva che succede al Tivano, e che si fa sentire dopo il meriggio, aiutando le imbarcazioni che a vela spiegata ritornano da Como.
15. Amoretti. Viaggio da Milano ai tre laghi. Milano, 1817, pag. 271.
16. Manzoni. Adelchi.
17. Questa roccia è quella stessa che forma il secondo dei cinque gruppi, di cui pare si componga la zona giurese nelle Alpi Lombarde e che giace tra l’arenaria rossa di Varenna, di S. Martino e d’Introbbio che le sta sotto, e il calcare bigio azzurrognolo talvolta arenaceo con fossili (Viggiù, Arzo, Saltrio) che lo ricopre. (Dott. Emilio Cornalia: Su alcune caverne ossifere dei monti del Lago di Como, inserte nei Nuovi Annali delle Scienze naturali di Bologna, fascicolo di gennaio e febbraio 1850 e riprodotte da lui nel Manuale della provincia di Como per l’anno bisestile 1852.)
18. Le scarpe di S. Pietro, così appellate forse da ciò che il principe degli Apostoli, alla chiamata di Cristo, camminò sul lago di Tiberiade, non sono altro che due imbarcazioni a foggia di lunga spola da tessitore, collegate insieme, oblunghe, cioè, e strette. Chiuse tutte e reggendovisi sopra, quasi servendosi di scarpa, è impossibile che anche per bufera si affondino.
19. Per altro il dottor Casella ci assicurò d’avere il primo laghetto passato a nuoto in una delle prime sue visite.
20. Ossements fossiles. Tom. IV.
21. Su alcune caverne ossifere, ecc., superiormente citate.
22. Argegno e la Vall’Intelvi, negli anni 1848 e 1859 per Gaetano Ferrabini. Milano 1860. Tip. Fratelli Borroni.
23. Virgilio. Georgica II, e si potrebbe così tradurre:
Perpetua qui la primavera ride,
E la state ne’ mesi ancor non suoi.
24. Eccone la versione:
Forse che il mar, che l’una e l’altra sponda
Bagna io qui rammento? O i tanti laghi,
E te, massimo Lario, e te, o Benaco,
Che pari al mar, gonfi i tuoi flutti e fremi?
25. Eccone la versione: “Minicio Esorato, figlio di Lucio, della tribù Oufentina, flamine del divo Tito Augusto Vespasiano, per consenso dei decurioni, tribuno de’ soldati, quatuorviro con podestà di edile, duumviro di giustizia, prefetto dei fabbri di Cesare e del Console, pontefice, a sè ed alla moglie Geminia Prisca figlia di Quinto ed a Minicia Bisia figlia di Lucio, vivente fece.„
26. Io ne dettai la biografia, che fu mandata innanzi alle Opere complete sue pubblicate in Milano da Ernesto Oliva ed al Marco Visconti, edito pure più volte in Milano da Amalia Bettoni.
27. Di questa Regina vedi il bello ed elegante studio fattone nelle Donne illustri, da quel gentile e colto intelletto di donna che fu Adele Curti.
28. “La libertà, che mal si vende per tutto l’oro, con fatica, litigio e denaro acquistata, a quella di Galbiate ed alle terre finittime arrise per regia concessione finalmente. Felice il giorno 17 giugno dell’anno 1671, nel quale, scosso il peso dell’infeudazione e d’ogni inferiore giurisdizione, questo popolo si ridusse direttamente sotto la vicaria podestà del potentissimo re delle Spagne e del Senato. La memoria di tanto riscatto, conservata privatamente negli scritti autentici di Francesco Giorgio Ottolini, notajo della Regia Camera ducale, viene pubblicamente affidata alla salda custodia di questa lapide il giorno diciotto settembre dell’anno 1671.„
29. Memorie storiche della Chiesa ed Abbazia di S. Pietro al Monte, e del Monastero di S. Calocero in Civate, raccolte dall’abate Giacinto Longoni. Milano, 1850, tip. G. B. Radaelli.
30. Al barone De Martini. Ediz. Reina.
31. Frammenti d’Ode ad Andrea Appiani.
32. Ode: La Vita Rustica.
33. Il mio amico Cominazzi aveva tradotte pel suo giornale due mie lettere francesi ch’io aveva dettate per le Matinées Italiennes, che si stampavano in Firenze.
34. Milano, Tip. Guglielmini.
35. La Corte di Roma.
36. La salubrità dell’aria. Ode.
37. Rocco Marliani, figlio di Pietro, di Milano, ampliato il vecchio convento, eresse ed ornò la villa, che volle si chiamasse Amalia dal nome della sua carissima consorte, 1801.
38. Satira VI. Lib. II. Gargallo così li traduce:
Un discreto poder, nè già sì vasto,
Che avesse un orticello, e una fontana
D’acqua perenne, a la magion vicina;
Un po’ di bosco ancor per giunta; ed ecco
Tutto qual era il voto mio. Gli dei
Han fatto meglio e più: sien benedetti!
. . . . . . . altro non chieggo.
39. Canto IV. Edizione Resnati.
40. Matidia era nipote di Trajano e suocera di Adriano; epperò qui la veggiamo divinizzata.
41. Vita di Gian Giacomo Medici, di Marcantonio Missaglia. Milano, ediz. Colombo, 1854.
42. Presso l’editore B. Saldini di Milano.
43. Intende parlare del marchese Pietro Caravaggi, la cui famiglia molto possedeva in Inverigo, e il quale fu professore nelle matematiche presso l’università di Pavia, e morì nell’anno 1688.
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici.
Copertina elaborata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio.