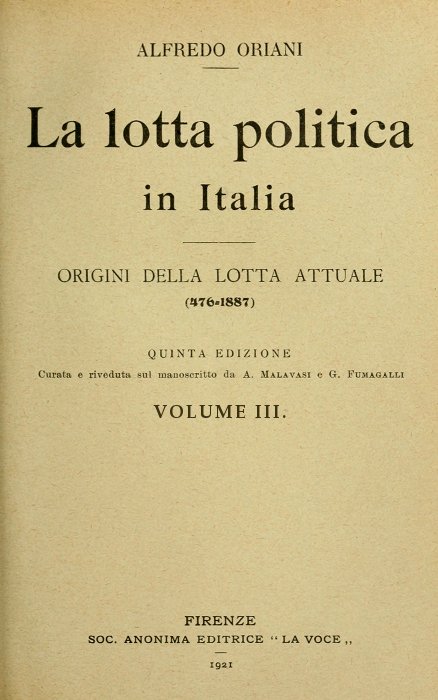
Title: La lotta politica in Italia, Volume 3 (of 3)
Author: Alfredo Oriani
Contributor: Giuseppe Fumagalli
Achille Malavasi
Release date: June 24, 2013 [eBook #43024]
Language: Italian
Credits: E-text prepared by Carlo Traverso, Claudio Paganelli, Barbara Magni, and the Online Distributed Proofreading Team (http://www.pgdp.net) from page images generously made available by Internet Archive (http://archive.org)
|
Note: Images of the original pages are available through Internet Archive. See https://archive.org/details/lalottapoliticai13oriauoft. All three volumes are included in this one book. Project Gutenberg has the other two volumes of this work. Volume I: see http://www.gutenberg.org/files/43022/43022-h/43022-h.htm Volume II: see http://www.gutenberg.org/files/43023/43023-h/43023-h.htm |
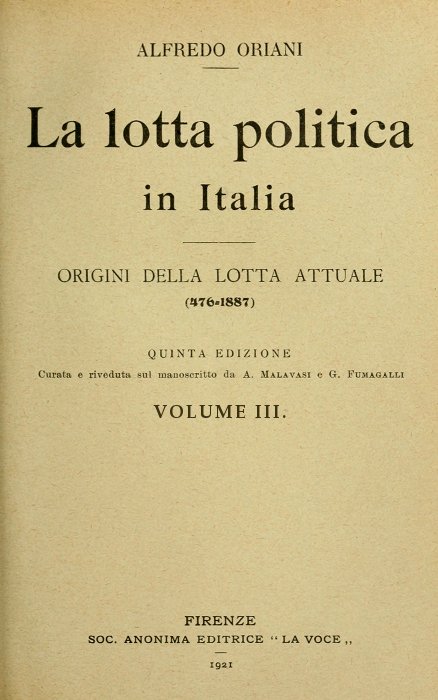
ALFREDO ORIANI
ORIGINI DELLA LOTTA ATTUALE
(476-1887)
QUINTA EDIZIONE
Curata e riveduta sul manoscritto da A. Malavani e G. Fumagalli
VOLUME III.
FIRENZE
SOC. ANONIMA EDITRICE «LA VOCE»
—
1921
INDICE
| LIBRO SETTIMO: La rivoluzione unitaria | Pag. 7 |
| Capitolo primo: La grande vigilia | 9 |
| — Esaurimento della reazione | 9 |
| — Ultime difficoltà del Piemonte | 13 |
| — L'idea napoleonica | 16 |
| — Alleanza Franco-Sarda | 18 |
| Capitolo secondo: La conquista regia | 25 |
| — Guerra Franco-Sarda | 25 |
| — La pace francese | 31 |
| — Catastrofe dell'idea piemontese | 35 |
| Capitolo terzo: Prime integrazioni rivoluzionarie | 40 |
| — I governi provvisori nell'Italia centrale | 40 |
| — Iniziative dittatoriali | 44 |
| — Le annessioni dell'Italia centrale | 51 |
| — Cessione di Nizza e di Savoia | 54 |
| Capitolo quarto: La conquista rivoluzionaria | 59 |
| — I mille di Marsala | 59 |
| — Ultime resistenze dei governi borbonico e piemontese | 71 |
| — Impresa di Napoli | 78 |
| — Campagna piemontese nelle Marche | 85 |
| — Annessione del reame | 90 |
| LIBRO OTTAVO: Il regno d'Italia | 95 |
| Capitolo primo: Il primo assetto | 97 |
| — Insufficienza storica della nuova monarchia | 97 |
| — I dati della politica monarchica | 99 |
| — Caratteri parlamentari | 105 |
| — Difficoltà politiche | 109 |
| Capitolo secondo: La proclamazione di Roma capitale | 113 |
| — Trattative diplomatiche | 113 |
| — L'ordine del giorno Buoncompagni | 116 |
| — Ultima lotta fra Garibaldi e Cavour | 118 |
| — Le Regioni | 124 |
| Capitolo terzo: I luogotenenti di Cavour | 128 |
| — L'ambiente politico | 128 |
| — I primi ministeri | 132 |
| — Empirismo legislativo | 135 |
| Capitolo quarto: La reazione del brigantaggio nel mezzogiorno | 140 |
| Capitolo quinto: La tragedia d'Aspromonte | 149 |
| — L'avventura di Sarnico | 149 |
| — Seconda spedizione garibaldina | 154 |
| — La monarchia italiana e il papato | 161 |
| Capitolo sesto: Soluzione monarchica del problema di Roma | 166 |
| — Roma durante la rivoluzione | 166 |
| — La convenzione di settembre | 171 |
| — Trasporto della capitale a Firenze | 176 |
| Capitolo settimo: La prima guerra italiana nel veneto | 181 |
| — Cospirazioni regie e democratiche | 181 |
| — La preparazione prussiana | 187 |
| — Trattative ed apparecchi | 191 |
| — La campagna | 197 |
| — Garibaldi nel Tirolo | 201 |
| — Battaglia di Lissa | 204 |
| — La pace di Vienna | 206 |
| Capitolo ottavo: Ultima ripresa rivoluzionaria | 212 |
| — Ultima reazione brigantesca a Palermo | 212 |
| — La politica ecclesiastica | 214 |
| — Ministero Rattazzi | 218 |
| — Mentana | 226 |
| — Contraccolpi parlamentari | 230 |
| — Ultimi conati mazziniani | 234 |
| Capitolo nono: La crisi finanziaria | 240 |
| — L'ambiente economico | 240 |
| — Quintino Sella | 244 |
| — Il pericolo del fallimento | 247 |
| Capitolo decimo: La presa di Roma | 259 |
| — Rivalità della Francia colla Prussia | 259 |
| — Fine del papato temporale | 265 |
| — Guerra Franco-Prussiana | 268 |
| — Esitazioni monarchiche | 270 |
| — Annessione di Roma | 280 |
| — Ingresso di Vittorio Emanuele a Roma | 283 |
| — Garibaldi in Francia | 285 |
| — La legge delle Guarentigie | 290 |
| Capitolo undecimo: L'opposizione ideale | 298 |
| — Decadenza letteraria | 298 |
| — Giosuè Carducci | 302 |
| LIBRO NONO: Il secondo periodo monarchico | 313 |
| Capitolo primo: Le due monarchie | 315 |
| — Esaurimento della destra | 315 |
| — I prigionieri della monarchia | 320 |
| — Ultimo ministero Minghetti | 323 |
| — Avvento della sinistra | 328 |
| Capitolo secondo: La conquista africana | 335 |
| — Attrazione della storia europea | 335 |
| — Influenza europea sull'Africa | 338 |
| — Iniziativa italiana | 343 |
| — Difficoltà diplomatiche | 345 |
| — Battaglia di Dogali | 356 |
| Capitolo terzo: L'Italia in Europa | 363 |
ORIGINI DELLA LOTTA ATTUALE
(476-1887)
Le condizioni della politica generale italiana al finire dell'anno 1857 non avevano mutato.
Se la diffusione sempre più rapida delle idee liberali accresceva il fermento dell'insubordinazione contro i governi reazionari, non bastava ancora a schiarire nella coscienza delle masse l'idea della rivoluzione, infiammandovi le necessarie passioni. Si accettava l'egemonia del Piemonte, ma non si vedeva modo a disfarsi di tanti principi e dell'Austria: il mazzinianismo decresceva senza che la Società Nazionale capitanata dal La Farina potesse sostituirlo.
Nessun segno di vita politica appariva nei governi reazionari: solo qualche volgo nelle campagne, o qualche frazione di borghesi intenti a razzolare guadagni tra le immondizie delle pubbliche amministrazioni, o preti fanatici di reazione inquisitoriale li sostenevano ancora.
A Napoli re Ferdinando, sbigottito dall'attentato di Agesilao Milano e dall'incendio della polveriera del Molo e della fregata Carlo III, si era rinchiuso nel magnifico palazzo di Caserta, abbandonando il governo alla ferocia della polizia: quindi la tragica impresa di Pisacane venne a moltiplicargli i terrori e a provocare nuove rappresaglie contro i liberali, mentre una difficile contenzione diplomatica si protraeva da [10] quasi un anno col Piemonte per la restituzione del Cagliari sequestrato dalle navi borboniche. I terremoti desolavano le provincie; la Sicilia dopo il moto infelice del Bentivegna dava ancora qualche crollo; le diplomazie dopo il Congresso di Parigi non restavano dal reclamare a favore degl'illustri prigionieri politici, così che il governo per non inimicarsi anche l'opinione delle Cancellerie dovette risolversi a mutare nel bando perpetuo la pena ad ottantotto detenuti. Ma anche questo cangiavasi per arbitraria determinazione dei ministri in una deportazione nell'America settentrionale: fortunatamente il capitano della nave americana che li deportava, minacciato di processo dagli esuli, li scaricò in Irlanda, ove il governo inglese fu loro largo di soccorsi. Re Ferdinando nel giorno stesso della loro grazia commetteva ad un nuovo consiglio di guerra il giudizio degli attentati contro la sicurezza interna dello stato. Fu questo l'ultimo decreto del tiranno: le sue estreme parole, fra gli spasimi di una tarda cancrena, poco prima della guerra franco-sarda contro l'Austria, parvero al tempo stesso una profezia e una confessione, giacchè, come di Giuliano l'Apostata, si narra esclamasse disperatamente: hanno vinto la causa!
Con eguale presentimento di sconfitta Pio IX, ubbidendo ai suggerimenti del cardinale Antonelli, tentava un viaggio nei propri dominî per rialzarvi col fascino religioso della propria presenza il prestigio della caduta autorità. Così il pontefice intendeva rispondere con una serie di feste ufficiali al triste quadro del proprio governo, esibito da Cavour al congresso di Parigi. Le campagne se ne commossero e corsero esultanti ad inginocchiarsi dinanzi al demiurgo, ma le città rimasero fredde. Sciaguratamente il partito moderato di Bologna, di Ravenna e più tardi di Roma stessa, tolse valore a quella freddezza col presentare al papa indirizzi politici, nei quali, invocando con incorreggibile ingenuità le solite riforme, veniva a riconoscere la sovranità pontificia. Tra i firmatari di questi indirizzi, che avrebbero voluto essere di protesta [11] ed invece erano di sudditanza, fu pure Marco Minghetti.
Dalle Romagne passando nella Toscana, Pio IX, benchè sollecitato vivamente dal clero, non seppe abbastanza adoprarsi per ottenere dal granduca l'abbandono delle ultime leggi leopoldine: i ministri di questo ricalcitrarono a tale suprema concessione, che avrebbe reso la Toscana non meno soggetta alla Santa Sede che all'Austria. Infatti sino allora tutta la politica del granduca era stata di sottomissione così incondizionata all'imperatore da ricusare persino ambasciatore sardo il conte Antonio Casati, perchè figlio di un fuoruscito lombardo. E il Piemonte aveva sopportato lo sfregio. Più piccolo e peggiore il duca di Modena, resistendo alle molte pressioni diplomatiche provocate dal conte di Cavour, cui la profluvie degli emigrati sfuggenti ai governi della penisola cominciava a procurare gravi imbarazzi nella politica interna, mantenne il Wiederkehrn nel Comando di Carrara. Quest'ultima reazione superava di crudeltà ogni altra, giacchè il truce soldato vi poteva giudicare arbitrariamente di qualunque crimine, applicando senza appello la pena capitale eseguibile ventiquattro ore dopo la sentenza anche per solo reato di ritenzione d'armi, persino su minorenni e per delitti anteriori allo stato d'assedio.
La duchessa di Parma con logica femminile aveva riassunto tutte le leggi in quella stataria.
Invece nel Lombardo-Veneto il rigore tirannico e poliziesco scemava. La cancelleria imperiale, avvisando lo scacco sofferto al Congresso di Parigi e l'invadente influenza del Piemonte, dopo aver revocato i sequestri sui beni dei fuorusciti, pensò destramente di giovarsi colle superstiti idee federaliste contro il pericolo dell'unificazione piemontese. Quindi nominò vicerè l'arciduca Massimiliano, gentile ed onesto cavaliere, lasciando intravedere la lusinga di una costituzione del Lombardo-Veneto in regno separato sotto l'alta sovranità dell'imperatore. Il nuovo principe sarebbe così stato l'unica virtù di questa cattiva idea. [12] Molti però del partito moderato, ai quali la tradizione servile ed un falso orgoglio municipale toglievano di comprendere la verità dell'idea nazionale tanto da non fare differenza fra una conquista piemontese e una semi-autonomia austriaca, aderirono al disegno come Cesare Cantù: alcuni di essi giunsero a mandare legati presso il conte di Cavour per convincerlo a dimettere ogni altra idea sul Lombardo-Veneto, che sarebbe stato felicissimo sotto Massimiliano d'Asburgo, re o vicerè indipendente. Però il popolo proseguì nell'ostilità sdegnosamente passiva ed irreconciliabile coll'Austria, mentre un gruppo di publicisti capitanati da Carlo Tenca sosteneva nel giornale Il Crepuscolo i principii dell'indipendenza e della nazionalità.
Tutto il buon volere dell'arciduca, ricondottosi a Vienna per carpire al sospettoso imperatore qualche altra concessione politica, si franse contro il sentimento patriottico del popolo, che, pure riconoscendogli il merito delle intenzioni, seguitò a cogliere tutte le occasioni per esprimere il proprio odio alla tirannia straniera.
D'altronde la vicinanza del Piemonte alimentava troppe speranze.
Se le cospirazioni, specialmente dopo gli ultimi insuccessi, non attiravano più che giovani inesperti o veterani indomabili, un'altra maggiore lusinga di guerra veniva dal Piemonte, che, malgrado l'esiguità del proprio stato, ingrossava sempre il bilancio militare. Si attendevano alleanze, si guardava alla Francia. L'ultimo attentato di Felice Orsini contro Napoleone III scatenò una fiera tempesta: i repubblicani applaudirono al forte regicida: i moderati imprecarono al settario, che per vendicare la omai lontana offesa alla repubblica romana aveva quasi tolto all'Italia l'unico possibile alleato. Nella politica estera del conte di Cavour si stringevano tutti i nodi dell'aggrovigliata politica nazionale. Intanto per naturale reazione al temperarsi del rigore austriaco nel Lombardo-Veneto s'inasprirono i rapporti fra i due governi di Vienna e di Torino.
La stampa torinese sbertava le nuove benignità imperiali; i diari governativi di Milano e di Venezia vilipendevano stato e dinastia sarda. La ragione stava nello scontro di due idee politiche implacabilmente nemiche e costrette a servirsi di un medesimo disegno. Così il conte di Cavour, nella contenzione diplomatica col conte di Buol per reciproci lagni di contumelie suggerite o permesse ai propri giornali, potè ancora avere il sopravvento; mentre, per scusarsi del monumento offerto dai milanesi ai reduci della Crimea, nel medesimo giorno dell'ingresso dell'imperatore Francesco Giuseppe a Milano, dovette rigettarne la responsabilità sul municipio di Torino, cui il dono era mandato e proibire che sopra vi si mettesse «alcuna iscrizione, dalla quale potesse risultare che quel monumento era un dono d'Italiani sudditi dell'Austria». Nullameno le relazioni diplomatiche furono troncate fra i due governi. La guerra pareva imminente, quando la congiura di Felice Orsini venne forse ad affrettarla. Questo ardente e formidabile cospiratore, dopo la più romanzesca vita di avventure politiche e militari e un ultimo dissidio con Mazzini, volle con bombe da lui stesso inventate tentare l'eccidio di Napoleone III a postuma vendetta della republica romana, e a fomento di nuova republica francese. L'attentato al solito abortì (14 gennaio 1858), massacrando un numero veramente eccessivo di innocenti. Napoleone, forse ancora più irritato che atterrito, stabilì per tutta la Francia lo stato d'assedio, dividendola in cinque grandi maresciallati; insistette a tutti i gabinetti per concordare una legge internazionale contro i settari; reclamò con burbanza dall'Inghilterra, ospite antica di tutti i fuorusciti, l'estradizione di Mazzini, di Ledru-Rollin, di Kossuth e di Blanc. L'Inghilterra rispose sdegnosamente col rovesciare il ministero Palmerston chiaritosi favorevole a tali pretensioni: il Piemonte, anche più vessato dell'Inghilterra, dovette cedere destreggiandosi.
[14] Forse nessun momento della sua storia fu politicamente e diplomaticamente più difficile. Tutta la politica cavouriana, intesa da quasi otto anni alla preparazione di una riscossa nazionale mercè un'alleanza francese, si trovava compromessa: disgustare Napoleone III era un perdere ogni speranza; acconsentire alle sue pretese un venir meno alla propria autonomia. L'imperatore esigeva la soppressione del giornale mazziniano L'Italia del Popolo, la proibizione ai fuorusciti di scrivere nelle effemeridi politiche, il giudizio pei reati di stampa contro sovrani stranieri sottratto ai giurati e attribuito ai giudici senza nemmeno richiesta della parte offesa, e l'espulsione dal regno degli esuli republicani. Cavour resistè. I clericali vincitori alle ultime elezioni lo urgevano con recriminazioni reazionarie; i radicali lo insultavano per avere con una politica servile perduta la causa italiana e condotto il Piemonte alla soggezione francese; l'Austria alla testa di tutti i governi italiani denunciava Torino per un covo di settari; i successi della guerra di Crimea e del Congresso di Parigi tornavano in nulla. Ma il suo spirito agile raddoppiò di elasticità: accusò tutti i governi reazionari italiani di moltiplicare le espulsioni politiche dei loro sudditi per creare imbarazzi al Piemonte; ai clericali rispose facendo stampare le lettere diplomatiche di Giuseppe de Maistre, nelle quali il terribile papista profetizzava alla Sardegna la necessità di combattere l'Austria e di guidare in Italia una rivoluzione nazionale; con fine lentezza tenne a bada il gabinetto francese, trattando colla diplomazia privata dell'imperatore, cui riuscì ad ammansire; ricusò di sopprimere L'Italia del Popolo e seppe ucciderla colla persecuzione abusando della condiscendenza dei magistrati, giacchè dei centocinquanta sequestri subìti dal giornale quelli giudicati dai giurati conclusero sempre all'assolutoria, mentre tutti gli altri esauriti dai giudici finirono in condanne; con una legge De Foresta restrinse la libertà di stampa e largheggiò di pene contro coloro, che attaccassero i governi stranieri o elogiassero [15] anche storicamente fatti o teoriche di regicidio; al Villamarina legato sardo a Parigi scrisse con ammirabile nobiltà di resistere a tutte le pressioni imperiali, perchè Vittorio Emanuele sarebbe pronto piuttosto a perdere la corona andando ramingo per le Americhe che a tradire l'autonomia del proprio stato o a menomarne l'indipendenza. Poi nella seduta del 16 aprile (1858), difendendo la nuova legge sulla stampa, accusò con terribile abilità di menzogna tutto il partito mazziniano di aver sempre sostenuto la teorica dell'assassinio politico e di macchinare in quei giorni stessi un complotto contro la vita di Vittorio Emanuele. Quest'ultima assurda calunnia finiva di esautorare moralmente il partito republicano.
Tutte le ire e le recriminazioni di Napoleone III contro i rivoluzionari non valsero questa denunzia contro di essi del massimo ministro rivoluzionario italiano, che ligio alla costituzione aveva pure osato di arrischiare ogni interesse della propria politica per resistergli. La publica opinione nazionale ne fu scossa: Mazzini in una lettera apologetica ribattè indarno l'atroce accusa, giacchè poco dopo due altre lettere di Felice Orsini all'imperatore prima di salire il patibolo, e da questi licenziate alla stampa, venivano a riconfermare nel volgo la medesima sinistra impressione. In esse il fortissimo ribelle, còlto da improvviso pentimento, scongiurava i rivoluzionari dal sistema dell'assassinio politico, ed affidava con fatidico voto all'imperatore la missione di liberare l'Italia.
Dopo l'accusa di Manin, la denuncia di Cavour, la confessione di Orsini, fu quasi perduto ogni credito morale pel partito republicano. Tutta la rivoluzione passava nel campo monarchico: la tradizione regia aveva vinto.
Le simpatie guadagnate da Cavour nei maggiori governi europei gli derivavano dalla sua guerra implacabile al partito rivoluzionario.
Nullameno nessuna alleanza era ancora stretta. La lunga e disastrosa preparazione minacciava di esaurire [16] il piccolo stato: in parlamento, nelle ultime discussioni pel prestito dei quaranta milioni necessari al compimento delle opere del Cenisio e della Spezia, solo una suprema speranza d'imminente guerra nazionale aveva potuto decidere della votazione.
La politica apparente del gabinetto francese, presieduto dal conte Walewski, era tutt'altro che rivoluzionaria; quella personale dell'imperatore si nascondeva fra ambagi inintelligibili anche ai più abili diplomatici. Il conte di Cavour non poteva sperare che in questa, ma nessuna destrezza di espedienti o di suggestioni sarebbe mai riuscita a decidere l'imperatore ad una guerra contro l'Austria in pro della rivoluzione italiana, senza l'oscura necessità che spingeva il secondo impero entro l'orbita del primo, condannandolo ad essere rivoluzionario suo malgrado, e a dover vivere e morire di guerre.
Dopo pochi anni, il prestigio ottenuto dall'impero coll'impresa di Crimea e col congresso di Parigi accennava a decrescere paurosamente. Il sodalizio delle dinastie non aveva ancora accettato nel proprio seno l'imperatore; l'opposizione scarsa di rappresentanti nelle Camere era guidata dai maggiori uomini francesi: Victor Hugo esule bastava solo a mantenere contro l'impero l'odio della coscienza nazionale, attirandogli, coll'irresistibile potenza di una lirica unica nella storia d'Europa, il disprezzo della coscienza universale. Il partito clericale, sostenendo Napoleone per l'appoggio da lui prestato al papa, si scindeva in legittimisti ed orleanisti, irreconciliabili per interessi dinastici; la borghesia avida di lucri non poteva sognarli al solito che da una effimera supremazia francese; il popolo sempre avido di gloria aspettava la pompa di nuovi trionfi. Nell'opinione europea l'impero napoleonico restava ancora un'avventura. L'Austria era uscita più forte dal congresso di Parigi; la Russia esausta ed [17] indarno blandita da Napoleone gli teneva il broncio; l'Inghilterra, malgrado l'oscillazione de' suoi partiti whig e tory al potere, si ostinava nei trattati del 1815; la Prussia si manteneva ligia all'Austria e alle tradizioni reazionarie: l'iniziativa rivoluzionaria doveva quindi venire dalla Francia ridivenuta imperiale come all'indomani della sua grande rivoluzione dell'89. Nato di rivoluzione, l'impero bonapartista non poteva vivere che di rivoluzione: l'inerzia lo avrebbe ucciso e un ritorno a maggior reazione rovesciato. La iniziativa Francese cominciata coll'89 doveva proseguire: tutte le rivoluzioni europee del secolo ne erano derivate, svolgendosi con processo più o meno simile al suo: ad una sistematica contraddizione di questa iniziativa la coscienza francese si sarebbe ritirata al tutto dall'impero: senza il sogno napoleonico di dominare nuovi stati con nuovi protettorati dinastici o politici, l'impero perdeva il proprio carattere europeo per restringersi ad un'interna prepotenza militare, incompatibile cogl'istinti della moderna democrazia.
L'Italia già conquistata dalla prima rivoluzione e dal primo impero francese, smembrata, sottomessa all'Austria, matura alla propria rivoluzione, si presentava come una fatalità di politica e di guerra a Napoleone III. In Italia solamente il secondo impero poteva espandersi e rinvigorirsi. Le mene murattiane a Napoli tradivano già il rinnovarsi di questo disegno bonapartista; la politica oramai decennale del Piemonte mirava alla Francia; lo spirito italiano guardava alla stella dell'impero come a quella di un nuovo mattino; la costituzione in Italia d'un forte stato boreale e costituzionale, e l'impianto a Firenze e a Napoli d'altri principi bonapartisti darebbe alla Francia, colla gloria d'aver risuscitato a vita politica il popolo più illustre del mondo, il vantaggio d'un'alleanza perpetua italiana contro l'Austria e di un predominio incontestabile sul Mediterraneo. La Francia riaprirebbe così un'altra epoca d'ascendente universale. Il cesarismo, effimera mistura di reazione e di rivoluzione, di dispotismo e di [18] democrazia, non poteva sottrarsi alla fatalità di questa politica apparentemente avventuriera e anticipatamente condannata a produrre risultati troppo diversi dalle intenzioni. Nè il terrore dell'attentato, nè l'estremo voto di Orsini decisero dunque l'imperatore Napoleone III alla guerra d'Italia come vantarono con puerile rettorica molti scrittori radicali: tutta la meravigliosa destrezza del conte di Cavour non sarebbe bastata ad impigliarvelo.
Infatti l'imperatore mandò spontaneamente al conte di Cavour le due ultime lettere di Orsini perchè le stampasse nella Gazzetta Ufficiale: poco dopo gli fece rimettere da uno dei propri diplomatici più familiari un'altra lettera con un disegno d'alleanza e una proposta di matrimonio fra il principe Girolamo Napoleone e una figlia di Vittorio Emanuele. Costantino Nigra fu il primo inviato del conte di Cavour a Parigi per studiare il terreno; il dottor Conneau si mutò in agente diplomatico per recare al conte di Cavour l'invito al convegno di Plombières nei Vosgi, ove si gettarono le vere basi dell'alleanza: il trattato si strinse quattro mesi dopo. Per esso l'imperatore s'impegnava a condurre in Italia duecentomila soldati contro l'Austria; suo sarebbe il comando superiore delle schiere alleate; a guerra vinta il Piemonte si aggregherebbe il Lombardo-Veneto, i Ducati, le Legazioni e le Marche; il Piemonte cedeva fin d'ora la Savoia e s'impegnava moralmente a cedere Nizza. Era fatalmente un disegno federativo; nè l'imperatore, nè il conte di Cavour potevano andare oltre. Quegli anzi, nascondendo la parte maggiore del proprio pensiero politico, intendeva a fondare un secondo regno d'Etruria per mezzo delle velleità autonomistiche dei federali toscani guidati dal Salvagnoli e dal Montanelli, aggregandovi i Ducati e molta porzione dello stato pontificio; a Napoli possibilmente si sarebbe installato Luciano Murat. Ma l'imperatore [19] e il conte di Cavour tentavano reciprocamente d'impaniarsi in questa trama. D'unità d'Italia sarebbe stato assurdo parlare, giacchè l'impero non aveva altra base morale che il clero, e non poteva togliere Roma al papa; la Russia proteggeva per tradizione i Borboni; una vera rivoluzione era impossibile in Italia ed inaccettabile alle diplomazie. Anzi l'avversione al partito rivoluzionario era tale che nella convenzione militare susseguita al trattato politico fra il generale Niel e il generale Lamarmora si sarebbe escluso ogni concorso di volontari, se il conte di Cavour con sapiente patriottismo non si fosse ostinato a volerlo. Solo le milizie volontarie potevano dare alla guerra franco-sarda guidata dall'imperatore il carattere d'una impresa nazionale, creando probabilmente ostacoli ai segreti disegni di nuovi stati bonapartisti.
Nei prodromi della nuova rivoluzione sembrava dominare ancora il principio federalista. Utopie diplomatiche e partigiane vi si imbrogliavano: dopo il matrimonio del principe Girolamo colla principessa Clotilde di Savoia il concetto d'un regno d'Etruria per essi si popolarizzò; a Parigi Laguerronière, letterato cortigiano, stampò un opuscolo enigmatico inspirato da Napoleone, nel quale si trattava d'una confederazione italiana fuori d'ogni dominio straniero, sul tipo di quella presentata dal Gioberti con la presidenza del papa, e intesa precipuamente a rattenere la rivoluzione. Poichè l'Inghilterra sarebbe ostile ad un altro regno bonapartista nel sud, si pensava di lasciarvi ad essa la scelta del nuovo re; nessuno all'infuori di Mazzini osava reclamare Roma. Il conte di Cavour, per resistere a questa eccessiva dilatazione bonapartista, non aveva di primo tempo trovato altro espediente che il maritare la principessa Clotilde al principe Leopoldo Hohenzollern, nato di Stefania Beauharnais «onde farne un re dell'Italia centrale, ove i Lorenesi si mantenessero ligi all'Austria».
Intanto si disponevano gli approcci.
A Varsavia fu mandato il principe Girolamo per [20] spingere la Russia a guerra coll'Austria, lasciandola libera ai padroneggiare il moto delle genti slave, mentre la Francia dominerebbe quello delle schiatte latine: ed era ancora il vecchio sogno di Napoleone I. Ma la Russia declinò l'invito per dichiararsi neutrale ed imporre la conservazione a Napoli dei Borboni; la Prussia non volle staccarsi dall'Austria e propose di provvedere alle cose d'Italia per comuni accordi pacifici; nell'Inghilterra l'opinione liberale del pubblico frenava a stento il mal volere del recente gabinetto tory.
Poichè Napoleone si era riserbato di scegliere il modo ed il momento d'una rottura coll'Austria, il conte di Cavour badava alacremente a crescere in Italia il fermento rivoluzionario, però dominandolo. In questo gli fu di largo giovamento la Società Nazionale del La Farina, che riassumendo il proprio programma politico nel motto: «Indipendenza, Unità e Casa Savoia», preparava possibili accordi per altri disegni durante o dopo la guerra. Nello scadimento del partito mazziniano la sua opera divenne improvvisamente più franca e feconda: Giuseppe Garibaldi entrò nel suo comitato centrate a Torino, altri comitati raggrupparono i migliori patrioti nelle provincie suscitandovi una disciplinata agitazione unitaria, mentre il conte di Cavour si riserbava il diritto di poterla in caso di pericolo rinnegare in parlamento. In un manifesto del 14 dicembre 1858 la Società Nazionale chiese all'Italia la dittatura di Vittorio Emanuele durante la guerra, affermando che la sollevazione italiana non implicherebbe nessuna questione di libertà e di ordinamento sociale atta a spaurire i governi: abile mossa, che abituava all'unificazione morale. L'idea piemontese giganteggiava: le acclamazioni a Vittorio Emanuele prorompevano da tutte le piazze; nessuna critica poteva turbare la nuova fede, le speranze deliravano.
Si dimenticava l'umiliazione di sorgere dietro un'iniziativa francese; l'unità d'Italia, alla quale tutti aspiravano, era momentaneamente negletta per concentrare ogni sforzo all'espulsione dell'Austria. Il mirabile [21] fenomeno politico di questo vasto moto nazionale, che s'indigava volontariamente entro le linee ancora incerte di un disegno di Napoleone III riveduto da Cavour, tradiva, attraverso l'incredibile docilità d'una disciplina improvvisata, la fiacchezza della coscienza nazionale e dell'idea rivoluzionaria: la nuova passione di guerra piuttosto che ira di schiavi appariva bramosia di liberti. L'adesione alla monarchia di Savoia era sudditanza, quella all'impero francese sommissione. I superstiti mazziniani avvampavano di sdegno; l'intera massa dei patrioti abbandonava invece ogni ideale per il possibile, preparando nella aspettazione dell'iniziativa franco-sarda nuove virtù di guerra e di concordia, senza chiedersi come l'Italia sarebbe all'indomani di un trionfo o di un abbandono francese.
Cavour, aggiungendo disegno a disegno, complicazione a complicazione, aveva sollecitato indarno l'alleanza dei Borboni e dei Lorenesi contro l'Austria.
Il discorso di Vittorio Emanuele all'apertura del parlamento (10 gennaio 1859) affermava che il re, malgrado il rispetto ai trattati, non poteva essere insensibile al grido di dolore che s'alzava verso di lui da tante parti d'Italia; e parve un grido di guerra. L'Austria, cullatasi fino allora nel dispregio del piccolo nemico e nell'orgoglio della propria posizione tanto migliore di quella di Francia, si riscosse: le diplomazie s'impensierirono; l'Italia si esaltò.
Sir James Hudson con motto profondo disse: «È la folgore che cade sui trattati del 1815». Infatti il moderno diritto di nazionalità doveva ottenere dalla rivoluzione italiana la sua prima grande consacrazione.
Il risveglio dell'Austria precipitò gli armamenti e complicò l'opera delle diplomazie. Nel Lombardo-Veneto ricominciarono i rigori: corpi d'esercito s'ammassarono di giorno in giorno alla frontiera, mentre la gioventù patriottica guadava a torme il Ticino per arruolarsi nell'esercito sardo. Cavour aveva richiamato Garibaldi per commettergli la costituzione d'un corpo di volontari; così lo avrebbe avuto nella guerra alleato ed ostaggio.
[22] Ma la politica sempre più ambigua dell'imperatore, arbitro della situazione, gettava il Piemonte nelle più umilianti perplessità. Da Londra il gabinetto tory di lord Malmesbury lo ammoniva, quasi minacciando, di guardarsi da ogni provocazione all'Austria; a Napoleone invece mostrava lo spettro rosso della demagogia pronto a ricomparire fra le imprevedibili difficoltà d'una guerra; quindi a Vienna ingrossava la voce perchè l'Austria rinunziasse all'intervento nello stato pontificio e spingesse i principi sulla via delle riforme.
Di rimpatto Napoleone prometteva all'Inghilterra di non soccorrere il Piemonte, se questo fosse primo alla guerra.
Si parlò d'un congresso per la pace: la proposta venne da Pietroburgo; Napoleone parve accettarla. Ma la questione peggiorò; l'Austria, che si ricusava superbamente alle esortazioni pacifiche dell'Inghilterra, aderendo all'idea del congresso, ne volle escluso il Piemonte come incapace di rappresentare l'Italia, della quale gli altri principi, per suggestione della cancelleria viennese, non v'interverrebbero. Ma le potenze, dopo aver accolto il Piemonte al congresso per la pace di Crimea, non potevano eliminarlo da quest'altro per la pacificazione d'Italia: allora l'Austria pretese che il Piemonte disarmasse e, poichè anche questo non le fu concesso, propose un disarmo simultaneo. Bisognava cedere; Cavour abilmente volle però sottrarre al disarmo le milizie volontarie, affermandosi pronto a raccoglierle sotto le Alpi e a licenziarle quando le potenze si fossero accordate sullo scioglimento della questione italiana. Così l'idea nazionale, incarnata nelle milizie volontarie, sovrastava alla stessa alleanza franco-sarda. L'Austria rifiutò questa condizione, ed impose bruscamente il disarmo.
La crisi diplomatica fu lunga e dolorosa. Napoleone sempre oscillante di spirito, non osava risolvere: per un momento impose a Cavour di cedere a tutte le pretese austriache, questi gli rispose con parole d'obbedienza: tutto sembrava perduto. Forse la situazione politica [23] costringeva l'imperatore a questa alternativa di spinte e di controspinte al Piemonte, per lasciare all'Austria la responsabilità dell'attacco e preparare in Francia la publica opinione alla guerra. Infatti la Francia non vi pareva ben disposta. Il partito clericale temeva di Roma, malgrado le publiche assicurazioni che l'imperatore aveva fatto dare a Pio IX dal generale Goyon; il partito conservatore abborriva da una guerra fatalmente rivoluzionaria nell'idea e nei risultati; il partito d'opposizione la qualificava d'avventura dinastica, giacchè modi e concetti rivoluzionari ne erano negati clamorosamente anche dal conte di Cavour.
La burbanzosa bruscherìa dell'Austria nel concedere tre soli giorni al Piemonte per la risposta sul disarmo troncò ogni difficoltà. Coll'assalire per la prima, essa violava i trattati del 1815, e la guerra rivoluzionaria dell'alleanza franco-sarda si mutava diplomaticamente in una guerra di difesa.
Intanto il conte di Cavour, spingendo vivamente i preparativi di guerra, otteneva dal parlamento poteri straordinari di governo: per contrastare alle mene bonapartiste in Firenze e in Napoli, allargava il moto rivoluzionario; accusava i mazziniani intransigenti di fare le parti dell'Austria; aveva nominato Enrico Cialdini comandante supremo del corpo di volontari costituito da Garibaldi. Questi doveva rimanere subalterno attirando la gioventù colla gloria del proprio nome, ma non guidarla alla vittoria: Lamarmora ministro della guerra negò con tanta ostinazione di riconoscere i gradi agli ufficiali garibaldini che i loro brevetti dovettero essere firmati dal ministro dell'interno. Poi i volontari furono male armati, frazionati, sospettosamente sorvegliati.
L'effervescenza degli animi cresceva d'ora in ora; la gioventù scaldavasi a questi primi clamori di guerra; solo i mazziniani resistevano nel nome dell'unità nazionale negata dal trattato franco-sardo e della democrazia compromessa dai momentanei dispotismi regii ed imperiali. Da Londra emanarono una protesta di [24] astensione dalla guerra, cui fallirono poco dopo generosamente accorrendo da ogni parte sotto le bandiere.
Il Piemonte esausto faceva gli ultimi sforzi, ma sottomesso fatalmente alla Francia. Quindi l'incendio rivoluzionario, che avrebbe dovuto avvampare per tutte le città d'Italia come nel 1848, non scoppiava: i volontari corsi in Piemonte non superavano i trentamila; le Provincie libere non si ribellavano, quantunque sicure che l'Austria impegnata in tanta guerra non avrebbe potuto invaderle per sostenere i principi alleati. E questi avevano milizie troppo scarse e fiacche per resistere ad una vera insurrezione popolare.
L'Austria accennava già a ritirare le truppe da tutti i luoghi occupati per concentrarle nel teatro della guerra: le ammonizioni di Cavour sconsiglianti da iniziative popolari non sarebbero bastate ad impedirle, se più intensa fosse stata nella nazione la coscienza dì patria e maggiore l'energia del carattere. I patrioti abitatori delle Provincie negli ultimi dieci anni erano tutti in Piemonte, onde lo spirito delle masse non mai da tormenti di tirannide spinte alla disperazione della rivolta, si effondeva ora nei vanti delle future vittorie francesi: mentre ai tirannelli abbandonati dall'Austria non restava più nemmeno il coraggio di sostenere con essa una guerra decisiva per la loro esistenza.
Solo la Toscana e le provincie limitrofe di Massa e Carrara, troppo straziate dal duca di Modena, tumultuarono all'annunzio della dichiarazione di guerra. Il granduca Leopoldo non osò resistere; il principe Carlo suo secondogenito non seppe farsi ubbidire dagli artiglieri, ordinando loro di bombardare Firenze dal forte di Belvedere: quindi il tumulto si sciolse in chiasso pacifico, e il popolo con berta ancora rispettosa augurò il buon viaggio al granduca fuggente.
I governi provvisorii di Firenze e di Massa e Carrara offersero la dittatura a Vittorio Emanuele; ma questi sottoposto alla volontà dell'imperatore, non osò accettare, malgrado la dittatura conferitagli dalla Società nazionale e dal parlamento.
Così cominciava la nuova rivoluzione unitaria.
L'intimazione dell'Austria al Piemonte, irritando l'orgoglio francese, agevolò a Napoleone il concorso della publica opinione. Se nelle sfere politiche e nei saloni mondani di Parigi la nuova guerra trovava vivi oppositori per complicate ragioni d'interessi, quelli fra i maggiori spiriti che per modernità di pensiero e di coscienza, da Flaubert a Quinet e da Michelet ad Hugo, rappresentavano l'iniziativa francese, vi erano favorevoli. La contraddizione del disegno napoleonico collo spirito democratico di quest'impresa non bastava a nasconderne loro la verità. L'esercito era fremente di entusiasmo; il popolo, attraverso le vanterie inguaribili della propria indole, insuperbiva di ridiscendere ad una guerra di emancipazione. L'eroica coscienza francese sentiva di riaffermare così il proprio primato sulla coscienza europea.
E la guerra incominciò.
Il 29 aprile 1859 il generale austriaco Giulay passa il Ticino con 100,000 soldati, avanzando senza incontrare resistenza verso Vercelli: la Lomellina è stata con patriottica abnegazione inondata, l'esercito piemontese, forte di 70,000 uomini e appoggiato sulle fortezze di Casale e di Alessandria, evita lo scontro, giacchè una dolorosa sfiducia sta per consigliare ai suoi generali una ritirata; ma Alfonso Lamarmora, cui [26] un rancore di Vittorio Emanuele aveva negato l'onore meritato di un seggio al consiglio di guerra, riesce ad impedirla. Il 12 maggio Napoleone sbarca a Genova fra deliranti acclamazioni di popolo; le prime colonne dell'esercito francese sono già calate dalle Alpi ed entrate a Torino. Il generale austriaco, che con un attacco rapido e vigoroso avrebbe potuto sgominare l'esercito sardo impedendone la congiunzione col francese, ora stenta a fronteggiare gli alleati. D'ambo i lati le forze si pareggiano. L'imperatore Napoleone assume il comando dell'esercito italiano umiliando l'orgoglio nazionale d'Italia, ma ottiene migliore unità di disegno e di opera; il generale austriaco deve al solito dipendere dal consiglio aulico di guerra residente a Vienna. D'altronde la sua incapacità lo predestina alla sconfitta, mentre una nobile emulazione raddoppia il valore degli alleati, e l'entusiasmo di patria muta le inesperte milizie volontarie in eroi.
A Montebello la cavalleria piemontese, sostenendo bravamente un forte assalto del generale Urban, dà tempo al generale francese Forey di accorrere colla propria divisione e di respingerlo: poi le battaglie si succedono con terribile crescendo. Mentre il generalissimo austriaco si concentra ostinatamente sul Po e sul Ticino, l'esercito francese coperto dalle truppe piemontesi gira inosservato il fianco destro del nemico; il Generale Cialdini con quattro divisioni italiane sostenute da un reggimento di zuavi sloggia da Palestro il presidio tedesco; poi, riassalito l'indomani da più forti colonne le schiaccia, e passa oltre. Vittorio Emanuele, umiliato come re di Piemonte dal supremo comando dell'imperatore, non è più che un soldato, ma vi ha sfolgorato di gloria improvvisa, gettandosi alla testa dei zuavi entro la Sesia rigonfia dalle pioggie e trascinandoli furenti alla vittoria. Quindi gli alleati, concentrati a Novara, costringono il nemico a ritirarsi sulla riva del Ticino: la battaglia ripresa presso il villaggio di Magenta si risolve in maggiore sconfitta per gli austriaci; i granatieri della guardia imperiale francese [27] vi sfoggiano eroismo, il generale Mac-Mahon vi conquista il titolo di duca; però una sola divisione italiana col generale Fanti ha potuto cooperarvi a vittoria già sicura.
Tutta la Lombardia è conquistata: gli austriaci sgombrano simultaneamente da Milano, dai Ducati, dalle Legazioni.
Intanto Giuseppe Garibaldi nel giorno stesso della vittoria di Montebello aveva passato arditamente la Sesia per gettarsi sulla Lombardia. La sua opera contraddetta da Mazzini, quasi strangolata da Cavour quantunque bene accetta al re, era passata per tutta una triste filiera di umiliazioni e di disinganni. Garibaldi, chiamato al ministero per la costituzione di un corpo di volontari, aveva dovuto sottomettersi al comando del generale Cialdini; gli si era proibito di formare i corpi; era stato relegato a Rivoli verso Susa, mentre si stabilivano due depositi di volontari a Cuneo e a Savigliano. La commissione di arruolamento istituita a Torino sceglieva la più forte gioventù pei corpi di linea e ne abbandonava i meno prestanti ai battaglioni di volontari: poi, siccome questi aumentavano, si chiamò dalla Toscana già ribellatasi il generale Ulloa per costituire un secondo corpo di cacciatori degli Appennini. Quelli di Garibaldi si chiamavano cacciatori delle Alpi. Una feroce gelosia di caserma irritava contro di lui tutte le vanità accademiche degli altri generali: dopo il comando di Cialdini chiamato alla difesa di Casale, Garibaldi dovette subire quello del vecchio generale De Sonnaz; malgrado gli ordini del re, Cavour ricusò di concedergli i volontari rimasti inerti ai depositi; per un momento gli si fè sperare di gettarlo attraverso i Ducati per sollevare l'Italia centrale, ma Cavour si oppose ancora.
L'abile ministro comprendeva fin troppo bene la necessità di avere una truppa rivoluzionaria per italianizzare la guerra franco-sarda, ma di tenerla subalterna per non perdere nel sentimento delle masse il prestigio delle future vittorie.
[28] Il conte di Campello, ministro della republica romana, aveva decretato che la legione di Garibaldi non dovesse oltrepassare i cinquecento uomini; il conte di Cavour con migliore ragione politica la volle limitata a tremila.
Nullameno la piccola truppa riuscì mirabile. V'erano volontari d'ogni grado, d'ogni classe, d'ogni merito: veterani del quarantotto come Medici e Cosenz, giovani come Bronzetti e De Cristoforis che dovevano improvvisarsi eroi, milionari ed artisti, intere famiglie di fratelli come i Cairoli, politici ignorati che poi divennero ministri, popolani fieramente poveri, aristocratici squisitamente liberali, gente di mare e di terra, di un coraggio intrattabile come Bixio o di una mitezza poetica come Gradenigo.
Tutta la loro politica si riassumeva nell'amore di patria: non discutevano di bandiera, sopportavano ogni ingiustizia senza lamento, non chiedevano gradi, non aspiravano ad onori. Una democrazia incredibile regnava nel loro campo, l'entusiasmo vi teneva luogo di disciplina, l'amicizia e la fede vi rendevano gli ordini indiscussi. La gloria del generale era la superbia di tutti: nobili e prodi come i paladini delle antiche leggende, ignoravano d'iniziarne un'altra: cavalieri di una democrazia reclutata fra tutte le classi sociali, anelavano colla più moderna delle contraddizioni alla guerra senza risentirne le malvagie passioni: e così creavano col più generoso degli eroismi la più bella originalità della rivoluzione italiana.
Ad un ordine del re, Garibaldi passa finalmente la Sesia, delude abilmente gli austriaci al guado del Ticino, da Sesto Calende si difila su Varese. Ma nemmeno la sua presenza basta a decidere il popolo lombardo ad una vera insurrezione: i villani gli ricusano quelle spiegazioni che dànno spontaneamente agli austriaci; i paesi lo accolgono festanti come un liberatore e tacciono sgomenti appena nella sua rapida marcia li oltrepassa. Emilio Visconti-Venosta, un mazziniano convertito non troppo onorevolmente alla monarchia [29] sarda, segue quale commissario cavouriano Garibaldi per istituire governi provvisori e sorvegliare le sue mosse.
Ma Urban, uno dei più fieri generali austriaci, è spiccato contro Garibaldi con oltre quindicimila uomini. Questi, che a Varese aveva con un pugno di volontari respinto un corpo della guarnigione di Milano, forte di tremila uomini, vi si trincera intrepidamente senza cannoni, senza cavalleria, con fucili poco servibili. Il 25 maggio fuga alla baionetta le prime colonne nemiche; quindi, ingannando con marcia coperta Urban, inteso a sorprendere la piccola città, lo persegue a San Fermo, entra a Como. Di là, padrone del lago, diffonde l'insurrezione per tutti i paesi delle sue rive fino su alla Valtellina, tenta di sorprendere con ardita fazione il forte di Laveno sui Lago Maggiore, ma fallisce perchè il maggiore Bixio non può decidere le barche doganiere della sponda piemontese a secondarlo nell'assalto. Poco dopo, stretto da nuove mosse dell'Urban vincitore di Varese e minacciante Como, può a stento fronteggiarlo, finchè alla notizia della vittoria di Magenta questi è costretto a ritirarsi; e Garibaldi risale il lago, da Lecco marcia su Bergamo, ributta una colonna austriaca a Seriate, occupa Brescia. Il suo piccolo esercito è raddoppiato, la Lombardia quasi tutta sgombra. Nello stesso giorno che Garibaldi libera Brescia, l'esercito francese proseguendo la vittoria di Magenta sconfigge a Melegnano l'ottavo corpo austriaco comandato dal generale Benedek, e Napoleone e Vittorio Emanuele entrano trionfatori in Milano.
La grossa metropoli lombarda, istrutta dai dolorosi ricordi dell'ultima rivoluzione, e conscia di essere lo scopo della guerra, appena evacuata dal nemico proclamava a delirio di popolo la propria annessione al Piemonte secondo il plebiscito del quarantotto, deputando assessori municipali al campo di Vittorio Emanuele come ambasciatori del voto popolare.
Il proclama di Napoleone III alto nei concetti e [30] sonoro nelle frasi, indirizzandosi ai milanesi, si volgeva a tutti gl'italiani per invitarli ad arruolarsi sotto il vessillo di Vittorio Emanuele, e diceva: «Io non vengo tra voi con un sistema preconcetto, per spodestare sovrani e per imporre la mia volontà: il mio esercito non si occuperà che di due cose: combattere i vostri nemici e mantenere l'ordine interno; esso non porrà ostacolo alcuno alla libera manifestazione dei vostri voti».
Sotto la cortesia delle parole s'intendeva già l'accento del padrone; ma la passione rivoluzionaria del momento, lusingata da quell'invocazione agli italiani, che sembrava associare alla liberazione di Milano tutti i popoli delle altre Provincie, non l'intendeva.
Per contrario il proclama di Vittorio Emanuele, invece di esprimere l'italianità di quella guerra emancipatrice, non s'indirizzava che ai Lombardo-Veneti e non prometteva loro che un libero e durevole reggimento, appena si fosse assicurata l'indipendenza della patria.
La guerra franco-sarda non era ancora italiana nè di idea nè di scopo.
Infatti, ripresa poco dopo con maggiore alacrità, doveva arrestarsi troppo presto a rovescio d'ogni previsione.
Gli austriaci, intesi a forte concentramento sul Mincio, sgombrano Pavia, Piacenza, Pizzighettone, il castello di Brescia, Bologna, Ferrara, Ancona, riordinando con nuovi contingenti l'esercito ed ingrossandolo di altri centomila uomini; lo stesso imperatore Francesco dal proprio campo di Verona assume il comando supremo. Gli alleati, sospettosi di un tranello nella troppo precipitosa ritirata, si avanzano lentamente con marcia parallela verso il Mincio. Gli austriaci chiusi nel formidabile quadrilatero avrebbero potuto resistere con molto vantaggio e ristabilire le sorti della guerra; invece, riprendendo improvvisamente l'offensiva, occupano le alture di Solferino e di San Martino. La battaglia vi scoppia quindi il 24 giugno sopra cinque leghe [31] di estensione, impegnando tutte le forze d'ambo le parti; l'accanimento più feroce vi moltiplica la strage, cinquantamila fra morti e feriti ingombrano il terreno, ma la vittoria rimane agli alleati; gli austriaci, ricacciati da tutti i poggi, debbono ripassare il Mincio.
Garibaldi, battuto pochi giorni prima dall'Urban a Castenedolo per aver ubbidito ad un ordine dal quartier generale di occupare Lonato in presenza di tutto l'esercito austriaco forte di duecentomila uomini, e che parve insidioso persino al generale Cialdini, era stato mandato nella Valtellina col pretesto di presidiarvi i passi delle Alpi contro una impossibile invasione di nuovo esercito tedesco, e vi aveva sloggiato le ultime guarnigioni nemiche dallo Stelvio.
Mentre la vittoria di Solferino raddoppiava le speranze d'Italia, la guerra si arrestò bruscamente. La sera del 7 luglio il generale Fleury aveva portato al campo austriaco di Verona una proposta di armistizio: quattro giorni dopo i due imperatori segnarono a Villafranca i preliminari di pace; a Zurigo se ne sarebbe firmato il trattato.
Vittorio Emanuele re ed alleato non ne era stato nemmeno avvisato.
Fu uno schianto: si urlò al tradimento. Vittorio Emanuele gemè tristamente: povera Italia! Cavour, dimenticando la tanto vantata prudenza, diè nelle furie. Nullameno le necessità del proprio disegno e la logica inesorabile dei fatti imponevano all'imperatore Napoleone questo abbandono, che Mazzini solo aveva preveduto colla chiaroveggenza dell'odio partigiano.
I preliminari di pace stabilivano:
«L'imperatore d'Austria e l'imperatore dei Francesi favorivano la creazione di una confederazione italiana: questa confederazione sarà sotto la presidenza onoraria del Santo Padre.
«L'imperatore d'Austria cede all'imperatore dei [32] Francesi i suoi diritti sulla Lombardia, ad eccezione delle fortezze di Mantova e di Peschiera, dimodochè la frontiera dei possedimenti austriaci partendo dall'estremo raggio della fortezza di Peschiera si estenda in linea diretta lungo il Mincio sino alle Grazie e di là a Scorzarolo e a Luzzara sul Po, dove le frontiere presenti continueranno a formare i limiti dell'Austria. L'imperatore dei francesi rimetterà i territori ceduti al re di Sardegna.
«La Venezia farà parte della confederazione italiana, restando sotto la corona dell'imperatore d'Austria. Il granduca di Toscana e il duca di Modena entreranno nei loro stati concedendo un'amnistia generale.
«I due imperatori chiederanno al Santo Padre d'introdurre ne' suoi stati le riforme indispensabili.
«È concessa d'ambe le parti piena ed intera amnistia alle persone compromesse in occasione degli ultimi avvenimenti nei territori delle parti belligeranti».
Vittorio Emanuele, apponendovi la propria firma, v'aggiunse questa, inintelligibile riserva: «Accetto per ciò che mi riguarda»; Cavour mormorò con mal represso sdegno rivoluzionario: «Torneremo a cospirare». Napoleone III, accomiatandosi, disse al re: «Il vostro governo mi pagherà le spese e non penseremo più a Nizza e a Savoia; ora vedremo che cosa gl'italiani sapranno fare da soli».
Queste ultime parole parevano al tempo stesso una sfida ed un sarcasmo.
Nullameno la condotta politica dell'imperatore, fra l'odio dell'inattesa delusione che riuniva contro di lui moderati e rivoluzionari, non rivelava nè l'una nè l'altro. Se discendendo alla guerra di Lombardia, egli aveva promesso solennemente di respingere gli austriaci al di là dell'Adriatico, aveva del pari negato ogni unità italiana riaffermando il diritto supremo del papa su Roma e respingendo ogni partecipazione rivoluzionaria. Nel suo segreto disegno bonapartista d'insediare [33] il principe Girolamo a Firenze e Luciano Murat a Napoli, riunendo l'Italia in una confederazione, della quale il papa sarebbe presidente onorario ed egli il padrone, la guerra all'Austria non poteva essere che una espansione dell'impero napoleonico sottoposto non già alle leggi storiche d'Italia, ma alla necessità del proprio assetto europeo. E tutto gli era mancato. Aveva lasciato in Alessandria il principe Napoleone ad organizzarvi un quinto corpo d'armata per ignota destinazione; poi lo aveva mandato in Toscana, malgrado tutte le istanze di Cavour come rappresentante di Vittorio Emanuele, dopo aver proibito a questo di accettarne la dittatura. Il principe Napoleone si era presentato a Firenze come un pretendente inviato dall'imperatore, ed aveva dovuto ritirarsi davanti all'invincibile avversione del popolo. Il ritorno dei whigs al potere, favorevoli all'unificazione italiana ed ostili all'impero, toglievano all'imperatore ogni speranza sul reame di Napoli; il suo disegno con Kossuth per sollevare l'Ungheria contro l'Austria, e pel quale erasi già costituita una forte legione ungherese con soccorsi francesi e con contratti favoreggiati a Torino da Cavour, aveva urtato nei disegni dello czar sui Principati Danubiani; la Germania, ostinata come nel '48 nelle idee della propria confederazione, considerava il possesso austriaco del Veneto come necessario alla sicurezza della sua frontiera meridionale; la Prussia, che prima della guerra aveva indarno proposto all'Austria di garantirle con una mediazione armata i possedimenti italiani secondo i trattati del 1815 se le fosse ceduta la primazia sulla confederazione, ora, sollecitata d'alleanza offensiva e difensiva dall'Austria, pur ricusandovisi, aveva ottenuto dalla dieta di Francoforte d'incorporare nel proprio esercito le milizie federali sotto il comando del reggente, e con una così rapida mobilitazione, che parve allora un miracolo del suo grande generale ancora sconosciuto von Moltke, ammassava in pochi giorni duecentomila soldati sul Reno. L'Austria, anche dopo la disfatta di Solferino, quantunque accettasse la pace [34] per diffidenza dell'Inghilterra e per non lasciare alla Prussia il vantaggio di frenare la Francia conquistando così un primato morale nella confederazione germanica, rimaneva intatta come potenza militare. Il suo imprendibile quadrilatero le avrebbe dato tempo a rifare l'esercito e ripiombare più forte sulla Lombardia.
Il disegno napoleonico sull'Italia doveva dunque svanire, dacchè l'impero bonapartista era minacciato.
Una guerra francamente rivoluzionaria, che avesse sollevato Italia ed Ungheria associandole alla Francia, poteva solo permettere a Napoleone di correre i nuovi rischi di una coalizione europea: ed era l'impossibile idea di Mazzini. La guerra iniziata col re di Piemonte nel proposito di una federazione italica su tipo giobertiano e con minacce contro ogni iniziativa rivoluzionaria per conquistare al Piemonte tutto il Lombardo-Veneto, non poteva proseguirsi nelle mutate condizioni della politica europea.
La guerra d'Italia non era più che una brillante avventura del secondo impero da interrompersi alla massima vittoria. Vittorio Emanuele, diventato vassallo nell'alleanza e subalterno nel comando, non meritava riguardi di pari; l'Austria, cedendo la Lombardia a Napoleone, dava all'Europa la misura del proprio avversario italiano; questi, costretto ad accettarla dalle mani di un alleato, che aveva concluso la pace senza nemmeno avvisarnelo, confessava la propria impotenza; la rivoluzione italiana veniva francamente negata, dacchè la guerra iniziata dall'imperatore con una alleanza segreta, quindi da lui ritardata nelle diplomazie e guidata finalmente sino al Mincio, era stata vinta quasi dalle sole armi francesi. Il valore delle truppe sarde e l'eroismo dei pochi volontarii garibaldini non aveva potuto decidere della campagna; il numero dei francesi periti in essa non solo superava di troppo quello dei piemontesi, ma vi uguagliava l'altro di tutti gli italiani morti per la rivoluzione, dal ventuno sino alla gloriosa giornata di San Martino.
Lo smacco del disegno napoleonico produceva la catastrofe dell'idea piemontese.
La politica cavouriana aveva concluso al peggiore dei disastri, malgrado una incontestabile abilità. Fatalmente falsa nei principii e nei mezzi, giacchè mirava ad una rivoluzione rinnegandone l'idea per giungere ad una impossibile conquista regia, aveva dovuto combattere i mazziniani ed accodarsi quasi inutilmente alla fortuna dell'impero napoleonico. Laonde l'idea piemontese soccombeva. Venezia restava in mano all'Austria; la confederazione dei principi colla presidenza del papa era impossibile; il duca di Modena e il granduca di Toscana, rientrando nei propri stati, dovevano scacciarne i commissari piemontesi; e il Pallieri era già stato inviato da Cavour a Parma, Luigi Carlo Farini a Modena, Massimo D'Azeglio a Bologna. Il loro ritiro secondo la convenzione di Villafranca avrebbe coperto d'infamia il Piemonte. Infatti la sua politica sottomessa agli ordini di Napoleone aveva fin troppo umiliato l'onore italiano: malgrado il voto delle popolazioni per una annessione immediata e la dittatura conferitagli, Vittorio Emanuele non aveva osato affermarsi re di quelle Provincie. Perugia, sollevatasi generosamente contro il governo papale, aveva subìto dagli sgherri pontifici saccheggi e massacri, mentre Cavour faceva insultare gli insorti dai propri giornali, e riconosceva altamente il diritto sovrano del papa; la persecuzione dei mazziniani era stata spinta all'assurdo: si era espulso Aurelio Saffi e carcerato Alberto Mario. Le grandi promesse della Società Nazionale racchiuse nel triplice motto — Unità, Indipendenza e Casa Savoia — svanivano: il trattamento usato a Garibaldi diventava ridicolo dopo quello inflitto da Napoleone III a Vittorio Emanuele. La guerra era stata inutile. Il Piemonte vi avrebbe guadagnato il Milanese, ricevendolo come una elemosina dalle mani del potente alleato che lo aveva conquistato, ma avrebbe dovuto poi cedere a questo Nizza e Savoia, giacchè l'imperatore sarebbe stato presto o tardi costretto ad esigerle, malgrado [36] la propria rinuncia verbale, per giustificarsi davanti alla opinione publica francese.
Cavour sentiva tutto questo.
L'edificio alzato in dieci anni d'instancabile operosità crollava improvvisamente, seppellendolo sotto una rovina senza poesia. La sua mirabile politica della preparazione piemontese, il coraggio di tante iniziative parlamentari, la splendida temerità della spedizione in Crimea, il trionfo al congresso di Parigi, il forte esercito ricostituito, le Alpi traforate, l'arsenale della Spezia, la stessa guerra franco-sarda si ritorcevano contro di lui. Invano, durante questa egli aveva preso tutti i portafogli della marina, dell'interno, della guerra, delle finanze, ed era bastato a tutto compiendo ogni giorno miracoli di lavoro e di espedienti; invano il suo patriottismo non aveva indietreggiato davanti a nessun rischio del Piemonte; più invano la sua destrezza aveva sottratta al mazzinianismo i migliori elementi, ora che la sua idea piemontese cadeva miseramente davanti all'idea italiana.
Mazzini, l'indomabile suo avversario, si rialzava contro di lui come un profeta vendicatore.
La politica di Cavour, concentrata nello sforzo dì espellere l'Austria dall'Italia, mentre invece questa vi restava formidabile nel quadrilatero minacciando la Lombardia se la convenzione di Villafranca non fosse rispettata, diventava assurda. Come mai Cavour non aveva previsto che la Germania si opporrebbe alla conquista della Venezia, dichiarata intangibile dalla Dieta di Francoforte nel 1848, e, sospettando in un eccessivo ingrandimento dell'impero francese un pericolo per le proprie provincie renane, avrebbe potuto durante la guerra di Lombardia minacciare la Francia sul Reno? Come mai Cavour aveva potuto accettare il disegno della confederazione italiana tracciato da Napoleone? Perchè aveva sollecitato, ed invano, l'alleanza del Borbone e del granduca di Toscana nella guerra contro l'Austria? Perchè aveva tanto mortificato la rivoluzione italiana e sottomesso il Piemonte a Napoleone [37] III per essere poi da questo abbandonato, e lasciare l'Italia in un disastro peggiore di quello del quarantotto, sotto la minaccia di una confederazione, che le avrebbe tolto ogni avvenire?
La pubblica opinione tempestava.
I rivoluzionarii reclamavano contro il vinto ministro colla nobiltà della loro fede unitaria e democratica: essi non avevano creduto a Napoleone III, il carnefice di Roma, l'uomo del 2 dicembre, ed avevano avuto ragione. Avevano sempre proclamato che la formula monarchica tradirebbe l'Italia, e il fatto dava loro fin troppo ragione, giacchè il Piemonte stesso veniva diminuito. La Lombardia non valeva Nizza e Savoia e il vassallaggio francese.
La fede d'Italia nel Piemonte arrivava alla stessa spasimante delusione della fede in Pio IX dieci anni prima.
L'avaro e piccolo stato non aveva mai inteso che ad ingrandire se stesso: Cavour, incredulo nell'unità ed avverso per istinto alla rivoluzione democratica, non aveva seguitato che la politica tradizionale di casa Savoia nella conquista della valle del Po. Il suo ultimo grido alla convenzione di Villafranca raccolto da Kossuth, «io sono disonorato in faccia al mio re!», mentre trattavasi invece dell'onore d'Italia, aveva tradito il segreto del suo spirito. Non si credeva più alla sua abilità, si rideva amaramente del suo patriottismo.
Mai posizione di ministro dittatore fu più triste; egli la comprese, e si dimise, abbandonando il portafoglio ad Urbano Rattazzi.
Non si comprendeva allora che gli errori della politica cavouriana erano una conseguenza inevitabile della formula monarchica, e che il fallimento dell'idea piemontese, provocato dall'abbandono di Napoleone III, era la sconfitta definitiva del federalismo. L'idea piemontese non doveva e non poteva essere l'idea italiana; la rivoluzione nazionale non poteva e non doveva esser fatta dalla Francia. L'immenso doloroso garrito della publica opinione era ancora una prova [38] umiliante dell'insufficienza italiana. Se la Francia avesse scacciato l'Austria oltre l'Adriatico senza che l'Europa vi si fosse opposta, l'Italia sarebbe caduta dalla servitù austriaca al vassallaggio francese: il Piemonte avrebbe avuto tutto il Lombardo-Veneto; la Toscana si sarebbe mutata irresistibilmente in un grosso regno d'Etruria; a Napoli avrebbe regnato un altro Murat troppo inferiore al primo; dopo i principi prefetti dell'Austria, l'Italia avrebbe sopportato i re luogotenenti di Francia; il papa, già subordinato all'impero per l'occupazione francese di Roma, non sarebbe stato che un presidente nominale della confederazione; tutta l'Italia una seconda Algeria.
Il trionfo della politica cavouriana avrebbe concluso ad un disastro peggiore della sua sconfitta.
Così il Piemonte non veniva meno all'Italia, ma a se stesso: gl'impegni assunti colla guerra all'Austria verso la nazione lo costringevano ora a mutare di idea e di processo. Dopo le sue alleanze coi governi doveva venire quella del popolo: lo spirito di Mazzini correggerebbe l'intelletto di Cavour, e Garibaldi prenderebbe il posto di Napoleone III come alleato di Vittorio Emanuele.
Infatti, mentre il gran ministro piemontese si ritira vinto non prostrato nella solitudine di Leri quasi ad attingere altre forze in seno alla natura, Bettino Ricasoli a Firenze, e Luigi Carlo Farini a Modena riprendono intrepidamente l'idea dell'unificazione; Garibaldi, ingrossato di truppe, instà già ai confini dello stato pontificio coll'audacia di un ribelle, che non conosce altra autorità che il diritto, altra patria che la nazione, altro dovere che la guerra; Mazzini, già penetrato incognito a Firenze urla: «al centro, al centro», mirando al sud! La Sicilia sta per scoppiare in aperta rivolta; a Napoli i murattiani, atterriti dalla diserzione di Napoleone, perdono terreno, mentre il nuovo re Francesco II non trova ancora una politica per difendersi. Alla progettata confederazione nessuno crede; si comincia a comprendere che Napoleone non potrà [39] indire guerra all'Italia se questa ricusi di seguire la convenzione di Villafranca, che l'Austria ancora indolorita dalle recenti percosse non potrà riprenderla. L'Inghilterra ora si chiarisce favorevole; di governi reazionari non restano che il papa e il Borbone, quegli fatalmente difeso dalla Francia, questi pressochè abbandonato da tutti.
Il minacciato ritorno del granduca, del duca di Modena e della duchessa di Parma diventa problematico, giacchè a Villafranca l'intervento militare per ristabilirli sul trono, qualora le popolazioni si mantenessero salde nella ribellione, non era stato deciso. Quindi, sbolliti i primi rancori contro il Piemonte, l'istinto delle masse afferra prontamente la necessità di sostenerlo: impossibile pensare adesso a Venezia, più impossibile ancora proseguire la rivoluzione nello stato pontificio. Lo sforzo di tutti, prima diretto all'espulsione dell'Austria, si riunisce ora a procurare le annessioni della Toscana e dei Ducati al Piemonte. Se qualche velleità di autonomia federale contrasta ancora, non è più che un ultimo tremito di vanità di qualche quarantottista in ritardo. Il sentimento nazionale urge tutte le coscienze; il Piemonte ingrossato della Lombardia, della Toscana, dei Ducati e delle Legazioni diventerà lo stato più forte d'Italia, e ne sarà il nucleo per un'altra riscossa.
Cavour, vinto e maledetto, sta per essere invocato direttore supremo: la sua destrezza è necessaria alle imminenti complicazioni. Mentre tutto il paese sta per abbandonarsi alla rivoluzione, egli, che ne era l'avversario, deve diventarne il complice e la guida.
La situazione dell'Italia, all'indomani della pace di Villafranca, era tale che nessun diplomatico avrebbe saputo definirla e nessuno statista dominarla. Il federalismo, vinto nella coscienza nazionale, sembrava risorgere per la volontà tirannica dei due imperatori; ma una federazione di principi italiani, mentre il Piemonte aveva già commissari propri nelle provincie insorte, e Venezia restava sotto l'Austria, e il papa dopo aver massacrato Perugia arruolava nuovi crociati per tutta l'Europa, era impossibile. Se i popoli insorti odiavano i principi, questi esecravano anche maggiormente il Piemonte.
Quindi non corsero subito trattative diplomatiche d'accordi.
Nelle provincie ribelli i governi provvisorii duravano. Parma e Modena, quella compresa nel teatro della guerra, questa posta sul suo confine, avevano ricevuto i primi contraccolpi della rivoluzione. La duchessa Maria Luigia era indarno ricorsa alla protezione dell'Inghilterra, giacchè il reazionario ministero Malmesbury veniva indi a poco rovesciato: poi l'Austria, ritirando le truppe dai Ducati per concentrarle sul Mincio, l'aveva abbandonata. Laonde la duchessa esulò, dirigendo un proclama ai propri sudditi, nel quale, dopo molti vanti sulle cure del proprio governo [41] per tutti i progressi «politici e saviamente liberali», raccomandava al solito la nomina di una commissione di governo per la tutela dell'ordine.
Il municipio aveva affidato il governo temporaneo ad un triumvirato composto del conte Girolamo Cantelli, Pietro Bruni ed Evaristo Armani, richiamando in vigore l'atto solenne di annessione al Piemonte decretata dal plebiscito del 1848. Dei triumviri, il Cantelli aveva servito insino allora alla Corte della duchessa, gli altri non valevano molto meglio di lui. Si abrogarono tosto lo stato d'assedio e i tribunali straordinari. A Piacenza, appena sgombrata dagli austriaci, si improvvisò un uguale triumvirato; poi le due città deputarono oratori a Torino, perchè si accettasse il loro voto di annessione. Ma il veto di Napoleone a Vittorio Emanuele lo impedì, benchè i Ducati fossero compresi negli ingrandimenti stipulati a Plombières. Quindi venne mandato commissario governativo nelle provincie parmensi il conte Pallieri, abile magistrato. A questi, richiamato per ordine dell'imperatore, successe il triumviro Giuseppe Manfredi.
Se la duchessa Maria Luisa aveva esulato senza resistenza, il duca Francesco di Modena tentò di sbraveggiare da Brescello alla testa di settemila uomini, ma alla notizia del concentramento sul Mincio delle truppe austriache fuggì a Mantova. I suoi ultimi atti di governo furono degni dei primi: vuotò l'erario, saccheggiò musei e biblioteche, ed emanò un supremo editto di minaccia contro tutti coloro che avessero attentato ai suoi diritti sovrani.
Nullameno la città, risaputa la partenza del presidio austriaco da Bologna, tumultuava e traeva con bandiera italiana al palazzo ducale. I reggenti cedettero. Una eptarchia di cittadini riunitasi a governo richiamò in vigore l'atto d'annessione al Piemonte del 1848 per dimettere poco dopo ogni suo potere nelle mani dello storico Luigi Zini, primo commissario governativo. Quindi giungeva governatore regio Luigi Carlo Farini (20 giugno 1859).
[42] Nelle legazioni e nelle Marche il pacifico moto insurrezionale si era allargato facilmente. Mentre la Corte Romana, cullandosi nella fiducia di una vittoria austriaca, respingeva burbanzosamente le istanze francesi per una rinnovazione delle sue proteste del 1815 contro la nuova occupazione di Ferrara e di Comacchio, appena i presidi tedeschi si ritirarono dalle provincie (11 giugno) vide rovinare silenziosamente il proprio governo. A Bologna s'instituì una Giunta provvisoria di quinqueviri, che sfrattò il cardinale legato Milesi: la Romagna, le Marche, l'Umbria s'associarono a Bologna nominandola metropoli. Nessuno spargimento di sangue: solo ad Ancona il presidio pontificio minacciò la moltitudine e conservò il castello.
Con unanime voto tutte le città insorte invocarono inutilmente la dittatura di Vittorio Emanuele.
Allora la Corte Romana, irritata dalla sorpresa, benchè scarsa di soldatesche, precipita a reazione. Il popolo non insorge; Ancona e tutte le altre città delle Marche ricadono senza sangue sotto il dominio pontificio; solo Perugia, assalita con 2500 mercenari dal colonnello svizzero Schmid, resiste debolmente ed infelicemente. Gli ordini di Roma contro di essa sono atroci: la Giunta improvvisata di governo si smarrisce invece nell'inazione: i magistrati municipali l'abbandonano timidamente, lasciando ad alcuni gruppi di popolani più risoluti preparare la battaglia. Ma pochi, male armati, peggio guidati, fra lo sgomento della moltitudine e l'odio dei villani, che in tutte le campagne parteggiavano ancora per il papa, debbono soccombere. Un osceno e truce saccheggio insanguina la città, si profanano chiese, si violano ospedali, orfanotrofi, monasteri, mentre da Roma escono vanti ribaldi dell'impresa, e il vescovo della città, oggi papa col nome di Leone XIII, celebra pompose esequie ai pochi sgherri caduti, scrivendo sul loro catafalco con satanica ironia: Beati mortui qui in Domino moriuntur. Con non meno crudele insensibilità il conte Cavour accusa i caduti [43] di faziosi e riconosce solennemente il diritto sovrano del papa.
Ma la reazione pontificia rattenuta dalla stessa volontà di Napoleone, che frenava l'espansione piemontese, non osò invadere le Romagne; la Cattolica, meschino villaggio marittimo fra Rimini e Pesaro, segnò il limite della rivoluzione: da questo vigilava il generale Luigi Mezzacapo coi volontari romagnoli arruolati in Toscana. Napoleone III gli aveva permesso di difendersi e proibito di assalire.
Pareva allora che lì sarebbe il confine del nuovo stato piemontese. L'incertezza politica, che confondeva dolorosamente le provincie insorte, si sbrogliava, ma più dolorosamente in Toscana. Mentre i Ducati e le Legazioni, vedendo ricusato il loro voto d'annessione al Piemonte, cominciavano a tremare nella fede al nuovo re, in Firenze s'apriva la prima scena del dramma bonapartista. L'urto delle diplomazie europee v'era cresciuto di giorno in giorno dalla fuga del duca Leopoldo: Russia, Prussia ed Inghilterra si ostinavano a riconoscerlo ancora sovrano: Vittorio Emanuele ricusava la dittatura, promettendo un protettorato indefinibile; il Buoncompagni, mandatovi commissario, male si accontava coi governanti provvisori ancora ammalati di autonomia amministrativa e intenti colla tradizionale avarizia del paese ad economizzare fatica e denaro per la guerra dell'indipendenza. Finalmente potè deciderli a ritirarsi e a nominare un altro governo, del quale divenne mente e volontà il barone Bettino Ricasoli: nell'impossibilità di convocare tosto il parlamento si costituì una consulta di quarantadue membri per aiuto e sindacato dei ministri; ne fu presidente venerato per sventura di cecità e lustro di vita Gino Capponi.
I momenti erano difficili. I duchisti mestavano fra la plebe delle campagne e dei borghi, il partito francese capitanato dal Salvagnoli aumentava d'iniziativa, all'annessione col Piemonte non si vedeva modo, un moto republicano repugnava, l'Europa proteggeva il [44] granduca. Improvvisamente il principe Girolamo Bonaparte si presentò a Firenze come pretendente inviato dall'imperatore, in assisa di generale, guidando un corpo d'esercito con ipocrito pretesto di guerra nazionale. Ma Bettino Ricasoli, Gino Capponi e il tribuno popolano Dolfi organizzarono una mirabile resistenza morale intorno al principe, che dovette presto persuadersi dell'impossibilità di crescere a re d'Etruria. Quindi venne invitata la Consulta a decidere sulla proclamazione della sovranità nazionale di Vittorio Emanuele, e il decreto ne era già redatto, quando da Torino il conte di Cavour, soccombendo da capo alle pressioni imperiali, vi oppose il veto. Allora il popolo eccitato da Dolfi, mazziniano moderato ed agitatore instancabile, forzò le troppe prudenze dei governi torinese e fiorentino coll'ottenere che tutti i municipi deliberassero per l'immediata unione della Toscana alla monarchia di Savoia. I municipi votarono con patriottica unanimità la subita fusione dei due paesi. Il voto popolare inanimì la Consulta, alla quale il commissario potè finalmente proporre tre schemi di legge per l'istituzione della milizia cittadina, per la riforma del codice penale e per il rinnovamento degli ordini municipali.
L'inaspettata pace di Villafranca venne a sgominare il pacifico lavoro. Il popolo tumultuò devastando per insana vendetta la stamperia, donde era uscito il giornale colla triste novella; il governo, cresciuto d'animo nel pericolo, affermò invece solennemente che per qualsiasi dolorosa traversia mai la Toscana sarebbe ricondotta sotto il giogo lorenese od austriaco.
Ma alla pace di Villafranca il problema delle annessioni si complicò.
Il Piemonte dovette subire l'umiliazione di richiamare i propri commissari e di abbandonare una insurrezione compiutasi nel nome di Vittorio Emanuele. [45] Il conte di Cavour si dimise per sottrarsi abilmente ai tristi risultati della propria politica; però, mutando di tattica con robusta agilità, dopo aver tanto mortificato la rivoluzione, l'incuorò. A prevenire tentativi di ristorazione nei Ducati, mandò Lodovico Frappolli a Modena per ordinarvi la difesa con Farini, dicendogli: «Fate arma di ogni palo: respingete i soldati del duca quando egli tentasse di rientrare; sono italiani, che hanno rinnegato la patria; cacciateli nel Po». Farini, sprigionando improvvisamente l'energia rivoluzionaria deposta nella sua coscienza dal mazzinianismo giovanile, si dimise da commissario regio per proclamare l'indomani la propria dittatura, alto gridando dal vecchio palazzo Estense: «Avanti colla stella d'Italia, perchè l'Italia non ha contrassegnato la pace di Villafranca».
Cavour dimissionario gli rispose: «Il ministro è morto, l'amico applaude alla vostra risoluzione».
D'Azeglio, richiamato da Bologna, disobbedì generosamente, mandando novemila soldati alla frontiera romagnola della Cattolica contro un possibile attacco degli svizzeri di Perugia, e non si ritirò che dopo munita la città di un altro governo. Sciaguratamente, a lui successe Lionetto Cipriani, bonapartista disonoratosi al quarantotto nella repressione di Livorno.
I reggitori provvisori di Toscana mandarono a Torino il segretario Celestino Bianchi, al quale il re promise di ritentare a primavera la guerra con le sole forze italiane, mentre Cavour gli consigliava di costituire subito un governo deliberato di resistere a pressioni diplomatiche e ad assalti armati. Di Firenze rimase ministro dittatore Bettino Ricasoli.
Mentre a Zurigo stava per riunirsi il congresso della pace, bisognava che le provincie abbandonate dai principi e dal Piemonte affermassero vigorosamente il proprio diritto italiano e la propria maturità civile, reggendosi da sole senza dare in eccessi. Un'altra guerra sarebbe quindi stata necessaria per ricondurvi i principi spodestati; ma l'imperatore Napoleone, ancora [46] alleato del Piemonte e compromesso da troppe affermazioni favorevoli alla nazionalità italiana, non avrebbe potuto ridiscendervi; l'Austria, non ancora rimessa dal disastro patito, col rivincere un'altra guerra avrebbe riconquistato sull'Italia l'antica supremazia, mentre la Francia non poteva consentirlo. Restava il pericolo della costituzione nell'Italia centrale di un grosso stato sotto un Bonaparte: a questo doveva opporsi il voto delle popolazioni, secondato dall'interesse delle diplomazie europee.
La nuova politica delle provincie insorte era fatalmente designata entro i due termini della rivoluzione e della monarchia.
Quindi Luigi Carlo Farini a Modena, quasi sotto il tiro dei cannoni austriaci, vi si caccia risolutamente. Deciso a convocare i comizi e a costituire parlamenti regionali, li previene con superba arditezza promulgando subito lo statuto, i codici e le leggi del regno sardo: apre gli archivi e getta al pubblico senza un commento le prove infami delle passate signorie. Il 14 agosto raduna i comizi modenesi; il 18 il Ducato di Parma gli offre la dittatura, ed ambo le assemblee unanimemente deliberano la decadenza dei duchi e l'annessione a Casa Savoia, riconfermando la dittatura al forte rivoluzionario. Quindi i due parlamenti si prorogano per non essere riconvocati che per chiamata del dittatore.
A Bologna Lionetto Cipriani, riuscito governatore per opera del marchese Gioacchino Pepoli, uno dei tanti parenti cui l'imperatore Napoleone aveva assegnato un piatto di cinquantamila lire annue, costretto ad inaugurare col 1º settembre il congresso dei rappresentanti delle Romagne, arrivava al medesimo risultato: l'assemblea eleggeva Marco Minghetti a presidente, votando l'abolizione del governo temporale e l'annessione al regno sardo di Vittorio Emanuele.
A Firenze, nella tornata del 20 agosto, l'assemblea uscita dai comizi popolari decretava unanimemente la decadenza dei Lorenesi e l'annessione della Toscana al [47] Piemonte, raccomandando la giustizia della propria causa allo stesso senno di Napoleone III e delle altre maggiori potenze. Infatti si erano già mandati oratori a Londra, Parigi, Berlino e Pietroburgo.
Quindi i quattro piccoli stati si stringono a lega militare. Farini, più ardente e teatrale, vorrebbe raddoppiarla con una lega politica, ma Ricasoli vi si oppone. Nella lega militare erano tosto cominciati gli screzi: Farini stesso temeva di ammettervi le Romagne che in una rivendicazione pontificia consentita dai grossi governi avrebbero potuto trascinare nella propria rovina gli altri stati. Marco Minghetti, plenipotenziario per la Toscana, trovò col Farini questo meschino ripiego, che Bologna dovesse formulare la propria domanda di accessione alla lega militare in guisa che Modena e la Toscana rimanessero svincolate verso di essa da qualunque impegno, nel caso di un intervento militare europeo nello stato pontificio «o di gagliardo assalto dell'esercito papale». Così l'egoismo regionale e lo spirito regio viziavano ancora l'idea rivoluzionaria. Alla lega politica Ricasoli si oppose con profonda sagacia per non offrire alle diplomazie maggiore facilità di costituire un regno nell'Italia centrale. Capitano della lega militare il Piemonte mandò in Manfredo Fanti il proprio generale migliore; Garibaldi, preso congedo il 7 agosto dall'esercito sardo, aveva assunto, per invito di Ricasoli, il comando delle truppe toscane, sotto gli ordini di Fanti.
Al quesito del come presentare al re i voti delle popolazioni, Farini rispose colla proposta di una sola deputazione, Ricasoli si ostinò alle quattro: vinse Ricasoli. Ma Vittorio Emanuele non osò accettarli e si limitò a promettere poveramente di patrocinare la causa delle provincie presso l'Europa. L'iniziativa piemontese era dunque cessata. Le assemblee dei quattro stati riconvocati proclamarono allora il principe di Carignano loro reggente in nome di Vittorio Emanuele (6-9 novembre); Napoleone sempre avviluppato nelle stesse ambagi, dopo aver risposto che non si farebbe [48] violenza alla volontà degl'italiani, telegrafò al re di ricusare la reggenza poichè manderebbe a monte il congresso di Zurigo e gli farebbe perdere l'Italia. Cavour nella solitudine di Leri fu invocato consigliere. Naturalmente il problema così posto essendo insolubile, si dovette bizantineggiare: d'accordo con Napoleone Vittorio Emanuele invece di accettare i voti delle popolazioni li accolse, e il Boncompagni fu nominato reggente per il principe di Carignano reggente pel re.
Mentre la diplomazia piemontese discendeva a così umili sofisticherie, le popolazioni fremevano d'impazienza, ma senza passione di guerra. Mazzini, penetrato in Toscana, aveva dovuto chiudersi prigioniero incognito in casa del tribuno Dolfi sotto sicurtà data da questo al Ricasoli che niuno lo avrebbe saputo. Aurelio Saffi, arrestato a Torino, aveva dovuto ripassare la frontiera; Alberto Mario e sua moglie, nobile scrittrice inglese fervida d'entusiasmo italiano, erano incarcerati a Bologna per ordine di Lionetto Cipriani. Altri illustri mazziniani venivano espulsi o imprigionati. Mazzini, aiutando generosamente il moto, avrebbe voluto dal paese qualche prudente riserva prima di abbandonarsi alla dinastia di Savoia, che non osava nemmeno accettarlo; e non comprendeva come ogni riserva essendo un passo verso la republica, ne fosse parimenti un altro contro la monarchia. Tutta la elasticità del suo sentimento patriottico non poteva vincere l'inflessibilità del suo sistema republicano. Il disegno da lui proposto di fondere i quattro piccoli stati in uno e di trasformare la loro assemblea in nocciolo di futura assemblea nazionale, proseguendo la guerra contro l'Austria e spingendo la rivoluzione nel reame per decidere poi, dopo la vittoria, se l'Italia dovesse reggersi a monarchia o a republica, esautorava anticipatamente il Piemonte. Le annessioni non potevano essere allora che incondizionate: la monarchia discussa avrebbe conchiuso alla republica, la quale era impossibile. Egli stesso, intransigente eroico, comprendendo [49] la necessità per l'impero napoleonico di conservare Roma al papa consigliava alla grande urbe di non muoversi per non complicare il già troppo aggrovigliato problema italiano.
Ma se il suo spirito rivoluzionario manteneva le Provincie salde nel proposito di formare col Piemonte un grosso regno nazionale, il suo sistema, reso più inapplicabile dalle complicazioni diplomatiche, accresceva le difficoltà delle annessioni colla trascendenza di una democrazia republicana, che si risolveva in una critica sanguinante di tutte le necessarie affermazioni del momento. La generosità del suo sacrificio in favore della monarchia savoiarda, pur di sottrarre le provincie al pericolo di un regno buonapartista, non era creduta; la sua propaganda esorbitava fatalmente la sua popolarità; i suoi seguaci, il suo genio stesso, lo rendevano altrettanto necessario allo spirito nazionale che impossibile nell'azione politica.
Quindi dovette riprendere la via dell'esilio, scrivendo una lettera a Vittorio Emanuele per eccitarlo con malinconica eloquenza all'impresa d'Italia.
Garibaldi, sorvegliato da Ricasoli, tenuto a bada da Farini, sottomesso a Fanti, quasi prigioniero del proprio stato maggiore, abbindolato con buone parole dal re, insisteva indarno a Modena per aprire la campagna contro il papa. La politica cavouriana, che lo aveva chiamato a Torino per la guerra contro l'Austria senza lasciargli nè iniziative nè glorie, lo perseguitava abilmente nei nuovi governi: si voleva la sua presenza, non la sua opera. Cipriani per ordine di Napoleone III lo angariava; si bistrattavano i Cacciatori delle Alpi; i generali Mezzacapo e Rosselli, subordinati a Garibaldi, avevano ordini dal ministero piemontese di non ubbidirgli, mentre lo si mandava al confine di Rimini come ad iniziarvi la guerra. Le popolazioni si agitavano; dalle incertezze crescevano i sospetti. Finalmente, l'opera antipatriottica del Cipriani offese, l'Assemblea lo costrinse a dimettersi, ed acclamò dittatore Farini proposto prima da Garibaldi stesso. Allora la lotta [50] scoppiò fra i due rivoluzionari: Farini, incredulo dell'unità italiana, non mirava che a costituire col Piemonte un più grosso stato; Garibaldi, sprezzante di tutte le difficoltà diplomatiche, voleva appunto nell'inerte imbroglio di tutti i governi compiere la rivoluzione italiana marciando al sud. Questi gl'intimò di cedergli la dittatura, ma il dittatore resistè, il re s'interpose e Garibaldi si dimise.
La sua grande ora non era suonata.
Intanto la destituzione del Cipriani a Bologna finiva di persuadere a Napoleone III l'impossibilità di un regno d'Etruria: le popolazioni dell'Italia centrale vi erano francamente avverse e contraria l'Europa. La sua doppia politica, colla quale faceva costringere insolentemente dal ministro Walewski il Piemonte e le altre provincie all'osservanza dei preliminari di Villafranca, mentre lusingava personalmente i legati italiani sul rispetto ai voti delle popolazioni, si sbrogliò: bisognava cedere l'Italia centrale al Piemonte e trarne come prezzo la già rinunciata cessione di Nizza e di Savoia. Il congresso di Zurigo, al quale l'Austria si presentava col linguaggio di Metternich, non doveva dunque riunirsi, giacchè Prussia e Russia l'avrebbero irresistibilmente sostenuta. Laonde, mentendo il proprio pensiero, scrisse a Vittorio Emanuele una lettera, nella quale peggiorava la confederazione proposta dall'Austria, col tramutare Modena dalla casa d'Este alla duchessa di Parma, col riconsegnare la Toscana accresciuta di alcuni territori pontifici all'arciduca Ferdinando, e col dichiarare Mantova e Peschiera fortezze federali. Vittorio Emanuele e l'Austria protestarono. Poco dopo, in un opuscolo come quello ispirato al Laguerronière sul principio della guerra, esortò la Santa Sede a contentarsi d'un dominio più ristretto, poichè l'imminente congresso avrebbe dovuto fatalmente toglierle le Legazioni: all'ultimo giorno dell'anno (1859), in una lettera autografa a Pio IX, con frasi più miti ripetè la stessa idea. L'Austria chiese al gabinetto francese se sosterrebbe tali proposte al congresso, e dietro [51] risposta affermativa dichiarò di non intervenirvi, protestando a nome dei principi spodestati: il papa svillaneggiava in un discorso solenne l'opuscolo imperiale. L'imperatore sostituì nel ministero il Thouvenel al Walewski; quindi il congresso abortì.
Contemporaneamente il conte di Cavour risaliva sulla scena politica.
Già nel proprio ritiro di Leri aveva conservato la direzione spirituale del moto. Corte, ministero, deputazione lo consultavano. L'atteggiamento risoluto delle provincie contro l'installazione di un principe buonapartista a Firenze, la forzata inazione dell'Austria, l'impossibilità per la Francia di un'altra guerra contro l'Italia, la gelosia di tutta Europa contro ogni ingrandimento napoleonico, gli scopersero la possibilità di ottenere l'annessione dell'Italia centrale al Piemonte. Il mazzinianismo era troppo debole per contrastarla republicanamente, Garibaldi troppo generoso per ribellarsi al re, i governatori delle provincie insorte troppo abili per lasciar sviare il moto annessionista.
La stella di Cavour risorgeva, tutti sentivano in lui il più destro dei negoziatori.
Il ministero Rattazzi-Lamarmora, succeduto al suo, aveva stentato a fronteggiare la situazione. Sessantamila francesi accampavano ancora in Lombardia a difesa contro l'Austria e dei patti di Villafranca, fors'anche a nuova conquista napoleonica nell'Italia centrale; l'Austria domandava oltre l'indennità di guerra 600 milioni come quota del debito generale dell'impero e di quello particolare di Lombardia; le provincie insorte basivano sotto l'incubo di una minacciata restaurazione; tutte le diplomazie d'Europa insistevano per l'esecuzione della pace di Villafranca.
Naturalmente il ministero, colla tradizionale ambiguità della politica savoiarda, dovette favoreggiare segretamente [52] le annessioni ed osservare apertamente i patti di Villafranca. Bisognava anzitutto negoziare la pace coll'Austria imbaldanzita dal contegno remissivo dell'impero francese. Il Piemonte, vincitore subalterno, veniva trattato come un vinto. Dacchè la Lombardia era stata ceduta a Napoleone III, Vittorio Emanuele doveva pagarne il prezzo; dopo molte trattative si convenne che il Piemonte assumesse ⅗ del debito del Monte Lombardo-Veneto e una quota di 40 milioni di fiorini sul prestito nazionale del 1854. Il letto del Mincio restò diviso fra le frontiere dei due stati, e il raggio della fortezza di Peschiera fu ridotto da sette a tre chilometri.
Il 10 dicembre si segnarono i tre trattati di pace: il primo tra Francia ed Austria risolveva la questione politica e territoriale d'Italia, riconfermando il disegno di una confederazione sotto la presidenza onoraria del pontefice e mantenendo intatti i diritti dei principi spodestati: però non si stabiliva intervento militare per ricondurre costoro sul trono, quantunque il Piemonte avesse dovuto aderire a tale disegno federativo. Il secondo tra Francia e Piemonte trattava della cessione della Lombardia a quest'ultimo. Il terzo fra le tre potenze unite assettava tutti gl'interessi estranei alla clausola posta dal re di Sardegna ai preliminari di Villafranca. Colla stipulazione della pace di Zurigo cessavano i pieni poteri accordati dal parlamento subalpino alla Corona; ma il ministero, fingendo di non accorgersene, proseguì a legiferare per decreto reale.
Però, se una rapida unificazione legislativa era il maggior bisogno del momento, il ministero nell'abbandonarvisi impetuosamente commise un triplo errore; anzitutto volle applicare tosto alla Lombardia le leggi amministrative piemontesi, non solo inferiori a quelle sopravissute della sua antica vita municipale e rispettate persino dall'Austria, ma peggiori della medesima amministrazione austriaca. Così falsavasi ogni originalità paesana per vanità di un cattivo modello. Poi le leggi emanate a fasci generarono una indicibile confusione [53] e un maggiore dispendio, mentre il paese doveva sopportare l'aumento di spese per la guerra patita e per l'impianto del nuovo governo. Finalmente le leggi piemontesi, nella loro asprezza monarchica e col carattere reazionario del passato, parvero dettate da un pensiero di conquista regia: l'arbitrio ministeriale, col prescindere in esse dal concorso del parlamento, finiva d'esasperare la publica opinione. L'antagonismo regionale rifermentò; i lagni di Lombardia echeggiarono nell'Italia centrale.
Il conte di Cavour, tutto inteso a riaffermare la direzione degli affari, sollevò la questione della riconvocazione del parlamento, ponendola come ultimatum alla sua accettazione di ministro plenipotenziario al congresso di Parigi; ma per meglio offendere i ministri, invece di scrivere loro, dettò la lettera a sir James Hudson. Questo stratagemma decise della ritirata del ministero, che vide nella lettera del legato inglese una insolente ingerenza di diplomatico straniero nelle cose di stato.
Cavour chiamò seco al ministero il generale Manfredo Fanti per la guerra, Stefano Jacini pei lavori publici, Terenzio Mamiani per la publica istruzione. Il suo disegno politico era semplice: barattare francamente Nizza e Savoia coll'Italia centrale; ma la politica annessionista aveva d'uopo del concorso parlamentare per perdere l'arbitrario carattere regio.
Così Cavour, passando sopra ogni regolarità di procedura, decise di ammettere al parlamento i deputati dell'Italia centrale.
Napoleone stesso suggerì a Cavour l'idea di un nuovo plebiscito delle provincie. Il risultato ne fu splendido. I comizi della Toscana e dell'Emilia convocati (11-12 marzo 1860) per pronunziarsi tra l'unione al regno costituzionale di Vittorio Emanuele e il regno separato diedero questi risultati: nell'Emilia su 526,258 elettori iscritti votarono 427,512, dei quali 426,006 per l'unione alla monarchia sarda; in Toscana votarono 386,445, dei quali 366,571 per l'annessione e 14,925 [54] pel regno separato. Il voto fu a suffragio universale, mentre l'elettorato politico nello statuto piemontese era il più ristretto d'Europa. In questa contraddizione stava il riconoscimento della sovranità nazionale tanto caldeggiato da Mazzini; lo statuto era la monarchia, il suffragio universale la rivoluzione; quella la forma, questa l'idea: il cittadino votando pel re si affermava sovrano, così che la monarchia costituzionale non avrebbe mai più potuto soverchiare il diritto popolare.
Compita l'annessione dell'Italia centrale, facendo riaffermare dal re la propria devozione al pontefice come principe cattolico, Cavour potè sciogliere finalmente la vecchia camera sarda ridotta da oltre un anno a poco più di un nome, e bandire le elezioni in tutte le provincie del nuovo regno. Farini passò al ministero dell'interno, Ricasoli rimase come governatore generale al fianco del principe di Carignano luogotenente del re a Firenze.
Senonchè, ottenute le provincie, si dovette subito pagarne il prezzo. La Savoia, fino dal trattato di Brosolo considerata come scotto alla Francia per un qualunque ingrandimento piemontese nella valle del Po, sebbene situata al di là delle Alpi, e francese di spirito, e annessa alla Francia dalla grande rivoluzione del'89, aveva dato il nome, la bandiera e la storia alla dinastia che stava per diventare nazionale: Nizza, conquistata dal Conte Rosso nel 1388, era doppiamente italiana come patria di Garibaldi; poi la loro cessione da re ad imperatore negava tutto il diritto politico della nuova rivoluzione. Fra i trionfi della sovranità popolare ricominciavano i mercati di popolo. Napoleone, col disertare la causa italiana al Mincio e col cercare ogni via ad impedire le annessioni dell'Italia centrale al Piemonte, aveva perduto anche i diritti stipulati a Plombières.
[55] Tutta la democrazia italiana si scosse: il popolo ne fu malinconico. Invano i giornali del ministero affettarono il più mercantile cinismo per persuadere la cessione; l'offesa alla coscienza nazionale anzichè placarsi s'inveleniva. Re Vittorio mormorò con poetica tristezza, alludendo a Napoleone: «Dopo avergli data la figlia bisognerà cedergliene la culla!»; Garibaldi ruggì; Mazzini moltiplicò articoli, invettive, proteste; alle Camere l'opposizione si disciplinò a battaglia. Per un momento parve che l'Europa medesima si opponesse alla cessione: l'Inghilterra per poco non trascorse a minaccie; Thouvenel la vinse, rispondendo che l'annessione della Savoia alla Francia non era politicamente diversa da quella della Toscana al Piemonte; l'Austria invece per dispetto la favoreggiò; la Svizzera invocò indarno i trattati di Vienna, pei quali alcuni territori savoini essendo stati introdotti nella sua neutralità, essa resterebbe così colle frontiere indifese.
Napoleone ammansì l'Inghilterra con un trattato di commercio libero-scambista, non tenne calcolo della Svizzera, minacciò coi propri giornali il Piemonte. La fatalità della politica cavouriana costrinse questo a cedere: il conte di Cavour stesso, assumendo arditamente alla Camera la responsabilità del triste atto, ebbe il coraggio di confessarlo.
Alla Camera, ove sedevano per la prima volta i deputati delle provincie annesse, la discussione fu tempestosa: Guerrazzi vi gettò lampi di eloquenza fra scrosci di sarcasmi, ai quali nullameno Cavour potè efficacemente rispondere; Urbano Rattazzi riapparve terribile di logica e di abilità, accusando i ministri dell'inutile ed indegno mercato; ma la fatalità del sistema regio prevalse: 229 voti su 262 votanti approvarono la cessione (22 maggio 1860).
Il trattato era stato sottoscritto il 24 marzo dal ministro Benedetti e dal principe di Talleyrand per l'imperatore, da Cavour e da Farini per Vittorio Emanuele; siccome però statuiva che l'annessione delle due [56] provincie alla Francia dovesse effettuarsi col consenso dei popoli, a larvarlo nella publica opinione s'indissero a Nizza e nella Savoia plebisciti, che oro e pressioni di governo fecero riuscire a favore della Francia.
Così finiva la conquista regia: nel suo primo giorno Vittorio Emanuele non aveva osato accettare la Toscana, nell'ultimo cedeva la Savoia; l'iniziativa francese aveva voluto la guerra, l'iniziativa piemontese vi si era associata; la Francia aveva respinto l'Austria dalla Lombardia, il Piemonte aveva ricevuto in regalo dal vincitore il campo di battaglia; l'Italia centrale era sfuggita mercè la propria energia alle lusinghe e alla minaccia di un regno bonapartista, ma la dinastia sarda, che non aveva ardito nè conquistarla nè accettarla, la otteneva ora dalle mani del proprio prepotente alleato col baratto di altre due provincie. La rivoluzione soccombeva alla monarchia, il Piemonte alla Francia, mentre l'Italia rimaneva divisa in quattro stati coll'Austria, il papa e il Borbone.
La politica regia non poteva andare oltre, l'Italia non pareva capace di sforzo maggiore.
Lo scarso numero de' suoi volontari alla guerra, che non superò i cinquantamila, la sommissione mostrata nel periodo annessionista, l'inerzia del reame che nemmeno le vittorie sui campi lombardi avevano potuto sollevare, l'atonia di Roma, la fiacchezza delle provincie pontificie riconquistate da un pugno di sgherri fra l'indifferenza di tutte le altre, l'abbandono dell'ideale republicano come troppo costoso di denaro e di sangue, la pazienza per tutte le prepotenze francesi, la stessa calma, che aveva reso ammirabile all'Europa il contegno del popolo, tradivano la debolezza della nazione.
Mazzini veniva abbandonato da tutti. Garibaldi non era ancora seguìto che da pochi.
Si era fidato nella Francia e nel Piemonte, accettando da entrambi quanto potevano dare. Invece di eserciti improvvisati ed irresistibili di passione si erano mobilizzate le guardie nazionali, innocua ed inartistica [57] parata di teatro. L'esercito regolare sardo era stato bello di disciplina e di valore, i volontari garibaldini incomparabili di originalità e di eroismo, ma della guerra popolare era mancato persino il fermento. Mazzini aveva sperato in cinquecentomila volontari; Garibaldi ne chiedeva centomila, e non era arrivato che ai dodicimila. L'iniziativa regia aveva in certo modo disinteressata l'iniziativa popolare.
Rivoluzionari, regii e republicani non erano che una minoranza, la quale senza l'intervento francese non avrebbe mai potuto fare nè la guerra nè la rivoluzione.
Il Piemonte, uscendo ingrossato dall'una e dall'altra, aveva di poco migliorato la propria condizione. L'Austria non aveva che a ripassare il Mincio per riprendere in una settimana tutta la Lombardia; verso Francia il nuovo stato era senza frontiere, mancava di comunicazioni col sud; il vassallaggio all'impero napoleonico gli scemava l'antica indipendenza; l'ostilità alla rivoluzione lo indeboliva all'interno; aveva esauste le finanze, fallito il programma, assunti impegni ineseguibili. L'unità d'Italia era negata come al quarantotto.
Le prime integrazioni rivoluzionarie non avevano potuto attuare che una parte dello stesso disegno regio di Plombières: ma senza Venezia, senza la Sicilia, senza Napoli e senza Roma l'Italia non era. La prodezza di Vittorio Emanuele, l'abilità diplomatica di Cavour, non bastavano all'Italia: la fusione della valle del Po era la parte più facile dell'unificazione nazionale; ma poichè nè Roma era insorta, nè Napoli si era sollevata durante la guerra franco-sarda, a fonderle coll'Italia bisognava conquistarle.
L'iniziativa regia non era da tanto. Infatti il primo atto della nuova politica piemontese fu di sollecitare l'alleanza di Francesco II, per impedire a Napoli ogni moto rivoluzionario.
Solo un'impresa temeraria come un'avventura, splendida come una visione, irresistibile come una profezia, [58] improvvisa, piccola, assurda, raccolta su due barconi sconnessi come quelli di Cristoforo Colombo, con un esercito non maggiore di quello di Cortez, senz'altra fede che la vittoria, altro amore che di patria, altra probabilità che di morte, con un capitano invincibile come un messia, senza danaro, quasi senz'armi, poteva approdando in Sicilia appiccarvi il fuoco della rivolta, assalire fortezze, liberare città, moltiplicare le battaglie come spari di festa; quindi più forte, più rossa del proprio e del sangue nemico, lanciarsi pazzamente fra Scilla e Cariddi, afferrare il continente, passare come una vampa per le Calabrie, correre su Napoli, sbaragliando eserciti, stordendo popoli, ministri, re, e, sollevando tutto un regno, che sentimenti, idee, costumi, storia rendevano tanto dissimile dal resto d'Italia, gettarlo in seno alla nazione e farne una patria sola.
Giuseppe Garibaldi doveva guidare quest'impresa.
Il vasto reame delle due Sicilie sembrava assistere con ignava curiosità al grande dramma della liberazione d'Italia: dopo tanto fervore di congiure, non vi restava abbastanza passione patriottica per osare d'insorgere contro il governo borbonico in tanta facilità di momento. L'Austria vinta non avrebbe potuto soccorrere re Francesco II; la Francia sarebbe stata favorevole per ambizione di un altro regno murattiano; l'Inghilterra per antagonismo coll'impero napoleonico avrebbe invece favorito un moto nazionale; Garibaldi era pronto ad accorrere colle bande rosse; il Piemonte, volente o nolente, avrebbe dovuto spingere sino al mezzogiorno la propria politica annessionista.
Re Francesco II, salendo al trono, aveva dichiarato all'ambasciatore russo Kisselef di ignorare che cosa potesse significare la indipendenza italiana; quindi, sollecitato d'alleanza dal Piemonte prima e dopo la guerra, aveva ricusato per chiudersi in una sprezzante neutralità; più tardi, costretto a mutare i vecchi cattivi ministri, ne aveva scelti di peggiori; e fingendo colla duplicità paterna di cassare la legge sugli attendibili o sospettabili politici l'aveva invece mantenuta con una circolare segreta del direttore di polizia, che poi dovette sconfessare. Un ignobile egoismo ed una insensata alterigia gli toglievano di comprendere il significato [60] fin troppo evidente di una situazione politica, nella quale la sua corona era minacciata da nemici di ogni sorta. La sua fede all'Austria e al papa, che avrebbe potuto essere cavalleresca alleandosi con loro contro la rivoluzione, non era che servilità di bigotto e di vassallo; la sua avversione alla libertà non derivava che da una vanità di despota senza carattere e senza ingegno. Ultimo di una famiglia di tiranni e di malvagi, al pari di tutte le vittime designate all'espiazione di una decadenza, non era più che un melenso, cui la rivoluzione trionfante spazzerebbe fra poco come un'immondizia, invece di spezzare come un ostacolo.
La sua sola idea politica in tanto frangente di guerra fu di una spedizione a favore del papa per aiutarlo a risottomettere le Romagne, ma nemmeno questa eseguì. Quindi, essendosi ammutinati gli svizzeri pel decreto del governo federale elvetico, che dopo le stragi di Perugia vietava il nome patrio e gli stemmi cantonali ai mercenari militanti per la Santa Sede e pel Borbone, egli disciolse il loro corpo grosso di 14,000 soldati, e lo sostituì portando la leva ordinaria della milizia stanziale a 18,000 coscritti. Al finire dell'anno (1860) l'esercito borbonico sommava a 100,000 uomini, ma senza merito negli ufficiali, senza valore nei soldati, senza patria, senza ideale. Una indescrivibile indisciplina no sconnetteva gli ordini: i volontari vi erano ribaldi di piazza o di polizia, i coscritti piuttosto fantocci che fanti, poco disposti a battersi, incapaci di morire combattendo.
Nullameno il loro numero bastava per togliere ai rivoluzionari del paese, così pronti a contarsi per migliaia, ogni velleità di rivolta. I più forti fra questi credettero far molto costituendo coll'inguaribile bizantinismo delle loro procedure un comitato a doppia assemblea dei iuniori e dei seniori, che più tardi si mutò in quello dell'Ordine per spargere qualche bollettino anonimo o gettare nei teatri qualche nastro tricolore col motto: «Italia e Vittorio Emanuele».
[61] D'altronde il conte di Cavour, mandando il Villamarina a Napoli, gli raccomandava vivamente di sconsigliare i liberali da moti violenti, «giacchè qualsiasi rivoluzione nelle due Sicilie riuscirebbe rovinosa all'Italia». Allora l'illustre statista non vedeva altra salute alla politica nazionale contro le tendenze republicane che nell'alleanza del Piemonte col Borbone.
Ma la rivoluzione urgeva. La prima mossa ne venne dalla Sicilia.
Già dopo i casi del '57 essendosi sciolto il comitato di Londra, nell'impossibilità di ritentare efficacemente altra insurrezione in Lombardia, il partito rivoluzionario non tardò a comprendere, che per resistere all'egemonia piemontese bisognava creare una forte base alla politica unitaria nel Reame. Nicola Fabrizi, Alberto Mario, Francesco Crispi, Maurizio Quadrio, Michele Amari si diedero con forte proposito al difficile lavoro: comitati aiutavano da Malta e da Genova; patrioti come Emilio Sceberras, Giorgio Tamaio, Onofrio Giuliano, Emanuele Pancaldo cooperavano con nobile coraggio all'interno. Ma le difficoltà erano troppe. Le popolazioni bigotte e svogliate, ignoranti e servili; mal compreso il nome d'Italia, incompreso affatto quello di democrazia; difficili le comunicazioni fra paesi e paesi separati ancora da fieri odi municipali; il feudalismo economico e politico tuttora vigile nell'angustia dei propri privilegi; i Borboni più temuti che odiati; nessuna abitudine di guerra malgrado il costume del brigantaggio; gli stessi liberali divisi nelle fazioni murattiana e piemontese. Di questa era capitano attivo e di molto seguito il La Farina. Nè il continente nè l'isola erano pronti a vera rivoluzione: nullameno colla guerra franco-sarda si spinse più vivamente il lavoro delle cospirazioni. Francesco Crispi, aiutato dal Fabrizi reduce in Modena sua patria dal lungo esilio, ne tenne discorso al dittatore Farini, che si mostrò favorevole ad un'impresa nel sud: già cimentando intrepidamente la vita, Crispi era penetrato parecchie volte nella Sicilia per introdurvi armi e [62] bombe all'Orsini. Ma la politica cavouriana venne ad impedire l'opera, facendo dal La Farina dissuadere ogni moto violento per non imbrogliare il problema già difficile delle annessioni al nord. Questo consiglio bastò naturalmente a scusare la troppa prudenza dei più; i pochi intrepidi rimasero abbandonati e sbandati. Oramai l'insurrezione era piuttosto contrastata dal partito moderato che dal borbonico.
Un'ispirazione giovanile trionfò della ragione di tutti. Un gruppo di giovani scrisse spontaneamente e segretamente a Garibaldi, scongiurandolo «ad affacciarsi sul loro continente con un pugno di uomini e una bandiera consacrata dal suo alito». Il generale da Bologna (2 settembre 1859) rispose incoraggiando e promettendo. Intanto Crispi coi comitati di Genova, di Firenze e di Malta ordiva per il 4 ottobre (1859) un'insurrezione a Palermo; Messina e Catania dovevano seguire; ma anche questa volta la cospirazione abortì, e la colpa al solito ne fu gettata sui contrordini del partito lafariniano. Allora Crispi e Fabrizi ritentarono l'animo di Farini: si convenne fra loro di una spedizione di volontari nel sud. Farini promise un milione, previo il consenso del ministero piemontese; siccome i Cacciatori delle Alpi potevano facilmente formare il nuovo corpo di spedizione, si pensò di radunarli all'isola d'Elba, mentre Garibaldi era già ritornato a Caprera. Ma Crispi non potè persuadere il ministro Rattazzi all'impresa: fu negato ogni denaro, conteso ogni aiuto. Cavour risalito al potere si chiarì anche più ostile, vessando così indegnamente colla polizia il Crispi da costringerlo ad abbandonare Torino.
Garibaldi, conscio di tutti questi maneggi, addolorato della cessione di Nizza e Savoia, isolato dalla vita politica con ogni intrigo da Cavour, meditava incerto del risolvere. Mazzini invece, spinto all'ultimo sacrificio di se medesimo dalla rovina di tutti gl'ideali, insisteva per una pronta azione del sud, rinunciando alla republica pur di raggiungere l'unità della patria. Le sue lettere ai palermitani, nelle quali scopriva con [63] mano sicura i viluppi della politica cavouriana e bonapartesca, non parlavano più che di unità nazionale: il republicano era vinto, il patriota lottava ancora.
L'abdicazione di Mazzini, l'impotenza di Cavour, l'inerzia forzata di Napoleone, il fermento di tutta la penisola, la fatalità della rivoluzione affrettavano silenziosamente l'azione di Garibaldi.
Oramai tutte le gradazioni dei partiti politici si fondevano in lui. La sua formula «Italia e Vittorio Emanuele», rimasta inalterata malgrado l'esosità dei trattamenti usatigli dal governo, riuniva le forze regie e democratiche per un programma, che, esorbitando dall'angustia della politica piemontese, ne riconfermava l'idea di una conquista regia. Il suo primo disegno della nazione armata, per organizzare militarmente davvero le guardie nazionali e pacificare i partiti, aveva naturalmente fallito, giacchè una organizzazione politica e militare d'Italia con metodo popolare era impossibile; nullameno egli restava programma vivente della nazione, altrettanto infallibile nell'intuizione che malleabile nell'eroismo.
All'alleanza franco-sarda, che aveva battuto l'Austria senza cacciarla da tutti i confini d'Italia, doveva succedere l'alleanza sardo-italiana, che caccerebbe i Borboni senza poter rovesciare il papa. Napoleone III aveva bistrattato Vittorio Emanuele: questi maltratterebbe Giuseppe Garibaldi.
La rivoluzione italiana, ispirata da Mazzini, guidata da Cavour, concentrata da Vittorio Emanuele, signoreggiata da Napoleone, si era arrestata fatalmente alle annessioni dei Ducati nell'imbroglio della propria politica, per ritornare nazionale e popolare con Garibaldi, unitario come Mazzini, monarchico quanto Cavour, più prode di Vittorio Emanuele e più avventuriero di Napoleone III. Mentre tutte le diplomazie d'Europa si spiavano temendo di nuova guerra, egli solo poteva riaccenderla per conquistare un regno al Piemonte, che avrebbe cercato sino all'ultimo d'impedirlo; egli solo, sotto tanto cumulo di pregiudizi, di dolori, [64] di viltà, poteva trovare il cuore del popolo italiano e, infiammandolo coll'entusiasmo di una fede indefinibile, dargli la trionfatrice energia delle più incredibili fra le vittorie di questo secolo.
Infatti la necessità di questa impresa meridionale lo stringe più forte ogni giorno. Mentre il governo piemontese contrasta, i patrioti siciliani incalzano. Rosolino Pilo e Giovanni Corrao si offrono per un viaggio nella Sicilia, esploratori di libertà fra pericoli ed episodi degni di un poema. Il 4 aprile (1860) Palermo tenta una rivolta presto soffocata nel sangue; la polizia trionfa ancora; i congiurati, raccolti nel convento della Gancia e soccorsi dagli stessi frati, sono trucidati o imprigionati. Nullameno qualche banda di essi può guadagnare i monti. A Genova le notizie dell'insurrezione si ripercotono in tumulto, le fantasie si esaltano, i cuori si scaldano. La Legione Sacra composta di vecchi patrioti e di giovani volontari vi si aduna, proclamandosi disposta a partire con Garibaldi ed anche senza lui: Mazzini offre a Nino Bixio e a Giacomo Medici il comando dell'impresa, se Garibaldi ricusi: Cavour, temendo che questi accetti e non potendo palesemente impedirlo, cerca ne sia capo il Ribotti. Ma Garibaldi solo può guidarla, rappresentando tutto il popolo italiano; Ribotti non è che un prode venturiero della libertà; Nino Bixio, coraggioso sino alla demenza, non può essere che un luogotenente; Medici, caduto nell'orbita della politica cavouriana, non saprebbe capitanare la rivoluzione.
Ma Garibaldi, cui la coscienza della grande responsabilità non scema il coraggio, tituba ancora: dopo le vittorie franco-sarde in Lombardia, il disastro di un'altra spedizione Pisacane annullerebbe la rivoluzione. Nullameno la grande ora sta per discendere sul quadrante della storia; l'impresa è inevitabile. Il colonnello Frappolli e Giacomo Medici mandati da Cavour la combattono: Nino Bixio invece minaccia di andarvi solo. Garibaldi si decide.
[65] A Crispi, che, ostinato nello spronarlo, pure temeva di un incontro colla flotta nemica, Garibaldi risponde:
— Io vi garantisco sul mare.
— E io vi garantisco per terra.
Epilogo di una scena degna di Eschilo!
Ma il governo piemontese moltiplica taccagnerie ed obbiezioni. Poichè nel primo slancio della rivoluzione si era iniziata una sottoscrizione per comperare un milione di fucili, le armi e i primi denari non sarebbero mancati all'impresa; sciaguratamente Cavour ordinò a Massimo D'Azeglio di sequestrare le quindicimila carabine depositate a Milano e Massimo D'Azeglio, persuaso che l'annessione del regno napoletano al Piemonte sarebbe la maggiore delle disgrazie possibili, ubbidì. Rubattino, ricco armatore di Genova, prestò due vecchi vapori, nascondendosi mercantilmente dietro il nome di Segrè, austero patriota. La Farina, stretto dagli esuli siciliani, diede finalmente mille fucili quasi inservibili e ottomila lire; Agostino Depretis, prefetto a Brescia, violando gli ordini ricevuti, consegnò a Giuseppe Guerzoni mandatario di Garibaldi, qualche altro denaro.
Cavour, osteggiando e permettendo al tempo stesso l'eroica avventura, ne calcolava con terribile freddezza di statista tutte le conseguenze. Se Garibaldi falliva, il governo piemontese si pompeggierebbe presso il resto d'Italia e le cancellerie europee delle difficoltà oppostegli; ma la rivoluzione avrebbe così perduto il suo grande capitano, e alla nazione non resterebbe più altra speranza che il Piemonte: con Garibaldi periva il fiore della democrazia italiana, che non aveva ancora accettato o subiva non senza riserve la preponderanza della monarchia piemontese. Se Garibaldi conquistava la Sicilia, il motto «Italia e Vittorio Emanuele» scritto sulla sua bandiera lo avrebbe costretto a cedere l'isola al Piemonte, cui il voto del parlamento siciliano nella rivoluzione del quarantotto aveva in certo modo aderito, offrendo la corona al duca di Genova. L'ammirabile perfidia, che dall'epoca dei [66] comuni sino al finire del rinascimento aveva dato alla politica italiana così irresistibile ascendente su quella di Francia e di Germania da rendere a queste grandi potenze impossibile la conquista d'Italia, e più tardi aveva permesso al Piemonte di crescere nel decadimento d'Italia fra le voraci gelosie dei più grossi vicini, trapelava dalle contraddizioni del conte di Cavour, rimasto ministro piemontese in piena rivoluzione italiana. Egli, primo in Italia a giudicare il Guicciardini molto miglior politico del Machiavelli, ne seguiva i criteri anche in questo supremo momento di epica iniziativa: per lui la monarchia piemontese non aveva in Italia peggior nemico della democrazia e maggior pericolo di una vittoria rivoluzionaria.
L'impresa era unitaria. Garibaldi intendeva sbarcare in Sicilia, gettando un corpo d'armati nello stato pontificio. Non si osava ancora l'idea di marciare direttamente su Roma, ma si voleva sottrarle tutte le provincie. Bisognava come Cesare passare un'altra volta il Rubicone: si sperava che Medici o Cosenz potessero invadere il territorio pontificio; Cavour pareva secondare il disegno. Il papa era in armi, il generale Lamoricière ne guidava l'esercito più grosso che valoroso; il conte De Pimodan capitanava gli zuavi volontari, ribaldi o legittimisti di gran nome, raccolti per tutte le contrade d'Europa. All'ultima crociata papale si contrapponeva così la crociata garibaldina: entrambe nel nome di un'idea mondiale, quella senz'altro principio che il privilegio ed altra virtù che la superstizione, questa colla fede della libertà e un entusiasmo di amore che perdonava ai nemici anche prima di averli vinti.
A Genova Agostino Bertani, medico già celebre, costituì il comitato di soccorso all'impresa, spiegandovi la più prodigiosa energia. I volontari eran quasi tutti giovani colti, ricchi, fanatici di libertà, superstiziosi d'amore al generale come i sicari del Vecchio della Montagna; fra essi brillavano illustri stranieri: Türr e Tuköry ungheresi primeggiavano per nome già famoso [67] di capitani; Sirtori era capo di stato maggiore; Nino Bixio doveva guidare una delle navi, il Lombardo; sull'altra, il Piemonte, precederebbe Garibaldi. Ippolito Nievo, poco più che giovinetto, già immortale per scritti d'arte, era il poeta della spedizione, e doveva perirvi al ritorno miseramente annegato come Shelley; Giuseppe Cesare Abba, quasi un fanciullo, allora ignoto anche a se stesso, doveva invece scriverne i commentari fra il pericolo delle battaglie e la poesia delle veglie; v'erano Acerbi, Mosto, Schiaffino, Nullo bello ed avventato come un moschettiere da romanzo, Fabrizi austero come un duce biblico, i Cairoli, tutti i più prodi, i superstiti legionari di Montevideo, i Cacciatori delle Alpi, i carabinieri genovesi, manipoli di artisti e di letterati, di principi e di cospiratori sopravvissuti alla tortura delle carceri, di esuli frementi nella stanchezza dell'esilio, di politici che cessavano di pensare per votarsi ai rischi dell'azione, di popolani poveri ed ignari che l'improvvisa epopea sollevava fra i più grandi cuori nell'uguaglianza del sacrificio, di disertori dell'esercito piemontese, di republicani, di monarchici: falange uscita dalla nazione come un getto dalle mani di uno scultore, altera, vibrante, serena. Non arrivavano a mille, vestivano borghesemente. Garibaldi non ne aveva voluto altro numero, giacchè anche decuplo sarebbe stato insufficiente, se il popolo laggiù non avesse poi secondato l'impresa. Allora non portavano che un fucile rugginoso e sedici cartucce; nessuna provvigione, non salmerie. La bandiera, dono d'italiani residenti a Valparaiso, ricordava le vittorie d'America, augurando maggiori trionfi.
Il motto era: «Italia e Vittorio Emanuele».
Il 3 maggio (1860), anniversario della morte di Napoleone I, salpavano silenziosamente da Quarto. Il governo piemontese, pur fingendo d'ignorarla, cercò con inutile inganno di contrastare l'imbarcazione; il mare fu propizio. A Talamone, ove approdarono per rifornirsi d'acqua, non rinvennero che poche armi quasi disutili; ad Orbetello un gruppo di republicani intransigenti, [68] capitanati da Brusco Onnis, si separò per non combattere sotto bandiera piemontese; un altro più grosso manipolo s'inoltrò nel territorio pontificio con Zambianchi sanguinario trucidatore di monaci a Roma nel '48 per sollevare le popolazioni; e fu indi a poco disperso dai dragoni papalini.
Ma non ostante le vigili crociere napoletane, Garibaldi potè sbarcare a Marsala. Allora la Sicilia, dapprima attonita, si solleva: Rosolino Pilo e Corrao tengono la campagna con forti bande; a Salemi Garibaldi proclama la propria dittatura e riceve il saluto di una truppa d'insorti, forte di quasi tremila uomini; a Calatafimi rovescia alla baionetta una colonna di cinquemila borbonici; la giornata terribile di ardimento prostra l'animo del nemico; alcuni monaci e qualche picciotto si sono mescolati ai garibaldini, ma i tremila siciliani hanno assistito dalla cima dei colli circostanti alla battaglia, sinistramente equivoci, coll'arma al piede. Presto l'odio popolare contro borbonici e napoletani esplode, scene atroci di sangue vituperano le prime vittorie; ma Garibaldi, raddoppiando di audacia, si drizza su Palermo. I borbonici tengono l'isola con trentamila uomini; ventimila difendono la capitale. Con abili marcie egli inganna quindi il nemico, accenna ad assalire la città dalla parte di Monreale, vi rumoreggia intorno tre giorni, sfianca su Corleone, si tira dietro il generale Bosco con una falsa ritirata, lo allontana da Palermo, lo tiene a bada con pochi legionari, finchè il 27 maggio per vie impraticabili ricompare dinanzi alla città già percossa dalla voce erronea della sua disfatta.
Però la sorpresa essendo fallita, l'assalto diventa al tempo stesso impossibile ed inevitabile.
La guerra, appena incominciata, sta per essere finita colla presa della capitale; la battaglia si muta in delirio. I garibaldini stremati, male armati, poco ordinati, si slanciano all'assalto; tutto cede al loro impeto; entrano travolti dalla fuga del nemico nella città. Ma il presidio, forte di quindicimila uomini, resiste ancora [69] dominando e tuonando dal castello colle artiglierie; la popolazione tituba; s'improvvisano barricate. I borbonici bombardano; per tre giorni una bufera di fuoco e di sangue rugge per l'antica metropoli, drammi sublimi ed orribili vi si amalgamano, monaci e suore incuorano i ribelli; i regi sguinzagliati nelle vie si ostinano alla difesa e si vendicano colla strage. I generali Bosco e Mekel delusi a Corleone ritornano su Palermo, la flotta dal porto fulmina le vie diritte della città; le munizioni scarseggiano; i palermitani, malgrado il crescente entusiasmo, non si armano e non combattono abbastanza. Per un momento tutto parve perduto. Una fregata sarda, alla quale Garibaldi chiese aiuto di munizioni, lo rifiutò mentre l'ammiraglio inglese Mundy con magnanima improntitudine imponeva alla flotta borbonica di cessare il fuoco contro la città. Fortunatamente la viltà del generale borbonico Lanza ridonò la vittoria a Garibaldi, domandandogli un armistizio per ventiquattro ore e prolungandolo poi per tre giorni. In questo tempo venne da Napoli l'ordine di capitolare, sgombrando Palermo. Lo sgombro durò tredici giorni, dal 7 al 20 giugno.
Allora a Palermo tra una festa frenetica, nella quale il popolo smantella notte e giorno l'antica fortezza, si allestisce il governo. Francesco Crispi, il più ostinato persuasore dell'impresa, ne diviene braccio e mente. Anzitutto bisogna spingere oltre la rivoluzione, propagandone l'entusiasmo che alla necessità dei primi sacrifici sta per agghiacciarsi, e domare ripetute atroci reazioni di brigantaggio, nelle quali si prepara forse una regia sollevazione. La minaccia della coscrizione sureccita già gli animi della moltitudine; l'egoismo di una mal celata autonomia vorrebbe sottrarsi alle spese di denaro e di sangue necessarie al compimento della rivoluzione. Fortunatamente, i comitati organizzati per tutta Italia e diretti da Agostino Bertani suppliscono miracolosamente ai bisogni. La Società Nazionale del La Farina, d'accordo con Cavour non aveva dato che poche migliaia di lire: Bertani ne raccolse [70] presto ottocentocinquantamila. Fra difficoltà politiche, economiche, commerciali, militari, tecniche, questo medico nel quale la scienza sperava un illustre e la patria trovò un eroe, seppe improvvisarsi organizzatore come Carnot. Alla prima spedizione dei Mille ne seguirono a minimi intervalli altre. Il disegno, suggerito da Garibaldi prima della partenza e caldeggiato con disperato amore da Mazzini, di una invasione negli stati pontifici per discendere dagli Abruzzi nel Napoletano, mentre il dittatore vittorioso lo risalirebbe dalla punta delle Calabrie, diventava l'inevitabile corollario della spedizione di Marsala, dopo la vittoria di Palermo. Per assicurare la Sicilia bisognava assalire il Reame.
Il fermento aumentava nel paese: volontari accorrevano da ogni parte a Genova per salpare verso il sud, e s'addensavano sui confini dello stato pontificio a minaccia; nell'esercito piemontese spesseggiavano le diserzioni; ufficiali e colonnelli entrativi colla rivoluzione si dimettevano per cacciarsi nella nuova guerra; il moto unitario si dilatava veemente ed irresistibile. Mazzini, sempre più infervorato per un pronto assalto nello stato pontificio, s'era condotto a Genova, e vi operava, nascosto dall'amore dei popolani alla vigilanza della polizia piemontese; d'accordo con Bertani, cercava un altro capitano, cui affidare l'impresa del centro. Medici era già partito con 2000 uomini per la Sicilia; il 2 luglio Cosenz lo seguì con altrettanta truppa; poco dopo il colonnello Corte vi sbarcò con un terzo reggimento.
Garibaldi, agile fra tante difficoltà politiche del governo improvvisato, si sbarazza del La Farina. Poichè la gelosia dell'ascendente guadagnato da Crispi nell'isola spingeva questo agente cavouriano a precipitare le annessioni, per impegolare la rivoluzione entro un immediato impianto di governo piemontese, il dittatore lo imprigiona, lo rimanda in Piemonte, e nomina al suo posto Agostino Depretis, abile parlamentare, più atto ad intendersi col Crispi. Naturalmente questa improvvisazione [71] di governo procede sbattuta fra le contraddizioni delle tendenze piemontesi e rivoluzionarie: quelle, temendo di una dichiarazione di autonoma o di una proclamazione republicana malgrado la ripetuta abdicazione di Mazzini e il motto di Garibaldi: «Italia e Vittorio Emanuele», tirano a sminuire l'opera e l'importanza del dittatore. Si teme il contagio dell'entusiasmo, si diffida sopratutto dei consiglieri di Garibaldi, tutti republicani o quasi; ma questi, più generosi e trascinati dalla fatalità dell'impresa, badano invece ai mezzi di compierla; hanno forse in cuore riserve democratiche, ma sentono già che la monarchia è invincibile.
La guerra ricomincia. Colla stessa rapidità della prima mossa da Calatafimi a Palermo, Garibaldi si dirige dalla capitale su Messina: il suo esercito diviso in tre colonne, traversando l'isola con marcia convergente, deve riunirsi all'assalto della grossa città, dalla quale il generale Bosco, unico prode fra i regi, s'inoltra minacciosamente. La battaglia scoppia (20 luglio) a Milazzo, ostinata, sanguinosa, perchè i borbonici questa volta si battono davvero entro formidabili posizioni: Garibaldi stesso ci resterebbe prigioniero, se Missori e Statella, due ufficiali delle sue guide, con valore ariostesco non lo salvassero da un viluppo di cavalieri; ma finalmente l'irresistibile valore dei volontari trionfa. Milazzo è presa, Messina poco dopo capitola.
La Sicilia è conquistata; ma staccata dal Reame e annessa al Piemonte non sarebbe che un'altra Sardegna. L'impresa di Napoli diventa fatale, l'unità italiana è imminente. A Napoli il meraviglioso approdo di Marsala, la presa di Palermo, la cacciata dei 30,000 regi esaltano le fantasie; gli echi della stampa europea, sonante di inni al vincitore, coprono le critiche più ostinate; l'esercito, diffidente dei generali e mal disposto [72] a guerra, tituba; la corruttela di tutti gli impiegati moltiplica i tradimenti alla vigilia del pericolo; la corte in preda al terrore non osa alcun partito. Russia e Prussia non le prestano più che un appoggio morale, l'Austria non ardisce ridiscendere in guerra, Napoleone III le consiglia di ridare la costituzione secondando l'idea nazionale. Troppo tardi! Il giovane re, incapace di mettersi alla testa dell'esercito e di gettarsi alle campagne per infiammarne la superstizione politico-religiosa, soffoca fra l'imbroglio dei partiti. La costituzione concessa il 25 giugno non contenta e non persuade alcuno; nel ministero composto dallo Spinelli compaiono uomini ignoti; De Martino, scaltro diplomatico, assume il portafoglio degli esteri, don Liborio Romano, settario amnistiato da Ferdinando II nel 1854, prende la direzione della polizia. Naturalmente i dissidenti liberali aumentano d'importanza e di numero; patrioti esuli o prigionieri ritornano frementi di vendetta e di libertà; la plebaglia venduta ai sanfedisti tenta indarno una delle solite reazioni al grido di: «Viva il re e abbasso la costituzione!», irritando maggiormente gli animi di tutti i partiti contro la corte. In questa pure scoppiano dissidi: i conti di Aquila e di Siracusa liberaleggiano, quello di Trapani invece si accanisce a reazione. La milizia civica, tosto costituita, tutela la sicurezza publica, mentre il ministro di polizia si acconta coi liberali, e mercenari stranieri difendono ancora la reggia. I comizi indetti pel 19 agosto e il parlamento convocato pel 10 settembre sembrano a tutti l'ultima insidia e l'estrema farsa della decadenza borbonica; le defezioni aumentano tutti i giorni; il generale Nunziante, già insanguinatosi tristamente in repressioni contro i patrioti e poco dianzi offertosi al re per spazzare dalla Sicilia i filibustieri di Garibaldi, per gelosia del generale Pianell nominato ministro della guerra, si dimette con ignobile teatralità dall'esercito, dirigendogli un proclama di rivolta.
Naturalmente la politica del nuovo governo napoletano [73] non poteva essere che un'alleanza col Piemonte per resistere a Garibaldi. Il ministro Manna e il barone Winspeare, mandati a Torino per concertare una lega, offerivano di riconoscere le annessioni dell'Italia centrale alla Sardegna, di costituire nello stato pontificio due vicariati, uno delle Legazioni pel re di Piemonte e l'altro delle Marche pel re di Napoli, libera la Sicilia di convocare il proprio parlamento secondo la costituzione del 1812 per darsi governo proprio con un principe della casa regnante per vicerè, alleanza offensiva e difensiva contro l'Austria per la futura liberazione di Venezia.
Era l'antico disegno cavouriano, riproposto a Cavour quando già l'impresa dell'unità cominciava a trionfare; ma l'abile statista, pur fingendo di non respingere quest'alleanza, seguitava a trattare coi liberali di Napoli, per tenersi aperta la via a maggiori speranze. Puntellare il trono dei Borboni in tal momento sarebbe stato uno scrollare le basi di quello del Piemonte, scriveva egli apertamente in una nota al legato sardo a Pietroburgo. La sua intensa preoccupazione era invece la rivoluzione di Sicilia. Garibaldi, per forzare la mano al governo piemontese, vi ritardava le annessioni, dichiarando che si farebbero ad impresa finita: bisognava ancora conquistare Napoli, e dopo Napoli, Roma. Il partito rivoluzionario faceva miracoli d'organizzazione e di valore; esercito e governo borbonico non potevano presentare oramai seria resistenza; la conquista di tutto il Reame, compiuta in due mesi da Garibaldi, avrebbe potuto produrre un ultimo duello fra republica e monarchia. Cavour sapeva Garibaldi incapace di tradire; ma il solo principio politico del grande dittatore era il rispetto della volontà popolare, e se questa avesse proclamata la republica, Garibaldi ne sarebbe stato l'invincibile generale. Quindi il disegno di Cavour non poteva essere che doppio: impedire a Garibaldi il passaggio sul continente, lasciando compiere ai Borboni l'ultimo esperimento costituzionale ed aspettando dalla prima complicazione che il Piemonte [74] potesse impadronirsi di Napoli, o promuovervi, prima ancora che Garibaldi vi entrasse vittorioso, una rivoluzione in senso monarchico-unitario.
Cavour spiegò indarno tutta la propria abilità; l'ora delle scaltrezze diplomatiche era passata.
Napoleone III, per un'ultima speranza di regno murattiano, aveva mandato una flotta per impedire a Garibaldi il passaggio sul continente; ma era rattenuto dalle dichiarazioni dell'Inghilterra, minacciante di entrare nella contesa se la Francia violasse nel Reame il principio del non intervento. Cavour, dietro ordine di Napoleone, fece scrivere da Vittorio Emanuele una lettera per imporre a Garibaldi di non valicare lo stretto; il dittatore rispose con magnanima semplicità che compirebbe l'impresa e deporrebbe ai piedi del re l'autorità conferitagli dalle circostanze. Cavour, che avrebbe voluto l'impresa senza Garibaldi, proseguì negli intrighi, scrisse al Villamarina e al Persano «facessero ogni possibile per impedire la dittatura di Garibaldi. Se la dittatura veniva offerta al Villamarina accettasse... Se si presentasse certo pericolo di veder cadere il governo in mani perfide od inette, Persano assumesse il maneggio della cosa publica. In caso estremo si costituisse un governo provvisorio con a capo il principe di Siracusa. Che ove il re (Francesco II) o il corpo diplomatico desiderassero di sottrarre Napoli all'occupazione di Garibaldi, si accettasse di occupare i luoghi più minuti della città coi soldati (piemontesi). Se la rivoluzione non si compie prima dell'arrivo di Garibaldi, saremo in condizioni gravissime. Ma per ciò non ci turberemo punto. L'ammiraglio Persano s'impadronirà, potendolo, dei castelli del porto, riunirà alla sua la flotta napoletana e farà che si presti subito giuramento di fedeltà al re e allo statuto. Poi vedremo».
Già poco prima aveva indirizzato al Villamarina in Napoli una specie di questionario: «Nel caso di un moto insurrezionale quale sarà il partito che avrà il sopravvento? Credete voi alla possibilità di un moto annessionista, simile a quello compiutosi in Toscana? [75] Il murattismo novera esso molti partigiani nell'esercito e nella borghesia? I republicani sono ancora numerosi e influenti nelle Calabrie? Voi comprendete, signore, quanto mi debba interessare di conoscere questi diversi elementi di una soluzione, alla quale non possiamo rimanere estranei. Voi sapete che io non bramo minimamente di sospingere la questione napoletana ad uno scioglimento prematuro. Credo al contrario, che ci converrebbe che lo stato attuale delle cose durasse ancora per qualche anno».
L'illustre statista era non solo impreparato, ma avverso ad una rivoluzione del sud.
Nell'angustia della propria decennale politica non si era procurato nè contatti nè precedenti nel mezzogiorno: l'impresa garibaldina lo sorprendeva al pari dei Borboni; ma, troppo maggiore di essi, non potendo impedirla cercava sfruttarla. La sua attività in questo periodo fu tanto meravigliosa di accanimento quanto vana nel risultato. A Napoli tutti gli sforzi per suscitarvi una rivoluzione riuscirono vani: i liberali del comitato dell'Ordine non osarono muoversi, mentre i patrioti radicali, più generosi e più coraggiosi, pure non ribellandosi apertamente, riuscirono ad impadronirsi dello scarso moto liberale e a dirigerlo verso Garibaldi. Bertani da Genova spingeva la rivoluzione. Dopo la spedizione di Medici e di Cosenz nella Sicilia, gli arruolamenti proseguiti con maggiore alacrità avevano prodotto un altro esercito: duemila volontari erano pronti nelle Romagne e nella Toscana; altri novemila dovevano partire da Genova per scendere nello stato pontificio. Bertani aveva saputo provvedere armi, munizioni, vestiti, vascelli. Si era offerto il comando al celebre Charras, rivale di Lamoricière, ma quegli aveva ricusato, perchè ancora troppo debole il numero delle truppe: poi si pensò di affidarlo al Pianciani, mettendogli a fianco il Rüstow, allora eccellente ufficiale e più tardi insigne scrittore di guerra, come capo di stato maggiore; Giovanni Nicotera, superstite capitano dell'impresa di Pisacane, uscito allora di carcere, [76] guiderebbe la legione toscana. Ma Cavour, spaventato da siffatto aire, vi si opponeva in mille modi. Poichè non poteva apertamente contrastare a questo moto divenuto nazionale, cercava di togliergli anzitutto il significato: la sua stampa ministeriale bersagliava ogni giorno con satanica malvagità Mazzini e Bertani, come intesi a cospirare per la republica e a smembrare così l'Italia: li accusava di feroce giacobinismo e d'ignobili ladrerie. Nullameno Bertani poteva seguire nell'opera, mentre Mazzini era costretto a nascondersi. Cavour, infatuato di arrestarlo, ne aveva dato l'ordine a Medici, che ricusò generosamente di ubbidire, e a Persano, che non seppe ubbidire.
A questo, da lui spedito in Sicilia, scriveva: «Il governo del re non farà chiassi, ma non intende di lasciarsi giuocare in tal guisa; quindi, dopo la spedizione di Cosenz già in corso, disporrà che nulla più per parte sua vada in Sicilia, sino a che non sia affatto tolta al Bertani ogni sua ingerenza negli invii». Farini, mandato a Genova, cercò di persuadere al Bertani come riguardi diplomatici costringessero il governo ad impedire che i novemila volontari sbarcassero da Genova nello stato pontificio; veleggiassero invece al golfo degli Aranci, poi toccassero la Sicilia.
Allora Bertani corse al Faro ad avvisarne Garibaldi: questi, sentendo la necessità di una più pronta operazione nel Reame, invece d'invadere lo stato pontificio, ebbe per un momento l'idea di un colpo ardito su Napoli; ma dei novemila volontari cinquemila soli erano al golfo degli Aranci; gli altri, per ordine del governo piemontese, erano già sbarcati a Palermo. Giovanni Nicotera, col consenso di Ricasoli, aveva radunato in Toscana un corpo di duemila volontari, pattuendo ai primi contrordini da Torino di non sbarcare nè sul litorale toscano, nè sul romano, se prima non avesse preso terra nello stato napoletano; ed invece poco dopo sentiva intimarsi di sciogliere la brigata. Il fiero rivoluzionario ricusò, i volontari rumoreggiarono così forte che Ricasoli dovette riconsentire il primo patto: senonchè [77] la brigata a Livorno non trovò che due bastimenti francesi sprovveduti di viveri e noleggiati dal governo per condurli in Sicilia. Un bastimento sardo da guerra, entrato nel porto, strinse d'appresso i due vapori; la batteria del molo puntò contro di essi le proprie batterie: il Nicotera, per evitare una battaglia fratricida, dovette cedere e andare in Sicilia, protestando con veemenza di republicano contro il tradimento del governo.
Ma il conte di Cavour, sospinto dalle circostanze, precipitava la propria azione monarchica: nel costringere tutto lo sforzo della rivoluzione al sud, si manteneva aperto l'adito a penetrarvi primo e solo per lo stato pontificio. Le sue vessazioni al partito rivoluzionario, mentre le vittorie garibaldine lo illuminavano di poesia, gli avevano svelato tutta la debolezza della rivoluzione. Il ministro Farini in una circolare aveva potuto calunniare e minacciare impunemente i comitati rivoluzionari, si erano bistrattati i volontari, si domandavano loro i passaporti da paese a paese italiano, si erano sequestrate cartucce quando Garibaldi ne mancava al fuoco; a Genova si erano persino imprigionati alcuni fabbricanti di polvere, senza che alcuno dei rivoluzionari osasse reagire; Garibaldi seguitava nella fede al re, Mazzini non chiedeva più che «lasciateci fare anche per voi». Le provincie romane tacevano sotto le minacce di Lamoricière forte appena di ventimila uomini; il Napoletano ciarlava, guardando Garibaldi armeggiare invano per passare lo stretto.
Il Piemonte dominava sempre l'Italia coll'apparenza di forte stato nazionale.
Ma la sua politica si sbrogliava al soffio della rivoluzione. L'impresa ormai inevitabile di Garibaldi su Napoli obbligava il Piemonte ad intervenirvi. Garibaldi vittorioso dei Borboni potrebbe marciare su Roma, attirando sull'Italia una guerra colla Francia.
Per salvare il papa e schiacciare contemporaneamente la rivoluzione, bisognava dunque invadere lo stato pontificio, cansare Roma, arrivare su Napoli a [78] tappe forzate, e, prima ancora che l'Europa si riavesse dallo sbalordimento, risponderle collo spettacolo del governo costituzionale già stabilito, e del papa libero entro più ristretto territorio.
Di questo era d'uopo però persuadere anzitutto Napoleone.
Intanto Garibaldi la notte del 9 agosto, sopra settanta barchette lancia in mare 200 volontari guidati da Mario, da Nullo, da Missori, e da Musolino, per sorprendere il forte di Alta Fiumara all'estrema punta di Calabria, e assicurarsi così il passaggio con tutto l'esercito: ma la temeraria impresa fallisce, onde quei prodi possono appena inerpicarsi sui gioghi dell'Aspromonte destinati alla gloria di maggiore tragedia. La piccola banda, soccorsa dai villani, malissimo armata, scaramuccia all'intorno sfuggendo al nemico e perseguitandolo, finchè Garibaldi, reduce con nuova truppa dal golfo degli Aranci, sopra due piroscafi sbarca il 20 agosto colla divisione Bixio a Melito. L'esercito borbonico supera i trentamila uomini con cavalleria, artiglieria, armi e munizioni eccellenti; Garibaldi, sommando tutte le proprie forze di Sicilia, non arriva a mezzo, con pochi cavalli, quasi senza cannoni.
La guerra ricomincia, ma non pare nemmeno più guerra. Reggio, attaccata dalle divisioni Eberhardt e Bixio, capitola subito; al rombo delle prime cannonate Medici e Cosenz rimasti in Sicilia traghettano fra Scilla e Bagnara, a Villa S. Giovanni cinquemila garibaldini accerchiano e fanno prigionieri quasi senza colpo ferire novemila regi, mentre il generale Vial si ritira con altri dodicimila su Monteleone. Nel Cosentino, nella Basilicata, nella Capitanata, nelle Puglie tumultua la sommossa. Garibaldi, con avvedutezza politica di condottiero, anzichè aspreggiare il nemico, ne seduce i soldati prosciogliendo i corpi prigionieri. Allora le defezioni si moltiplicano: invece di combattere le truppe [79] fraternizzano, scene di romanzo dànno alla guerra l'apparenza d'una innocua e divertente teatralità, capitani ed aiutanti garibaldini intimano soli o con scarsi drappelli a generali nemici la resa, e l'ottengono. Il generale Ghio, crudele trucidatore di Pisacane a Padula, si arrende con dodicimila uomini a Soveria, il generale Caldarelli ha di già capitolato a Cosenza, una fiamma d'entusiasmo si leva per tutti i paesi ove passano i volontari, mentre i soldati regi si sbandavano con allegria brigantesca, obliando egualmente i doveri verso il proprio re e verso la patria. Ma se nella Sicilia il popolo aveva salutato i garibaldini come liberatori per l'odio secolare verso la signoria napoletana, nel Regno Garibaldi non è acclamato che come vincitore. La sua gloria, la sua mitezza, le favole sulla sua vita, esaltano la veemente immaginazione popolare; il valore dei volontari, meraviglioso nei fatti parziali, l'incredibile viltà dei regi, la prestezza delle marcie che precedono persino il grido delle vittorie, la singolarità d'un trionfo ottenuto anche troppo facilmente, la temerità infine di Garibaldi, che dinanzi al proprio esercito, con una scorta piuttosto d'onore che di battaglia, in carrozza di posta, galoppa verso Napoli, finiscono di dare all'impresa l'irresistibile fascino di un miracolo. Tutta la parte meridionale del Regno è già conquistata: i calabresi, ardenti di odio verso i Borboni, sono i soli napoletani che si battano. La marina regia, colpita dalla stessa defezione dell'esercito, lascia avvicinare a Napoli i piroscafi, che portano i garibaldini.
Nella capitale terrore ed entusiasmo sconvolgono le coscienze. La corte allibisce, i sanfedisti si rimpiattano, la plebe attende con ansia fantastica il nuovo Messia. Invano il generale Pianell consiglia a Francesco II di mettersi alla testa dei quarantamila uomini che ancora gli rimangono, per tentare un colpo supremo o almeno perire gloriosamente: fortunatamente la viltà del re paralizza l'intelligenza del ministro. Infatti, se Francesco II si fosse messo alla campagna, la superstizione religiosa e politica era ancora tale in molta [80] parte di questa, da ristabilire le sorti della guerra. Bastava una sola sconfitta per dissipare il prestigio di Garibaldi. Il Regno si lasciava solcare dalla rivoluzione senza parteciparvi, i patrioti v'erano in minoranza debolissima, la moltitudine non intendeva gran cosa al nome d'Italia e meno ancora a quello di libertà. La inettitudine del popolo veniva ora rivelata dalla codardia dell'esercito regio, contro il quale non si era osato alcun tentativo di rivolta, e che poche bande garibaldine erano bastate a sopraffare.
Intanto il sentimento della paura universale invade il partito di corte. Mentre il conte d'Aquila e la regina vedova vorrebbero scatenare lazzaroni e mercenari a furibonda reazione, il conte Leopoldo di Siracusa consiglia il re, suo nipote, ad uscire dal Reame sciogliendo i sudditi dall'obbedienza, e, non ascoltato, parte sfrontatamente per Torino a ricevervi da quella corte le congratulazioni del vile tradimento. Don Liborio Romano perfeziona con scaltrezza settaria il consiglio del conte di Siracusa col suggerire al re di allontanarsi e d'investire della reggenza un nuovo ministero: lo stesso generale Bosco caduto d'animo scongiura il re a salvarsi nella Spagna. Tutto è perduto.
Nullameno il partito moderato non si leva ad alcuna iniziativa nel nome di Vittorio Emanuele, prima che tutta Napoli si accalchi intorno a Garibaldi vittorioso. Le vivissime istanze di Cavour, che in quei giorni apriva arditamente la campagna contro il papa passando il Rubicone, non valsero a comunicargli il coraggio di ribellarsi ad un re che fuggiva, ad un esercito che non combatteva, ad una polizia complice nel tradimento. Nè i patrioti radicali furono più audaci. Francesco II, dopo molto titubare, abbandonò la capitale per chiudersi nella fortezza di Gaeta. Il giorno dopo (7 settembre) don Liborio Romano scriveva a Garibaldi per invitarlo a Napoli, e Garibaldi con temerità indefinibile, mentre la guarnigione borbonica teneva ancora la città, vi entrava con soli quattordici compagni. Le milizie regie vedendoli passare presentavano attonite [81] le armi, il popolo urlava, la guerra si riassumeva in un chiasso di trionfo, il dramma delirava nell'apoteosi finale.
Nella lunga storia d'Italia nessuna conquista era stata più facile e pronta di questa: un regno di oltre dieci milioni, una flotta di quaranta navi, un esercito di centomila uomini, coll'appoggio di tutte le diplomazie europee, con una vecchia dinastia non potuta sradicare nè dalla rivoluzione francese nè dall'impero napoleonico, cadevano in potere di pochi drappelli garibaldini, armati alla meglio da un comitato di Genova malgrado i divieti del Piemonte. Un uomo solo era bastato al miracolo. Il suo spirito era rivoluzione, il suo nome legione: aveva appena combattuto e le vittorie gli avevano preceduto le battaglie; era un conquistatore, ed era entrato nella capitale senza esercito, come viaggiatore che si lasci dietro il più grosso bagaglio. Intanto che i generali dei suoi scarsi reggimenti marciavano ancora contro i resti dell'esercito borbonico concentrati tra le fortezze di Capua e di Gaeta, egli, dimentico di loro, assettava già dittatoriamente la capitale e tutto il Regno. Pareva un sogno. Fra i garibaldini si udivano favelle di tutta l'Europa: polacchi, francesi, ungheresi, spagnuoli, vinti in patria combattendo per la libertà, avevano seguito Garibaldi quasi ad imparare da lui la vittoria. Alessandro Dumas, il maggiore novelliere di avventure, era capitato a questa, incredibile e vera come le più belle de' suoi capolavori: così, dietro il più grande eroe, brillava la più eroica fantasia del secolo.
L'impresa era davvero un romanzo fatto di storia, di poema, di dramma, di commedia, con una sceneggiatura multiforme e una violenta preponderanza di pochi individui sulla massa, che rappresentava appena lo sfondo e l'ambiente.
Un giorno avrebbero dovuto chiamarla conquista garibaldina; allora con ingenua vanteria il popolo la diceva rivoluzione napoletana.
La giovane democrazia europea, riunita dall'apostolato [82] di Mazzini, trionfava per la prima volta nel campo di Garibaldi.
Il dittatore, comprendendo la necessità di rivoluzionare immediatamente il Regno per rendervi stranieri i Borboni e più difficile l'intervento della diplomazia europea, allentò la guerra. I suoi primi decreti furono decisivi. Aggregò la flotta napoletana alla squadra piemontese comandata da Persano; chiamò al ministero il Pisanelli, lo Scialoia, il Conforti, liberali cavouriani; tolse la polizia a don Liborio Romano, cui sottopose alla vigilanza di Bertani, venuto a Napoli primo segretario di governo; ordinò che ogni editto emanasse nel nome di Vittorio Emanuele, vietò il cumulo degli uffici pubblici stipendiati; proclamò l'intangibilità del debito pubblico. Quindi con assennato arbitrio abolì l'ordine dei gesuiti, dichiarando nazionali i loro beni e cassando ogni loro contratto fino al giorno del primo sbarco in Sicilia; incamerò i patrimoni della casa reale e dei maggioraschi regi; instituì i giurati; invece di assalire i forti ancora tenuti dalle milizie regie, le prosciolse, e allora queste si sbandarono: qualche battaglione si unì al resto dell'esercito borbonico, la maggior parte rincasarono e si buttarono a brigantaggio.
Il conte di Cavour, con agile mutamento di tattica, ordinava intanto al proprio partito di circuire Garibaldi, allontanando da lui o sopraffacendo i più attivi consiglieri democratici. Cattaneo, Mazzini, Saffi erano già accorsi a Napoli: ogni speranza di republica era svanita; ma, democratici inflessibili, volevano almeno salvare nella procedura delle inoppugnabili annessioni il principio della sovranità popolare. Così domandavano illuminato e cauto il voto delle provincie meridionali, o per mezzo di un'assemblea transitoria o con plebiscito veramente sovrano, nel quale fossero punti fondamentali del patto fra popolo e re il compimento dell'unità della patria con Roma e Venezia e la convocazione d'una costituente deputata a dar forma alla nuova vita della nazione. Sciaguratamente era troppo e troppo tardi, dopo che Garibaldi aveva già preso possesso [83] di Napoli in nome di Vittorio Emanuele, e questi si avanzava attraverso lo stato pontificio per cacciare il dittatore. Un patto fra popolo e re con riserve e procedura democratica diventava assurdo: se il popolo ne fosse stato capace, avrebbe poi dovuto votare la republica.
Ora di tutta Italia il paese più superstiziosamente monarchico era appunto il napoletano.
Ma la guerra mossa dal partito moderato ai consiglieri democratici fu atroce: Bertani svillaneggiato, accusato di furto dopo i prodigi dell'organizzazione rivoluzionaria, dovette dimettersi; si mandò la plebaglia a gridare sotto le finestre di Mazzini: mora, mora! e s'indusse l'ingenuo Pallavicini a scrivergli una lettera, perchè riprendesse la via dell'esilio. Cattaneo fu coperto d'obbrobrii; Crispi cacciato da Palermo e sostituito col Mordini prodittatore. Nemmeno Garibaldi rimase rispettato. Mentre popolo, borghesia, aristocrazia coll'ignobile servilità dell'antico costume s'addensavano nelle sue anticamere prosternandosi a domandare impieghi ed onori, si accusavano i più puri eroi garibaldini di scroccheria: sembrava che la viltà universale, offesa dal loro coraggio, avesse d'uopo di negarlo. Il dittatore inetto a così laida guerra e mal destro in amministrazione, perdeva terreno: l'avvicinarsi dell'esercito piemontese trionfante scemava prestigio alle sue vittorie. D'altronde si rifletteva che a Francesco II restavano ancora quarantamila uomini e due fortezze inespugnabili alle milizie volontarie per difetto d'artiglierie.
Lo stesso disegno, publicato temerariamente dal dittatore di marciare su Roma sfidando la Francia, atterriva. Ogni volgare politico sentiva che quest'impresa avrebbe riattirato l'Italia in una conflagrazione europea, poichè l'impero buonapartesco non poteva abbandonare il papa. Quindi il pensiero di Cavour avviluppava e dominava l'opera di Garibaldi.
Questi però, fra tante cure di governo, non dimenticava il nemico ingrossante ogni giorno sul Volturno: [84] così verso la metà di settembre, riprendendo l'offensiva, mandò il Türr con tre brigate a Santa Maria e San Leucio. Si tentò felicemente l'occupazione di Caiazzo ad oriente di Capua, ma avendovi lasciato troppo debole presidio, i borbonici ripresero la piazza. Era la prima sconfitta. Garibaldi, richiamato a Palermo per placarvi i dissensi politici fra democratici e cavouriani, non aveva potuto impedirla. Intanto una reazione selvaggia di superstizione s'accendeva nelle campagne del regno, ove il clero aizzava i villani: le soldatesche prosciolte vi si raccozzavano a bande di briganti; un odio feroce scoppiava contro i garibaldini conquistatori, ora che s'avanzavano a più stabile conquista i piemontesi. Si faceva con assurde dicerìe temere al popolo per le proprie case; lo si lancinava coll'idea della coscrizione oltre i confini del Reame, come se il resto d'Italia fosse stato un altro mondo lontano; lo si fanatizzava a difendere i vecchi idoli di villaggio minacciati d'imminente distruzione. Ariano e Avellino erano insorte; ad Isernia un manipolo di volontari capitanati da Mario e da Nullo era stato rotto dai cafoni che si erano battuti con bravura di antichi Sanniti, infellonendo poi sui cadaveri.
Bisognava quindi riattirare i regi in una suprema battaglia e prostrarli.
Dopo il disastro di Caiazzo, Garibaldi, per meglio ingannarli, finse di accerchiare Capua, fortificandosi a Santa Maria, San Tommaso e Sant'Angelo, e munendo invece la via di Napoli: il suo esercito era appena di ventimila uomini con trenta cannoni, i borbonici menavano in campo quarantamila uomini con quaranta cannoni. Questa volta (1º ottobre) la mischia fu aspra; i borbonici si batterono accanitamente, respingendo su tutti i punti i volontarii; ed avrebbero forse vinto, se i loro generali meno inetti avessero dato una battaglia obliqua anzichè parallela, e Garibaldi, volando su tutti i punti più combattuti, non avesse raddoppiato il valore dei propri soldati, mentre il maggiore Bronzetti con duecento uomini rinnovava a Castel Morone il prodigio [85] di Leonida, arrestando per tutta la giornata un corpo di quattromila borbonici. Non un solo dell'eroico manipolo volle rendersi prigioniero, quasi nessuno sfuggì alla morte. Garibaldi vincitore al Volturno sperdeva l'indomani quella regia brigata sulle alture di Caserta vecchia con un'ultima vittoria.
Il generale Cialdini era già penetrato nel Reame sconfiggendo al Macerone quegli stessi cafoni, che avevano rotto il drappello di Nullo ad Isernia.
L'intervento piemontese mutava l'impresa garibaldina in conquista regia.
Infatti il problema italiano non poteva avere allora altra soluzione.
L'annessione del Napoletano, ritardata nella procedura del voto da Garibaldi, minacciava di compromettere tutti i risultati della rivoluzione. Il disegno del dittatore di procrastinare i plebisciti sino alla conquista di Roma implicava una intimazione di guerra alla Francia e una sottomissione del re a Garibaldi. La monarchia piemontese, già vassalla dell'imperatore francese, perderebbe ogni prestigio in Italia, se Garibaldi potesse non solo conquistarle un regno, ma ritrascinarla a guerra contro Napoleone. Il dittatore, alla testa di ventimila volontari, circondato da un ammirabile stato maggiore, con un consiglio di grandi democratici intorno, trattando con diplomatici esteri, nominando prodittatori, maneggiando il denaro dello stato, legiferando e battagliando, era più re del re. Il partito moderato napoletano, che non aveva osato insorgere prima del suo ingresso in Napoli, non poteva ora dominare il vincitore; anzi, obbedendo alle istruzioni di Cavour, non riusciva che a precipitare la crisi.
Solo l'esercito piemontese poteva fermare Garibaldi sulla via di Roma. Quindi Cavour, sapendo Napoleone a Chambéry, gli aveva mandato oratori Farini e Cialdini: la missione era stata difficile. Forse l'imperatore [86] non aveva ancora abbandonato tutte le speranze di un regno murattiano, fors'anco questo eccessivo ingrandimento del Piemonte contraddiceva a tutti i calcoli della sua politica generale. Ma Garibaldi aveva spinto così oltre la rivoluzione nazionale nel Reame, da rendervi impossibile l'impianto di una dinastia straniera, mentre una sua marcia su Roma poteva gettare l'impero in male prevedibili complicazioni. L'imperatore non voleva abbandonare il papa, e non poteva combattere la rivoluzione italiana per non ridestare le questioni sopite di Villafranca. D'altronde il Piemonte per annettersi il Napoletano aveva bisogno di una linea di comunicazione per terra: ad esautorare Garibaldi anche in faccia all'Italia nessun miglior modo che di far conchiudere la sua guerra da Vittorio Emanuele: fortunatamente n'era ancora il tempo. L'impresa di Garibaldi, aiutato da tutta la democrazia europea, riaccendeva le speranze della democrazia francese: se una rivoluzione republicana scoppiasse in Italia, la Francia non vi resterebbe forse estranea. L'impero non era abbastanza sicuro per trascurare questa possibilità. Intanto l'anarchia tempestava già a Napoli, secondo le bugiarde notizie dei giornali moderati; i più ardenti republicani circuivano il generale, la marcia su Roma determinerebbe lo scoppio della rivolta: poichè il Piemonte non avrebbe potuto allearsi con Garibaldi contro la Francia, nè con questa contro Garibaldi per non accendere una guerra civile, una seconda republica italiana diventava inevitabile.
I legati piemontesi insistevano vivamente, dipingendo a foschi colori la situazione del Piemonte condannato a diventare tutta l'Italia o perire.
L'imperatore non acconsentì senza dichiarare che, se l'Austria fosse intervenuta, la Francia non sarebbe discesa a combatterla.
Contro tal pericolo il conte di Cavour, riprendendo il disegno già combinato l'anno prima con Kossuth per eccitare la rivoluzione in Ungheria, mandò da Genova [87] alla volta del Danubio cinque bastimenti carichi d'armi e il Klapka a Costantinopoli.
Quindi precipitò gl'indugi.
Il generale Lamoricière, dopo aver paragonato la rivoluzione italiana all'Islamismo e dichiarata la causa del papa essere quella della civiltà e della libertà del mondo, con editti crudeli seguitava a terrorizzare le provincie: ordini di morte fioccavano dappertutto e contro tutti. Questa demenza di repressione facilitò al conte di Cavour i pretesti di guerra. Quindi con nota del 7 settembre, nel giorno medesimo dell'ingresso di Garibaldi a Napoli, aveva già chiesto al cardinale Antonelli lo scioglimento della bande mercenarie rese infami dall'eccidio di Perugia. Naturalmente il cardinale aveva ricusato con alterigia. La Santa Sede si credeva allora in condizioni migliori del Piemonte: l'imperatore Napoleone, sempre ravvolto nelle stesse ambiguità, richiamava da Torino il proprio ambasciatore ed ingrossava il presidio francese a Roma, facendo dichiarare dal duca di Grammont al papa che si opporrebbe ad ogni aggressione del re di Sardegna. Ma quando il 9 settembre il generale Fanti, nominato comandante supremo, aveva annunziato al Lamoricière che occuperebbe le Marche e l'Umbria nel caso che le truppe pontificie vi contrastassero le manifestazioni nazionali, e questi aveva scritto all'Antonelli di far avanzare il presidio francese, il duca di Grammont vi si era ricusato. L'imperatore Napoleone non aveva inteso che di difendere Roma e il territorio occupato dai propri soldati.
Intanto il conte di Cavour aveva diramato un Memorandum a tutte le cancellerie, spiegando come, per liberare le popolazioni dalle tirannidi secolari e per impedire alla rivoluzione di sciorsi nella peggiore delle anarchie, nell'interesse d'Italia e di Europa, fosse costretto a questa nuova guerra.
I nemici questa volta erano Pio IX e Garibaldi, la Santa Sede e la rivoluzione.
La campagna era stata rapida.
[88] L'esercito papalino arrivava appena a ventimila uomini, quello sardo quasi al doppio. Il Lamoricière, prode generale educato alla scuola d'Africa, invece d'afforzarsi in Ancona, tentò d'impedire la congiunzione dei due corpi nemici; ma Cialdini con celere marcia oltrepassò Ancona, mentre Fanti, prostrato lo Schmid a Perugia, scendeva ad incontrarlo. Tutti i presidii della città avevano capitolato quasi senza colpo ferire, arrendendosi sino a bande di volontari romagnoli, mescolate in abito borghese e con armi da caccia a questa guerra come ad un'ottobrata. Lamoricière prima di avere combattuto era già chiuso fuori d'Ancona. Cialdini occupava Castelfidardo: il conte De Pimodan comandante degli zuavi pontifici volle attaccarlo, e morì bravamente nella battaglia colla fede di un antico crociato; il suo corpo si sbandò, molti riparati a Loreto vi si arresero l'indomani; Lamoricière potè a stento guadagnare Ancona.
Tutta la guerra si era così costretta ad un assedio. La piazza, fortissima per natura e ben munita, aveva ancora un presidio di 7000 uomini; nullameno, bersagliata vivamente dalla squadra del Persano, aveva dovuto soccombere indi a poco (29 settembre).
La campagna non era durata che diciotto giorni, e non aveva costato che seicento soldati tra morti e feriti.
Contemporaneamente Garibaldi, esasperato dalla guerra dei moderati al suo governo, aveva mandato il marchese Pallavicino al re, per chiedergli le dimissioni del ministero di Cavour e di Farini. Questa esorbitanza, giustificando tutte le accuse dei monarchici, aveva permesso a Cavour di perdere facilmente l'ingenuo e pericoloso avversario: infatti, mentre questi si affermava francamente in una dittatura rivoluzionaria, l'abile ministro, contro ogni consiglio di sospendere la costituzione, si era appellato al parlamento. La libertà dal campo di Garibaldi era passata in quella di Cavour. Il parlamento, convocato il 2 ottobre, aveva votato: «Il governo del re è autorizzato ad accettare e stabilire [89] per decreti reali l'annessione allo stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio universale diretto la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra monarchia costituzionale».
Nella relazione su tale disegno di legge il conte di Cavour, dopo alcuni elogi di Garibaldi, attribuiva con audace sofistica alla politica di Casa Savoia, iniziata da Carlo Alberto, anche le ultime mirabili conquiste del mezzogiorno: quindi, dichiarata impossibile ogni nuova guerra per la liberazione della Venezia o per la conquista di Roma, denunciava l'anarchia settaria già scoppiata a Napoli per la colpa di Garibaldi nel ritardare l'annessione, e chiamava giudice il parlamento nella propria contesa col dittatore, pindareggiando nullameno sulla generosità di lui.
Infatti Garibaldi, coll'infallibile buon senso della propria natura, che la passione di patria e l'entusiasmo della vittoria avevano esaltato per un momento, prima ancora che la legge fosse sancita, convocava con decreto dell'8 ottobre tutti i comizi del Reame a votare su questa formula: «Il popolo vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele re costituzionale e i suoi legittimi discendenti».
Il plebiscito era a suffragio universale: agli squittini risultarono nelle provincie napolitane 1,302,064 sì e 10,312 no, nella Sicilia 432,053 sì e 667 no; nelle Marche 133,807 sì e 1212 no; nell'Umbria 97,040 sì e 380 no.
Frattanto re Vittorio Emanuele, commessa la luogotenenza generale del regno al principe di Carignano, annunciava da Ancona, in un primo proclama ai popoli del mezzogiorno, il suo prossimo arrivo per tutelare l'ordine e far rispettare la loro volontà. Tale proclama era il commentario della lettera, colla quale Farini comunicava all'imperatore Napoleone la marcia su Napoli per sottrarre la grande città all'anarchia delle bande rosse.
L'epopea garibaldina era finita. Bertani, tanto calunniato, [90] aveva già votato generosamente nella camera piemontese la legge proposta da Cavour per fare le annessioni con decreti reali; Mazzini riprendeva più desolato la via dell'esilio, lasciando stretta a Napoli una vasta colleganza popolare col titolo di Associazione Unitaria Nazionale, e affidando al Nicotera la direzione del nuovo giornale L'Italia del Popolo. Garibaldi, dopo la vittoria del Volturno, restava inerte. Il disprezzo, col quale la monarchia affettava di trattarlo, lo isolava nell'ingratitudine dei più.
La monarchia trionfava.
Nessuna delle molte querele diplomatiche fioccanti allora sull'Italia potè ritardare il compimento della nuova conquista regia.
L'Austria tentò di riunire una conferenza a Varsavia per abolire il non intervento, ma Napoleone III ne dissuase lo czar Alessandro; la Prussia rumoreggiò più a lungo, però Cavour, proclamandosi con giusta vanteria unico restauratore in Italia del principio monarchico quasi cancellatovi dalla rivoluzione, potè rispondere finalmente al ministro Schleinitz di dargli un esempio che egli sarebbe ben fortunato di imitare fra poco; l'Inghilterra invece era così favorevole alla rivoluzione italiana che il suo primo ministro lord Russell potè affermare con superba originalità di diplomatico in una nota al legato inglese a Torino il diritto dei popoli all'insurrezione.
Intanto Vittorio Emanuele era già penetrato nel regno napoletano passando il Tronto (15 ottobre); Garibaldi venne ad incontrarlo a Teano; il generale borbonico Ritucci stava non molto lontano, schierato a battaglia. La situazione era epica: un mattino freddo, Capua antica e minacciosa da lungi, alta sovra di essa l'ombra immensa di Annibale; Garibaldi con un fazzoletto annodato sotto il collo e ravvolto nel povero mantello dinanzi alle bande rosse, Vittorio Emanuele sulla [91] fronte del primo esercito italiano: la rivoluzione e la tradizione, la democrazia e la monarchia; un popolano che donava un regno ad un re, il quale accettandolo creava una nazione.
Garibaldi, mostrando Vittorio Emanuele al proprio esercito, gridò: — Ecco il re d'Italia!
Vittorio Emanuele, incapace di comprendere la grandezza di quella scena e la generosità di quel riconoscimento, tacque villanamente, e più villanamente ingelosito degli applausi, che i contadini accorsi levavano dinanzi a Garibaldi, spronò il cavallo. Più tardi la letteratura cortigiana sentì il bisogno di raccontare diversamente tale incontro.
Il generale Ritucci, per non sostenere da solo l'urto dei due eserciti riuniti, si ripiegò dietro la linea del Garigliano, lasciando diecimila uomini a presidio di Capua. Vittorio Emanuele, dietro l'esempio di Garibaldi, mandò Cialdini al Salzana, generalissimo dei borbonici, per tentarlo, ma invano; allora s'investì Capua e s'incalzò l'esercito borbonico, che nella notte ripassò il Garigliano. Garibaldi venne messo alla coda, mentre l'ammiraglio francese De Tinau, mandato da Napoleone nelle acque di Gaeta ad impedire che le navi sarde la distruggessero per mare, vietò alla squadra italiana di correre da Terracina alla foce del Garigliano per proteggere la strada della marina.
Vittorio Emanuele, dopo l'umiliazione del vietato investimento di Gaeta per mare, dovette nuovamente abbassarsi a pregare l'imperatore di un contrordine all'ammiraglio Tinau. L'imperatore, nell'impossibilità di ritardare più oltre la conquista piemontese, acconsentì. Poco dopo il Garigliano era guadagnato; la legione De Sonnaz rompeva il campo del Salzana, che si rifugiava vilmente oltre la frontiera pontificia; Capua s'arrendeva dopo quattro giorni d'assedio; il 7 novembre Vittorio Emanuele entrava trionfalmente in Napoli, e Garibaldi, dimessosi dalla dittatura ricusando ogni ricompensa, ne usciva nel cuore della notte, povero come quando v'era entrato conquistatore, ravvolto nell'ingratitudine [92] dei partiti, ma col gran cuore d'Italia nel petto, gridando ai pochi compagni dal ponte del vascello che lo riconduce a Caprera: — Arrivederci sulla via di Roma!
Alla fine di novembre Vittorio Emanuele ricevette le deputazioni delle Marche e dell'Umbria; il 1º decembre visitò Palermo, emanandovi un proclama, nel quale, dopo molti vanti sul regno di Vittorio Amedeo II, si taceva con scempia ingratitudine di Garibaldi. Al prodittatore Mordini, malviso, fu sostituito il marchese di Montezemolo col Cadorna e La Farina, come consiglieri di luogotenenza. A Napoli governava Luigi Carlo Farini, ma per maggior lustro monarchico vi fu mandato il principe di Carignano.
Tutto il regno era già annesso al Piemonte, mentre Francesco II resisteva ancora a Gaeta. L'assedio, incominciato il 6 novembre, malgrado tutti gli sforzi dei generali Menabrea e Valfrè, procedeva lentamente a cagione del mare mantenuto aperto agli assediati dalla flotta francese. Questo tardo intervento napoleonico umiliava il governo italiano, senza salvare la dinastia borbonica. L'imperatore, stretto dalle istanze dell'Inghilterra, dovette finalmente persuadersene e consigliare al re di rendere la piazza; questi, fiducioso in una reazione delle campagne, rispose alteramente; allora Napoleone propose un armistizio di quindici giorni, che Francesco II ricusò ancora e, atterrito dal bombardamento, accettò poco dopo per raccomandarsi in quell'intervallo a tutti i governi d'Europa. Spirato l'armistizio e riprese le ostilità, cominciò il blocco per mare: il bombardamento seguitò, una polveriera della fortezza scoppiò, un altro armistizio di quarantotto ore fu concesso per seppellire i morti; ma gli assediati essendosene giovati proditoriamente per riparare la breccia delle mura, Cialdini spinse così vigorosamente l'attacco che la fortezza dovette capitolare (13 febbraio).
Re Francesco II esulò: i Borboni avevano finalmente cessato di regnare sull'Italia.
La grande annessione delle due Sicilie creava politicamente [93] la nazione italiana: Venezia restava sotto l'Austria, Roma in mano del papa, ma un regno di ventidue milioni d'italiani era cresciuto nell'Europa. Le diplomazie dovevano riconoscerlo. La sovranità popolare vi aveva sconfitto il diritto divino; la rivoluzione, giovandosi di tutte le forme e di tutte le forze, vi aveva costretto a rimutarsi in se medesima principato e democrazia; i plebisciti a suffragio universale vi contrastavano ancora coll'elettorato incredibilmente ristretto dello statuto; lo stato, emancipatosi dalla chiesa, le aveva ritolto prerogative e territori; le guerre avevano rimessa una certa energia nel popolo; il federalismo era cessato; l'unificazione aveva condotto all'unità. La monarchia piemontese, forzata dalla rivoluzione a diventare monarchia italiana, aveva dovuto accettare la base democratica dei plebisciti, ed ora il cittadino sovrastava al re: la regalità era mutata in funzione dello stato, la dinastia in una rappresentanza resa simpatica dal coraggio mostrato. Se l'alleanza del Piemonte colla Francia aveva aperto a questo l'adito al consesso delle grandi potenze d'Europa, l'altra della monarchia colla rivoluzione, di Vittorio Emanuele con Garibaldi, aveva creato la nazione.
Il re, secondando e più spesso subendo gli avvenimenti, aveva meritato dal popolo in tanto discredito della regalità il titolo originale di galantuomo; ma Garibaldi, solo fra l'impossibile republica unitaria di Mazzini e l'impotente monarchia piemontese, opponendosi ad entrambe, abbassando l'idea dell'una e slargando la realtà dell'altra, sfidando le diplomazie e sollevando il popolo, era stato tutta l'Italia. Vittorio Emanuele, Cavour e Mazzini non vi significavano che particolari tendenze fra contraddizioni, che limitavano la loro opera ad un sistema. Così, nell'infallibilità dell'istinto, Garibaldi aveva invece operato più di tutti loro quando la rivoluzione pareva esaurita; ma, troppo grande per aspirare a ricompense e troppo forte per serbare rancori, aveva resistito persino al proprio trionfo, ritirandosi dalla guerra appena le battaglie vi diventavano [94] inutili, pronto a ricominciarla l'indomani con una sconfitta maggiore di ogni vittoria. Ora, nell'inevitabile gazzarra dell'improvvisazione monarchica, si era ritirato a Caprera, non trasportando sulla piccola barca, frutto di tante conquiste, che pochi legumi da seminare fra gli scogli dell'isola vigilata dalla sospettosa ingratitudine della monarchia.
Il nuovo regno non era ancora l'Italia.
Se il principio della nazionalità aveva trionfato, riunendo intorno al Piemonte la maggior parte delle province italiche, Venezia rimasta soggetta all'Austria e Roma sottoposta al papa toglievano alla nazione la coscienza della propria integrità individuale. Attraverso la clamorosa vicenda di tante vittorie si intendevano tuttavia i lamenti di una grande speranza caduta. Un doloroso peccato d'origine turbava la conquista regia anche nella gloria degli insperati trionfi. L'alleanza offerta dada Francia al piccolo Piemonte e la discesa in Lombardia per cacciarne l'Austria avevano tolto all'egemonia piemontese la simpatica originalità dei primi ardimenti. Quindi la pace imprevista di Villafranca l'aveva umiliata: re Vittorio Emanuele vi era sembrato appena un vassallo, come gli antichi suoi avi, che gl'imperatori si associavano nelle guerre, donando o ritogliendo loro qualche provincia.
Mentre il Piemonte, prima della guerra lombarda, era un minimo stato ammirabile di iniziativa e di patriottismo, che, improvvisando tra le servitù millenarie d'Italia una nuova epoca di libertà costituzionale, si metteva all'avanguardia d'Europa ancora impacciata nei trattati della Santa Alleanza, dopo la guerra lombarda era caduto come un satellite nell'orbita del secondo [98] impero napoleonico. La fortuna delle prime annessioni era così poco bastata a ridargli l'antica libertà che l'impresa garibaldina nel mezzogiorno, raddoppiandogli il problema, lo sottoponeva ora più supinamente all'arbitrio dell'imperatore. Nullameno il fatto nazionale aveva potuto concretarsi in una rudimentaria organizzazione.
La nuova monarchia vincitrice quasi senza vittorie proprie, giacchè nessuna battaglia piemontese era stata decisiva, restava in difetto dinanzi all'Europa e dinanzi alla rivoluzione: per quella, la soggezione alla Francia le toglieva di essere considerata potenza di primo ordine come per grandezza di storia e di territorio avrebbe meritato; per questa, l'abdicazione verso il papa e il vassallaggio a Napoleone le scemavano tristamente la necessaria legittimità.
Il profondo mutamento avvenuto nella storia nazionale cogli ultimi fatti non era ancora abbastanza visibile.
La monarchia piemontese, annullando in se stessa i Ducati e il regno delle due Sicilie, non aveva sollevato la nazione nella modernità di un fatto pari a quello di Francia e d'Inghilterra. Certo la dinastia di Savoia si era mostrata incomparabilmente migliore di ogni altra lorenese o borbonica, ma l'idealità italiana non aveva potuto incarnarsi in essa. Il moto rivoluzionario ispirato da Mazzini e guidato da Garibaldi la trascendeva; la spontaneità popolare, quantunque scarsa, era bastata a sopraffare la sua iniziativa; quindi la sua opera vi era stata più necessaria che benefica, la sua abilità più egoistica che feconda, i suoi guadagni più grossi che legittimi. Nessuna grandezza epica consacrava i suoi trionfi, nessuna superbia di pensiero o di carattere poteva dare alle sue prime parole in Europa quell'accento baldo dei popoli, che si affacciano alla storia. Anzi il suo atteggiamento era anche più umile di prima, le diplomazie le negavano tuttavia il riconoscimento ufficiale, la rivoluzione le rifiutava persino [99] quel rispetto, che tutti i vinti sentono involontariamente pel vincitore.
Garibaldi, malgrado il divieto dell'Europa, aveva potuto conquistare il regno delle due Sicilie; la monarchia, per bloccare l'ultima fortezza di Gaeta, aveva dovuto implorare il permesso di Napoleone III.
Alla servitù austriaca sarebbe quindi succeduto il vassallaggio francese; dopo una politica di schiavi un'altra di liberti; ad una rivoluzione provocata da un'avventura napoleonica e compita da una avventura garibaldina seguirebbe fatalmente una monarchia senza tradizione e senza principii, costretta a ridere dell'idealità rivoluzionaria e a carpire i modi della propria resistenza ad un imperatore, più sensibile ai pericoli che alle vergogne, con poco credito in Europa, senza frontiere a ponente e a levante, con uno straniero nemico sul petto, uno straniero protettore sulle spalle, uno straniero indigeno nel cuore.
Non pertanto il nuovo regno doveva funzionare come se fosse tutta l'Italia: dal 1849 al 1859 si era svolto il periodo della preparazione piemontese; dal 1860 al 1870 si svolgerebbe quello dell'organizzazione nazionale.
I suoi dati ne erano immutabili come in tutti i periodi storici.
La nuova monarchia doveva per necessità della propria forma combattere con ogni mezzo la rivoluzione, assorbendone i migliori elementi per creare nel popolo la fede a se medesima, e nullameno subire il programma rivoluzionario, che metteva a scopo immediato di ogni azione la conquista di Venezia e di Roma. La fatalità dell'unità spingeva a queste due ultime annessioni senza che la monarchia potesse nè sottrarsi alla politica clericale di Napoleone, nè combattere da sola contro l'Austria. Il suo programma si dibatteva in un'antitesi insolubile a qualunque abilità di statista. [100] La monarchia, come risultato dell'insufficienza rivoluzionaria della nazione, era destinata a fallire dinanzi ai due problemi nei quali la stessa rivoluzione si era infranta. Per conquistare Roma bisognava rovesciare l'impero napoleonico, per liberare Venezia era d'uopo sconfiggere l'impero austriaco.
La politica monarchica si sarebbe dunque trascinata d'espediente in espediente, aspettando in Europa un'altra alleanza che le permettesse di combattere l'Austria, ed augurando un caso indefinibile che le concedesse Roma. Intanto all'interno, dopo l'unificazione plebiscitaria, bisognava ricominciare quella più efficace delle leggi e dei costumi: la nuova dinastia, assorbendo il prestigio di tutte le altre dalla millenaria servilità del popolo, doveva conservare l'aureola rivoluzionaria. A ciò era prima difficoltà lo stesso carattere dell'egemonia piemontese e della conquista regia, che, irritando la vanità delle altre provincie, dava al piccolo stato sardo un'ombrosa sembianza di usurpatore. Torino era troppo piemontese per poter restare la capitale d'Italia: la casa di Savoia, più antica che illustre, non era mai penetrata abbastanza nella storia italiana per iniziarne la nuova epoca da Torino, ove aveva molto regnato nel più chiuso egoismo dinastico e con tendenze antinazionali. La tradizione monarchica e il diritto statutario non bastavano a risolvere il problema ideale di Roma: il re era piccolo in faccia al papa, l'idea regia vaniva dinanzi all'idea cattolica. Solo la rivoluzione poteva proclamare Roma capitale d'Italia, giacchè proclamarla tale e non conquistarla sarebbe la più dolorosa e ridicola confessione d'impotenza; solo l'idea democratica era maggiore dell'idea cattolica. La monarchia ricadeva quindi in una seconda antitesi per l'impossibilità di restare a Torino e di andare a Roma.
D'altronde la rivoluzione, forzata a vivere di idealità dopo la sconfitta toccata alla republica mazziniana, si sarebbe giovata di questa impotenza monarchica per compromettere il governo con vani tentativi di guerra contro Venezia e contro Roma; così che la monarchia, [101] impedendoli con le armi, avrebbe pericolato nel disonore della guerra civile.
Se la monarchia non aveva nemici terribili all'interno, non contava dai piemontesi in fuori altri sudditi devoti: tutta la sua forza stava nella necessità di una maggiore unificazione politica e nell'impossibilità di una republica mazziniana.
Il popolo non afferrava ancora il significato della rivoluzione. Accettava piacevolmente lo sfratto degli austriaci e degli altri tirannelli, ma non sentiva vergogna di doverlo all'intervento della Francia; applaudiva le vittorie di Garibaldi, ma non si era levato e non si leverebbe in massa per seguirlo, trovando naturale che la monarchia arrestasse la sua opera per meglio sfruttarla. La rivoluzione non era per la maggior parte della gente che un buonissimo affare politico, dal quale bisognava trarre il maggior profitto senza compromettersi in nuovi rischi. Il magnanimo idealismo della minoranza rivoluzionaria pareva rettorica all'ottuso senso morale e alla istintiva furberia della moltitudine. Cavour, massimo rappresentante degli interessi, soverchiava Mazzini, supremo apostolo delle idee. La rivoluzione non si chiariva ancora nella propria opposizione coll'idea cattolica del papa; non si capiva che il principio della sovranità popolare doveva tradursi nella sfera della religione come sovranità del pensiero civile; che emancipandosi dal diritto divino bisognava liberarsi dal diritto papale; che la regalità dell'elettore in faccia al re produceva la libertà del credente contro il papa.
Il clero italiano, antinazionale a cagione del potere temporale, avrebbe dovuto essere considerato doppiamente nemico.
Invece dopo le vittorie in quasi tutti i paesi si cantarono Tedeum per le piazze; l'esercito piemontese doveva ancora recitare le orazioni mattina e sera nelle caserme, ed assistere tutte le feste alla messa; Garibaldi medesimo a Napoli aveva dovuto visitare San Gennaro, che colla solita compiacenza a tutti i vincitori ripetè [102] per lui il miracolo della ebullizione del sangue. Il popolo tutt'altro che rivoluzionario sembrava invece non volere accettare la rivoluzione che consacrata dalla religione. Quindi la teatralità dei trionfi si spiegava nelle più grottesche forme: molti preti liberaleggiavano, la maggior parte degli elettori dopo il plebiscito andavano ad accusarsi del voto come di un peccato, e ne ricevevano la penitenza. Appunto perchè il popolo aveva dato un numero troppo scarso di volontari imbizzarriva ora sotto le assise della guardia nazionale chiamandola al palladio della nazione. E queste guardie nazionali furono mandate a guarnigione da paese a paese come una specie di presentazione che ogni città facesse all'altra dei propri cittadini. Invece la coscrizione venne accolta con tristissima ripugnanza: nella sola Sicilia i renitenti alla leva giunsero presto a seimila, nelle Romagne superarono il migliaio; e se ad essi si aggiunga, come purtroppo si aggiunsero, quelli delle altre provincie e le innumerevoli bande di briganti che infestarono lungamente il Napoletano dandovi combattimenti quasi grandi come battaglie, nell'indomani trionfale della rivoluzione il numero dei ribelli reazionari pareggiò quasi quello dei volontari. Certamente Garibaldi non ne ebbe seco di più.
Eppure la coscrizione a lunga ferma secondo l'antico sistema non colpiva che un numero ristretto di giovani, conservando l'ignobile privilegio borghese della surrogazione per denaro.
Le campagne erano specialmente ostili al nuovo governo per la coscrizione e per l'immediato aumento delle imposte. Si sarebbe voluta la libertà senza pagarne le spese: i preti aizzavano, la borghesia chiusa nell'egoismo economico dubitava ancora di affidarsi in massa al nuovo governo, che nessuna potenza d'Europa aveva riconosciuto. Sotto la baldoria delle feste si sentiva un certo scoramento; poichè la rivoluzione non era frutto dell'energia nazionale, solo coloro che avevano combattuto erano forti nella sua fede. Però nella rivoluzione il capo più saldo essendo la monarchia [103] piemontese, non si credeva che ad essa. Garibaldi aveva piuttosto colpito le immaginazioni che persuaso gli intelletti. Le sue incredibili vittorie erano in gran parte risultate, come nel Napoletano, dalla viltà dei nemici: i suoi volontari erano o giovani colti e signorili, o spostati di piazza pronti sempre ad accorrere in tutti i tumulti. Quindi l'avaro buon senso della borghesia ricusava di credere a queste forze rivoluzionarie, se maggiori complicazioni avessero ricondotto l'Italia ad una guerra contro l'Austria o contro la Francia. Il programma rivoluzionario pareva assurdo, il principio democratico diventava paradossale in un paese, ove il popolo non esisteva ancora come classe politica.
Bisognava quindi disfarsi al più presto degli elementi rivoluzionari.
Dopo aver ottenuto l'indipendenza per un aiuto francese, era suprema necessità carpire all'Europa il riconoscimento ufficiale con una politica di moderazione che non desse ombra alle maggiori potenze: i rivoluzionari, indispensabili alle prime vittorie, diventavano adesso d'impaccio e di pericolo. Sola la borghesia dietro la scorta infallibile degli interessi materiali poteva, entrando nella rivoluzione, assodarne la base e regolarizzarne il governo. I suoi istinti commerciali ed industriali avrebbero mirabilmente assecondato il moto di unificazione nelle leggi; l'abitudine dell'ordine, antica in essa, avrebbe creato la nuova disciplina politica; la sua chiaroveggenza finanziaria avrebbe permesso nella necessità di un nuovo immenso debito il meno disastroso esercizio di spese. Però la borghesia avrebbe voluto naturalmente arricchirvisi.
Il conte di Cavour lo comprese mirabilmente.
La sua prima politica interna fu di seduzione ai borghesi e di ostilità ai rivoluzionari. Per passare dalla rivoluzione alla organizzazione era d'uopo accogliere nel governo il maggior numero dei più forti interessi; l'esercito dovrebbe funzionare come un crogiuolo assimilatore per le differenze morali delle varie provincie, [104] disciplinando la tradizionale insubordinazione italiana. La burocrazia, ingrossata celermente ed elefantescamente, avrebbe fornito un altro esercito d'impiegati, più mobile, meglio aderente al governo perchè cointeressatovi come in una azienda commerciale. Da questi due corpi bisognava escludere tutti i rivoluzionari, che per altezza d'ingegno o purezza di carattere o riottosità di sentimento non si convertissero alla monarchia: e a questi irreconciliabili infliggere quel disprezzo che tutte le società hanno per i propri scarti.
Il moto di condensazione intorno alla monarchia riuscì poderosamente.
Nessuno si preoccupò che Mazzini, ancora sotto l'onta dell'ultima condanna a morte per la spedizione di Pisacane, restasse in esilio: a Garibaldi l'istinto borghese cercò un rivale prima nel Fanti, poi nel Cialdini; malleabile e destro il primo, satrapesco e pretoriano il secondo, ambedue mediocri d'ingegno e di opere. I giornali moderati crebbero d'importanza, di numero e di abilità; naturalmente difendendo il fatto attuale del governo, la loro argomentazione fu sempre nella realtà, mentre i giornali radicali condannati ad una critica intransigente caddero nella rettorica: quelli furono satanicamente abili nel denigrare le glorie della rivoluzione aggravando il pervertimento morale della nazione; questi stancarono anche i buoni intelletti colla ripetizione monotona di idealità incompatibili colla vita reale.
La rivoluzione non ebbe quindi espressione artistica nel trionfo. Il popolo non vi trovò ispirazioni: l'inno garibaldino e l'inno reale furono due marcie peggio che volgari; di maggior estro la fanfara dei bersaglieri, truppa ammirabile di severa eleganza, creata dal Lamarmora, e che la monarchia oppose invano alle bande rosse destinate a rimanere il tipo più originale di soldato nel secolo decimonono. La poesia ammutolì. Vittorio Emanuele in tanta aureola di fortuna non commosse la fantasia nazionale; tutti sentivano che l'uomo, quantunque onesto d'intenzioni, non era pari nè [105] all'idea nè al fatto della rivoluzione: il suo valore di soldato non bastava a compensare la sua sommissione di re a Napoleone III; l'inevitabile egoismo dinastico, avendolo subordinato a tutte le umiliazioni politiche del governo durante il periodo delle annessioni, gli toglieva ogni carattere eroico. Finalmente la sua necessaria e mostruosa ingratitudine a Garibaldi, che più tardi cortesie intermittenti ed ineleganti non poterono velare, mentre l'incomparabile eroe seguitava a tributargli il più affettuoso rispetto, finirono di scoprire il fondo volgare della sua natura. L'eccesso medesimo della fortuna lo perdè nel sentimento poetico della nazione: Manzoni e Niccolini tacquero, Giosuè Carducci, allora giovinetto e poco dopo non meno grande di loro, lo salutò tribuno armato del popolo, ma quel saluto fu complimento peggiore del silenzio. Oggi stesso, dopo molti anni dalla sua morte, non una pagina immortale della moderna letteratura è ispirata dal suo nome. Il re di Savoia, diventato re d'Italia, non ebbe quindi la consacrazione della poesia perchè l'elemento poetico era tutto nella rivoluzione, dalla quale la monarchia usciva come un fatale processo prosastico. Le dinastie cadute non destarono lamenti, il papa non eccitò entusiasmi, Napoleone al di fuori dei circoli officiali non ottenne riconoscenza avendo guastato il beneficio col contrastarne le conseguenze.
Il primo parlamento italiano, radunatosi a Torino nell'ambito angusto del parlamento subalpino, non potè organizzare costituzionalmente i propri partiti.
La destra raccolse fra i vecchi monarchici tutti i nuovi convertiti alla monarchia; la sinistra, prigioniera del governo nei propri scanni, non seppe e non volle essere francamente antidinastica, avendo implicitamente accettato la monarchia col giurarle fede. Quindi il suo programma, suggerito dai comitati rivoluzionari, che si affaccendavano ancora per le piazze, riuscì assurdo [106] nelle idee e grottesco nei mezzi. Mentre il governo rifaceva ogni giorno con nuovi espedienti una politica di sommissione all'estero e di compressione all'interno, la sinistra per combatterlo efficacemente avrebbe dovuto oppugnare la monarchia; ma poichè la sua posizione di partito parlamentare subordinato ai plebisciti lo vietava, ne usciva una critica qualche volta eloquente, sempre inutile. D'altronde in quelle prime e multiple difficoltà di governo la sinistra non ebbe uomini di abbastanza pratica abilità per influire potentemente nella discussione: la stessa povertà della stampa radicale, senza nè economisti, nè finanzieri, nè giuristi, nè tecnici di altra maniera, intristiva la sinistra parlamentare. I suoi migliori personaggi, cresciuti nelle congiure e nelle battaglie, non erano che magnanimi d'intenzioni e rettorici nei mezzi, quando le condizioni della politica esigevano caratteri supini ed ingegni destri, coscienze elastiche e sentimenti volgari. La destra parlamentare, accampata nella devozione monarchica e nell'egoismo borghese, appariva incomparabilmente più forte. Il suo programma fu semplice: sommissione all'estero evitando qualunque nuova guerra che compromettesse le sorti del giovane stato, ed esautoramento della rivoluzione all'interno. Nelle sue file s'addensarono per coscienza di necessità storica ed avidità di lucro o di potere gli uomini più colti e più abili. Naturalmente i nuovi convertiti alla monarchia furono più aspri dei vecchi monarchici contro i rivoluzionari intransigenti: la compressione giunse spesso alla persecuzione; si ebbero ribalderie poliziesche, leggi di sospetto, che parvero richiamare i tempi borbonici. La misura, suprema gloria dei governi parlamentari, mancò troppo spesso anche per l'ignavia del paese, che lasciava maltrattare inutilmente i suoi eroi più ammirati.
Nell'unificazione legislativa la destra per istinto di governo fu più rivoluzionaria della sinistra, la quale per necessità di opposizione oppugnò la violenta centralizzazione e quel sopprimere subitaneo tutte le consuetudini [107] e gli statuti locali sovente migliori dei nuovi. Ma senza questa violenta ed affrettata unificazione, la coscienza unitaria avrebbe forse pericolato. Il modello legislativo, al solito accattato in Francia dai tempi del primo impero, non poteva in quel momento essere più adatto. Bisognava al governo un maneggio rapido ed assoluto di quasi tutta la vita publica per dominarla, giacchè la reazione clericale avrebbe potuto appiattarsi nemica in ogni istituto indipendente, o la rivoluzione farsi di questo una cittadella, dalla quale compromettere o sfidare la monarchia. I comuni, antica gloria italiana, vennero quindi mortificati sotto le prefetture; ogni autonomia provinciale inceppata; contese tutte le attività e le iniziative singole a pro dell'opera governativa. In questa inevitabile frenesia di rinnovamento legislativo le leggi grandinarono informi, disformi, deformi: fu un tumulto, nel quale la verità degli studi si confuse, la proporzione dei fatti colle idee si alterò. Il governo, invece di rappresentare la vita nazionale nella varietà delle sue tendenze e de' suoi atteggiamenti, parve una immane azienda nella quale pochi direttori manipolassero uomini e cose. Ma se la destra era politicamente reazionaria osteggiando la rivoluzione, che esigeva la conquista immediata di Roma e di Venezia, e mantenendo nel vecchio statuto l'elettorato così assurdamente ristretto che appena cinquecentomila erano gli elettori politici, nella sua opera penetrarono largamente i principii rivoluzionarii. Lo stesso assorbimento governativo ne fu causa. Così, presto si fe' strada la gratuità e obbligatorietà della istruzione elementare, la giurìa fu applicata dappertutto anche nelle provincie meno atte a così alto magistrato. Le strettezze del bilancio spinsero all'abolizione degli ordini religiosi coll'incameramento dei loro beni; la necessità di combattere il clero condusse a restringerne i privilegi; la promulgazione di tutti i codici nuovi, alla accettazione di moltissimi principii liberali non ancora accolti nella maggior parte delle legislazioni europee. Burocrazia ed esercito riuscirono efficaci strumenti [108] di livellazione democratica; si dovettero moltiplicare con paradossale energia strade, ferrovie, telegrafi, scuole; ogni creazione conteneva fatalmente un'idea democratica per quanto smezzata; ogni mutamento anche sbagliato era un progresso. Il passato, respinto da sforzi prodigiosi, dileguava a perdita d'occhio.
Urgeva rinnovare tutto e rinnovare presto: poi si sarebbe ricorretto e migliorato.
Altro terribile strumento di livellazione e di unificazione fu la imposta. Nel crescendo fantastico di spese e di debiti, malgrado le più dolorose sproporzioni di quote, i contribuenti sentirono la solidarietà italiana cui venivano sacrificati. Naturalmente le provincie del nord più ricche e civili, ove per ragioni di catasto o di altri congegni amministrativi era molto più facile colpire il contribuente, pagarono per le provincie meridionali più povere, e nelle quali mancavano le più necessarie opere pubbliche e i redditi erano di più difficile accertamento.
Così l'ignavia di coloro, che avevano assistito come spettatori alla liberazione d'Italia, trovò la pena nel trionfo; quelli, che non avevano sofferto sui campi di battaglia, patirono nel campo economico; chi non pagò di sangue pagò di borsa. Ma in questa crisi economica, nella quale perirono molte industrie e si disfecero parecchie classi di proprietari, altre ne crebbero: sotto la pressione del bisogno aumentò il lavoro; le vie di comunicazione, la soppressione di tutte le dogane interne, la diffusione delle idee, degli scambi e delle forze, le opere pubbliche, la concorrenza straniera e sopra tutto l'energia della nuova coscienza nazionale trionfarono delle micidiali esazioni. La ricchezza si sviluppò. Dall'arringo parlamentare, ove si discutevano publicamente gli interessi della nazione, derivò a questa la passione della vita publica: si cominciò a comprendere che il governo non era più un nemico come pel passato e che nel popolo, sebbene ancora amministrato da pochi borghesi, stava tutto il diritto. Entro i partiti [109] belligeranti per le grandi idee politiche se ne formarono altri con intendimenti minori di economia e di libertà interna: la partecipazione al governo diventò mano mano desiderio anche nelle masse; il nuovo assolutismo borghese trovò presto degli avversari.
Ma le questioni politiche soverchiavano. Mentre il governo a forza di procrastinarla rinunciava quasi alla conquista di Venezia e di Roma, si doveva nullameno sacrificare il paese all'improvvisazione di un esercito e di una marina capaci di maggior guerra appena se ne presentasse il destro. Il problema della riorganizzazione militare, già difficile in un periodo nel quale la scoperta di sempre nuove armi impone radicali e subiti mutamenti, diventava difficilissima in Italia per la fusione dei vecchi eserciti in quello piemontese. Mancavano illustri generali ed abili organizzatori: v'erano rivalità pericolose di milizia, tristissime abitudini da sradicare, odiosi privilegi da concedere.
Si dovevano accogliere reggimenti e generali, che avevano combattuto contro l'Italia o tradito i propri sovrani all'ultima ora, riformare i quadri, sottomettere gelosie, graduare meriti male definibili, fabbricare un numero immenso di armi, stabilire una nuova disciplina, creare la fede nella bandiera tricolore, profondere denaro, e nullameno dar paghe esigue fino al ridicolo.
Il partito piemontese, più forte ancora nell'esercito che nella camera, poteva diventare pericoloso; però l'esercito piemontese, per conseguenza della propria monarchia, doveva essere nucleo e tipo dell'esercito italiano. La flotta napoletana, maggiore della savoiarda, pretendeva al primato e lo meritava; ma non si poteva concederglielo per lo scarso patriottismo e la mala condotta del suo personale. Bisognava schiacciare nelle bande garibaldine il fiore della vita militare italiana. [110] perchè il suo profumo non inebriasse pericolosamente le altre milizie.
Sotto l'insistente proclamazione di idee e di sentimenti militari il morto federalismo risorgeva odiosamente, formandosi in camorre regionali, che la cresciuta facilità di lucri e di onori stimolavano avaramente. Se i piemontesi affettavano la loro conquista sino ad irritare in molte provincie il sentimento politico, di rimpatto queste si gettavano sul governo nazionale come sopra una preda: in tanto inevitabile sperpero di milioni e di miliardi ognuno voleva accaparrarsi la parte più grossa.
E questa rapacità e vanità provinciale intralciava l'opera già difficile del governo: nel parlamento destra e sinistra si scindevano per interessi regionali; nei ministeri bisognava proporzionare il numero dei ministri all'importanza delle regioni, cui appartenevano come deputati, sotto pena di una coalizione di opposizione altrettanto assurda che invincibile. Nessun ministero si sarebbe sostenuto, se composto di uomini nati a caso in una sola parte d'Italia. Naturalmente nei ministeri preponderava l'elemento piemontese, cui contrastava poderosamente l'elemento napoletano come il più numeroso e compatto nella camera. Al senato invece, nell'assenza di un'aristocrazia davvero dirigente come in Inghilterra, la battaglia si risolveva in una accademia, giacchè il privilegio di nomina regia permetteva di non introdurvi che senatori o nulli o della più ortodossa devozione monarchica. Esso non funzionava quindi che come una valvola di sicurezza per dare sfogo ai troppi vapori della camera, e come un magazzino di scarti politici, dai quali trarne ancora qualcuno servibile.
L'opposizione francamente antimonarchica rimasta a combattere il governo perdeva terreno ogni giorno, poichè la quantità possibile di rivoluzione pel paese penetrava abbastanza facilmente nelle leggi e nei costumi della vita nuova. Già le defezioni di coloro, che si sentivano o si credevano atti alla vita parlamentare, [111] e quelle dei moltissimi attirati dall'esercito, dalla burocrazia o da altri interessi trionfanti nei governo l'avevano miseramente assottigliata. Il mazzinianismo si restringeva sempre più a setta, l'ingrossare dell'esercito nazionale scemava l'importanza di altre future milizie garibaldine.
L'epopea era finita: alla rivoluzione non rimaneva che la sublime risorsa di qualche ultima tragedia.
Gli stessi disertori della rivoluzione nobilitavano contro di essa la monarchia agli occhi delle masse giudicanti sempre coll'istinto: nessun tentativo di rivolta avrebbe quindi trovato ribelli; Mazzini stesso non osava predicarla, Garibaldi non l'avrebbe capitanata. La parte rivoluzionaria era costretta a pretendere sulla monarchia una priorità d'iniziativa, alla quale il buon senso e la fiacchezza delle moltitudini si ricusavano; il nuovo regno d'Italia, entrando nel sinedrio delle potenze d'Europa, doveva d'ora innanzi agire diplomaticamente.
Le temerarie iniziative del momento venivano dall'opera legislativa, che sommoveva violentemente l'antico assetto italiano, pareggiando politicamente provincie differentissime per periodi di civiltà, per indole di storia e per irrigidimento di carattere. Lo stesso confuso e febbrile lavoro di costruzioni, comunicato dal governo alle provincie e ai comuni a guisa di un contagio, nascondeva all'occhio dei più iniziative non meno ammirabili delle più temerarie imprese garibaldine, come l'impianto delle ferrovie a rovescio d'ogni ragione economica e scientifica attraverso regioni quasi prive di ogni altra strada e quindi incapaci di alimentarle. Solo l'America aveva osato questo, ma l'America era ricca: l'Italia povera, in ritardo con ogni produzione, costretta ad improvvisare tutti i propri organi politici a un tempo, moltiplicando i debiti oltre qualunque elasticità di credito, esagerando le imposte, preparandosi ad altre guerre, coi terribili problemi di Roma e di Venezia insoluti, ancora smembrata e pericolante in uno stato provvisorio, era magnifica di ardimento [112] nel gettare miliardi per ferrovie che saldando la sua unità dovevano, anzichè coronare il sistema stradale, svilupparlo ove era appena abbozzato.
Scientificamente e finanziariamente quelle ferrovie erano un errore; politicamente furono il maggiore dei vantaggi, e resteranno malgrado gli immensi difetti una delle migliori glorie del nostro risorgimento.
Colla resa di Gaeta, cui seguì poco dopo quella del castello di Messina e di Civitella del Tronto, la conquista regia era compita. La nuova camera adunata a Torino si componeva di 443 deputati, ma nel primo fervore di adesione monarchica Guerrazzi, Bertani, Cattaneo, Montanelli ne rimasero esclusi. Il discorso di apertura corteggiò tutte le nazioni d'Europa per trarle al riconoscimento ufficiale del nuovo regno, tacque di Roma e di Venezia ammonendo severamente i volontari a non agitare ulteriormente il paese per una guerra.
La prima legge fu di un solo articolo: «Re Vittorio Emanuele II prende per sè e pe' suoi successori il titolo di re d'Italia», formula infelice, giacchè il titolo di secondo, conservato dal re nella cronologia della propria stirpe, ribadiva il concetto della conquista piemontese: Vittorio Emanuele non poteva essere che il primo re d'Italia. Un'altra legge gli riconobbe il diritto dalla grazia di Dio e dalla volontà della nazione; e fu espressione assurda ma inevitabile ad un regno costituzionale, in cui la sovranità nazionale si amalgamava al diritto divino.
Alla proclamazione del regno fioccarono le proteste dell'Austria, del papa e degli altri principi spodestati. La Francia sembrava tenere il broncio: nullameno ricusò [114] la proposta spagnuola ed austriaca di convocare un congresso delle tre primarie potenze cattoliche per assicurare i diritti sovrani della chiesa. La Prussia si manteneva sul diniego, la Russia proseguì nelle ostilità: solo l'Inghilterra fra i grandi stati aveva riconosciuto il nuovo regno.
Cavour, raddoppiando di attività, si accinse ad assettarlo. Allontanato Garibaldi, mantenuto in esilio Mazzini, impedito a Cattaneo il parlamento, domata la rivoluzione e scompaginato il partito rivoluzionario, egli rinunciò abilmente ad insistere per il ricupero della Venezia, sulla quale la Germania manteneva ancora troppe pretese, per tentare invece il problema di Roma. Il tumulto dei nuovi elementi parlamentari non lo stordiva. Egli comprendeva benissimo, quantunque monarchico e piemontese, che il nuovo regno non poteva organizzarsi intorno a Torino: tutto il mezzogiorno avrebbe recalcitrato contro questa eccessiva preponderanza piemontese, mentre una pericolosa incertezza come di provvisorio avrebbe sempre pesato sul nuovo regno. L'italianità era in Roma. Ma dinanzi a questo problema il suo destro ingegno di statista doveva fatalmente venir meno.
Già prima dell'occupazione delle Marche e dell'Umbria, nel subito tumultuare della rivoluzione, egli aveva mandato a Roma l'abate Stellardi, elemosiniere del re, con una lettera di Vittorio Emanuele al pontefice e con facoltà di esibire queste proposte: il papa conserverebbe l'alto dominio sulle Romagne, le Marche e l'Umbria, e ne affiderebbe il governo al re di Sardegna come vicario. Era un'esumazione dei concetti medioevali, che naturalmente abortì, e una rinuncia a Roma capitale. Cavour, sempre incredulo nell'unità d'Italia, insidiando queste provincie al papa, non mirava che ad un'altra forma d'annessione. Infatti l'alto dominio del pontefice si sarebbe nel fatto ridotto a meno che nulla.
Ma la rivoluzione avendo con Garibaldi conquistato le due Sicilie e prodotto il regno d'Italia, il problema [115] di Roma capitale s'imponeva alla politica monarchica. Il conte di Cavour, troppo grande statista per non sentirlo, non lo era nullameno abbastanza per comprendere che solo la rivoluzione avrebbe potuto idealmente risolverlo. Quindi tentò. La sua formula: «libera chiesa in libero stato», avrebbe dovuto fare il miracolo. Diplomatico in queste trattative entrò il dott. Diomede Pantaleoni, residente in Roma e ben ricevuto nei circoli vaticani: il padre Passaglia, gesuita cresciuto di nome per la difesa del dogma dell'Immacolata Concezione, e più tardi di fama per una mezza apostasia, assecondava.
Il disegno era una specie di alleanza fra il papato e l'Italia col principio: «libera chiesa in libero stato»; quindi abolizione di tutte le leggi giuseppine, tanuccine, leopoldine; tutti i vescovi eletti senza intromissione del governo, assoluta libertà alla chiesa d'insegnare e predicare, il patrimonio ecclesiastico dichiarato intangibile, garantita al Santo Padre ogni immunità nell'esercizio spirituale, assicurata ai fedeli di tutto l'orbe la comunicazione col Vaticano, ministri e nunzi pontifici inviolabili, creato un lauto patrimonio alla Santa Sede.
In compenso essa rinuncierebbe al potere temporale.
La curia Vaticana resistè.
Allora il conte di Cavour si torse verso Francia: questa volta intervenne diplomatico il principe Girolamo Napoleone, genero del re. Non potendo ottenere Roma dal papa, l'astuto ministro cercava di sottrarre Roma al protettorato francese: le basi delle nuove convenzioni, senza adesione della corte romana, erano: la Francia, garantito il papa da qualsivoglia intervento straniero, ritirerebbe da Roma le proprie truppe; l'Italia s'impegnerebbe a non aggredire e a non permettere aggressioni esteriori contro il territorio attuale del pontefice, non reclamerebbe contro l'organamento di un esercito pontificio con volontari cattolici stranieri, purchè non superasse i diecimila soldati e non trascorresse a minacce contro il regno; infine accetterebbe [116] di trattare col governo romano per assumere la propria parte proporzionale nelle passività delle antiche provincie pontificie. Ma nemmeno questa convenzione fu conchiusa, giacchè l'imperatore non voleva ancora nè abbandonare il papa, nè emancipare al tutto l'Italia. Con tale convenzione, che pochi anni dopo doveva generarne una ben più triste, il conte di Cavour senza rinunciare formalmente a Roma nè proclamarla officialmente capitale, avrebbe ottenuto di potersene facilmente impossessare appena ne capitasse il destro, senza rompere guerra alla Francia.
Poi, nel dicembre dell'anno 1860, rimandò a Roma Omero Bozzino a ritentare la prova delle prime offerte sulla fede di qualche cardinale, come il Santucci, che sembrava mantenersi propizio agli accordi. Lo stesso segretario Antonelli si prestò furbescamente al giuoco per meglio umiliare la politica piemontese; ma, dopo aver finto di patteggiare persino il prezzo delle proprie condiscendenze, troncò bruscamente la pratica esiliando il Pantaleoni.
Questa volta il fino diplomatico piemontese aveva trovato nel prelato romano una scaltrezza anche più perfida.
Intanto la parte rivoluzionaria agitava vivamente nel paese la questione di Roma: si moltiplicavano indirizzi e proteste al re e all'imperatore; l'Inghilterra per gelosia del cesarismo bonapartesco insisteva officialmente per lo sgombro da Roma del presidio francese; il governo doveva uscire dal silenzio con più alta affermazione italiana sotto pena di soccombere nella coscienza nazionale.
Cavour ebbe tutta l'audacia consentitagli dal proprio sistema e dal proprio temperamento politico: combinò col deputato bolognese Audinot un'interpellanza e coll'ex-ministro Buoncompagni un ordine del giorno, nel quale era scritto: «La camera, udite le dichiarazioni [117] del ministero, confidando che, assicurata l'indipendenza, la dignità e il decoro del pontefice e la piena libertà della chiesa, abbia luogo di concerto colla Francia l'applicazione del principio di non intervento e che Roma, capitale acclamata dall'opinione nazionale, sia resa all'Italia, passa all'ordine del giorno» (27 marzo 1861).
Tutta l'insufficienza e l'astuzia italiana erano riassunte in questo ordine del giorno. Il diritto nazionale su Roma vi diventava opinione, quello del non intervento cessava di essere un principio per ridiventare materia di accordi, la sudditanza alla Francia nella ragione più intima della vita e della storia nazionale era proclamata in faccia a tutto il mondo; ma con questo così umile ed umiliante ordine del giorno il governo persuadeva al paese di aver compiuto un atto magnifico di audacia. Nella coscienza confusa della borghesia Roma diventava legalmente capitale d'Italia, l'occupazione dei francesi vi era segnalata come un arbitrio, l'agitazione rivoluzionaria perdeva quasi totalmente ogni efficacia di persuasione per una nuova impresa su Roma, che la monarchia si appropriava rimettendone la presa di possesso alla prima favorevole occasione.
Infatti la publica opinione esultò: solo Mazzini e Garibaldi, il genio e il cuore d'Italia, sentirono l'ineffabile offesa. La pace di Villafranca non aveva tradito che il Piemonte, troppo piccolo allora per resistere solo contro Austria e Francia: il riconoscimento officiale del diritto alla Francia di occupare militarmente Roma, e la proclamazione di non ricevere questa che dalle sua mani, annullava la neonata individualità dell'Italia.
Nullameno tacere di Roma sarebbe stato impossibile ed altrettanto miserevole per il governo, che nei primi dubbi delle annessioni meridionali per propiziarsi la Francia aveva dovuto lusingarla con un'altra possibile cessione della Sardegna: per fortuna le veementi proteste dell'Inghilterra, irritata dal pericolo che [118] il Mediterraneo si mutasse così in lago francese, salvarono questa isola all'Italia, e il ministro potè in seguito mentire alteramente respingendo tale accusa.
Ma colla proclamazione di Roma capitale d'Italia il conte di Cavour otteneva l'incomparabile vantaggio di consacrare italiana la monarchia sarda: l'umiliazione di quell'ordine del giorno, così profonda che sfuggì al sentimento delle masse, ne impediva una peggiore di una rinuncia a Roma capitale. La monarchia trionfava un'altra volta della rivoluzione, la quale conquistando Roma non avrebbe potuto che conquistarla per essa. La politica regia era da troppi secoli abituata a vincere colla sola astuzia e a guadagnare anche con la sola viltà, perchè quella formale abdicazione del più alto fra i diritti nazionali potesse sgomentare la sua coscienza; la giovane nazione era troppo poco rivoluzionaria per imporle una politica più nobile, e troppo memore della passata servitù per offendersi di un vassallaggio ideale, cui sentiva nel proprio istinto di potersi fra non molto sottrarre.
Il conte di Cavour in questa campagna parlamentare manovrò colla stessa prontezza di decisione e rapidità di cangiamenti tattici che in quella dell'invasione nel territorio pontificio per impossessarsi di Napoli: difetti di forma e insufficienza d'idea vi derivavano meno dal suo spirito che dal sistema monarchico. Se egli lo avesse trasceso coll'ingegno o col carattere, non ne sarebbe stato il massimo politico: quindi stretto in un'antitesi insolubile, invece di lasciarvisi schiacciare, italianamente scivolò fra i due termini.
La nazione, che aveva con Garibaldi e con Mazzini mostrato al mondo il più eccelso esempio di epica semplicità, poteva giovarsi impunemente della doppiezza di Cavour.
Intanto le difficoltà politiche del primo assetto urgevano: bisognava abbreviare con ogni mezzo possibile [119] i governi luogotenenziali, pacificare il mezzogiorno ove il brigantaggio era già scoppiato, assimilare politicamente ed amministrativamente tante provincie diverse, fondere sette bilanci in uno solo e già oberato da un passivo di mezzo miliardo, organizzare il nuovo esercito.
Il conte di Cavour fu ammirabile di destrezza e di coraggio. Il suo profondo acume politico gli scoprì che di tutti gli elementi rivoluzionari il più pericoloso per la monarchia era allora il più nobile, quello che con prodigi di valore e di fortuna aveva conquistato più che mezzo il regno. I mazziniani battuti idealmente e politicamente non erano ormai altro che una setta; i garibaldini invece rimanevano ancora maggiori di un partito. La loro incorporazione nell'esercito piemontese vi avrebbe dissipato il prestigio monarchico e distrutta la devozione al re: la politica, entrando nelle caserme, avrebbe resa la sinistra parlamentare arbitra della camera, tristissimi pronunciamenti alla spagnola sarebbero scoppiati ad ogni difficile questione di governo. Bisognava dunque rifiutare nell'esercito le bande garibaldine, accogliendovene quei capi più illustri che si convertissero alla monarchia: così, prive dei migliori capitani e disorganizzate dalle defezioni, non potrebbero che difficilmente riordinarsi per una ribellione. Questa politica era la conseguenza della campagna delle Marche e dell'ingresso delle truppe piemontesi nel Napoletano per soffocarvi la anarchia rossa: dopo aver disonorata l'impresa garibaldina in faccia all'Europa, era d'uopo esautorarla nell'opinione d'Italia col respingere dall'esercito nazionale i reggimenti vincitori.
Garibaldi, rinunciando nelle mani del re la dittatura, gli aveva raccomandato con passione di capitano i propri soldati; quindi, conscio delle nuove trame, aveva già protestato da Caprera e minacciava di venire in parlamento a farvi uno scandalo pericoloso. Tutta la sua magnanimità non poteva tollerare che gli eroi di Calatafimi e del Volturno fossero peggio trattati dei [120] loro prigionieri borbonici. Egli poteva sorridere vedendo generali d'Italia Nunziante e Pianell, l'uno ferocemente reazionario prima della rivoluzione e vilmente disertore del proprio re nell'ora delle battaglie, l'altro ministro di Francesco II durante la conquista del regno napoletano, entrambi a lui preferiti dalla nuova politica ministeriale; ma per coscienza di generale e di cittadino, per carità di soldato e di patriota, non doveva sopportare che le ferite e i gradi guadagnati dai propri soldati sul campo di battaglia fossero senza valore per quello stesso governo, che profittava delle loro vittorie.
Nullameno una più alta ragione imponeva agli eroi delle sue imprese questo nuovo sacrificio.
Garibaldi coll'impetuosità del proprio carattere soldatesco, e stimolato da molti partigiani, aveva esorbitato nei primi attacchi al ministero. Egli, nizzardo, non poteva perdonare a Cavour la cessione di Nizza; egli, italiano e democratico, odiava eroicamente Napoleone III, che dopo aver tradito il Piemonte a Villafranca, impedendo la liberazione della Venezia ed esigendo come prezzo del tradimento Nizza e Savoia, negava ancora Roma all'Italia.
Nella superba ingenuità del proprio istinto rivoluzionario egli non comprendeva nulla delle difficoltà diplomatiche del nuovo regno: per lui ottenere il riconoscimento officiale dalle grandi potenze monarchiche d'Europa non era nemmeno un problema. Esaltato dall'entusiasmo delle ultime vittorie, domandava ad alte grida l'armamento di tutta la nazione, confidando di battere con essa tutta l'Europa. Cavour con più sicuro senso della realtà giudicava invece l'Italia incapace di sostenere altra guerra con l'Austria e, siccome questa cercava di esservi provocata, non voleva fornirle pretesti. Nei primi giorni del 1861 per l'incoronazione del principe reggente e futuro imperatore, Guglielmo I, aveva mandato a Berlino il generale Lamarmora per sedurre la Prussia coll'esempio della rivoluzione italiana a conquistare contro l'Austria l'egemonia [121] germanica; ma il nuovo re, tardo di mente e di cuore, non ne rimaneva persuaso, quantunque il ministro Schleinitz si lasciasse piegare. La Russia rimaneva pur troppo ostile, la Francia sempre oppressiva nella propria politica tergiversante tardava a rannodare col governo piemontese le relazioni officiali, mentre una vera anarchia reazionaria scoppiava nel mezzogiorno in mezzo al più scandaloso disordine dei partiti, compromettendo all'estero la dignità del nuovo regno. Il Farini, il principe di Carignano, poi il conte Ponza di San Martino, mandati l'uno dopo l'altro a reggere Napoli, vi avevano ripetuto lo stesso infelice esperimento; il Napoletano pareva diventare una nuova Irlanda saldata dalla rivoluzione ai fianchi del regno d'Italia.
Cavour, malgrado la coraggiosa elasticità del proprio ingegno, piegava ogni tanto sotto il peso dell'enorme problema: l'intervento di Garibaldi nella politica interna poteva produrre la guerra civile. Il dittatore rappresentava in quel momento la passione rivoluzionaria della nazione, non ancora domata dalla proclamazione e dall'assetto della monarchia: le sue invettive al ministero, giuste nel concetto rivoluzionario, esaltavano la publica opinione malcontenta della troppa viltà di quell'ora; l'aureola di tante vittorie lo rendeva un rivale pericoloso pel re.
Intanto il parlamento frustato dalle accuse di Garibaldi nella coscienza della propria servilità s'impennava, minacciando di voler mettere il generale in accusa: ribellione di liberti contro il liberatore, che nessuna regolarità di procedura costituzionale avrebbe potuto giustificare! Il parlamento era allora troppo poca cosa in Italia per farsi arbitro della contesa fra rivoluzione e monarchia. Il conte di Cavour già vincitore di Garibaldi alla camera, quando questi da Napoli aveva chiesto al re di cacciare il ministero, trovò anche questa volta un ottimo espediente. Fra tutti gli uomini parlamentari di allora il più illustre per nome, per opera, per carattere, era il barone Bettino Ricasoli. La sua austerità aristocratica, la sua alterezza patriottica, [122] il suo coraggio politico, lo rendevano altrettanto stimato che temuto: in quella gazzarra di conversioni e di transazioni, nella quale i migliori caratteri si dissolvevano, egli restava fermamente saldo nel proprio concetto rivoluzionario e monarchico, impaziente contro il vassallaggio francese, favorevole per ingenita intrepidezza ad una ripresa di guerra.
Il conte di Cavour oppose Bettino Ricasoli a Giuseppe Garibaldi.
Con profonda abilità di parlamentare Ricasoli, anzichè accusare Garibaldi, affermò in una interpellanza di crederlo calunniato. «Io, disse, gli ho stretto la mano dal momento, in cui prese il comando dell'esercito dell'Italia centrale: noi eravamo allora animati dagli stessi sentimenti, noi eravamo tutti e due egualmente devoti al re. Noi abbiamo giurato entrambi di fare il nostro dovere: io ho fatto il mio. Chi dunque potrebbe reclamare il privilegio di patriottismo e d'innalzarsi sopra gli altri? Una sola testa fra noi deve dominare su tutte le altre, quella del re. Davanti al re tutti debbono inchinarsi, ogni altro atteggiamento sarebbe di ribelle... Chi ebbe la fortuna di compiere il proprio dovere più generosamente, in una più larga sfera d'azione, in una maniera più proficua alla patria, e l'ha veramente compito, questi ha un dovere anche più grande, di ringraziar Dio d'avergli accordato così prezioso privilegio, concesso a pochi cittadini e di poter dire: ho servito bene la mia patria, ho interamente compito il mio dovere».
Garibaldi da accusatore diventava accusato: la solennità dell'intimazione fattagli dal Ricasoli lo costringeva a venire in parlamento per sostenere quanto aveva scritto. Garibaldi, che non voleva e non poteva ribellarsi, era già vinto: prima ancora di giungere a Torino pubblicò una lettera, smentendo ogni intenzione di attacco contro il re e il parlamento. Non gli restava quindi di fronte che il ministero, il quale nella camera era sicuro della vittoria.
Nullameno la giornata fu aspra.
[123] Il parlamento, costretto dalla propria dedizione incondizionata a seguire una politica servile all'estero ed ingiusta all'interno, era tuttavia affollato di uomini illustri per ingegno e per sacrifici, che sentivano di non meritare le accuse di Garibaldi. Il loro risentimento, giustificato dall'orgoglio delle opere compiute ed inasprito dalla coscienza del torto presente, degenerava in aperta ed ingenerosa ostilità. Si dimenticavano i titoli di Garibaldi alla riconoscenza nazionale per non vedere più in lui che un volgare vanesio ed uno scapigliato ribelle.
Quando entrò nella sala colla camicia rossa e il solito poncho americano, la singolarità dell'abito parve una brutta teatralità. Il suo primo doloroso rimprovero a Cavour per la cessione di Nizza provocò la tempesta; alla sua accusa contro il ministero di avere arrestato la rivoluzione trionfante nel mezzogiorno con ogni maniera d'insidie e colla provocazione di una guerra civile l'uragano scoppiò. Solo Garibaldi rimase calmo. L'accusa era troppo vera perchè non bisognasse smentirla. Ma Garibaldi non poteva andare oltre. La stessa ragione, che lo aveva sottomesso in Napoli agli ordini del re, lo costringeva ad accettare ora le spiegazioni di Cavour. Il generale Fanti, ministro della guerra, si destreggiò abilmente nell'esposizione dei motivi, che impedivano la incorporazione in massa dei garibaldini nell'esercito; si respinse l'altro progetto di Garibaldi di formare coi giovani non compresi nell'esercito dai 18 ai 35 anni una guardia nazionale mobile, cui lo stato fornisse d'armi, di cavalli e di materiali inscrivendo in bilancio una somma di trenta milioni. Cavour, pronto a servirsi di tutta la propria superiorità in quel momento, riassunse con sobrietà magistrale la propria politica, chiudendo il parlamento nel dilemma o di accettarla intera o di buttarsi ai rischi immediati di un'altra guerra o di un'altra rivoluzione.
Garibaldi piegò: i garibaldini furono sacrificati. Invano, nell'abboccamento con Cavour procuratogli dal re, egli tornò malinconicamente ad insistere per un [124] migliore trattamento dei propri soldati; l'abile ministro rimase inflessibile.
L'indomani il generale Cialdini, tristamente ammalato d'invidia per l'eroe, credendo propizio il momento per levarsi contro di lui come campione della monarchia, lo apostrofò con una lettera altrettanto assurda che arrogante.
Cavour con questa suprema vittoria assicurava la propria politica di moderazione. Ma egli stesso era fiaccato dalla immensa opera.
Nel disegno di riforme amministrative presentato al parlamento, appena risoluta la questione militare, il suo ingegno parve rimettere del solito coraggio. Quel potente senso di accentramento governativo cresciutogli dal fatto dell'unità nazionale, che lo spingeva alla più rapida delle unificazioni legislative, gli venne improvvisamente meno nel maggior problema delle circoscrizioni. Forse in nessun paese d'Europa per troppe complesse ragioni di storia la divisione e l'aggruppamento dei comuni e delle provincie era più assurda che in Italia: tutta la lunga guerra federale era ancora visibile nei loro reparti: nè monti, nè fiumi determinavano i confini. Divisioni politiche e diocesane intralciavano gli scambi reciproci, la mancanza di strade rendeva spesso impossibili molti esercizi di doveri e di diritti, rivalità municipali e provinciali si alimentavano tuttavia di odii storici, che la pacificazione dell'unità sembrava riconfermare nella teatralità di un perdono reciproco. Alcune città si barattavano come pegno di pace trofei di guerre medioevali.
Le nuove circoscrizioni avrebbero dovuto distruggere tali differenze spersonalizzando parecchi comuni ed alcune provincie. Invece il ministero proponeva una nuova istituzione di regioni, tagliate nello stato a capriccio, senza nè fondamento di tradizione, nè ragioni di modernità. L'idea era stata del Farini, che prima [125] delle annessioni meridionali aveva proposto di dividere il regno in sei regioni: ma innanzi a lui, fino dal 1833, Mazzini nell'opuscolo sull'Unità Italiana proponeva di sopprimere le provincie, riducendo gli ottomila comuni a milleduecento con circa ventimila abitanti ciascuno e spezzando l'Italia in dodici regioni di cento comuni. Così, per combattere il federalismo storico, si creava un federalismo artificiale. Nell'impossibilità di correggere subito i limiti dei comuni e delle Provincie era miglior sistema negli inizi del governo nazionale raggrupparli il più naturalmente possibile sotto le prefetture. Nelle regioni gli antagonismi federali si sarebbero serviti delle nuove libertà contro l'unificazione: le facoltà legislative, loro concesse inevitabilmente, vi avrebbero creato tanti piccoli stati nello stato in opposizione col governo centrale.
L'istinto rivoluzionario del parlamento supplì al difetto di Cavour, che aveva permesso al Minghetti, ministro dell'interno, di ripresentare raffazzonato e peggiorato il primo disegno di Farini; la legge fu scartata. L'unità trionfava attraverso tutti gli errori. Poco dopo lo stesso ministro proponeva che la festa dello Statuto dichiarata civile si solennizzasse col clero, il quale vi si ricusò.
Il ministero scopriva già le proprie tendenze bigotte.
Improvvisamente il grande statista morì. La divorante attività di una vita politica, per dieci anni senza un'ora di riposo, aveva logorato il suo superbo temperamento di atleta; ma fino agli ultimi giorni pensò e lavorò con lo stesso impeto. La moltitudine rinascente dei problemi non potè mai sopraffarlo: contemporaneamente rannodava le relazioni diplomatiche colla Svezia, colla Danimarca e col Portogallo; spingeva le trattative con Napoleone III per l'evacuazione di Roma, vegliava sui disordini di Napoli, dirigeva le finanze, preparava la marina, lottava nelle camere per tutte le questioni. La maggioranza docile ma inesperta aveva d'uopo della sua presenza. Il 28 maggio respingeva ancora un disegno di legge in favore dei veterani [126] delle repubbliche del quarantotto, nel quale si ripresentava la questione pericolosa sollevata da Garibaldi. «La sola ragione, per cui il governo non può riconoscere il grado degli ufficiali veneti è perchè non vuole riconoscere anche quelli della republica romana... Non credo che si debba andare incontro a tutti quelli, che hanno combattuto sotto una bandiera, che non era la nostra. Non tutti fecero adesione alla monarchia... Possiamo rispettarli, ma per noi sono avversari, nemici. Non consentiremo mai che si faccia nulla a pro di loro». Queste intrepide parole furono la sua ultima bravata di ministro monarchico.
Una febbre violenta lo colpì: ogni rimedio fu presto inutile, il delirio sorprese il suo pensiero, che aveva resistito a tutti i turbini della rivoluzione. Però anche nell'agonia il grande politico riaffermò il proprio sistema: «L'Italia del nord è fatta, non vi sono più nè lombardi, nè piemontesi, nè toscani, nè romagnoli: ma vi sono ancora napoletani. Oh! vi è molta corruzione laggiù nel loro paese! Bisogna moralizzarli... ma non stato d'assedio, non mezzi violenti di governo assoluto. Tutti sanno governare collo stato d'assedio».
Agli ultimi momenti chiamò un frate, col quale sette anni prima si era accordato per non vedersi negati i conforti della religione come il ministro Santa Rosa: volle morire cristianamente e che tutta Italia lo sapesse. Il frate raccontò poi che il conte Cavour gli avesse risposto nelle estreme preghiere degli agonizzanti: «Frate, frate, libera chiesa in libero stato». Così morì (6 giugno 1861).
Il dolore d'Italia fu profondo, la costernazione maggiore del dolore. L'Europa suonò d'encomii; lord Palmerston vinse ogni altro oratore tessendogli l'elogio funebre; Napoleone III ne trasse argomento per accordare finalmente all'Italia il riconoscimento officiale; la monarchia trepidò; gli avversari democratici, vinti ed oppressi dal ministro vivo, s'inchinarono al suo feretro come ad una delle più grandi ed improvvise rovine della storia moderna. Allora la sua gloria, balenando [127] come una rivelazione fra uno sgomento di ammirazione e di rimpianto, diede all'opera della sua politica così prepotentemente personale l'apparenza di un miracolo.
Ma attraverso le generose ed inevitabili esagerazioni d'un'ammirazione, che cercava già nel solco tracciato dal suo pensiero nel passato la sola via sicura dell'avvenire, si riaffermava nella coscienza nazionale il sentimento dell'unità. Per la prima volta dopo tanti secoli un dolore italiano era veramente nazionale: Cavour era stato l'unità vivente della rivoluzione, organizzando nella realtà immortale della propria opera i risultati di tutte le iniziative.
Come Cesare, egli aveva dominato il maggiore periodo politico d'Italia: l'antico impero romano non aveva mai potuto uscire dall'orbita cesarea, la moderna monarchia italiana conserverebbe fino all'ultimo giorno l'impronta cavouriana.
L'Italia, collocando Cavour fra Mazzini e Garibaldi, comporrebbe la triade politica più perfetta del secolo decimonono.
La morte del conte di Cavour tolse al governo quella potente unità d'azione che, dopo i miracoli della preparazione piemontese gli aveva permesso di assimilarsi senza scosse tutta l'opera rivoluzionaria. La paura fu tale nei primi momenti che corte e paese dubitarono della propria fortuna: si temette che la rivoluzione insorgente per il ricupero immediato di Roma e di Venezia travolgesse l'Italia ad irreparabile ruina. Il parlamento inesperto, frazionato da rivalità d'interessi regionali, affollato di recenti convertiti alla monarchia, impotente ad assorbire la rivoluzione con una politica indipendente all'estero e liberale all'interno, non era abbastanza forte per dominare il trambusto dell'opinione: la dinastia, amata per la gloria degli ultimi fatti ed ammirata dalla moltitudine per il tradizionale rispetto a tutti i re, non poteva esorbitare efficacemente dalla costituzione senza eccitare pericolosi sospetti di dispotismo dopo il trionfo della propria conquista piemontese: nessun uomo politico aveva allora abbastanza autorità per sostituire il conte di Cavour.
Nullameno nè la monarchia, nè la nazione dovevano pericolare dopo la morte del grande statista. L'Italia era essenzialmente monarchica.
Malgrado le vanterie rettoriche di tutti i partiti [129] unanimi nell'esagerare la grandezza della rivoluzione italiana, questa era stata piuttosto una insurrezione contro gli stranieri per conquistare l'indipendenza che una vera rivoluzione. Anzitutto la stessa insurrezione non aveva potuto scoppiare che dopo l'intervento francese: l'impresa garibaldina non aveva trovato ostacoli politici alla propria espansione; l'esercito borbonico si era pochissimo battuto; il popolo aveva assistito festeggiando alla caduta delle vecchie dinastie e all'impianto della nuova. I partigiani dei governi abbattuti come non li avevano difesi nel pericolo, così non erano stati attaccati nè prima nè dopo dai pochi rivoluzionari combattenti; nessuno spostamento di classe era avvenuto, nessuna idea originale aveva cangiato col proprio trionfo la fisonomia storica della nazione. Tale comoda e simpatica rivoluzione senza spargimento di sangue era l'argomento più evidente contro la rivoluzione: la storia non ebbe e non avrà mai rivoluzioni incruente. La passione democratica vi si era condensata nello sforzo militare, acquetandosi sotto una monarchia costretta alla più mostruosa delle ingratitudini. La sola idea originale della rivoluzione italiana sarebbe stata l'abolizione del regno papale, ma la rivoluzione non aveva osato tampoco assalirlo.
La rivoluzione italiana non poteva paragonarsi a nessuna vera rivoluzione popolare, nè alla inglese, nè alla olandese, nè alla americana, nè alla francese, nè alla greca.
L'Italia era essenzialmente monarchica. Nello stesso partito rivoluzionario, Mazzini era il re dell'idea e Garibaldi l'imperatore della spada: il partito volontariamente soggetto alla più rigorosa disciplina s'unificava nei due capi; nessuno aveva osato mai una vera mossa politica senza il consenso di Mazzini; nessuno avrebbe tentato un moto militare senza la guida di Garibaldi. L'incapacità del popolo si rivelava in questa dedizione di tutta la propria parte migliore ai due maggiori individui: Mazzini era sinonimo di republica, Garibaldi di guerra.
[130] Però la morte di Cavour toglieva al governo la superba consapevolezza della propria superiorità sul partito mazziniano e garibaldino: dopo Cavour nessun altro uomo della monarchia poteva affrontare il paragone con Mazzini e con Garibaldi.
La politica cavouriana doveva nullameno proseguire non solo come inevitabile illazione della grande opera dello statista, ma come un risultato fatale dell'ambiente nel quale la monarchia si era formata. I dati della sua politica restavano immutati. I successori del conte di Cavour, definiti da Giuseppe Ferrari con fine ironia i generali di Alessandro, avrebbero nella loro altalena ministeriale subìto le oscillazioni di questi dati senza poterli modificare: la varietà dei loro caratteri personali si presterebbe alle antinomie del progresso, che trionfa sovente coll'errore; le loro parziali ed ammirabili facoltà si addestrerebbero nei molteplici particolari delle grandi questioni, creando una scuola politica e spremendo le proprie primizie spirituali senza potersi irrigidire nei propri falli. Così, dopo la potente unità politica di Cavour, che a lungo andare avrebbe colla propria supremazia ritardato il progresso del parlamento, apparvero meglio le correnti della pubblica opinione: i ministeri diventarono crogiuoli, ove gli interessi nazionali neutralizzandosi dovettero fondersi nell'interesse nazionale; la medesima incertezza di criteri concesse più facile il saggio di tutti i problemi: la partecipazione alla vita pubblica fu più intensa dacchè la mediocre autorità dei successori di Cavour mise nella nazione come uno sgomento vigilatore: le insufficienze della monarchia nelle quistioni di Roma e di Venezia servirono a ridonare prestigio all'idea democratica; le impotenze del sistema mazziniano persuasero che la republica non poteva derivare da un uomo per quanto sublime di spirito; le tragedie patriottiche di Garibaldi ridiedero al popolo la coscienza che l'eroismo è la verità suprema della storia.
Il partito cavouriano, intitolandosi dalla moderazione, fu come tutti i partiti impropriamente definito. [131] La sua moderazione nei grandi problemi di Roma e di Venezia non era fatalmente che sommissione alla prepotenza straniera; nelle questioni interne la febbre della unificazione lo rendeva talvolta più che rivoluzionario. L'opera politica della ricostituzione nazionale subì quindi l'influsso di due metodi antagonisti: si cercò con ogni studio di tener lontano il popolo dagli uffici pubblici, e si spinse la rivoluzione nelle leggi. Mentre i governi passati erano stati sempre contro il popolo, il nuovo fu pel popolo ma non del popolo. La violenta unificazione, cassando molti errori, molti ne produsse: la burocrazia invece di essere un organo di tutela e di trasmissione, limitato al minimo di personale e di spese, crebbe smisuratamente per la necessità di assettare gli spostati, di compensare i vincitori, di sedurre gli avversari. Nei salarii specialmente imperversò l'ingiustizia, sebbene tutti rimanessero sproporzionati ed esigui. Si dovette subire una seconda più disastrosa preparazione di guerra; le finanze parvero diventare un problema insolubile; le imposte depauperarono molti campi di produzione, mentre le spese nelle opere pubbliche ne fecondavano altri; i trattati di commercio subirono i contraccolpi dell'inferiorità politica; l'agricoltura, così sproporzionata in Italia da raggiungere in alcune provincie il reddito di duemila lire per ettaro e in altre di cinque, sofferse anche maggiormente per la sproporzione anche più assurda delle aliquote.
Il governo, ridotto ad una clientela, venne sfruttato dalla classe governante; la plutocrazia germogliò vigorosamente dalla politica.
Nullameno il rinnovellamento della nazione procedeva. Era una guerra incessante, minuta, universale, nella quale era impossibile contare i morti e i vincitori: idee e fatti fermentavano e sparivano come in una improvvisazione fantastica, per riprodursi con sempre nuovi aspetti; le attitudini si svegliavano, la esistenza nazionale maturava la vita politica.
Se nella cronologia del regno d'Italia il primo ministero era stato quello di Cavour, l'assorbente preponderanza del grande ministro lo rendeva nullameno troppo simile agli altri del piccolo regno sardo per cominciare da esso la nuova storia parlamentare. Così il primo ministero veramente italiano fu di Bettino Ricasoli, eletto dal re fra i tanti luogotenenti di Cavour. La scelta, eccellente in quanto toglieva al ministero l'eccessivo carattere piemontese, non modificò la situazione parlamentare: il Minghetti, il Bastogi, il Peruzzi, il De Sanctis vi rimasero: il Ricasoli tenne gli esteri, la presidenza e l'interim della guerra, dando la marina al Menabrea. Per una malsana imitazione del conte di Cavour, che nel periodo della preparazione piemontese aveva assunto quasi tutti i portafogli, si cominciò ad attribuirli fuori d'ogni criterio tecnico: Ricasoli, agricoltore e diplomatico, successe al Fanti, il migliore organizzatore militare d'Italia. Più tardi questo difetto giunse a tale che si videro avvocati e generali di cavalleria al ministero della marina, criminalisti ai lavori pubblici, filosofi al commercio.
Nell'impossibilità pel governo di un vero programma politico abbracciante Venezia e Roma, il nuovo ministero non fece che promesse generiche e contraddittorie per l'interno: fortificare l'esercito, instaurare la finanza, unificare leggi e governo, decentrare l'amministrazione. Dal bilancio 1861, nel quale non erano comprese le provincie del mezzogiorno rette ancora da governi luogotenenziali, risultava già un deficit di 344 milioni: il governo propose un debito di 500 milioni al tasso di 75 lire per 5 di rendita, che detratte tutte le spese non diedero poi che 495 milioni di incasso. Quindi s'unificarono i debiti dei singoli stati nel gran Libro del Debito pubblico, malgrado le loro differenze, giacchè quelli del Piemonte essendo maggiori avevano pure la scusa di essere stati contratti per fondare il [133] regno d'Italia, mentre gli altri di Napoli e della Toscana non avevano servito che a pagare le soldatesche straniere. Scartato il disegno delle regioni, il ministero dichiarò di fondare gli ordini interni sulle basi naturali dei comuni e delle provincie, affermando alteramente, a proposito delle voci circolanti intorno ad una possibile cessione della Sardegna alla Francia, di non conoscere «palmo di terra italiana da cedere, bensì un territorio nazionale da ricuperare». Tale nobile dichiarazione dissipò molte paure nella pubblica opinione, ma non potè essere che una frase. Tutto l'orgoglio baronale ed italiano del Ricasoli non bastava a trovare una soluzione pei problemi di Roma e di Venezia. Il suo stesso altero contegno verso la Spagna, ricusantesi alla consegna degli archivi consolari del già regno delle due Sicilie, e dalla quale richiamò minacciando l'ambasciatore; le severe parole onde alla camera e in una nota diplomatica denunciò al mondo civile le orribili trame ordite dal Vaticano per alimentare il brigantaggio scoppiato in alcune provincie napoletane, non facevano che rendere più umiliante la posizione del governo costretto a subirle, mentre Garibaldi agitava il paese per un'impresa immediata su Roma, e il Minghetti con una infelicissima circolare proibiva una protesta contro l'occupazione francese. Un'altra ripresa di trattative col papa a mezzo del padre Passaglia, dal quale per rivincita dello smacco si fece poi combattere con inutile pompa di erudizione il potere temporale promuovendo persino fra il clero un'assurda sottoscrizione per indurre il pontefice alla cessione di Roma, tolse alla politica di Ricasoli la simpatica originalità del suo carattere aristocratico e patriottico.
Mentre la diplomazia francese lo faceva svillaneggiare dalla propria stampa, la corte male lo sopportava per la sua poca arrendevolezza, i moderati lo sospettavano per le sue simpatie garibaldine e i rivoluzionari lo urgevano di critiche magnanime, egli era segretamente il più vivo oppositore di se stesso: in [134] lui le qualità del gentiluomo e la generosità del patriota contrastavano dolorosamente colle remissività inevitabili pel ministro. Abbastanza destro negli affari, rotto alla diplomazia, atto al comando, pronto a grandi cose se l'ora le avesse consentite, egli era fra gli eredi di Cavour il meno idoneo alla politica di quel periodo. La sua posizione parlamentare non poteva consolidarsi. Mancavano tempo e mezzo a misure potenti: non si erano ancora potuti abolire i governi luogotenenziali nel sud, il brigantaggio vi assumeva proporzioni di vera guerra, in Sicilia un moto separatista era scoppiato al grido assurdo di: viva la republica e morte ai liberali, ed era durato tre giorni, malgrado le milizie avessero dovuto inferocire per reprimerlo; la sinistra tempestava per l'accatto pontificio dell'Obolo di San Pietro destinato a combattere l'Italia; la destra inveiva pei Comitati d'azione instituiti da Garibaldi collo scopo di forzare il governo alla guerra. Il ministero, composto di elementi discordi e sprovvisto di vero programma, invece di stringersi intorno al Ricasoli, oscillava scompaginandosi all'urto delle correnti. Il fermento dei rivoluzionari cresceva, le pressioni estere si aggravavano sulla corte. Urbano Rattazzi, natura subdola e temeraria, avido di potere e di azione, combatteva il ministero da Parigi, ove si era recato a corteggiare l'imperatore, di là spaventando il re con una relazione machiavellicamente arguta.
Ricasoli si dimise prima di essere costretto ad arrendersi.
In questo secondo periodo decennale di preparazione italiana, tra i luogotenenti di Cavour, Ricasoli rimase il carattere più nobile, e il suo esperimento fu il più generoso: dopo di lui Urbano Rattazzi, che da Cavour aveva ereditata l'arditezza delle combinazioni equivoche, si arrischiò tristamente a Sarnico, ad Aspromonte e a Mentana opponendo la monarchia alla rivoluzione, mentre Cavour con quella era sempre riuscito a signoreggiare questa; ma i problemi di Venezia e di Roma rimasero insoluti. Marco Minghetti, salito [135] alla presidenza a cagione della follìa di Luigi Carlo Farini, ritentò la questione romana per concludere colla Convenzione di settembre al trasporto della capitale a Firenze, abdicando a Roma e decapitando la nazione; Alfonso Lamarmora, alleato colla Prussia, condusse il primo esercito italiano alla sconfitta, ed umiliò nuovamente l'Italia a Napoleone, ricevendo dalle sue mani Venezia. Giovanni Lanza, solo fortunato tra tutti, alla caduta del secondo impero napoleonico, potè entrare vittorioso a Roma per la breccia di Porta Pia. La tradizione di Cavour fu il principio direttivo di tutti i ministeri, ma la sua prodigiosa abilità non si rinnovò in nessuno de' suoi successori. Solamente Quintino Sella, geologo improvvisatosi finanziere, parve rinnovare coll'arditezza di alcune imposte e la tenacia del volere il suo mirabile empirismo, mentre economisti illustri come lo Scialoia, il Ferrara e il Minghetti si mostrarono nel ministero poco più che mediocri; nella diplomazia ebbe vanto di destrezza Emilio Visconti-Venosta, ma alle sue combinazioni mancò la grandezza dell'idea e la fortuna del risultato. Il Menabrea, sempre reazionario come nei primi giorni del parlamento subalpino, rinnovò all'indomani di Mentana l'inutile prova di un bigottismo politico senza nobiltà di sentimento religioso e senza elevatezza di sentimento monarchico; Agostino Depretis conservò di Cavour la destrezza parlamentare e la pratica di tutti i portafogli; però come tutti i solamente abili fu piccolo. Nessuno di essi si mostrò personalmente disonesto, malgrado la inevitabile corruttela di un governo costretto a vivere d'espedienti.
Il crescendo della rivoluzione legislativa s'impose a tutti i metodi e a tutti i sistemi, giacchè per conservare si dovette innovare continuamente. Le affermazioni di principii furono torbide. La gratuità, la laicità e l'obbligatorietà trionfarono nelle scuole elementari, [136] senza che al problema della istruzione nazionale si cercasse una vera soluzione. Il governo, anzichè assumere le scuole elementari per impiantarle ovunque e secondo il bisogno, le affidò all'ignoranza, all'avarizia e alla miseria dei comuni; le scuole tecniche rimasero mal definite e peggio organizzate, le classiche si mantennero confuse, troppe e male distribuite; fra queste e quelle non vi ebbero le distinzioni di metodo e d'indirizzo reclamate da tutti i grandi spiriti. Per un postumo rispetto al federalismo si conservarono tutte le università, lasciandone la maggior parte senza materiali scientifici, senza professori e senza scolari.
Nella soppressione degli ordini religiosi e nell'incameramento dei loro beni si rispettarono gli ordini insegnanti, sebbene dovessero essere aboliti primi per sottrarre il paese all'influenza dell'insegnamento clericale; ma il sentimento conservatore della monarchia e la bigotteria borghese li vollero invece soli superstiti. Non si osò spingere l'incameramento ai beni parrocchiali che avrebbe reso più docile il clero costringendolo lentamente a tornare all'antico costume cristiano di vivere colle sole elemosine dei fedeli: nella vendita dei beni incamerati non si ebbe alcun criterio politico per sollevare la miseria delle popolazioni agricole.
Nelle opere pie si lasciò l'amministrazione in mano alla borghesia con intervento del clero, rispettando, per una infelice superstizione del diritto di proprietà, gli antichi testamenti incompatibili colla vita moderna: così dall'immenso patrimonio della carità publica la miseria publica non ebbe quasi sollievo; la burocrazia ne assorbì in media il 75 per cento delle rendite, spese con spirito di clientela in disaccordo colla filantropia e colla scienza. Nelle ferrovie, massimo fra i benefizi della rivoluzione, in pochi anni cresciute a quattordici mila chilometri, pur tentando la magnifica audacia d'iniziare con esse in molte provincie il sistema stradale invece di compirlo, si dovette sottostare a deviazioni politico-federali: quindi la loro costruzione fu [137] simultanea con raddoppiamento di spese e di tempo, di difetti e di disastri per ignoranza d'ingegneri e rapacità di appaltatori. Scandali obbrobriosi ne nacquero sino in parlamento, dal quale alcuni deputati ebbero a dimettersi convinti di truffa.
Fra i balzelli il più originale e il più giusto fu quello della ricchezza mobile; ma, ripartito per contingenti anzichè per quotità, produsse nelle applicazioni le maggiori ingiustizie: fra i peggiori quello del macinato aggravò la miseria dei più miseri, ma salvò le finanze dal fallimento. Della perequazione fondiaria, presto promessa, non si ardì organizzare gli studi, giacchè le provincie meridionali, fortunate della mancanza o della insufficienza dei catasti, ricalcitrarono. Nella rovina della crisi finanziaria il governo si sgravò di molti oneri, addossandoli ai comuni già fortemente gravati e in preda essi medesimi alla febbre dei debiti e delle opere pubbliche. Il consolidato nazionale, colpito dal discredito, discese sino al saggio del 39 per cento; il corso forzoso della moneta cartacea, inevitabile in tanto stremo della moneta metallica, passò attraverso la più incredibile sregolatezza di metodo, dall'anarchia delle banche al monopolio quasi assoluto della Banca Nazionale. Nell'esercito, sino alla guerra infelice del 1866, s'imitò pedissequamente l'organizzazione francese, dopo si copiò quella prussiana; nella marina sino al disastro di Lissa non si ebbero idee di sorta; poi, con splendida spontaneità di genio, si mutò tutto radicalmente, improvvisando le più forti navi che il mondo vanti tuttora. Migliori furono i nuovi codici derivanti per la massima parte da quelli del primo Napoleone, ma la loro applicazione incontrò ancora resistenze federali: la Toscana serbò il proprio codice penale non perchè migliore, ma perchè toscano; si temette di abolire la pena di morte e di ammodernare la penalità, così che mentre il codice civile rivoluzionava la società moderna, quello penale esprimeva tuttavia una società passata. L'ordinamento giudiziario, sminuzzato alle base in un numero immenso ed [138] assurdo di preture, rimase scisso al vertice in quattro o cinque supreme Corti di cassazione, che perpetuarono nell'unità della giurisprudenza le rivalità federali delle antiche provincie: la magistratura troppo numerosa, male distribuita in circoli arbitrari, peggio pagata, quasi sempre sottomessa alla preponderanza del governo, se per opera di alcuni illustri mantenne la gloria della tradizione italiana, funzionò poco più che mediocremente come servigio pubblico.
Potente motivo di unità e di progresso commerciale divenne invece la unificazione dei pesi, delle misure e delle monete sul sistema metrico decimale, imposto con pronta e sicura energia dal governo alla disparità ricalcitrante delle abitudini storiche e regionali.
Comuni e provincie, mortificati sotto le prefetture, perdettero quasi ogni autonomia: il sindaco fu di nomina regia, necessario alle convocazioni consigliari il permesso governativo, ogni atto controllato, fissata la materia e il limite delle imposte, contesa ogni iniziativa, imposto qualunque onere al governo piacesse.
Ma attraverso tanto tumulto legislativo e siffatto disastro di improvvisazione politica, fra le umiliazioni della politica estera e le pressure della politica interna, l'Italia diede all'Europa il superbo spettacolo di un progresso, del quale nemmeno i suoi antichi ammiratori l'avrebbero supposta capace. Il governo costituzionale, malgrado crisi d'ogni maniera, funzionò regolarmente; la ricchezza pubblica crebbe col deficit delle finanze dello stato; agricoltura, industria, commercio risorsero; le città si abbellirono; la cultura si rialzò, quantunque il numero dei grandi intelletti scemasse. La coscienza politica si schiarì nei cittadini esercenti l'elettorato, e si preparò negli altri a riceverlo. Nè il brigantaggio del mezzogiorno, nè la tragedia di Aspromonte, nè la sconfitta di Custoza, nè l'ecatombe di Mentana, impedirono alla nazione di prendere il proprio posto nel consesso delle grandi potenze europee. La dinastia non distrusse con troppo gravi peccati il prestigio [139] datole dalla conquista regia: la democrazia dalle congiure di Mazzini e dai campi di Garibaldi passò nel parlamento e nella stampa.
A Roma solamente, dopo la preparazione piemontese di Cavour e la preparazione nazionale de' suoi luogotenenti, doveva cominciare la moderna vita italiana.
L'impresa garibaldina non aveva ancora trionfato nel Mezzogiorno che una reazione borbonica e brigantesca vi era già scoppiata.
In Sicilia Nino Bixio e il maggiore Bassini avevano dovuto soffocarla con terribile prontezza nel sangue; sul continente i cafoni avevano sconfitto il manipolo garibaldino guidato da Francesco Nullo e da Alberto Mario: Ariano e Avellino erano insorte, sebbene non troppo pericolosamente. Il patriottismo italiano delle provincie meridionali era per lo meno di una lega male definibile. Le bande siciliane, presentatesi a Garibaldi in Salemi, assistettero alla battaglia di Calatafimi coll'arma al piede in numero di oltre tremila, incerte fra le parti combattenti, e forse pronte a schierarsi col vincitore; almeno così credettero molti garibaldini siciliani, che conoscevano bene l'indole di quegli insorti. I picciotti, arruolatisi coi Mille, si batterono poco: i morti garibaldini venivano spogliati ignudi dagli abitanti del paese. Se l'odio dei siciliani contro borbonici e napoletani era profondo, il loro amore all'Italia era troppo superficiale. Solo Garibaldi, col fascino del nome e coll'irradiazione simpatica del proprio spirito, poteva appassionare i loro cuori così da trascinarli alla rivoluzione.
Nell'intendimento delle masse e di gran numero [141] fra gli stessi maggiorenti politici, che poi lo negarono, la Sicilia avrebbe dovuto compiere una rivoluzione separatista: forse le simpatie dell'Inghilterra per l'insurrezione siciliana nascondevano il proposito, se non d'impossessarsi politicamente dell'isola, almeno di dominarla economicamente sfruttandola.
A ogni modo i più fra quei pochi siciliani, che combatterono coi Mille, si stancarono presto della guerra; quindi tornarono alle proprie case, ritennero armi, munizioni, quanto poterono. Certo non mancarono alla Sicilia patriotti del più nobile eroismo, e basterebbe alla sua gloria il solo Rosolino Pilo; ma l'italianità del sentimento era scarsissima nel popolo, che, invece di levarsi dopo le vittorie di Palermo e di Milazzo per seguire Garibaldi sul continente, imbroncì fieramente alla prima parola di coscrizione. Infatti, quando il governo ve la stabilì, i renitenti raggiunsero presto l'enorme cifra di seimila, onde si dovette dar loro la caccia come ad assassini, trattando famiglie e villaggi con crudeltà così borbonica, che Garibaldi indignato si dimise dal parlamento (1864). Sul continente il concorso dei volontari napoletani riuscì altrettanto scarso che inefficace: i calabresi del barone Stocco furono fra i pochi che meglio si batterono; bande di insorti nel nome di Garibaldi commisero ogni sorta d'angherie e di ladronecci; alcune esattorie vennero saccheggiate. Moto rivoluzionario e militare non v'ebbe e non poteva esservi. La superstizione politica e religiosa era troppo profonda nel paese, ove gli stessi liberali odiavano il governo borbonico meglio che non comprendessero la nuova idea democratica, e tutti si sentivano più napoletani che italiani. Il trionfo dell'unità vi si dovette alla doppia conquista garibaldina e regia, dalle quali Napoli fu sopraffatta. Il popolo festeggiò, acclamò, menò la più scapigliata gazzarra, sperando dalla libertà venuto il tempo della licenza. L'aristocrazia potentissima, specialmente sulle campagne, fu trascinata nel moto dall'elemento monarchico: se l'Italia si fosse costituita a republica, una reazione [142] forse indomabile sarebbe scoppiata nel mezzogiorno. La celebre frase, che Francesco Crispi doveva pronunciare nel 1864: «la monarchia ci unisce e la republica ci dividerebbe», a cui Mazzini rispose con eloquenza terribile di ironia, conteneva nullameno una verità altrettanto umiliante che terribile.
Infatti i governi luogotenenziali di Palermo e di Napoli non erano ancora assisi che la reazione divampava in molte terre con impeto anche maggiore della rivoluzione: questa era stata una festa teatrale, mentre l'esercito borbonico indietreggiava sbandandosi, quella erompeva da un odio regionale contro i nuovi conquistatori, che il feudalismo dell'aristocrazia, la corruzione del governo cessato, la superstizione religiosa, il costume brigantesco e la barbarie del paese spiegavano e purtroppo giustificavano. Il clero, aizzato da Roma, aizzava; i grossi signori legittimisti aiutavano sotto mano; lo stato pontificio era rifugio alle bande e magazzino per armi e munizioni; la dinastia decaduta dava carattere di rivolta politica all'insurrezione, coprendola col manto della propria legittimità; l'assassina abitudine della camorra e della mafia favoriva l'organizzarsi dei banditi; un patriottismo di municipio e di regione, ignorante, aspro, inconciliabile, metteva nella rivolta una poesia capace di rinnovare i prodigi del valore garibaldino. Infatti Garibaldi, il miglior giudice d'insurrezione e di guerra, in un libro che scrisse poi, rese omaggio al valore dei briganti napoletani, i quali, non raggruppati dal re ad esercito, senza altri capitani che i propri capi, senza programma e senza bandiera, resistettero siffattamente per anni a tutti gli sforzi del governo nazionale da costringerlo all'umiliazione di dovere per essi sospendere le guarantigie statutarie, sostituendo a Napoli luogotenenti a luogotenenti, mutando nella campagna più di un generale, discendendo finalmente a una guerra di esterminio così orribile di ferocia che si dovette e si deve ancora nasconderla alla storia.
Le prime bande erano manipoli degli eserciti borbonici [143] congedati da Garibaldi, che dalla condizione di gendarme, unico ufficio dei soldati sotto il governo di Ferdinando II e di Francesco II, passavano naturalmente a quella del bandito. Il momento non poteva essere per loro più propizio: i municipi abbandonati a se medesimi, disciolta la polizia, la guerra ancora accesa, il saccheggio facile, preti, signori e re complici del disordine per speranza di recupero.
All'infuori delle più grosse città, ove la cultura delle idee aveva sviluppato l'italianità del sentimento, tutto il resto del paese si sentiva conquistato come da signoria straniera. Infatti l'accentramento del nuovo governo in queste provincie, abituate alla rilassatezza dell'antico regime, si annunciava al sentimento insubordinato delle masse come una servitù: il servire nell'esercito piemontese fuori dai confini del reame differiva troppo dal servire nella milizia borbonica, che non aveva in questo secolo mai date vere battaglie; l'aumento delle imposte, inintelligibile allo spirito oscuro della moltitudine, diventava spogliazione; la guerra dell'Italia al papa si mutava nella superstizione popolare in guerra di religione; l'unità italiana minacciava d'annullamento l'individualità napoletana rimasta distinta da ogni altra in tutti i lunghi periodi della storia italica. Il popolo napoletano non era più affine ai piemontesi di Vittorio Emanuele che ai francesi di Murat; ma quelli, invece che mercenari ai servigi di una dinastia desiderosa di fondersi nel paese, erano tutta l'Italia del nord, che invadeva in mezzogiorno preparandosi a mutarlo, battendogli già sull'intelletto e sul cuore col martello della modernità.
La reazione scoppiò feroce, spontanea, simultanea.
Se Francesco II, invece di riparare a Roma, ospite di Pio IX nel bruno palazzo dei Farnesi, si fosse subito presentato nelle provincie insorte, lanciando un proclama all'esercito disciolto poco accortamente dalla monarchia, che avrebbe invece dovuto internarlo e sorvegliarlo nelle provincie del nord, forse nè Vittorio Emanuele, nè Garibaldi sarebbero bastati a tenere salda [144] la conquistata unità. Alla rivoluzione per agire faceva d'uopo di potersi gridare spontanea, alla monarchia di essere invocata; forse l'Austria e la Francia, quella per la tradizionale politica dello smembramento italiano, questa per le aspirazioni del bonapartismo, avrebbero secondata la reazione.
Ma a Francesco II due grandi difetti impedivano l'impresa: un'assoluta incapacità militare e politica e una intransigenza politica che lo condannava al più antiquato ed impossibile legittimismo. I Vandeani, insorti contro la grande Convenzione francese, avevano avuto una bandiera e un principio; i ribelli napoletani, senza l'uno e senza l'altra, non erano e non poterono essere che briganti. La guerra durata più anni si sminuzzò quindi in atroci fazioni, e fu guerra della barbarie contro la civiltà, del feudalismo contro la democrazia, del federalismo contro l'unità.
Il conte Ponza di S. Martino, mandato luogotenente a Napoli da Cavour, pensò di richiamare sotto le bandiere i borbonici congedati, ma non avendo provvisto a tempo i denari per le paghe, i soldati disertarono in massa diffondendo il discredito sul governo. Al Ponza di San Martino succedette il Cialdini. Dalla Terra di Lavoro il brigantaggio si era già propagato in tutto il mezzogiorno. Se quegli aveva corteggiato gli aristocratici per amicarli al governo, irritando i radicali, questi lusingò i rivoluzionari, inasprendo i signori: onde il brigantaggio infierì. A domarlo, Cialdini costituì un corpo di guardie nazionali mobili in ogni distretto, coll'intedimento di opporre napoletani a napoletani, e così interessarne almeno una parte in favore del governo; ma l'espediente non fu troppo benefico. Le guardie nazionali, poco disposte ai rischi di una guerra nella quale i briganti non concedevano quartiere e il governo non premiava con gradi militari il valore, non potevano odiare tanto improvvisamente i propri compaesani da combatterli a vantaggio dei piemontesi incapaci di tenerli soggetti. La prima mossa strategica di Cialdini fu di occupare il Principato Ulteriore e la [145] Capitanata per mantenersi aperte le comunicazioni colle Puglie e l'Adriatico, tagliando in due la rete del brigantaggio e chiudendo alle bande del mezzogiorno il rifugio dello stato pontificio. Nelle guerre si mescolarono congiure: a Roma si ordì un complotto per sorprendere in Napoli il Castello Nuovo, quello di Sant'Elmo e il palazzo reale; Cialdini, avvertitone a tempo, potè arrestare e mandare l'arcivescovo prigioniero a Civitavecchia, licenziare lo Spaventa capo della polizia, sbarazzarsi del Castelli, grande consigliere d'amministrazione, e sostituirlo col Visone, governatore di Piacenza.
La Francia, sempre con la stessa politica tergiversante, ora vessata dalle rimostranze inglesi più vivaci delle italiane ammoniva severamente i Borboni rifugiati in Roma di non aizzare il brigantaggio, ora chiedeva altezzosamente spiegazioni al ministro Ricasoli, che le ricusò, sulle sevizie usate contro i briganti dal generale Pinelli. Infatti queste furono tali da far dimenticare quelle del francese Manhés. Soldati e briganti, invece di combattersi apertamente, si cacciavano come selvaggi: nessuna legge, nessun quartiere. Il generale Pinelli e il maggiore Fumel opposero terrore a terrore. I briganti sorprendendo qualche manipolo di soldati li martoriavano, li mutilavano vivi, li vituperavano morti; scene di cannibalismo desolavano campagne e villaggi; si vendeva sui mercati, si mangiava carne di soldati; mezze compagnie di bersaglieri accolte a festa in qualche borgo erano convitate ed avvelenate dalle stesse autorità municipali. Quindi il generale Pinelli e il maggiore Fumel, sferzando la giusta ira delle milizie, le spinsero a tutti gli eccessi. Vennero saccheggiati paesi, arse a dozzina le borgate senza pietà nè agli infermi, nè ai fanciulli, nè ai vecchi; si fucilò a caso, per qualunque sospetto; non si vollero prigionieri ma cadaveri. Ai briganti forniti di cavalleria si oppose la cavalleria regolare, si dovettero usare i cannoni, si profuse l'oro comprando tradimenti, massacrando famiglie intere per colpa di uno solo. Nella [146] strage non si contarono le vittime, benchè i soldati vi morissero in troppo maggior numero che non nella campagna delle Marche e in tutta l'impresa garibaldina; il governo vergognando taceva dei propri morti e degli altri.
Nullameno le stragi e gl'incendi del generale Pinelli furono tali che il governo dovette richiamarlo. Il brigantaggio era soffocato, non vinto: dagli immensi boschi della Sila sbucavano sempre bande nuove; l'odio ai piemontesi cresceva coi danni e coi dolori patiti: una ostinazione demente dava talora al coraggio delle bande e alla bravura assassina dei loro capi una sinistra poesia non senza grandezza.
Ma gli eccessi medesimi di questa guerra ne impedivano lo sviluppo. La viltà di re Francesco, appiattato in Roma e dilapidante il proprio patrimonio fra i briganti più accorti che gli promettevano vittorie per mungergli denaro, rendeva inutile lo stupido e crudele fanatismo dei cafoni; la loro organizzazione, nell'assenza del re e di veri ufficiali, non divenne mai militare; le città sbigottite non si mossero; i legittimisti imitarono la codardia del re.
Il moto separatista, scoppiato a Castellamare di Sicilia sui primi dell'anno 1862 e soffocato furiosamente nel sangue dal governo, persuase della inutilità della rivolta: le rimostranze severe di Napoleone a re Francesco, lo sfratto di quattro generali borbonici da Roma finirono per avvilire il partito reazionario; l'energia spiegata dal governo contro i renitenti alla leva anche nelle altre provincie diede alla coscrizione il carattere di una ineluttabile necessità. Infatti non solo i renitenti venivano cacciati come assassini, ma a togliere loro l'appoggio delle famiglie si mandava in queste un manipolo di soldati col diritto di farsi alloggiare e nutrire finchè il renitente fosse preso o si consegnasse da se medesimo. A questo rigore di giustizia medievale, che aveva almeno l'utilità di incutere spavento, il governo, sempre incerto nei criteri, faceva poi succedere la più umiliante confessione d'impotenza [147] bandendo una sottoscrizione nazionale a favore dei danneggiati dal brigantaggio: così, fatto accattone per coloro, che non aveva saputo guarantire, invitava il popolo a legalizzare colla propria elemosina l'insufficienza della legge e l'inettitudine del potere. Nullameno la sottoscrizione fruttò un milione: l'idea era stata del Peruzzi.
Naturalmente il credito della nazione ne scapitava moltissimo all'estero e all'interno: là si cominciava a dubitare della rivoluzione italiana; qua si accresceva il dispregio per un governo, che, affettando rigore contro i rivoluzionari sino ad imprigionare Garibaldi dopo averlo ferito in Aspromonte, non sapeva sperdere qualche banda di briganti.
La giunta parlamentare, inviata nel Mezzogiorno a studiare sul luogo le cagioni e i rimedi del brigantaggio, lesse alla Camera in adunanza segreta la propria relazione dettata dal Massari. La quale onestamente dotta ed arguta non scoperse cosa che già non si sapesse, e non trovò cura al male: i suoi due modi di provvedimenti furono, per l'avvenire l'affrancazione dei beni di manomorta onde mutare i cafoni in possessori, la costruzione di strade, l'impianto di scuole, il taglio dei boschi ed altre di simile fatta; pel presente la ripresa del metodo di Pinelli cacciando i briganti come belve, massacrando i sospetti, sospendendo ogni giurisdizione, riassumendo tutte le pene in quella della morte e della galera.
La legge a tal uopo votata, e che prese il nome di Pica dal deputato proponente, importava la soppressione di qualunque giustizia nelle provincie infette di brigantaggio, mutando poco accortamente in misura legale quelle che avrebbero dovuto essere più prontamente provvisioni di guerra. Pinelli aveva commesso stragi ed incendi da soldato, che si potevano ufficialmente negare o scusare: i nuovi disonorerebbero insieme parlamento, giustizia ed esercito nazionale.
Fortunatamente Napoleone, perduta ogni speranza di effetto politico dalla reazione del brigantaggio pei [148] suoi tardi sogni bonapartisti, sentì la necessità di purgarsene in faccia all'Europa coll'imporre più severamente al papa e al Borbone di cessare dall'alimentarlo. Le bande, abbandonate dal partito reazionario, non furono più che di volgari assassini: il paese stesso, esausto da tante vessazioni, se ne stancò; si comprese l'impossibilità di scrollare il governo; i primi benefici effetti della libertà scemaron l'odio ai piemontesi ed accrebbero le adesioni alla monarchia. I capibanda vennero ad uno ad uno traditi o trucidati: la reazione capitolò.
V'ebbe ancora qualche ripresa; nei paesi più malmenati dalla repressione militare covarono lunghi odii ai liberali sotto la paura; quindi la stessa coscrizione, mescolando la gioventù napoletana a quella delle altre provincie, ne migliorò il carattere; clero e signori da reazionari intransigenti si mutarono in partigiani del governo per sfruttarlo, mentre il progresso della vita penetrava come un soffio di primavera fra la caliginosa aridezza delle provincie più brigantesche.
Così la reazione legittimista, dopo una guerra di masnadieri, finiva piuttosto vinta dall'influenza benefica della libertà che da una rapida e logica azione della monarchia: governo borbonico e papale erano stati battuti in pochi giorni quasi senza combattere; essa invece lottò parecchi anni con ferocia pari al coraggio, con perversità forse maggiore della stupidaggine, per acquetarsi lentamente come una di quelle convulsioni, che, dopo aver dato al malato la violenza di un delirio e lo spasimo di un'agonia, lo lasciano spossato ma senza nessun organo offeso e colla fisonomia di prima.
Verso il 1866, al rompere della guerra contro l'Austria, la reazione del brigantaggio nel napoletano era quasi finita.
Il trionfo della monarchia, prostrando la parte rivoluzionaria, l'aveva divisa.
A Mazzini non era rimasto intorno che un manipolo di republicani magnanimi ed impotenti: Garibaldi, licenziate le bande rosse, dirigeva loro ogni tanto la parola per accennare a nuove imprese. Quegli, convinto dell'impossibilità politica di snidare Napoleone da Roma, avrebbe voluto trascinare la monarchia ad un'ultima guerra contro l'Austria minacciata a tutte le frontiere orientali da moti slavi e minata all'interno dall'odio ungherese; questi pensava essere per l'Italia più urgente la conquista di Roma. Così anche questa volta l'istinto di Garibaldi era più sicuro del genio di Mazzini. Ad una guerra contro l'Austria nè paese, nè governo erano preparati: quindi una vittoria di questa avrebbe potuto rimettere in questione la conquistata unità, che l'Europa diplomatica non aveva ancora riconosciuto officialmente; una vittoria per quanto improbabile della monarchia avrebbe invece compita la distruzione del già sconfitto partito republicano. All'impresa di Roma la politica sempre incerta di Napoleone e il favore manifesto dell'Inghilterra potevano aiutare; nè l'Europa cattolica avrebbe probabilmente difeso il papa, nè la Francia democratica permesso a Napoleone una seconda spedizione di [150] Oudinot. A ogni modo se l'impresa falliva secondo le maggiori probabilità, l'Italia vi guadagnerebbe in faccia all'Europa di avere affermato eroicamente il proprio diritto nazionale, e la monarchia vi perderebbe, opponendovisi, la propria legittimità rivoluzionaria.
All'eroe e all'apostolo della rivoluzione contrastava allora potente in Cavour lo statista.
Quindi alla morte di questi i rivoluzionari sentirono più forte il dovere d'una iniziativa. Il Ricasoli per orgoglio di patriottismo pareva favorevole a nuove agitazioni; lord Russell a nome dell'Inghilterra bersagliava di note diplomatiche il gabinetto francese perchè ritirasse da Roma ogni presidio, e il vigore delle sue rimostranze rendeva col paragone più supina la remissività italiana. Mazzini al solito mandava in giro una protesta del popolo contro l'occupazione francese in Roma, e un'altra in forma di lettera ne indirizzava allo stesso Napoleone, arcadicamente nobili entrambe ed inefficaci. Poscia, scendendo a più precisi propositi ma sempre col vecchio metodo delle congiure, per iniziare l'impresa veneta chiedeva indarno al popolo un piccolo prestito di 300,000 lire; un altro suo tentativo per fondere in un'associazione generale emancipatrice tutte le forze della democrazia abortì a cagione di parecchie differenze di vedute fra lui e Garibaldi; non maggiore risultato ebbero i comitati di provvedimento, imitati su quelli del Bertani. Si tentò pure un'istituzione di tiro a segno per eccitare il sentimento marziale delle masse, che non vi scorsero se non una teatralità resa occasionalmente simpatica dalla presenza di Garibaldi.
L'agitazione rivoluzionaria si svolgeva tristamente sopra se stessa. Nè Mazzini nè Garibaldi potevano credere seriamente alla possibilità d'una guerra all'Austria senza il soccorso della monarchia; nè questa, ancora incerta della propria posizione in Europa, lasciarsi in così pericolosa contingenza sopraffare dai rivoluzionari. Infatti un'altra guerra, anzichè riprodurre il momento epico nell'impresa garibaldina nel [151] sud, ora che il regno d'Italia era costituito, avrebbe dovuto esprimere la potenza del nuovo stato: la monarchia vi sarebbe quindi assolutamente sovrana per la scelta del momento e dei mezzi. Re Vittorio Emanuele, che con incerta imitazione della politica napoleonica ordiva trame segrete coi rivoluzionari d'Ungheria, era egli stesso troppo poco padrone per forzare la politica remissiva dei propri ministeri: nè potendolo lo avrebbe forse osato. Il doppio problema di Venezia e di Roma non lasciava allora scorgere soluzioni di sorta. Ad una guerra di governo era assurdo pensare coll'esercito scompaginato dalle fusioni di tutte le milizie granducali e borboniche; in una guerra popolare, dopo lo scarso numero di volontari offerto dal paese nella rivoluzione, nemmeno la fantasia di Mazzini e l'eroismo di Garibaldi potevano davvero sperare. D'altronde la monarchia vi si sarebbe opposta.
Nullameno nuove congiure solcavano le provincie venete. Al solito si dipingeva l'Austria presso a sprofondare, si esageravano ingenuamente gli antagonismi antichi nel suo impero, si calcolava sopra una rivolta imminente degli ungheresi per concludere che pochi drappelli insorgenti nel Cadore, mentre il governo austriaco vegliava attento nelle armi, basterebbero a provocare colla guerra la vittoria. Intanto il partito rivoluzionario restava scisso all'interno: i suoi capi republicani bersagliavano d'invettive la monarchia; gli altri, divenuti parlamentari, avrebbero voluto invece concordare prima ogni mossa col governo. La rivalità di Garibaldi con Mazzini, abilmente avvelenata dalle insinuazioni del governo finiva di guastare gli ultimi accordi per l'azione. Già si buccinava che Garibaldi malcontento dell'Italia andasse in Grecia o tornasse in America a combattere per altre libertà: lo sfacelo del partito rivoluzionario degenerava in corruzione. La maggioranza della nazione, pochissimo disposta a sacrifici di nuova guerra, non vedeva più che una setta nei mazziniani ed un avventuriero in Garibaldi: tutti [152] sentivano che Venezia e Roma non si potevano conquistare come Palermo e Napoli.
Intanto il ritorno di Urbano Rattazzi al potere parve rianimare molte speranze. Si sapeva che lo stesso imperatore Napoleone lo aveva imposto al governo di Torino, quindi se ne traevano argomenti per fantasticare di prossime complicazioni politiche. Alcune frasi di Rattazzi a Parigi sulla fratellanza dalle razze latine e sulla missione dell'impero bonapartista in Europa, altri suoi precedenti nella Camera di lusinga ai partiti d'opposizione, l'indole del suo ingegno altrettanto facile ai brogli che ai rischi, promettevano nel nuovo anno (1862) importanti avvenimenti. In Grecia, in Rumenia, nel Montenegro, in Dalmazia, in Albania era già scoppiata la lotta: l'imperatore d'Austria aveva licenziata la Dieta d'Ungheria respingendone le deliberazioni ed applicando al paese la legge marziale: si prevedeva d'ora in ora la rivolta dei Magiari.
Già l'assemblea delle associazioni unitarie riunite a Genova arieggiava i clubs della grande Rivoluzione francese, mirando a creare un governo nel governo: la sua proposta di affidare a Garibaldi la repressione del brigantaggio con una ricostituzione dell'esercito garibaldino era stato un primo agguato pel ministero Ricasoli; il nuovo ministero subì il fascino dell'avventura rivoluzionaria.
Rattazzi, fiducioso nella propria conoscenza della politica napoleonica, sperò di poterla forzare come era riuscito felicemente al Cavour: le pericolanti condizioni dell'Austria lo sedussero, la debolezza del partito rivoluzionario lo lusingò. Il suo piano era semplice e temerario: chiudere la sessione parlamentare; mortificare apparentemente la rivoluzione col mantenere Mazzini in esilio e col processare alcuni capi dell'associazione unitaria; maneggiare destramente Garibaldi, perchè infiammasse il paese e tentasse un moto nel Trentino come all'insaputa del governo; sedurre la Prussia colla speranza del primato germanico; prendere l'Austria [153] fra due fuochi, e strapparle forse senza guerra, con un semplice trattato, la Venezia.
Di questo disegno ordito fra Garibaldi, Rattazzi e il re non si è ancora potuto risapere i termini, nè forse si sapranno. A ogni modo Rattazzi ingannava, e Garibaldi fu ingannato. Fu affermato che il ministero promettesse a Garibaldi un milione per l'impresa; certo gli si permise di allestirla, assicurando contemporaneamente, con una circolare a tutte le regie legazioni, le potenze sulle intenzioni pacifiche del governo. Intanto Garibaldi infiammava gli animi scorrendo per le città di Lombardia, mentre l'imperatore d'Austria visitava le provincie venete, e Vittorio Emanuele viaggiava nel mezzogiorno.
L'avventura guerresca procedeva alacremente, malgrado frequenti dissidii fra gli iniziatori garibaldini e i mazziniani: alcuni fra i migliori ufficiali delle sciolte legioni volontarie raccoglievano munizioni ed armati sulla frontiera del Trentino; Garibaldi da Trescorre, ove era sembrato condursi per curarsi le vecchie ferite, stava pronto ad assumere il comando; il giorno 15 maggio (1862) veniva stabilito per l'entrata in campagna. Quando improvvisamente, per ordine del governo, il 15 maggio viene arrestato a Palazzolo il colonnello Nullo con altri capi. A Trescorre e a Sarnico s'imprigionano i volontari, si dichiara officialmente Garibaldi estraneo all'impresa insensata: questi, tradito, smentisce il governo, e con una delle solite esorbitanze dittatoriali decreta che i volontari sono incolpevoli avendo agito sotto i suoi ordini: nei più fervidi fra i paesi lombardi il popolo si sdegna; a Brescia si tumultua per forzare la prigione del colonnello Nullo, ma le guardie tirano sulla popolazione inerme assassinando. Garibaldi, per protestare contro la strage fratricida, svillaneggia l'esercito; quindi visita Como, Lecco, Varese, luoghi memorandi delle sue prime vittorie, minaccia nuovi scandali in parlamento, finchè rabbonito dal re riparte per Genova.
A questo infelice conato di guerra contro l'Austria [154] scoppiano in parlamento le battaglie dei partiti: il ministero, scosso dalle disapprovazioni di tutti i liberali, allenta i freni della sùbita reazione e rilascia senza processo i prigionieri, ma nè governo, nè opposizione osano rivelare tutta la verità. Garibaldi, vittima dei propri accordi col re, è costretto a mentire in una lettera al presidente della Camera, dichiarando che l'assembramento di volontari non aveva per scopo una spedizione nel Tirolo, bensì una serie di esercizi militari in attesa di nuovi eventi; Giuseppe Sirtori definisce severamente il ministero una sventura nazionale, ma la Camera sopra un ordine del giorno presentato dal Minghetti lo assolve.
L'Austria aveva trionfato un'altra volta dell'Italia patteggiando col partito moderato ungherese capitanato dal Deak, lusingato con una conciliazione i Magiari, proclamandosi solidale colla Prussia nelle cose germaniche e sventando così i disegni di Napoleone III sulle Provincie renane, col limitare la rivolta nei Principati danubiani. Il ministro Rattazzi usciva malconcio dalla prova. D'altronde vero disegno di guerra non v'era stato nè pel governo, nè pei rivoluzionari: si era sperato in uno smarrimento dell'Austria, quindi si dovette indietreggiare nella reazione di un tradimento verso i più ingenui fra gli accorsi garibaldini, per calmare i sospetti delle cancellerie auliche.
Questo triste esperimento, che prese nome da Sarnico, svelò all'Europa le umilianti condizioni della politica interna italiana: sessantamila soldati regolari non erano ancora riusciti a domare la reazione brigantesca, mentre gli arrestati per la spedizione del Tirolo non oltrepassavano i sessanta, e a seicento non era giunto tutto l'assembramento. La nazione stava quasi indifferentemente fra governo e rivoluzionarii; la stampa europea sogghignava; in Vaticano vescovi e prelati di tutto l'orbe, raccolti nel pretesto di canonizzare [155] alcuni martiri del Giappone del secolo XVI, firmavano una nuova protesta in favore del potere temporale. Napoleone III, sempre colla stessa politica equivoca, per riavvicinare la chiesa all'Italia, giungeva sino a proporre a Pio IX una nostra rinuncia a Roma (30 maggio 1862). A quest'ingiuria il parlamento rispose umilmente col riconfermare il 18 giugno l'ordine del giorno Buoncompagni che dichiarava Roma capitale d'Italia subordinandone l'acquisto al beneplacito della Francia.
Ma nelle file del partito d'azione cresceva il fervore: le inevitabili bassezze del governo esasperavano l'eroica generosità, che aveva prodotto i miracoli dell'epopea garibaldina. Se la monarchia, impotente a lottare contro l'Austria e la Francia, espiava colle presenti umiliazioni il proprio peccato d'origine, la rivoluzione sentiva di dovere daccapo soccorrere alla sua impotenza con un'alta affermazione del diritto nazionale. Una vera guerra era impossibile; ad un'impresa come quella di Napoli mancavano il momento ed il modo; non restava quindi che un'avventura tragica. Nè disegno politico, nè preparazione militare vi occorrevano; l'obbiettivo doveva essere Roma, giacchè là batteva il cuore della nazione e stava il principio della nuova vita nazionale.
Così, mentre il ministero appena rimesso dal fortunale di Sarnico, sembrava intento a riparare le più grosse avarie amministrative e finanziarie, Garibaldi capitava improvvisamente a Palermo: la notizia sbalordiva tutta Italia, si temevano o si speravano altre complicazioni politiche. Lord Palmerston in un memorabile discorso alla Camera dei Comuni aveva già segnalato in quei giorni all'Europa lo scandalo in Roma del principio, predicato e disconosciuto ad un tempo dal Bonaparte, del non intervento, e Garibaldi gli aveva risposto nobilmente a nome dell'Italia; nel parlamento italiano il generale Durando dava esca all'aspettazione proferendo officialmente queste gravi parole: «Oso promettere che fra non molto saremo a Roma». Si buccinava di un'alleanza franco-russa, poichè [156] si era allora ricevuto per gli uffizi di Napoleone il riconoscimento della nuova monarchia da parte dello czar, pagandolo però con un principio di persecuzioni agli esuli polacchi rifugiati nel regno.
A Palermo si era mandato Giorgio Pallavicino; Garibaldi vi arrivava con intenzioni di guerra. Per quanto è oggi permesso di arguire si trattava di un nuovo imbroglio rattazziano: lo scaltro ministro per disfarsi del pericoloso generale gli aveva fatto promettere dal re aiuti per una spedizione in Grecia; Garibaldi aveva chiesto trentamila lire per mandare colà alcuni ufficiali, diecimila fucili, diecimila paia di scarpe, diecimila camicie rosse e una fregata. Così il governo si sarebbe liberato del partito rivoluzionario, mentre Garibaldi, sfiduciato dell'Italia, si disponeva a combattere per la libertà del più glorioso fra tutti i popoli.
Ad una spedizione su Roma egli allora non pensava e non poteva pensare dalla Sicilia, ove il governo avrebbe potuto bloccarlo con ogni comodo.
Ma toccato Palermo, l'entusiasmo avvampa sotto i suoi passi, le memorie della prima impresa rifiammeggiano, i figli del re allora in visita per l'isola s'inchinano al dittatore; nella squadra dell'ammiraglio Albini fra marinai si parla liberamente di arruolarsi coi nuovi volontari per la Grecia; Garibaldi passa in rivista (10 luglio 1862) la guardia nazionale, e, trascinato dall'impeto del proprio patriottismo e dai propositi del 1860, quando vincitore a Palermo si preparava alla liberazione di tutta Italia, ricorda con parole di fuoco, al popolo dell'antico vespro, Roma. Il suo grido è sempre: Italia e Vittorio Emanuele. Pochi giorni dopo, accolto con ovazioni deliranti a Marsala, riparla ancora di Roma al popolo: una voce gli risponde — o Roma o morte — ; e il motto si muta in programma. L'effervescenza degli animi cresce a contagio. Nel tempio della Vergine della Cava il garibaldino frate Pantaleo celebra una messa invitando generale e popolo a ripetere sull'altare il giuramento: o Roma o morte. Così, da popolo cattolico, in tempio cattolico, con rito [157] cattolico, per una bizzarra antitesi della storia, si giurava la distruzione del cattolicismo romano; ed anche questo era indizio di quanto fosse torbida nella coscienza popolare l'idea della rivoluzione.
Intanto a Palermo si ordina la legione romana con tanta publicità che i carabinieri accompagnano al bosco della Ficuzza i marinai della squadra in uniforme, perchè cangino il camiciotto azzurro nel rosso: a bordo delle navi i mancanti alla chiamata serale non si reputano disertori.
Trentamila fucili sono mandati e sbarcati senza mistero dal governo; nel continente molti vecchi e nuovi garibaldini disertano dai reggimenti per raggiungere Garibaldi in Sicilia. Tutti credono il ministro d'accordo col generale.
Ma l'equivoco di Sarnico ricomincia; Rattazzi vorrebbe un'agitazione abbastanza seria da persuadere i governi d'Europa a cedere Roma all'Italia per cansare i pericoli di nuove rivoluzioni, se non che, aiutandola sottomano, arrischia e teme di essere trascinato troppo oltre. I suoi ordini sono quindi equivoci e contradditorii peggio del disegno di una guerra in Grecia, col quale aveva cercato di sviare Garibaldi: la Sicilia, galvanizzata momentaneamente dalla presenza del proprio liberatore, s'infervora nell'idea di Roma, quantunque male comprendendola. Non vi è preparazione di guerra ma tumulto teatrale: da Genova la commissione esecutiva dell'associazione unitaria riprepara aiuti ed organizza a Roma un comitato contro quello dell'associazione lafariniana sempre ligia al governo ed ostile all'iniziativa rivoluzionaria, manda a Garibaldi un piroscafo rimorchiatore con bandiera inglese, e raccozza volontari; Mazzini avverso all'impresa ne rimane sorpreso, e poco giova; i deputati Fabrizi, Mordini e Cadolini spediti a Garibaldi per dissuaderlo finiscono col convertirsi all'avventura. Garibaldi, trascinato dall'istinto tragico della situazione, dimentica improvvisamente il vecchio senno militare e politico di tutte le sue imprese: l'idea di Roma lo affascina, la coscienza [158] di essere nesso fra la nazione e il re per compiere i destini d'Italia lo assolve anticipatamente di ogni illegalità e di ogni errore. La sua fede in Vittorio Emanuele giunge all'assurdo. Così, quando questi emana da Torino (3 aprile) un proclama di disapprovazione e di minaccia, Garibaldi, memore della lettera colla quale due anni prima gli aveva proibito di passare il continente alla conquista di Napoli, lo crede una lustra, e lo legge alla propria legione. Il ritiro di Giorgio Pallavicino dalla prefettura di Palermo lo lascia indifferente, la disapprovazione del parlamento non lo turba.
Allora comincia la tragica avventura. Il governo, impacciato nei propri equivoci, non sa nè impedirla, nè permetterla: concede al generale Lamarmora, che li domanda da Napoli, i pieni poteri, manda proconsole a Palermo il generale Efisio Cugia, richiama dalle terme di Valdieri il generale Cialdini per affidare al suo odio invidioso la repressione della nuova impresa garibaldina. Il partito moderato reso feroce dalla paura di complicazioni colla Francia, avventa vituperii contro il partito d'azione, ed accusa Garibaldi di voler rovesciare la monarchia.
Questi invece, evitando accuratamente ogni conflitto coi regii, che nullameno avrebbero potuto accerchiarlo, traversa incolume tutta l'isola dal bosco della Ficuzza a Catania; il suo esercito è una turba di giovinetti, d'entusiasti, di discepoli, fra i quali i pochi veterani del '59 e del '60 appaiono dispersi. A Messina un comitato apre pubbliche sottoscrizioni ed arruolamenti; l'idea degli accordi col re occupa da per tutto la mente popolare; il contegno dell'esercito regio ribadisce questa opinione. Il prefetto di Messina chiede per favore notizie del campo garibaldino al comitato di provvedimento; quello di Catania dopo un colloquio col generale lascia la città per trasportarsi sulla nave Duca di Genova; Garibaldi deve improvvisare nella città un governo provvisorio con a capo Giovanni Nicotera.
Fabrizi e Mordini, recatisi al campo del generale regio Mella per parlamentare, si sentono rispondere [159] che non vi sono ordini per combattere Garibaldi; anzi il generale offre di rimandare gli spedati in camiciotto rosso fatti prigionieri dalle proprie avanguardie, pregando come ricambio di cortesia che gli sia permesso di provvedersi di viveri a Catania. Poi l'esercito regio accenna a levare le tende da Misterbianco, e Garibaldi asserragliandosi nella città ripete al popolo i due gridi — Italia e Vittorio Emanuele — Roma o morte — .
L'equivoco diventa così torbido che nessuno può trovarne l'uscita.
La fregata inglese Amphion lo raddoppia, ormeggiandosi fra la città e la fregata italiana Maria Adelaide, quasi per proteggere Garibaldi; il 24 agosto questi, emanato un proclama nel quale annuncia di marciare su Roma e riconferma la propria fede alla monarchia, cattura nella rada il Generale Abbatucci francese e il Dispaccio italiano, due vapori postali, sotto gli occhi della nave ammiraglia Maria Adelaide, che invece esce dal porto lasciando alle fregate Duca di Genova e Vittorio Emanuele l'istruzione sibillina «di operare a norma dei casi, ricordando il bene inseparabile della patria e del re».
A mezzanotte Garibaldi salpa dal porto coi due vapori e tremila uomini salutato da un'immensa ovazione di popolo: le fregate lo lasciano passare, ma i due capitani cadono così sotto consiglio di guerra. Garibaldi presa terra presso la spiaggia di Melito si è difilato su Reggio; se non che, bersagliato mollemente dalla Maria Adelaide ripara sul pianoro d'Aspromonte. I suoi ordini agli uffiziali sino dalla partenza da Palermo sono «evitare l'esercito e, in caso d'incontro, non combattere»; di rimpatto Cialdini gli manda contro il colonnello marchese Pallavicini di Priola come a brigante con ordine «di schiacciarlo e di non concedergli resa che a discrezione». A mezzogiorno del 29 i bersaglieri cingono in catena i pendii dell'Aspromonte, aprendo sui garibaldini un vivo fuoco di moschetteria: qualcuno di questi risponde a fucilate, ma Garibaldi ordina la cessazione del fuoco; allora i bersaglieri [160] tristamente aizzati si slanciano alla carica, mentre Garibaldi, ferito da due palle alla coscia sinistra e al malleolo del piede destro, cade urlando sempre: «Viva l'Italia, non fate fuoco!».
I morti di ambe le parti sono dodici, i feriti cinquanta.
La tragedia è compita: Aspromonte, mutato in calvario della rivoluzione italiana, resterà la cima più alta della storia moderna.
Il marchese Pallavicini in tanta sventura, ultimo gentiluomo di un esercito che tirando primo su Garibaldi macchiava il proprio onore, fu ammirabile di rispetto e di devozione al ferito. La legione venne disarmata e scortata: Garibaldi imbarcato sopra una lancia del Duca di Genova, passando al traverso della Stella d'Italia, ove superbo della misera vittoria s'impettiva il Cialdini, salutò con epica cortesia; l'altro non rispose al saluto. L'Italia monarchica si rivelava intera nel contegno di Cialdini. Infatti questi annunziò la propria vittoria così: «Garibaldi, raggiunto in Aspromonte in formidabile posizione, attaccato dalle truppe italiane comandate dal colonnello Pallavicini, dopo vivo combattimento, pienamente sconfitto, ferito, prigioniero con tutti i suoi.» La stampa moderata vantò il trionfo. Al Varignano, lazzaretto e galera a mezza costiera di ponente nel golfo della Spezia, ove Garibaldi fu trasportato, mancava ogni decenza ed ogni comodo di alloggio per il ferito, mentre vi si largheggiava di conforti ai cospiratori borbonici. Intanto una reazione senza nome insaniva contro i garibaldini; a Catania s'arrestavano i membri del comitato, patrioti, giornalisti, si disarmava la popolazione, si perseguitavano ferocemente i volontari fuggitivi. Lamarmora, imprigionati a Napoli Fabrizi, Mordini e Calvino, telegrafava a Rattazzi: «Ho arrestato i deputati; li fucilo?» E il ministro più scaltro rispondeva: «li metta in libertà e si scusi». Il generale Pinelli in un caffè di Messina brindò alla palla di Aspromonte; a Fantina un maggiore De Villata, truce brigante, sorpresi [161] alcuni volontari fuggitivi, li fucilava dileggiando; il ministero, pazzo di orgoglio fratricida, promuoveva sul campo il Pallavicini a generale; in parlamento e nei circoli politici si disputava seriamente sul come processare Garibaldi, e si pendeva incerti fra il senato costituito in alta corte di giustizia e il magistrato ordinario. Prevaleva già il secondo partito; la corte di cassazione di Napoli dietro invito del governo aveva richiesto quella di Milano per la designazione della corte d'assise giudicante.
L'Italia taceva. Solo Giosuè Carducci, il suo giovane e maggior poeta, avventò un'ode che stridè come una saetta per la morta atmosfera di quei giorni, ma il silenzio del popolo tradì il segreto della rivoluzione. Le proteste del partito rivoluzionario, le veementi invettive di Mazzini, gli sdegni di Cattaneo, le minacce di Nicotera chiedente alla Camera di mettere il ministero in istato d'accusa, non sembravano e non erano che rimpianti e rimbrotti di vinti: il popolo taceva. Il popolo, al quale Garibaldi aveva dato l'unità, non ebbe allora una rivolta nè di amore nè di onore. II governo potè moltiplicare pazzamente errori e provocazioni, ma il popolo indifferente per Venezia, dimentico di Roma, inconsapevole della rivoluzione dalla quale era uscito, vedeva nella monarchia il miglior riparo alla propria fortuna, e le abbandonava Garibaldi come un volgare disertore.
Con questo popolo e per questo popolo Mazzini sognava ancora una republica italiana per strappare alla Francia l'iniziativa storica, ed aprire un'altra epoca di civiltà in Europa! I Borboni avevano trovato migliaia di briganti per una reazione antinazionale ed inumana; Garibaldi ferito e prigioniero non provocò in nessuna città d'Italia il più piccolo moto di ribellione. Le sue bande rosse soccombettero all'ignavia nazionale. Se la monarchia fosse stata veramente un principio [162] nella rivoluzione italiana, non si sarebbe trovata costretta a fucilare Garibaldi sulla via di Roma proclamata capitale da un voto ripetuto del parlamento; ma se l'Italia non comprendeva allora il sublime significato di Garibaldi moschettato per ordine di Vittorio Emanuele, mentre si accingeva ad aprirgli l'eterna capitale del mondo e ad incoronarlo in Campidoglio respingendo con ultimo sforzo tutto il medio evo cattolico dalla storia moderna, le venienti generazioni cresciute a migliore democrazia forse non potrebbero mai più riconciliare nella propria coscienza la monarchia piemontese coll'idea italiana, la sovranità nazionale col diritto regio.
Intanto l'Europa si esaltava d'amore per l'eroe ferito, cui il ministero lesinava così ignominiosamente ogni conforto di cura che un impiegato dell'arsenale dovette faticare più giorni per fornirgli un letto di ricambio, e il dottore Riboli ebbe ad elemosinare per lui la biancheria da una signora della Spezia. Quindi lord Palmerston mandò al ferito un letto dall'Inghilterra, affrancato come una lettera perchè viaggiasse colla massima rapidità, e per non umiliare il governo italiano volle serbarsi incognito donatore; Partridge, primo chirurgo di Londra, fu pagato con mille sterline dai propri clienti perchè venisse a visitare il ferito; la Russia spedì il chirurgo Plougoff, Drouyn de Lhuys inviò Nélaton; un mondiale plebiscito di carità vendicò Garibaldi dell'ingratitudine italiana.
Allora il governo comprese il pericolo di processarlo: il sentimento popolare si sarebbe probabilmente appassionato alla teatralità di così grande dibattito, mentre l'eroe, chiuso fino allora nel più magnanimo silenzio, avrebbe forse dovuto rivelare fra le morse di un interrogatorio qualcuno dei molti imbrogli della politica regia, scoprendo al disprezzo del paese la figura del re. Peggio ancora tutte le giurìe del regno lo avrebbero certamente assolto di un delitto, del quale nessuna abilità di magistrato avrebbe potuto definire la natura. Fortunatamente le nozze della figlia secondogenita [163] del re con don Luigi di Portogallo offersero l'occasione di una amnistia; questa fu conceduta il 5 ottobre a tutti i colpevoli di Aspromonte, meno i disertori che condannati a morte ebbero commutata la pena in una prigionia prima a vita, poscia a tre anni.
Il ministero, infatuato della propria vittoria su Garibaldi, credette potersene giovare dopo siffatta reazione per chiedere la restituzione di Roma all'Italia, come se le popolazioni avessero secondato il governo nella repressione del tentativo garibaldino solo per la fede che il governo del re sapesse meglio risolvere tanto problema. Ma a tale querula questua, vantata dalla stampa moderata di allora quale una protesta ammirabile di orgoglio italiano, Napoleone rispose al solito con un opuscolo del Laguerronière, L'Europa e il Papato, ribadendo la vecchia utopia, Roma essere indispensabile all'esercizio del potere spirituale, e riproponendo un congresso europeo per dividere l'Italia in tre stati. Il ministero tentò replicare: allora Napoleone chiamò al Ministero il Drouyn de Lhuys, e mandò ambasciatori al Vaticano il La Tour d'Auvergne, entrambi nemici d'Italia.
Così, in poco più di un anno dalla morte di Cavour, il partito rivoluzionario aveva tentato indarno i due massimi problemi di Venezia e di Roma contro la monarchia. A Sarnico il minuscolo moto aveva abortito siffattamente che nel ridicolo della sua insufficienza militare svanivano le brutture della reazione monarchica; ad Aspromonte invece la tragedia del diritto nazionale era salita più alta dell'epopea rivoluzionaria. Garibaldi, ritentando la distruzione del papato difeso ancora da un impero francese, diventava l'ultimo martire di una lunga storia di eroi. Da Arnaldo da Brescia a Cola da Rienzi, da Porcari a Burlamacchi, da Dante a Machiavelli, da Bruno a Giannone, attraverso la storia millenaria di un federalismo sempre tendente all'unità e di una lotta fra la libertà del pensiero civile e l'autorità del pensiero religioso, Roma era stata il centro della guerra e della vita italiana. Il patto della [164] chiesa coll'impero, di Leone con Carlomagno, si riproduceva enorme, assurdo, mezzo secolo dopo la rivoluzione francese. L'Italia, alla quale quel patto aveva tolto di essere nazione, non poteva diventarlo che lacerandolo.
Garibaldi, l'eroe più italiano e più universale della democrazia moderna, marciando su Roma assaliva contemporaneamente papato ed impero: tutto il diritto moderno giustificava la sua impresa, tutte le libertà erano scritte sulla sua bandiera. Fra l'antico patto della chiesa coll'impero erano sorti prima vinti, poi vittoriosi i comuni; Garibaldi, campione della nazionalità era insorto fra il nuovo, ed era stato vinto dalla monarchia nazionale d'Italia nel nome della chiesa e dell'impero.
Onesta fatale mostruosità diventava più dolorosa al ricordo che la democrazia italiana aveva già fino dal 1849 decretato a Roma l'abolizione del potere temporale e la republica. Il pensiero italiano parve quindi indietreggiare di molti secoli. Mazzini stesso, protestando contro la bassezza del governo, criticava con meschini criteri di opportunità politica il disegno di Garibaldi.
Intanto il ministero Rattazzi, sbattuto da troppe correnti, sprofondava. Dalle simpatie di tutta l'Europa per Garibaldi il popolo riprendendo coraggio, cominciava ad appassionarsi pel ferito. Le ultime umiliazioni inflitte al governo dalla diplomazia francese rendevano più amaro il lutto prodotto dagli equivoci ministeriali; le necessità dei nuovi balzelli, fra i quali odiatissimo quello della ricchezza mobile, aumentavano i pretesti al malcontento; le ladrerie moltiplicantisi nella vendita dei beni demaniali, che a rovescio di ogni legalità si facevano troppo spesso per ordinanza di ministro anzichè per decreto reale, sminuivano la già scarsa fiducia nell'amministrazione centrale; la paura della destra per una politica troppo complicata nella diplomazia, compromessa colla rivoluzione, e pericolosa nei risultati, l'odio della sinistra per il tradimento sofferto [165] e per la raddoppiata sommissione alla Francia, il trionfo del papato vantato dal clero oscenamente, tutte queste colpe e queste forze si unirono contro il ministero, che dovette dimettersi fra l'esecrazione universale.
Ma anche nella disperata difesa dell'ultima discussione Rattazzi mantenne la propria superiorità parlamentare, destreggiandosi con insuperata agilità fra tanta tempesta di accuse e di accusatori.
La tragedia d'Aspromonte, travolgendo il ministero Rattazzi, rese nella coscienza publica più urgente il problema di Roma.
Rivoluzione e monarchia sentirono del pari la necessità di uscire da una situazione che infirmava ogni fatto della nuova vita italiana. A Torino la monarchia correva rischio d'immobilizzarsi nel piemontesismo reso più odioso dall'obbligo di difendere il papato contro qualunque rivendicazione nazionale. In parlamento la posizione dei ministeri diventava sempre più precaria. I partiti, esagitati da inconciliabili passioni, si combattevano senza vera distinzione di programma: quello rivoluzionario difendeva per opposizione dialettica tutte le piccole autonomie, e rispondeva col grido di Venezia e di Roma alle continue domande di spese militari; la moltitudine si cullava ancora nell'illusione di una quasi segreta ricchezza nazionale, mentre le finanze mal rinsanguate da imposte poco esigibili e pessimamente distribuite declinavano verso il fallimento.
La formazione del nuovo ministero fu tra le più laboriose. Il conte Ponza di San Martino, primo a riceverne l'incarico, avrebbe voluto un programma di raccoglimento, limitando tutte le spese ed aggiornando la soluzione di tutti i problemi, ma dovette ritirarsi, [167] anche perchè la sua qualità di piemontese l'avrebbe reso impossibile in quel momento. Si ricorse al Farini, già ammalato di spinite, e gli si diedero compagni il Minghetti, il Peruzzi, il Pasolini, il Pisanelli, il Menabrea, l'Amari, lo Spaventa. Il ministero così composto parve più italiano dei precedenti, sebbene la sua azione non potesse spiegarsi con più italiani intendimenti: si sarebbe bramato una tregua alle questioni politiche quando invece queste incalzavano sempre più fiere.
L'insurrezione della Polonia, della quale il partito rivoluzionario si servì per riscaldare il sentimento patriottico delle masse con sottoscrizioni, con comizi ed arruolamenti, mise il governo nel più difficile imbarazzo diplomatico collo czar, che aveva in quei giorni riconosciuto il nuovo regno. Emilio Visconti-Venosta, succeduto al ministero degli esteri, pur giuocando di destrezza, dovette concludere collo Spaventa, direttore generale della polizia, ad un'altra persecuzione dei liberali: anzi questi nella violenza della propria fede monarchica vi risuscitò concetti ed abitudini della polizia borbonica con un dizionario di sospettati e di sospetti e con istruzioni assurdamente inquisitoriali a tutte le prefetture.
Alla reazione militare di Aspromonte seguiva così un'altra reazione poliziesca: la monarchia sembrava aver paura, il popolo affettava di disprezzarla; nella vita dell'una e dell'altro non pareva che il formarsi del nuovo stato avesse prodotto radicali mutamenti.
Da Roma il papato sbraveggiava e l'antica metropoli invece durava nella propria oramai storica indifferenza.
Dalla caduta della republica e durante il lungo periodo della occupazione francese, Roma non aveva dato alcun segno di vita politica. La ripristinazione del papato, malgrado la subdola ferocia di un'ultima reazione, non aveva potuto scuotere il suo scetticismo: vi erano state molte feste religiose affollate al solito come spettacoli di circo, e null'altro. Poi il popolo superstizioso ed incredulo, la borghesia ignorante ed ignara, [168] l'aristocrazia altera ed impotente, il clero, onnipotente ed inetto, avevano ripreso la propria vita di ozio e di disordini. In mezzo al deserto dell'agro, Roma non era più che un'immensa necropoli, nella quale la republica del 1849 aveva durato appena il tempo di un'improvvisazione teatrale, cadendo senza lasciare rovine.
Nullameno qualche lievito indefinibile sembrava fermentare nella sua coscienza. L'antico orgoglio quiritario, sopravvissuto nel popolo alle umiliazioni di tanti secoli, gli rendeva odiosa l'occupazione francese; la viltà mostrata nella crisi della republica dal clero aveva scemato a questo il prestigio di padrone; l'antagonismo fra le truppe papaline e francesi irrompente spesso in piccole mischie, nelle quali la bravura brigantesca degl'individui dava a quelle, un vantaggio sul valore collettivo di queste, aizzava nella moltitudine l'odio allo straniero. Il quale, pure essendo diverso dall'odio generoso dei lombardi per gli austriaci, non si mostrava molto meno vivo, giacchè i francesi, costretti a fare da gendarmi al papa contro l'Italia, dovevano per sospetti di mene liberali vessare il popolo come gendarmeria papalina. L'odio menò al sangue: la plebe con perfida crudeltà si diede a circuire i soldati vaganti per le vie nei primi giorni dell'arrivo, e col pretesto di spiegar loro i monumenti antichi li traeva in agguato, gittandoli dai ponti nel Tevere o trucidandoli nei vicoli più deserti.
Ma ogni tentativo per mezzo di congiure mazziniane vi fallì. Il bolognese Petroni lasciatovi da Mazzini a rannodare le fila delle antiche cospirazioni era stato presto imprigionato; i migliori liberali emigrarono; gli altri finsero di adoprarsi alla rivoluzione ed invece si studiarono d'impedirla per non correrne i rischi.
Così, quando ad esautorare Mazzini anche nelle cospirazioni, Cavour per mezzo del La Farina fondò la Società Nazionale, aggregandovi tutti quei liberali che volevano aspettare di essere liberati dalla monarchia sarda, a Roma si formò presto un comitato per contrastare [169] l'azione dei mazziniani, magari coll'infamia di denunzie alla polizia papalina.
Fu questo uno degli spettacoli più miserandi della rivoluzione italiana.
Quindi al suo scoppiare, mentre le Romagne, le Marche e l'Umbria insorgevano, Roma non si mosse: le Romagne fortunate di più sollecita annessione non ricaddero più sotto al gioco papale, ma le Marche e l'Umbria patirono stragi di guerra; e Roma non si mosse. Dopo la sconfitta di Lamoricière e di De Pimodan, quando gli eserciti piemontesi trionfanti passavano al suo traverso per congiungersi alle bande rosse di Garibaldi, Roma, paurosa del presidio francese e ubbidiente alla parola di Cavour, non si mosse. La città dalla quale in una storia di tremila anni era derivata la nazionalità dell'Italia, non parve italiana: dopo aver assistito con colpevole accidia alla tragedia della republica mazziniana, Roma si manteneva indifferente alla formazione del grande regno italico. Dai suoi mille monumenti di gloria non un sentimento le venne della grandezza moderna. Eppure un'insurrezione popolare le sarebbe stata quasi troppo facile per meritare le lodi d'Italia. Forse il presidio francese non avrebbe osato battersi per il papa, giacchè Napoleone III per difendere Roma dalla conquista regia aveva insino allora dovuto persuadere l'Europa della fedeltà dei romani verso il pontefice. O Garibaldi o Cavour, quegli in nome della rivoluzione, questi col pretesto dell'ordine, vi sarebbero entrati evitando di scontrarsi col presidio francese e salvaguardando il papa: quindi l'imperatore, costretto a combattere il proprio alleato di ieri per rimettere in trono il papa, avrebbe probabilmente ceduto al doppio principio del non intervento e dei fatti compiuti.
Ma se il popolo romano venne meno al dovere della propria gloria, il governo papale in tanta rovina di se stesso non trovò nè coraggio per resistere, nè dignità per cadere. Anzitutto l'ignavia del popolo egualmente incredulo all'Italia e al papato gli tolse [170] di poterlo chiamare alle armi: poi l'esercito raccolto fu di mercenari e di volontari stranieri, comandati da generale straniero. Ogni apparenza di legittimità mancò alla difesa dello stato; per mezzi politici si usarono scomuniche e preci; vi furono processioni per l'assedio d'Ancona e per quello di Capua, quasi la causa del Borbone fosse identica a quella della chiesa; la stampa papalina mentì e vituperò fanciullescamente tutti gli eroismi della rivoluzione.
Per l'Italia non s'ebbe che qualche dimostrazione di strada e di teatro: in questi si gridava monellescamente «viva Verdi», facendo col nome dell'illustre maestro un anagramma: Viva Vittorio Emanuele re d'Italia. Nel carnevale del 1860, la popolazione avendo disertato come a protesta il corso di porta del Popolo per riempire quello di porta Pia, il cardinale segretario Antonelli con satanica ironia mandò a quella passeggiata politica in carrozza di gala il carnefice mastro Titta. Nullameno la popolazione divorò in pace l'insulto. In sostanza la metropoli non soffriva di agitazione rivoluzionaria: il residuo del suo stato circoscritto dalle maremme toscane, dall'Umbria, l'Abruzzo e la Terra di Lavoro, non aveva altra vita politica che quella del brigantaggio. Le condizioni delle provincie erano miserande come pel passato; la feudalità dei grandi signori romani vi spadroneggiava d'accordo colla strapotenza del clero. Il brigantaggio antico come costume vi rifioriva ora per aiuti del papa e del Borbone, compiendo di corrompere la brutalità delle popolazioni.
La decadenza del governo papale diventava anche più scandalosa al paragone del risveglio di ogni attività, prodotto dalla rivoluzione in tutto il regno d'Italia.
Nella metropoli popolo e borghesia vivevano della chiesa; la burocrazia v'era così cresciuta che si contavano quasi sessantamila impiegati; il resto era plebe e servitorame; l'esercito raccogliticcio e straniero, e piuttosto di parata che di guerra; la flotta composta di una sola corvetta ancorata nel Tevere; l'antica università [171] ridotta a poco più di un seminario; i conventi innumerevoli e vasti come paesi: migliore se non unica speculazione quella degli alberghi: Roma non viveva più che d'ospitalità e di feste religiose.
Una vasta e torbida malinconia pesava sulla città eterna, fasciata dal deserto inconsolabile del proprio agro come da un immenso mantello luttuoso: le sue cattedrali, miracolo di genio e di grandezza, parevano esse pure sopravvissute alla religione del popolo che le aveva erette: la fede non vivificava più alcuno dei loro riti; le arti non abbellivano più nessuna delle loro forme. La romanità era morta da secoli. I grandi intelletti stranieri visitando Roma rimanevano colpiti dal silenzio della sua vita, nella quale i costumi della plebe parevano di villaggio, e quelli dell'aristocrazia riproducevano entro la più severa delle cornici storiche il quadro effimero delle eleganze parigine.
Della republica del '49 non restava altra traccia che il Vascello ancora rovinante: in Campidoglio durava, superstite maschera, un senatore del quale nessuno si occupava, e che a certi giorni usciva in grande pompa di carrozze e di valletti, come idolo vivente nella città di tutte le idolatrie.
Questa era la capitale assegnata da tremila anni di storia all'Italia divenuta finalmente nazione. Quando Garibaldi cadeva moschettato dai bersaglieri sul pianoro di Aspromonte, Roma papale non avvertì nè il pericolo, nè la speranza dell'avventura rivoluzionaria: i clericali ne sorrisero sprezzantemente, i liberali indettati dal La Farina se ne rallegrarono come di un trionfo della monarchia piemontese.
Infatti poco dopo il ministero Minghetti, dal quale il Farini aveva dovuto uscire per malattia incurabile, dava al problema di Roma capitale la sola possibile soluzione per la monarchia.
Anche questa volta l'iniziativa venne dall'Inghilterra [172] e dalla Francia. All'indomani di Aspromonte lord Russell, proseguendo nella politica di ostilità all'espansione dell'impero bonapartesco, che colla spedizione al Messico accennava ad un'azione potente anche nel nuovo mondo, protestava vigorosamente contro l'occupazione francese a Roma, dichiarando la Francia responsabile del brigantaggio napoletano e di ogni possibile complicazione europea nella questione italiana. Il legato francese De Sartiges, succeduto al Benedetti, invitò quindi il gabinetto di Torino a riprendere gli studi per una conveniente soluzione del problema romano.
Il ministero, angustiato dalle agitazioni in favore della Polonia, dai risultati dell'inchiesta parlamentare sul brigantaggio, dagli scandali di ladrerie negli appalti delle strade ferrate pei quali l'ex-ministro Bastogi e troppi altri deputati avevano dovuto ignominiosamente dimettersi; sferzato dalle accoglienze entusiastiche fatte a Giuseppe Garibaldi (marzo 1864) a Londra nell'intendimento di osteggiare l'alleanza austro-prussiana a danno della Danimarca; sopraffatto dall'avvilimento del nome italiano in Europa, credette necessario a salvarsi un grande colpo politico.
Le trattative su Roma furono riprese.
Napoleone III, persuaso finalmente che la perfidia della curia romana e l'indomabile istinto della rivoluzione italiana avrebbero potuto suscitare dall'occupazione francese in Roma motivi di guerra europea, pensò a trarsi dal cattivo passo senz'offendere le facili suscettibilità dei clericali francesi. Il suo disegno finissimo per eccessiva semplicità consisteva nel ritirare le truppe da Roma, incaricando la monarchia italiana della salvaguardia del papa, e chiedendole un pegno tale delle proprie promesse che significasse in faccia all'Italia e all'Europa una tacita rinunzia a Roma. Cotesto pegno doveva essere nell'elezione di un'altra capitale.
Alle prime aperture del governo francese il gabinetto italiano ripropose la già fallita convenzione di [173] Cavour: sgombro delle milizie francesi da Roma e dal territorio pontificio, impegno per l'Italia di non assalire e di non tollerare che altri assalisse il dominio del pontefice. Era un'abdicazione al diritto nazionale col solito sottinteso di mancare al trattato qualora eventi fortunati lo permettessero: la politica regia non poteva sottrarsi a siffatto espediente. Ma l'imperatore, indovinando il facile giuoco, pretese dall'Italia l'elezione di un'altra capitale per esautorare simultaneamente la tradizione piemontese e il diritto nazionale. Il ministero accettò. La subdola convenzione del conte di Cavour, che all'indomani della proclamazione del regno italico mirava con ogni sforzo e a qualunque prezzo di contraddizioni a trarre i francesi da Roma, diventava coll'elezione di una nuova capitale un'esplicita rinunzia a Roma: la presenza nel ministero del Minghetti, ex-ministro papalino, e del Peruzzi, toscano tardi convertito all'idea dell'unità, spiegava anche troppo chiaramente il pensiero politico del governo. Non si voleva andare a Roma; dopo la Francia si temeva dell'Europa; il papato, istituzione millenaria, cosmopolita, necessaria al cattolicismo, era giudicato inseparabile dal dominio di Roma; la monarchia italiana non osava abbatterlo. Si sentiva che la rivendicazione di Roma avrebbe reso per sempre inconciliabili monarchia e religione; il bigottismo del re rabbrividiva all'idea di così terribile guerra; si esagerava il sentimento religioso delle popolazioni; non si credeva al già visibile declino dell'impero napoleonico; non s'intravedeva, e sarebbe stato facile e Mazzini da anni l'aveva annunziata, la lotta imminente fra Prussia ed Austria, che doveva ripetersi maggiore fra Germania e Francia. Il dottrinarismo monarchico, effimera ed assurda miscela di tradizioni regie e d'idee rivoluzionarie, di classicismo accademico e di empirismo plateale, doveva soccombere nel grande problema di Roma.
D'altronde la necessità di trarre da Torino la capitale coonestava l'espediente. Quanto all'umiliazione e all'impossibilità di proteggere il papa da nuovi assalti [174] italiani, dopo la triste vittoria di Aspromonte non ci si pensava: all'accusa di abdicazione con sottigliezza parlamentare si rispondeva invocando i plebisciti e proclamando che colla nuova convenzione Roma ridiverrebbe dei romani: a questi il pronunziarsi contro il papa in favore dell'Italia. Ma poichè li si conosceva incapaci di tanto, si ripeteva con orgoglio l'insidioso argomento.
Negoziatori italiani della convenzione, che prese nome dal 15 settembre 1864, erano il Nigra, allievo del Cavour, ambasciatore a Parigi, e il marchese Gioacchino Pepoli, parente dell'imperatore, laido per vizi, vano nella depravazione del poco ingegno; pel governo francese firmò il ministro Drouyn de Lhuys. Dei cinque articoli il primo statuiva che l'Italia nè assalirebbe, nè tollererebbe assalti al territorio pontificio; il secondo fissava allo sgombro delle truppe francesi da Roma il termine di due anni; il terzo assentiva al papa la formazione di un esercito anche di mercenari stranieri; il quarto obbligava l'Italia a negoziare colla Santa Sede per l'assunzione di una parte dei debiti delle antiche provincie pontificie; il quinto stabiliva la ratificazione della convenzione nel termine di quindici giorni. Un protocollo esigeva però, ad ingiuria della fede italiana, che la convenzione non avrebbe effetto, se non quando il re d'Italia avesse decretato il trasferimento della capitale in altra città.
Per tale convenzione risorgeva a Roma il federalismo: invano governo, parlamento e plebisciti avevano sino allora decretato una l'Italia e Roma sua metropoli. Il papa acquistava il diritto di armarsi contro l'Italia, alla quale da anni faceva un'orribile guerra di brigantaggio, mentre la nazione veniva condannata ad essere il suo gendarme e a ripetere indefinitamente la tragedia di Aspromonte, se tutti gl'italiani non rinunciassero unanimemente ai patrii diritti.
Ma all'infuori di Roma nessun'altra città poteva essere capitale d'Italia. Torino rappresentava la conquista regia, tutte le altre erano state conquistate; Firenze [175] non era più che la maggiore prefettura di Toscana, illustre di gloria antica quanto povera di significato moderno; Napoli, capitale delle due Sicilie, mancava di affinità col resto d'Italia: trasportarvi la capitale sarebbe stato un cadere dall'assorbente prepotenza piemontese nella più inorganica preponderanza napoletana.
Senza Roma capitale la rivoluzione italiana non era più che una conquista piemontese.
Ma la monarchia, che aveva vinto come negazione della rivoluzione, era spinta irresistibilmente alla rinunzia di Roma. Il Pasolini, uscito allora dal ministero degli esteri, l'affermava esplicitamente; D'Azeglio, nel più misero dei propri opuscoli, lo dichiarava con inconscio candore; il Boggio, deputato e pubblicista eminente fra i moderati, aveva già confessato durante la tragedia di Aspromonte, che Roma conquistata da Garibaldi all'Italia sarebbe stata una sventura per la monarchia; e infatti questa non avrebbe avuto al proprio attivo che il tradimento francese di Villafranca. Il Peruzzi con astuzia toscana preparava già per Firenze il fasto e l'enorme debito di una capitale immutabile; il Minghetti diplomatizzava accennando in un indefinibile avvenire alla possibilità di ottenere Roma, ma lavorando con energia ad assidere stabilmente il governo a Firenze.
L'Italia taceva come per Aspromonte.
La formula ipocrita: «Roma dei romani», contro la quale i pochi mazziniani di Roma protestarono nobilmente, era l'argomento rivoluzionario per sedurre i più ingenui; la perfida riserva di tradire la convenzione dopo lo sgombro dei francesi, e appena se ne presentasse il destro, l'argomento politico per convincere i più restii.
Fortunatamente per la monarchia, il papato, pauroso di un vero abbandono da parte della Francia, protestava contro la convenzione dandole l'apparenza di un falso patto.
Ma il modo col quale il governo l'annunziò al paese, [176] ne tradì il triste segreto: invece di publicarne francamente il testo, si credette furberia preavvisare nell'Opinione, organo massimo del partito moderato, che nel termine di due anni cesserebbe l'occupazione dei francesi in Roma. Pochi giorni dopo la Gazzetta di Torino, altro giornale officioso, in un articolo apologetico della convenzione, s'abbandonava a minacce contro Torino, se mai osasse per grettezza municipale contrastare al trasferimento della capitale. Allora la vecchia metropoli piemontese, che credeva ingenuamente di aver conquistato l'Italia, s'inquietò: si sapeva che Vittorio Emanuele era contrario alla convenzione per dignità di re italiano e più per orgoglio di principe savoiardo; una ressa di popolo tumultuante assalì gli uffici della Gazzetta di Torino, e non si sperdette che sotto i colpi di daga dei poliziotti; il consiglio municipale raccolto a seduta improvvisa protestò; circolavano voci di altre cessioni territoriali alla Francia; si temeva per l'integrità piemontese; il ministero con singolare inettezza, non prevedendo tanto subbuglio, non aveva preso precauzioni, e non osava prenderne. Il tumulto degenerò in ribellione, la legione degli allievi carabinieri tirò sul popolo inerme che gridava: «Abbasso il ministero!»; la sera appresso nuove rappresaglie ed altro sangue. Si contarono 23 morti e 80 feriti, fra i quali un colonnello. La guardia nazionale potè a stento frenare la strage. Finalmente il re costrinse il ministero a dimettersi, incaricando il Lamarmora di formare il nuovo gabinetto, e lo sdegno municipale della città si placò in una indefinibile speranza sul nome di questo illustre piemontese.
Nel resto d'Italia le solite proteste e null'altro.
Mazzini in articoli roventi di dolore patriottico encomiò il tumulto torinese fingendo di crederlo ispirato da un alto senso di italianità; la publica opinione invece, mal disposta verso Torino, accettò piacevolmente [177] l'idea di una nuova capitale a Firenze, e rise colla tradizionale furberia politica dello spirito italiano sul papa e sull'imperatore, che potevano credere sul serio alla rinunzia a Roma.
I massacri di Torino vendicavano in certo modo i morti di Aspromonte.
Il Lamarmora, benchè avverso alla convenzione, dovette subirla; solamente a sgravarsi della troppa responsabilità ottenne che il trasferimento della capitale si compiesse per legge anzichè per decreto reale, e la decorrenza del termine per lo sgombro delle truppe francesi da Roma cominciasse dal giorno della sua promulgazione. Il parlamento, convocato per discutere questa legge, recriminò sul ministero caduto votando una inchiesta; il municipio torinese di rimpatto ne iniziò un'altra. Quindi il gabinetto francese, commentando in una nota diplomatica la convenzione per rendere più evidente la rinunzia italiana a Roma, dichiarò fra i mezzi violenti interdetti all'Italia per entrare in Roma anche i maneggi di agenti rivoluzionari; e si riservò, nel caso di una spontanea rivoluzione nella città eterna, ogni libertà d'azione.
Allora il Lamarmora in una nota di risposta dovette riaffermare che eseguendo la convenzione alla lettera non intendeva contraddire alle aspirazioni nazionali, nè vincolarsi qualora scoppiasse in Roma una simile rivoluzione.
La discussione della legge in parlamento durò tempestosa dal 7 al 19 novembre.
Il ministero vi si mostrò al di sotto della propria dignità. Si sarebbe voluto, e il Boggio ne fu uno fra i più caldi oratori, che la Camera accettasse senza controllo la convenzione già firmata dal re e dall'imperatore; il ministro Giovanni Lanza sostenne con ingenua improntitudine che la convenzione avendo avuto l'assenso dell'imperatore non poteva decentemente discutersi dal parlamento; la sinistra combattè abbastanza nobilmente invocando i plebisciti, che la convenzione avrebbe distrutti, ma, soffocata nella propria [178] antitesi di partito rivoluzionario e parlamentare, rimase senza efficacia. In così suprema questione le sarebbe bisognato il coraggio di dimettersi in massa per appellarsi al paese; ed invece, malgrado la rinuncia a Roma, Francesco Crispi, uno de' suoi capi più autorevoli, sostenne che la monarchia ci unificava e la republica ci avrebbe divisi. Mazzini gli rispose invano con una lettera tremenda d'ironia. Il Mordini, simpatico oratore e rivoluzionario di recente convertito alla monarchia, votò la convenzione scusandosi col sofisma traditore che le transazioni temporanee della politica officiale non infirmavano la sanzione popolare della nazione alla sua capitale; Giuseppe Ferrari, genio scetticamente profondo, l'accettò giudicando Roma piuttosto sepolcro del cattolicismo che culla di una terza Italia.
Poco dopo la Camera su proposta di Ricasoli rinunciava a discutere i risultati dell'inchiesta sui casi di Torino, lasciando i ministri colpevoli atteggiarsi a Catoni. Quindi una voce circolante, ed era forse vera, commosse vivamente la publica opinione. Si temette che colla rinunzia a Roma e cogl'impegni assunti di difendere il papa da qualsiasi atto esteriore, il governo si fosse pure vincolato ad impedire qualunque attacco al Veneto e, nel caso propizio di un ricupero di questa provincia, a rettificare nuovamente le frontiere piemontesi colla Francia sulla linea della Sesia. Mazzini sempre bene informato denunciò particolareggiandolo questo segreto protocollo; il Villa, oratore piemontese di parte democratica, commentò questa rivelazione, che un discorso imperiale al parlamento francese parve riconfermare: il ministero respinse alteramente tale accusa.
Intanto l'odio municipale di Torino cresceva a segno da mutarsi in fervido amore d'italianità per dispetto a Firenze e alla monarchia. Una vasta associazione politica coagulatasi improvvisamente coi più vari elementi piemontesi scomponeva i partiti della Camera: il suo motto d'ordine era il grido d'Aspromonte — Roma o morte! — Moderati e democratici si stringevano [179] in falange per combattere tutti i ministeri, nei quali governassero gli uomini che avevano offeso Torino, e spingerli a forza, come per vendetta, su Roma. Così la rivoluzione traeva nella propria orbita i più restii conservatori di quel Piemonte che aveva sempre considerato l'Italia come terra di conquista. La cosa giunse a tale che si vide persino il Boggio, uno fra i più accaniti nemici di Mazzini, trattare col grande esule a nome di questa associazione per eccitare nuovi moti di ribellione nel Veneto.
Invero il governo, ostinato nel proprio concetto di una rinunzia a Roma, non solo ritirava un incertissimo schema di legge sull'asse ecclesiastico onde non sopprimere le corporazioni religiose, i beni delle quali avrebbero rinsanguato le finanze, ma ritentava una riconciliazione col papato. Nè l'ultima enciclica Quanta cura, stridente di recriminazione contro l'Italia, nè il Sillabo, ove si condannavano in ottanta proposizioni quasi tutti i postulati del pensiero civile moderno, parevano nuovi ostacoli ai ministri. La Curia romana colla solita malizia si prestò al giuoco: Pio IX scrisse una lettera a Vittorio Emanuele per provvedere di buon accordo alle numerose vacanze delle sedi vescovili nel regno; il governo deputò a Roma il Vegezzi, magistrato illustre; corsero cortesie d'ambo le parti, e si finì necessariamente ad una rottura, giacchè la Curia ricusò ostinatamente al re il diritto all'exequatur e al giuramento dei vescovi.
Ma nemmeno quest'ultimo smacco persuase al governo migliore politica; anzi il Lanza uscì dal ministero per non averlo potuto spingere a maggiori concessioni verso il Vaticano, mentre il ministro Natoli sospendeva la guerra aperta contro i seminarii.
Nel giugno del 1865 la capitale s'insediava a Firenze, ma i francesi, secondo i termini della convenzione, rimanevano ancora a Roma nè alleati, nè mercenari, nè presidio del pontefice, che la monarchia italiana avrebbe dovuto tutelare e i romani sostenere. La loro presenza, dopo il sacrificio di Torino e l'abdicazione [180] a Roma, diventava il peggiore degli oltraggi pel governo di Firenze così guardato a vista dagli austriaci e dai francesi, sbertato dal papa, accusato di tradimento dalla rivoluzione. Se a Torino l'Italia soffocava nell'angustia dell'idea piemontese, a Firenze avrebbe dovuto perire per la mancanza di una qualunque idea: da Torino si poteva guardare fiso a Roma aspettando il momento per lanciarsi al suo assalto; a Firenze non rimaneva più che aspettare nuovi ordini dalla Francia.
Intanto la piccola e bella metropoli coll'audacia mercantile dei suoi tempi migliori si gettava a spese d'ogni sorta per ospitare nobilmente il governo nazionale; nessuno credeva sul serio alla precarietà della nuova capitale; corte e ministeri incuoravano il municipio; si demoliva, si fabbricava, si abbelliva, si lussureggiava così che in pochi anni il debito municipale raggiunse la cifra enorme di centocinque milioni.
Questo scandalo trascinò altri municipii; i debiti parvero un contagio; all'imminente fallimento del governo si aggiunse il dissesto delle provincie e delle più grosse città, mentre il giovane regno minacciato simultaneamente dall'Austria, dalla Francia e dal papa, perdeva colla sincerità del proprio principio rivoluzionario la sola originalità, che potesse crescergli la vita.
Ambo le politiche avevano fallito davanti al problema di Roma.
Quindi Mazzini in una protesta veemente dichiarò di riprendere tutta la propria libertà d'azione pel compimento dell'unità nazionale senza o contro la monarchia: Garibaldi invece seguitò a tacere per non provocare altri conflitti fratricidi fra governo e paese. Quegli e questi cercarono aiuti nella democrazia estera mirando a coordinare i nuovi moti italiani ad una rivoluzione di tutti i popoli, specialmente slavi, aspiranti alla nazionalità.
La politica delle alleanze passava così dalla tradizione cavouriana nell'azione rivoluzionaria a riconfermare che l'Italia con un esercito di trecentomila uomini e quasi venticinque milioni di popolazione non bastava ancora a riconquistare le proprie provincie di Roma e di Venezia.
Dal proprio canto Vittorio Emanuele, insofferente delle troppe umiliazioni, imitando da lungi i tortuosi avvolgimenti della politica napoleonica, ordiva trame segrete con rivoluzionari esteri e nazionali. Nella bramosia d'integrare al più presto possibile il grosso regno regalatogli dalla fortuna, egli per scrupoli invincibili di cattolico intendeva anzitutto al Veneto. Contro l'Austria ferveva tutto il suo coraggio di soldato e il [182] suo patriottismo di re: per opposte ragioni i suoi disegni concordavano quindi con quelli di Mazzini persuaso dell'impossibilità per Napoleone di cedere Roma all'Italia. Re e republicano, di cospirazione in cospirazione, tra ungheresi e galiziani, serbi e rumeni agitantisi ad oriente dell'Austria, finirono coll'incontrarsi. Un segreto ascendente di re patriota, superiore alla politica della propria monarchia, dava a Vittorio Emanuele un forte vantaggio nelle nuove trattative con Mazzini, dacchè Garibaldi, malgrado i tradimenti sofferti, seguitava a credere nella sua parola. La glorificazione del re, prodotta da tutte le glorie assorbite dalla rivoluzione, dominava inconsciamente l'uno e l'altro sino a farli credere che Vittorio Emanuele potesse davvero contrapporsi con nobile iniziativa al proprio governo. La sua bravura di soldato nelle battaglie dell'indipendenza quando tutti gli altri re fuggivano, il suo generoso cordoglio per la pace di Villafranca, l'alterezza ingenita di certi sentimenti significati nelle crisi più dolorose della patria, e sopratutto il bisogno istintivo di trovare qualche epica grandezza nella forma politica prescelta dall'Italia a risorgere, persuadevano a molti che nel re fosse qualche geniale originalità d'eroismo. L'evidenza di troppi fatti contrarii non bastava in quell'orgasmo del dover risolvere in qualche modo i due ultimi e massimi problemi della rivoluzione.
Diplomatico onesto e fine degli accordi fra Mazzini e Vittorio Emanuele fu l'ingegnere Diamilla Müller: l'occasione ne venne dal conflitto dano-germanico, nel quale Austria e Prussia si allearono momentaneamente quasi a conquistare nelle provincie dello Schleswig e Holstein il pretesto della terribile guerra, che doveva indi a poco rimutare tutte le condizioni politiche della Germania. L'Inghilterra, impensierita dalle minacce dell'espansione tedesca, spiava di mal occhio la guerra danese, favoreggiando con magnifiche accoglienze in Londra a Garibaldi le aspirazioni italiane; Napoleone III al solito aveva proposto indarno un congresso europeo e blandiva la Russia accarezzando contemporaneamente [183] le democrazie slave per tener l'Austria in freno. I rivoluzionari italiani tornavano ad agitarsi in speranze di guerra: Vittorio Emanuele avrebbe desiderato una qualunque iniziativa, ma non osava assumerne la responsabilità. Quindi nelle trattative con Mazzini tentava trascinare le forze del partito rivoluzionario entro l'orbita della propria politica regia senza abbandonarsi a concessioni. Il suo disegno era che Mazzini spingesse a rivolta la Galizia, l'Ungheria e gli altri principati lasciando il Veneto in calma, perchè il governo potesse poi scegliere con maggior comodo e rischio minore il momento di romper guerra all'Austria. Naturalmente Mazzini non potè piegarsi a questo egoismo di re, che non voleva nel proprio regno la rivoluzione per non correrne i pericoli, mentre invece l'Italia, avendola già compita nella massima parte, si trovava contro l'Austria in migliori condizioni di rivolta che gli altri popoli.
Le trattative andarono in lungo. Intanto che il re cospirava segretamente, il ministero proseguiva nella persecuzione dei rivoluzionari: si sequestravano le armi raccolte per una insurrezione veneta dai comitati mazziniani e garibaldini; i moderati della Società Nazionale dentro e fuori delle provincie venete spargevano semi di discordia e di scoraggiamento; Vittorio Emanuele stesso dichiarava di esser pronto a reprimere con qualunque mezzo ogni tentativo ribelle non solo verso il Veneto, ma nell'interno del Veneto.
La politica segreta del re non era che un dilettantismo rivoluzionario, troppo poco dissimile da quella del suo governo: giacchè, dopo aver profittato di tutti i sacrifici della rivoluzione italiana, egli avrebbe voluto con ingenua furberia sfruttare in un primo accordo tutta la democrazia europea senza nè sottrarsi davvero al vassallaggio francese, nè assalire il papato, nè largheggiare di libertà cogli stessi rivoluzionari nazionali. Infatti a capo della polizia sbraveggiava sempre contro questi Silvio Spaventa. Nullameno Vittorio Emanuele non cessò dalle trame nella Galizia e nell'Ungheria; [184] da Parigi Napoleone III vi mestava anche più vivamente.
Il governo segreto della rivoluzione polacca aveva proposto a Garibaldi di assumere il mandato di capo morale dell'insurrezione, conferendo al figlio Menotti il comando di una legione italiana per la Galizia, e Garibaldi aveva accettato: nella Serbia, nella Moldavia, nel Montenegro, nell'Albania si raccozzarono bande di armati: un Bulewsky venne a Torino per accordarsi col re, il quale, avendo finito col rivelare la cospirazione al ministero, ne accettò il consiglio di servirsi di questa «per allontanare dal regno torbidi elementi, indisciplinati agitatori e pericolosi cercatori di novità».
Intanto si era trattato con Napoleone III la rinunzia a Roma col trasferimento della capitale a Firenze.
Garibaldi, sempre confidente nella parola del re, aveva promesso di seguire immediatamente i successi delle cose di Galizia e di Ungheria colla guerra nella Venezia, e si preparava già a capitanare personalmente la rivoluzione slava: nel suo concetto doveva essere questo il primo pegno della nuova vita italiana all'Europa. Ma alla voce della sua partenza dall'Italia i più chiaroveggenti fra i patrioti, sospettando dopo gli esempi di Sarnico e d'Aspromonte il tranello, iniziarono pubbliche proteste: il re spaventato mandò allora a Garibaldi un ordine di soprassedere; questi piegò. Intanto la Polonia soccombette alle repressioni del feroce Murawieff, la Danimarca cadde sotto la strapotenza dell'alleanza austro-prussiana; in Italia proseguirono le persecuzioni ai patrioti: Mazzini fu accusato dai più puri fra i suoi seguaci per i tentati accordi col re; Garibaldi, piuttosto che raggirato da perfidie diplomatiche, parve come sempre pronto a tutti i sacrifici per la libertà universale.
Nullameno l'orgasmo di queste cospirazioni non si acquetò nei rivoluzionari. Tutto il Trentino sembrava pronto ad insorgere, quando certo Rossi negoziante denunziò la congiura all'Austria: v'ebbero al solito [185] arresti e condanne, che paralizzarono l'imminente moto nel Veneto; solo nel Friuli alcune bande guidate da un Tolazzi e da un Andreuzzi, intrepidi fra i più intrepidi garibaldini, insorsero. La novella della piccola insurrezione ingigantita dai racconti di piazza agitò Milano e qualche altra grossa città lombarda: il Comitato centrale del partito d'azione, allora presieduto a Torino da Benedetto Cairoli, titubò malgrado tutte le istanze di Mazzini; Ergisto Bezzi, uno fra i più sperimentati ufficiali garibaldini, arruolava emigrati veneti, trentini e quanti volontari lombardi potesse. Il nuovo disegno di guerra tracciato da Mazzini era di formare bande su tutte le località montuose del Friuli, del Cadore e dei Sette Comuni per congiungersi a quelle che sorgessero nel Trentino, tenere a bada con grosse dimostrazioni i presidii nelle città venete serbando Brescia a centro di riunione. Ergisto Bezzi con rapida marcia doveva da Bagolino guadagnare Tione, mentre altri marcerebbero da Limone a Riva per muovere uniti su Trento.
Invece il Comitato centrale di Torino, composto di uomini parlamentari, dichiarò intempestiva la spedizione negandovi soccorsi: parve tradimento e non era che debolezza; il governo moltiplicò ostacoli e minacce. Garibaldi tacque sfiduciato, il resto d'Italia derise l'impresa. Però Ergisto Bezzi, troppo compromesso, dovette tentarla con i più animosi, e partito il giorno 13 novembre (1864) da Brescia con centocinquanta volontari fu arrestato il 16 da un capitano dei carabinieri sul giogo del Manivo, trascinato ad Alessandria con tutta la banda, minacciato di condanna, e finalmente liberato per ordine del Ministero poco disposto allo scandalo di così grande processo.
Gli altri insorti del Friuli, occupate il 16 ottobre le grosse terre di Spilimbergo, Aviano e Maniago disarmandone i presidii senza colpo ferire, dopo qualche fortunata scaramuccia contro le soldatesche austriache spedite a perseguirli, mentre i commissari imperiali di Venezia e di Udine ponevano con bandi feroci sotto [186] la legge stataria i distretti della rivolta, dovettero disperare dell'impresa. La cattiva stagione, le poche armi, la terribilità del nemico, l'abbandono di tutti, vinsero il loro giovanile coraggio; quindi la piccola truppa si sciolse senza onore di battaglia.
A questo aveva concluso l'iniziativa rivoluzionaria italiana, nella quale Vittorio Emanuele, Mazzini, Garibaldi e tutti i migliori si erano intesi per affrettare colle armi la soluzione del problema veneto.
Poco dopo Mazzini subì due altre grandi disillusioni circa l'appoggio dell'agitazione piemontese ai suoi disegni, e nel tentativo di una confederazione di tutte le società democratiche nazionali. Il patriotismo di Torino, inspirato da un rancore municipale, si stancò presto di un lavoro rivoluzionario, pel quale non aveva sincerità nè di fede nè di passione: la federazione delle forze republicane venne meno al doppio scopo politico e finanziario. Mazzini non ne ricavò che l'inventario delle miserie della propria parte: fu impossibile trarne denaro per altri tentativi di insurrezione, e precisare loro una qualunque azione dentro o fuori del parlamento. I più abili vi erano entrati indarno, i più puri non avrebbero voluto nemmeno partecipare alle elezioni contro l'opinione di Mazzini stesso, che sostenne contraddicendosi il concorso alle urne per le prime elezioni di Firenze.
Il dualismo fra Garibaldi e Mazzini impediva nel partito rivoluzionario qualunque azione: senza Garibaldi, sempre fedele alla monarchia, non una banda di volontari si sarebbe raccozzata; senza Mazzini, tornato avversario implacabile della monarchia, nessun programma politico era possibile. La nuova Camera, uscita dalle elezioni generali dell'ottobre 1865, si compose quindi della sinistra democratica, della vecchia consorteria moderata, e dei dissidenti piemontesi capitanati da Rattazzi col nome di terzo partito: Mazzini, eletto replicatamente a Messina, fu mantenuto in esilio dal parlamento malgrado ogni giustizia, perchè la sua presenza in Italia vi avrebbe prodotto agitazioni dolorose [187] ed inutili. Naturalmente la discussione alla Camera fu desolante di sofisticheria e di calunnie; il partito piemontese, dianzi suo alleato, votò il suo esilio ad un cenno di Rattazzi.
Dalla guerra franco-sarda del 1859 le condizioni politiche non erano cangiate.
Come quella non era stata possibile senza il concorso della monarchia piemontese e dell'impero napoleonico, così un'altra guerra per la conquista della Venezia non poteva arrischiarsi senza l'aiuto di una nuova grossa alleanza. Fortunatamente il principio rivoluzionario del secolo, urgendo con diverso processo e misura tutti i popoli d'Europa all'integrale costituzione delle proprie nazionalità, preparava la Germania al soccorso della rivoluzione italiana.
Necessità di sbocchi marittimi e pretese nazionali spingevano la Germania oltre i propri confini settentrionali verso la regione danese e il mare del Nord. Incentivo a questa passione erano le provincie di Holstein Lauenburg e dello Schleswig, quasi tutta tedesca la prima, danese per la maggior parte la seconda, entrambe dipendenti per combinazioni dinastiche dalla Danimarca e per combinazioni politiche dalla Confederazione germanica. Secondo il trattato di Londra (1852), alla morte di Federico VII essendo succeduto alla corona danese il principe Cristiano di Schleswig-Holstein, e avendo il parlamento negli ultimi giorni del regno precedente colla riforma della costituzione considerato il ducato di Schleswig come libero dai vincoli che stringevano l'Holstein-Lauenburg alla Germania, la lite dei confini non mai composta con questa si rinfocolò. La Dieta germanica minacciò l'esecuzione federale sui due Ducati dell'Elba: il governo danese rispose alle minaccie con forti preparativi di guerra fidando nell'appoggio della Svezia e dell'Inghilterra. Il conflitto parve scongiurato per un istante, ma Ottone [188] di Bismarck divenuto in quei giorni grande cancelliere della Prussia, potè abilissimamente eliminarne la Dieta associandosi l'Austria ad una guerra di conquista contro la Danimarca (gennaio 1864). Naturalmente la vittoria rimase ai due forti alleati, però con siffatte difficoltà di ordinamento politico nei due Ducati, da provocare presto fra i vincitori più vasta guerra.
Infatti la rivoluzione germanica, dopo la prova infelice della Dieta di Francoforte e le reazioni sanguinose di Berlino e di Vienna, spingeva la Prussia a mutarsi in campione dell'unità contro la egemonia austriaca. La grande tradizione di Federico II pesava sulla sua dinastia: la Prussia doveva diventare il Piemonte della Germania con tutti gli equivoci di una eguale politica regia peggiorata da più retrive ripugnanze nella corte alla grande opera di un nuovo impero tedesco. Ottone di Bismarck, forse meno destro ma più forte del conte di Cavour, appena chiamato al governo si era accinto alla guerra contro l'Austria. La sua alleanza con questa contro la Danimarca non era stata che un espediente per rialzare la Prussia dalla lunga soggezione austriaca in faccia alla Germania e dare un pubblico saggio della sua nuova forza militare. Sciaguratamente corte e parlamento gli contrastavano con pari ostinazione il disegno. La corte imbevuta ancora delle idee assolutiste proclamate dalla Santa Alleanza aborriva dalla rivoluzione: il nuovo re Guglielmo, macchiatosi di sangue nella repressione di Berlino, era odiato dal popolo e odiava ogni libertà popolare: di rimpatto il parlamento, proseguendo nel dottrinarismo infecondo della Dieta di Francoforte, combatteva il governo fino a ricusargli il voto dei bilanci per chiedergli libertà costituzionali prima che l'unità della patria fosse conquistata.
In Prussia come in Italia i rivoluzionari sognavano d'iniziative popolari trionfanti con metodi costituzionali, mentre invece le rivalità federali e l'impreparazione del popolo in ambo i paesi costringevano la rivoluzione ad organizzarsi entro una salda monarchia [189] per trovarvi le forze militari e politiche necessarie alla guerra contro l'Austria. Ma se in Italia la preparazione piemontese potè svolgersi colla dittatura parlamentare del conte di Cavour, conservando alla Camera l'apparenza della libertà costituzionale, nella Prussia, più tenace delle proprie tradizioni feudali, con una dinastia più reazionaria della sabauda, con una democrazia troppo dotta d'idealismo nei borghesi e così povera di sentimento nel popolo da non avere rappresentanti che nemmeno lontanamente somigliassero a Garibaldi e a Mazzini, la preparazione si addensò segreta e violenta nella duplice opera del ministro Bismarck e del generale Roon.
Rendere inevitabile un conflitto coll'Austria sottraendo prima alla sua influenza quanti stati minori si potesse, sconfiggere in una guerra improvvisa con un esercito superiormente organizzato questo impero debole e superbo della propria eterogeneità, travolgere in questa guerra la dinastia prussiana costringendola suo malgrado ad allearsi colla rivoluzione germanica per fondare un nuovo impero, impadronirsi delle forze latenti della rivoluzione negandola apertamente e forzandola a convergere per passione di patria nel governo, ecco il disegno del più originale fra gli uomini politici di questo secolo. A volta a volta prepotente nella volontà come Napoleone e pur serbandosi agile nella diplomazia quanto Talleyrand; tiranneggiando simultaneamente corte, parlamento e popolo; più inflessibile nell'orgoglio dell'idea germanica che nella sicurezza del proprio metodo, egli potè da prima non sospettato, poi deriso, quindi temuto, ammirato, quasi adorato dalla propria nazione, farne la prima potenza militare d'Europa, e rovesciare due imperi, compiere la rivoluzione italiana, dominare per vent'anni tutte le rivoluzioni balcaniche, sempre vittorioso su tutti i campi, senza che la sua politica dovesse mai degradarsi come l'italiana in negazioni antipatriottiche, o mendicare indarno da stranieri alleati rispetto ai propri diritti dopo aver subìto il loro concorso come un protettorato [190] e ottenuto dalle loro mani alcune provincie come una elemosina.
Alla guerra di Danimarca, che Napoleone III e l'Inghilterra avrebbero voluto impedire, successe la pace di Vienna (1864), colla quale il re di Danimarca rinunziava ad ogni diritto sui Ducati di Schleswig-Holstein e Lauenburg, e si obbligava a riconoscere quanto su questi potessero disporre i sovrani d'Austria e di Prussia.
Quindi i conquistatori col trattato di Gastein, riserbata la sovranità comune sui Ducati, se ne divisero l'amministrazione: quella dell'Holstein toccò provvisoriamente all'Austria, l'altra dello Schleswig alla Prussia. Questa convenzione, definita con disprezzo da Bismarck una cazzuolata alle screpolature dell'edificio, doveva procurargli anche troppo presto il motivo della grande guerra. Infatti i due governatori dei Ducati proseguirono ad osteggiarsi apertamente appoggiando ed oppugnando il pretendente principe di Augustenburg: il maresciallo austriaco Gablenz nell'Holstein spingeva a dimostrazioni popolari verso il principe per riunire sotto il governo nominale di questo i Ducati alla confederazione; il generale prussiano Manteuffel nello Schleswig reprimeva tali manifestazioni manovrando a trarre i Ducati sotto il dominio esclusivo della Prussia.
Ma per combattere l'Austria, ancora in credito di grande potenza militare, Bismarck, malgrado la temerità del proprio ingegno sentiva il bisogno di un'alleanza. Da molti anni la sua idea politica mirava ad isolare l'Austria: quindi, appena salito al governo, aveva dato mano alla Russia per soffocare l'ultima rivoluzione polacca e farsela così propizia contro l'Austria, cui lo czar non poteva perdonare il contegno subdolo e minaccioso tenuto nella guerra d'Oriente. Poi a Biarritz aveva saputo neutralizzare Napoleone III, facendosi credere poco meno di un pazzo nell'esporgli francamente i propri disegni contro l'Austria.
Ma solo un'alleanza italiana, prendendo l'Austria fra due fuochi, poteva garantire una pronta vittoria [191] prussiana. Già sino dalla guerra franco-sarda Bismarck, mandato ambasciatore a Pietroburgo, aveva consigliato il proprio governo ad aiutare la liberazione dell'Italia per prendere il posto dell'Austria in Germania: non ascoltato allora dal ministro Schleinitz e dal re, aveva nullameno maturato la propria idea. Al principio del 1864, per la prossima scadenza dello Zollverein, aveva aperto pratiche col governo italiano onde stringere un trattato di commercio, che i dissidi della confederazione e la guerra colla Danimarca gli imposero di sospendere: quindi nel maggio del 1865 lo riproponeva. Il governo italiano, accettandolo prontamente, vi poneva a solo patto l'adesione di tutti gli stati componenti lo Zollverein per trarli così al riconoscimento del regno d'Italia. Baviera e Sassonia premute dalla Prussia aderirono; Annover e Nassau ossequienti agli ordini di Vienna ricusarono. Pochi mesi dopo Bismarck faceva chiedere dal ministro prussiano in Firenze al Lamarmora se, date certe contingenze, l'Italia unirebbesi alla Prussia per fare la guerra all'Austria.
Era la ripetizione delle prime proposte d'alleanza francese nel 1858.
Il Lamarmora rispose con soverchia circospezione domandando più chiare proposte: quindi alla convenzione di Gastein, frutto delle esitanze della corte berlinese, che obbligò Bismarck a sospendere qualunque trattativa d'alleanza, rimase come acciecato dal bagliore di così grande speranza. Infatti, con inescusabile cecità non solo tentò la corte di Vienna per un componimento amichevole della questione veneta attirandosi dalla cancelleria il più sprezzante diniego, ma con tristissimo espediente finanziario consentì, per riguardi di bilancio, a ritardare la leva dell'anno e a vendere un grosso numero di cavalli, indebolendo il già debole esercito.
[192] Da Parigi l'ambasciatore Nigra con non maggiore intelletto della situazione europea mandava a Firenze consigli di disarmo e di rinuncia ad ogni prossima soluzione del problema veneto.
Giammai la politica italiana si era mostrata più inane. Ma il disegno di Bismarck stava per trionfare anche di lui stesso costringendolo, benchè nemico della rivoluzione, a proporre nella Confederazione un parlamento nazionale a base di suffragio universale e diretto. Idea germanica e idea nazionale vi si fondevano così nella più irresistibile unità: l'Austria veniva respinta dalla Confederazione; la Prussia, vindice del diritto moderno, assurgeva campione della Germania.
La proposta di questo parlamento nazionale, equivalente ad una dichiarazione di guerra, era la prima conseguenza dell'alleanza italo-prussiana, che Bismarck aveva potuto finalmente persuadere ai due governi. In essa però l'Italia con scarsa dignità aveva dichiarato di non impegnarsi per oltre tre mesi e, come condizione essenziale, di non intimare guerra all'Austria se non quando la Prussia avesse già aperte le ostilità. Tale eccessiva circospezione rendeva naturalmente l'Italia satellite della Prussia. Infatti le umiliazioni le fioccarono sopra anche prima che la guerra fosse cominciata.
La diplomazia europea, spaventata dalle conseguenze del vasto conflitto, tentò coi soliti espedienti di impedirlo: una prima proposta di disarmo cui Bismarck dovette cedere per riguardo della propria corte ancora repugnante alla guerra, scoperse l'Italia, giacchè l'Austria ormai sicura al nord mandò giù nel Veneto un grosso corpo di soldatesche. Da Londra lord Clarendon, persuaso che l'Austria fosse necessaria all'equilibrio della politica europea, accusava il gabinetto italiano di provocazioni; a Parigi il ministro degli esteri, spingendo l'improntitudine oltre tutti i confini dell'ingiuria, mallevava al legato austriaco Metternich che l'Italia non avrebbe mai assalito per la prima; da [193] Berlino Bismarck per comando del proprio re, disdiceva l'obbligo di soccorrere l'Italia anche se aggredita dall'Austria.
A queste oltraggiose ingiustizie il ministro Lamarmora rispondeva colla più donchisciottesca cavalleria, giacchè l'Austria, fatta persuasa indi a poco della inevitabilità di una guerra colla Prussia, per meglio vincere la partita, offriva d'accordo con Napoleone III la cessione spontanea del Veneto; e il gabinetto di Firenze ricusava. Dopo il tradimento di Bismarck parve al Lamarmora nobile politica rifiutare la Venezia dalle mani dell'Austria per arrischiare una guerra, che non poteva giovare se non all'infedele alleato; mentre diritto nazionale ed internazionale avrebbero permesso all'Italia di ritirarsi da un'alleanza già disonestamente disdetta.
La grande tradizione di Cavour non assisteva più la politica italiana ridotta ad un'alternativa di servilità troppo basse e di preziosità cavalleresche troppo retoriche.
I maneggi diplomatici non s'arrestarono a questa guasconata d'onore: un congresso fu indetto a Parigi per comporre la vertenza (27 maggio 1866); l'Italia vi acconsentì, dichiarando di sperare dal congresso la retrocessione della Venezia; la Prussia vi aderì senza riserve; la Dieta germanica invece ricusava di sottomettere tali questioni della propria politica interna ad alcun arbitrato; l'Austria domandava, insistendo per l'invito della corte di Roma al congresso, che nessuna potenza vi potesse chiedere aumenti di territori, e si fosse stabilito il trattato di Zurigo per punto di partenza alle nuove trattative.
Naturalmente il congresso fallì.
Quindi (7 giugno 1866) il generale prussiano Manteuffel passava l'Eider invadendo l'Holstein.
In Italia gli apparecchi furono spinti alacremente: si consentì un prestito forzoso di 50 milioni all'interno e un mutuo di 250 milioni colla banca nazionale all'1½% con cedole al corso forzoso: espediente, [194] che, reso più triste dai disastri militari, doveva far discendere il consolidato italiano verso il 40%, e rimanere lunghi anni come balzello esiziale su tutte le produzioni e i commerci nazionali. Con insano terrore di nuova reazione borbonica si permise al governo di mandare a domicilio coatto per semplici indizi quanti individui fossero sospetti di ostilità al nuovo ordine di cose: la facoltà durava al governo tre mesi, e la relegazione ai sospettati un anno. Con decreto reale si autorizzò la formazione di dieci reggimenti di volontari con Garibaldi a duce supremo, si mobilitarono le milizie nazionali, si apprestò in poche settimane un esercito di 300 mila uomini. Commessa la luogotenenza del regno al principe di Carignano, e partito il generale Lamarmora pel campo, il ministero dovette rimpastarsi: n'ebbero la presidenza il Ricasoli, il Visconti-Venosta gli esteri, il Depretis avvocato la marina.
Il parlamento, largheggiando colla corona, accordò al governo ogni straordinario potere durante la guerra: esigere nuove imposte, anche se votate da un ramo solo del parlamento; promulgare la legge per la soppressione delle corporazioni religiose e il riordinamento dell'asse ecclesiastico, quantunque non discusso nel senato, che non lo avrebbe forse approvato; provvedere per decreto reale alle grandi opere pubbliche specialmente ferroviarie. Così malgrado la guerra e la crisi economica, si poterono compiere il breve tempo e senza maggior onere dell'erario, congiungendo con l'Italia centrale le provincie venete, le linee da Ferrara a Rovigo, da Firenze a Napoli per Roma, da Messina a Catania, da Pavia per Cremona a Brescia.
Era quasi una dedizione parlamentare giustificata dall'entusiasmo del momento e dalla coscienza di una necessaria dittatura.
Ma la guerra si apprestava con tristi auspicii. Politicamente la posizione dell'Italia era già guasta dall'arbitrario intervento di Napoleone, cui l'Austria aveva offerto di cedere la Venezia perchè la rimettesse al [195] governo di Vittorio Emanuele: si sentiva oscuramente da tutti che l'azione italiana non era più libera, dacchè il protettorato francese tendeva ora a salvare l'Austria da un ultimo sfacelo. L'esercito, non ancora ben fuso, nè abbastanza addestrato, era minato da rivalità di generali e di regioni: non buone le armi, migliore la disciplina, ma scarsa la fede nei capi, e in questi l'abilità e la gloria. Il concorso dei volontari, che avrebbero potuto crescere sino a centomila e si vollero ridotti appena ad un terzo, era giudicato dal governo piuttosto un pericolo che un aiuto: malgrado la fede in Garibaldi, si temeva sempre di qualche moto rivoluzionario, se una sconfitta avesse compromesso la monarchia. Perciò si era pensato prima a gittare Garibaldi sulla Dalmazia per sollevare alle spalle dell'Austria con forte diversione Slavi ed Ungheresi, ma questo ardito proposito venne presto mutato perchè importava un attacco aggirante anzichè diretto del quadrilatero. La guerra avrebbe allora dovuto procedere colla massima celerità, proteggendo con due corpi Milano e Firenze, marciando su Venezia per attirare il nemico in campo aperto, e minacciando Vienna. Era questo il disegno proposto dal grande stratega Moltke per mezzo del legato Usedom, e suggerito con opposte intenzioni rivoluzionarie ma pari intuizioni di guerra da Mazzini: Garibaldi sulle coste dalmate avrebbe potuto con cinquantamila volontari essere di valido aiuto. Invece si volle, malgrado l'esperienza infelice del 1848 e 1859, tentare l'attacco diretto sul quadrilatero reso imprendibile da nuove fortificazioni. Il Lamarmora ricusò per orgoglio di generale il disegno offerto da Moltke, e piegò come ministro agli intendimenti di Napoleone, che voleva la guerra italiana limitata al minore sforzo possibile: sciaguratamente la rivalità col Cialdini, cui si era con inescusabile parzialità conferito pari comando, finì di guastare il disegno di guerra adottato. Garibaldi, internato nel Tirolo con scarse forze, malissimo armate al solito [196] e contrastate con ogni maniera d'intrighi, non era più che un prigioniero della monarchia, abbastanza furba per trarre la gioventù rivoluzionaria in tale nobile domicilio coatto.
La marina, della quale pel vantaggio numerico delle navi si menavano grandi vanti, avrebbe dovuto essere uno dei maggiori nerbi della guerra: l'Austria, scarsissima di armata, non avrebbe potuto nell'angustia dell'Adriatico evitare nè la battaglia, nè la sconfitta: facilissimo quindi l'impossessarsi di Venezia e di Trieste. Ma a capo della flotta invece del Galli della Mantica, illustre e potente marinaio, si volle mantenere il Persano, timido ed inetto, mentre al ministero della marina con disinvolta insipienza armeggiava il Depretis.
Nullameno tale era la superiorità numerica dell'esercito e dell'armata italiana sull'austriaca che la vittoria sarebbe stata ancora possibile senza quel capitale errore di un attacco diretto sul Mincio, e con una maggiore indipendenza politica. Già dalle prime ore, attraverso l'entusiasmo della guerra, era penetrata una snervante sfiducia; la generosità donchisciottesca del Lamarmora nel ricusare l'offerta cessione della Venezia riduceva la guerra quasi ad un torneo, del quale il premio fosse in certo modo assicurato, e nel quale Napoleone era giudice di campo; il disegno dell'attacco diretto sul Mincio ribadiva il sospetto che non si volesse marciare su Venezia; l'inazione imposta a Garibaldi nelle gole del Tirolo, la lentezza delle prime mosse, quel limitarsi a poco più di una difesa, mentre la posta data all'esercito italiano sotto le mura di Vienna dall'esercito prussiano avrebbe raddoppiato l'entusiasmo nazionale, l'impossibilità di credere a nessun generale regio, preparavano in una inconscia diffidenza quella tempesta di ire magnanime e partigiane, che poi scoppiò alle prime sconfitte.
Ma nella maggioranza il vecchio scetticismo italiano si apprestava invece a profittare delle vittorie prussiane, e a contentarsi della cessione della sola Venezia [197] anche per mezzo di Napoleone, se l'altra del Tirolo e dell'Istria non fossero possibili per le pretese della Germania.
La guerra cominciò sul Mincio.
Tre corpi di esercito ne tentarono il guado, mentre il quarto comandato da Cialdini avrebbe dovuto passare il Po a Ferrara per prendere forte posizione fra Vicenza e Verona, ed assaltare il quadrilatero alle spalle; Garibaldi dal lago di Garda risaliva la valle del Tirolo; l'ammiraglio Persano colla flotta aveva incarico di assalire l'armata nemica a Pola. L'arciduca Alberto, generalissimo degli austriaci e meritamente in voce di buon stratega, aveva messo a guardia del Tirolo dodici battaglioni di cacciatori imperiali e ventidue centurie di cacciatori tirolesi, aspettando col grosso dell'esercito nel quadrilatero. Le sue truppe arrivavano appena alla metà delle nostre, ma erano più forti per posizioni, per armi, per disciplina, per fede nel generale; l'esercito italiano sommava a 300 mila uomini, la flotta a 36 vascelli, tra i quali 12 corazzate. Un telegramma del re la sera del 22 giugno mandato al Ricasoli, e da questo letto in senato per iattanza teatrale, finì di chiarire all'arciduca Alberto il disegno dell'attacco: e però, ingannando abilmente il Lamarmora, che dalle campagne deserte oltre il Mincio lo giudicava concentrato fra l'Adige e il Po, egli lo lascia avanzare a bell'agio in ventaglio sopra una zona di quaranta chilometri in mezzo al triangolo formato da Peschiera, Mantova e Verona. Le colline di Salionze, Oliosi, San Giorgio in Salice e Sommacampagna, obbiettivo del Lamarmora, sono già occupate dagli austriaci sino dalla notte del 22; un'incredibile illusione persuade al Lamarmora che la battaglia sia ancora lontana; la marcia in avanti è ripresa senza indicarne nemmeno con precisione le strade: ignoranza e disordine la sviano. La divisione del generale Sirtori rimane [198] senza avanguardia, l'altra del generale Cerale con due, mentre il nemico, spiegato a mezzaluna sopra un arco di quindici chilometri, s'inoltra all'attacco. La battaglia (24 giugno) non prevista e male ordinata, si risolve in un disastro; il principe ereditario Umberto vi corre rischio della vita, ed è appena salvato dal valore di un reggimento che si schiera in quadrato per resistere ad un assalto disperato di cavalieri ulani; i generali Villarey e Cerale soccombono ad Oliosi, il generale Dezza capitola coi resti della divisione alle Maragnotte; giù nei piani di Custoza il generale Durando, respinto da tutte le posizioni, deve cedere il campo. Lo sgomento dai soldati, dei quali molti gettarono i fucili, e dal treno borghese, che fuggì tagliando le tirelle ai cavalli, sale ai generali: si teme già un'invasione austriaca. Lamarmora telegrafa a Garibaldi che avanzava lentamente su pel Tirolo: — Salvate l'eroica Brescia — e a Cialdini inerte oltre il Po: — Coprite Firenze — : quindi ordina la ritirata di là dal Mincio per assicurare l'esercito nel forte triangolo di Cremona, Pizzighettone e Piacenza.
Giammai battaglia più insensata e rotta minore prostrarono più grosso esercito e più giovane nazione.
Il paese, giudicando la battaglia dal numero dei combattenti e dei morti, appena un cinquantamila degli uni ed un migliaio degli altri, non può comprendere quella fuga, e fantastica d'infami accordi con Napoleone III. Le prime trattative per la cessione della Venezia sembrano ora il prologo di una guerra, nella quale si ricusi di combattere: trecentomila uomini infatti che si ritirano dinanzi a settantamila; una flotta padrona ed inerte sull'Adriatico; Garibaldi confinato nel Tirolo, poi richiamato, quasi il suo piccolo corpo potesse proteggere davvero quello anche troppo grosso dell'esercito regio; Cialdini sempre immobile davanti al Po, quindi in ritirata egli pure senza aver sparato un solo colpo; tutte le speranze svanite, tutte le vanterie cadute e, tremendo aculeo nella coscienza popolare, le rapide e strepitose vittorie dei Prussiani rovescianti in [199] sette giorni l'impero austriaco. Moltke invece, rivaleggiando con Napoleone I, aveva vendicato sull'Austria l'umiliazione sofferta dalla Prussia nella campagna del 1807; nessuna guerra in nessun secolo era forse stata condotta con più chiara semplicità di disegno e più mirabile puntualità di esecuzione.
Difatti, intimato entro dodici ore il disarmo ai re di Sassonia e di Annover e all'Elettore di Assia Cassel, che nella Dieta avevano votato per la mobilitazione delle truppe federali, alle prime equivoche risposte Moltke aveva gittato i generali Vogel von Falckenstein e Manteuffel sull'Annover e di là sul Meno contro altri corpi di soldati tratti dalla Baviera, dal Würtemberg, dal Baden, dall'Assia-Darmstadt e dal Nassau, sfasciandoli al primo urto. I sassoni atterriti si ripiegavano allora sulla Boemia, ma Moltke li perseguiva con tre eserciti di circa ducentocinquantamila uomini. Tutto piegava davanti alla loro marcia: a Münchengrätz, a Nachod, a Skalitz, a Soor, ogni scontro si risolveva in una vittoria; a Gitschin i tre eserciti vittoriosi si congiungevano per la suprema battaglia scoppiata quattro giorni dopo a Königsgrätz (3 luglio). L'impero austriaco vi soccombeva per sempre, la Prussia vi si mutava in centro della nuova Germania. Napoleone III, che avrebbe voluto diplomaticamente arrestare i vincitori, non era nemmeno ascoltato: con foga irresistibile i prussiani cacciavano già gli austriaci fino sotto le mura di Vienna, e da Blumenau presso Presburgo minacciavano l'Ungheria.
Allora in Italia si comprese improvvisamente tutta la verità e la grandezza del disegno strategico suggerito da Moltke a Lamarmora dandogli la posta sotto le mura di Vienna.
Ma l'Austria, anche più vinta dell'Italia, era costretta a capitolare, accettando la propria esclusione dalla Confederazione germanica e consentendo alla Prussia le annessioni di Cassel, Nassau, Annover, Schleswig-Holstein e Francoforte; Napoleone, sopraffatto dalla politica di Bismarck e dalla strategia di [200] Moltke, s'argomentava indarno a risollevare l'impero austriaco per mantenere l'antico equilibrio europeo, e sovra di esso la propria preponderanza; ma il suo ultimo imbroglio diplomatico non concludeva più che ad una inutile umiliazione coll'Italia e ad un'inimicizia pericolosa colla Prussia.
L'imperatore d'Austria dovette bensì cedergli la Venezia perchè la rimettesse all'Italia, e così distrarre questa dalla guerra per ritentare colla Prussia una suprema rivincita o migliori condizioni di pace; ma la cessione della Venezia alla Francia dopo il disastro di Custoza era tale offesa all'Italia che nessun ministro poteva accettare. Nullameno Napoleone l'aveva resa anche più odiosa coll'inserirne l'annunzio nel Monitore francese, e mostrando all'Europa il governo italiano ridotto a meno di un governo tributario.
Lamarmora per resistere non trovò più quell'accento di alterigia cavalleresca, col quale aveva ricusato le prime proposte di tale cessione; parve dimesso al paese, sospetto alla Prussia, inabile a tutti. Quindi la sua ripresa delle ostilità, quando i prussiani incalzavano con impeto sempre maggiore i residui dell'esercito sgominato, fu tarda, inefficace e non creduta da coloro stessi che dovevano eseguirla. Il generale Cialdini all'ordine di passare il Po, mentre non era più nessun dubbio sull'esito della guerra prussiana e sulla cessione della Venezia pel tramite dell'imperatore francese, rispose con soldatesca amarezza: — È una buffonata! — Nino Bixio, il solo non vinto a Custoza, ruggì: — Siamo disonorati! — L'ammiraglio Persano invece, all'indomani della rotta di Custoza, aveva dal quartiere reale della Torre di Malimberti ricevuto l'ordine «di fare subito qualche impresa», ma restava inattivo ad Ancona sotto tutte le provocazioni della flotta nemica. In tale strana ripresa di ostilità, allorchè gli austriaci avevano già cominciato a ritirarsi, e il Cialdini si avanzava liberamente fino sotto Padova sognando di valicare le Alpi e scendere per la valle della Drava incontro all'esercito vittorioso di Moltke, quello del Mincio, [201] lasciata la divisione Nunziante all'impresa di Borgoforte, metteva il campo a Ferrara per aspettare gli avvenimenti.
Come sempre, la più onorevole guerra doveva essere combattuta da Garibaldi su per le valli del Tirolo.
Già al primo rompere delle ostilità il governo, per insano terrore di rivoluzioni, aveva limitato i novantacinquemila volontarii inscritti a soli trentacinquemila, assegnando loro Barletta a campo di formazione per tenerli lontani dal teatro della guerra. L'entusiasmo scoppiato ai primi appelli di Garibaldi si era quindi venuto agghiacciando: d'altronde i nuovi volontarii non avevano più quell'eroico spirito d'impresa, che aveva resi così originali e potenti i garibaldini della difesa di Roma e della spedizione di Marsala. Il soverchio numero di adolescenti accorsi sotto le bandiere, la scarsa uffizialità dei veterani impotenti per indole e per brevità di tempo ad addestrarli, la vecchiaia del generale costretto poi a seguire l'esercito in carrozza, un'abbondanza pericolosa di politicanti venuti per vanità di onorificenze e per seminare dissidii, sopratutto la coscienza che un'impresa anche fortunata nel Tirolo non avrebbe potuto influire decisivamente sulle sorti della guerra, infirmavano l'opera della nuova campagna garibaldina.
La quale, aprendosi per le gole dirute del Tirolo, avrebbe voluto molta sapienza di stato maggiore e perseveranza nei soldati. Invece, il merito patriottico soverchiando nella comune estimazione la conoscenza dell'arte di guerra, s'ebbero nomine a comandanti di troppi invalidi o incapaci; e si vide il Picchi d'Ancona, oramai disadatto a fazioni campali, assumere il comando di una divisione; Giovanni Nicotera, già segnalatosi buon parlamentare dopo le tragiche prove delle congiure, guidare con meravigliosa insipienza una brigata.
[202] Quella selezione naturale di ufficiali, onde è costituita tutta la forza dei corpi volontarii, mancò ai reggimenti del 1866, che esprimevano l'ibrida combinazione dell'entusiasmo del 1860 colla regolamentarità degli anni successivi. Il generale stesso, meglio atto a strappare la vittoria coll'irresistibile violenza di una improvvisazione che colla pazienza di studi tecnici, parve minore di se medesimo in questa guerra di montagna, ove la pratica dei luoghi dava ai nemici impareggiabili vantaggi, e le vittorie non bastavano a dilatare la zona d'operazione.
Al rompere delle ostilità Garibaldi non disponeva che di seimila uomini scaglionati su lunga fronte, fra i punti estremi di Tiarno in Val d'Adda e Salò sul Benaco: erano punti intermedi Edolo nella valle d'Oglio e Rocca dell'Anfo in quella del Chiese, ove dovevano concentrarsi tutte le forze volontarie. La flottiglia austriaca sul lago di Garda contava otto piroscafi con quarantotto cannoni e buoni equipaggi: quella italiana su cinque navi non ne aveva che una sola pronta, e con un solo cannone.
Le scaramucce, cominciate sino dal 22 giugno, avevano conchiuso alla fortunata occupazione del ponte del Caffaro e di Monte Suello, quando il telegramma del Lamarmora, annunziante la rotta di Custoza coll'ordine di coprire Brescia, obbligava Garibaldi a richiamare l'avanguardia e a concentrarsi su Lonato. La maggior parte dei garibaldini inerti per colpa del governo nei depositi meridionali mancavano al campo, così che una subita irruzione di austriaci avrebbe potuto costringere Garibaldi ad una ritirata peggiore di quella di Lamarmora. Ma l'indomabile condottiero, riprendendo presto l'offensiva, si reca a Salò per far uomini ed impedire che la minima flottiglia lacustre sia distrutta dai piroscafi nemici e dal primo panico prodotto dai dispacci regi; quindi, persuaso che la miglior prudenza nel triste caso è la temerità, fronteggia il nemico, lascia il generale Avezzana e la flottiglia a difendere la riva sinistra del lago, e con dodicimila [203] uomini irrompe nuovamente nel Tirolo. Il 14 luglio si drizza su Trento, ove convergeva anche il generale Medici con un'altra divisione risalendo la valle del Brenta. Il 3 luglio attacca indarno Monte Suello, ma ferito nella confusione di un panico improvviso dai propri soldati, deve cedere il comando al generale Corte; l'indomani il nemico sloggia dalle posizioni contrastate, e si occupano Bagolino e il Caffaro. La poca attitudine dei volontari a quella guerra alpestre e le armi quasi inservibili rendono difficili gli assalti: Ponte Dazio e Storo, piccolo villaggio al confluente delle valli Giudicaria e d'Ampola, cadono in mano dei volontari. Garibaldi v'impianta il quartier generale; poi, per non essere tagliato fuori da Brescia, attacca coll'artiglieria del maggiore Dogliotti il forte d'Ampola; Giovanni Nicotera per vanità di bravura s'inoltra, disobbedendo, sino al ponte del Chiese, ma è respinto in isbaraglio; nullameno il forte d'Ampola capitola, e la via di Val di Ledro rimasta aperta permette di stendere la testa della colonna sino a Tiarno e a Bezzecca. Infatti Garibaldi con rapido movimento a destra per Val di Ledro mirava a proteggere la giunzione del 2º reggimento ingolfatosi a rovescio degli ordini per Monte Nota verso Pieve; il 10º reggimento marciava per Val Testina a salirne la giogaia e discendere per Val Lorina su Ampola. Intanto il nemico con viva prontezza aveva riunito da seimila uomini nella valle di Conzei e, scendendo su Bezzecca per impedire la giunzione del 2º reggimento, ricacciava il battaglione Martinelli fin dietro le sue mura (21 agosto): ma Garibaldi vi fa testa, risospinge il nemico, lo sbaraglia dopo sanguinosa giornata. La valle Giudicaria dopo altri combattimenti fortunati di Fabrizi a Condino, è già sgombra, il forte Ledro sta per capitolare, il generale austriaco Kuhn si ripiega frettolosamente sul Tirolo tedesco, e Garibaldi marcia già sopra Riva quando l'annunzio dell'armistizio sottoscritto lo arresta.
Era la fine.
Infatti anche la flotta comandata da Persano aveva già col più doloroso disastro tolto ogni onorata speranza alla guerra.
Questi, rimasto lungamente inoperoso in Ancona assordando di querimonie il governo per difetto o di cannoni, o di carbone, o di macchinisti, mentre il suo avversario Tegethoff osava il 27 giugno inoltrarsi sino a due chilometri dalla città per sfidarlo a battaglia, non solo aveva ricusato la sfida, ma, dissuadendo i capitani con ignobili pretesti da ogni animoso consiglio, si era poi vantato al ministero di aver costretto il nemico a ritirarsi. E il ministro Depretis, credendo al vanto inverecondo, aveva consigliato più lunga attesa insino a che l'esercito del Po riprendesse l'offensiva. Naturalmente ciurme e capitani si demoralizzavano in questa inazione: la codardia dello ammiraglio, oramai nota anche ai mozzi, finiva di prostrare gli animi più saldi.
Il Lamarmora invece, combattuto fra il proprio coraggio di soldato e la inevitabile remissività di ministro, urgeva l'ammiraglio di consigli per una pronta azione contro la flotta nemica, ma proibendogli di minacciare Venezia o Trieste, l'una perchè già ceduta, l'altra perchè la Dieta germanica vi manteneva ancora pretese. Così la guerra, ridotta ad inabile torneo, scivolava in una sanguinosa commedia. La stessa riserva aveva impedito al generale Medici, malgrado le istanze del Ricasoli ripetente con orgoglio l'antico motto del Lamberti «cosa fatta capo ha», di spingersi come avrebbe potuto su Trento prima ancora che Garibaldi minacciasse Riva.
Il Persano, incalzato da tutte le parti, salpò finalmente da Ancona l'8 luglio per ritornarvi dopo cinque giorni d'inutili volteggi: quindi, minacciato di destituzione, ne salpò nuovamente per l'impresa di Lissa, isola montuosa a scirocco d'Ancona sul 43º parallelo [205] con un circuito di 30 chilometri, fortilizi, torri, e una rocca così forte da meritarle il nome di Gibilterra dell'Adriatico. Invano il vice-ammiraglio Albini lo sconsigliò dall'impresa militarmente insensata: il Persano vi si ostinò due giorni, e vi fu sorpreso la mattina del 20 luglio dalla squadra nemica. Allora, reso pazzo dalla paura, dopo aver ordinato su due file distanti l'una dall'altra mille metri i propri vascelli, abbandonò la nave ammiraglia Re d'Italia per riparare sull'Affondatore, grossa corazzata comprata dal governo in America e allora creduta invincibile, sulla quale fece inalberare il pennone di vice-ammiraglio. Così la flotta senza ammiraglio non ebbe più comandi, e la battaglia degenerò in tanti duelli navali. Faà di Bruno, capitano del Re d'Italia, dopo strenua difesa, sentendo il proprio vascello orrendamente squarciato affondare, s'uccise con un colpo di pistola; Alfredo Capellini, capitano della Palestro incendiata, mise in salvo malati e feriti, e si votò con tutto l'equipaggio alla morte sparendo sublime di disperazione in un incendio di gloria.
La battaglia era perduta, ma l'onore del nome italiano era salvo.
L'ammiraglio chiuso nelle torri del suo «monitor» non aveva veduto nulla; poi, a combattimento finito, mentre l'armata austriaca stava ordinata davanti al canale di Lissa, e alcuni fra i più valenti capitani gli consigliavano non imprudentemente di tentare una riscossa, vi si ricusò dichiarandosi vincitore per essere ancora padrone delle stesse acque.
La notizia della vittoria, complice il ministro Depretis, corse per tutta l'Italia a rendere ridicolo un disastro nobilitato dall'eroismo di Faà di Bruno e di Alfredo Capellini.
L'ammiraglio Persano fu più tardi condannato dal senato costituitosi in alta corte di giustizia; il ministro Depretis potè invece, coll'avvento della sinistra al potere, diventare presidente del consiglio e morire all'indomani di un'altra catastrofe militare, in Africa, provocata dalla sua insipienza.
L'intervento napoleonico dopo la grande vittoria prussiana di Sadowa precipitò le sorti della guerra, giacchè tutta Germania, sollevatasi contro tale intromissione straniera, permise a Moltke di stringere più da presso il nemico. In Italia invece il governo piegò, quantunque il Lamarmora per onestà cavalleresca ricusasse di trattare primo di pace coll'Austria abbandonando l'alleato: ma le ostilità riprese senza vera intenzione di guerra non mirarono che ad occupare il terreno già consegnato dall'Austria nelle mani di Napoleone. A convincerne anche i più restii il principe Girolamo Napoleone venne tosto al campo di Ferrara per stringere gli ultimi accordi con Vittorio Emanuele, e il Grandguillot, altro diplomatico confidente di Napoleone, fu mandato a Firenze presso il Ricasoli ripugnante alla nuova vergogna.
In tutta Europa una satira spietata mordeva il nome italiano: Austria, Prussia, Francia, persino l'amica Inghilterra, vilipendevano l'Italia mostratasi alla prima guerra nazionale ancora più inetta che non nella secolare servitù: le si rinfacciava l'inanità di tutte le sue rivoluzioni anteriori, le vittorie francesi del 1859, gli stessi miracoli dell'epopea garibaldina nel 1860 siccome compiuti da un pugno di eroi contro gli ordini del governo e l'opinione di tutti: il nome di Machiavelli, infame di codarda perfidia nel gergo delle scuole, era la definizione della nuova Italia; si compiangeva Garibaldi moschettato ad Aspromonte ed ora relegato fra le rocce del Tirolo, non si credeva più all'onestà di Lamarmora, non si trovavano confronti per la ritirata di Custoza e la rotta di Lissa. Le fulminee vittorie della Prussia rendevano anche più umiliante il giudizio sull'Italia. Il governo di Firenze non somigliava neppur lontanamente a quello di Torino, quando il conte di Cavour vi preparava l'egemonia piemontese.
[207] La publica opinione italiana, anzichè reagire contro sì terribili accuse, le inveleniva: tutti sentivano che quella prima guerra nazionale aveva deciso dell'onore della patria, e che l'onore era macchiato; nessun eroismo individuale bastava più a salvare la nazione. Nell'impeto magnanimo e partigiano dello sdegno si gettava naturalmente la responsabilità sopra pochi: si gridava che Lamarmora aveva patteggiato la sconfitta, che la corte aveva tradito il paese.
Intanto la Prussia, persuasa che l'Italia non andrebbe militarmente oltre i limiti assegnati dalla cessione della Venezia alla Francia, dopo aver risposto a Napoleone colla minaccia di una seconda guerra sul Reno, il 22 luglio segnava un armistizio coll'Austria, e quattro giorni dopo segnava a Nikolsburg i preliminari della pace. Gli articoli di questa dicevano: scioglimento della Confederazione germanica e assenso dato dall'Austria a un nuovo assetto politico della Germania senza di essa; costituzione degli stati tedeschi al nord del Meno in una confederazione sotto la direzione militare e politica della Prussia; facoltà negli stati del sud di confederarsi conservando la loro autonomia; annessione alla Prussia dei ducati dell'Elba, dell'Annover, dell'Assia-Cassel e Nassau; conservazione e integrità dell'impero austro-ungarico ad eccezione della Venezia. In un articolo separato il re di Prussia si faceva mallevadore dell'adesione del governo italiano all'armistizio e alla pace, tosto che il Veneto fosse per una dichiarazione dell'imperatore dei Francesi messo a disposizione di Vittorio Emanuele.
La Prussia, guarantendo l'adesione del governo italiano, non aveva degnato nemmeno d'interrogarlo.
Quindi l'Austria, imbaldanzita subitamente contro l'Italia, le negò per l'armistizio la concessione dell'uti possidetis, già consentita nelle prime trattative con Napoleone; nuovi corpi d'esercito si drizzarono minacciosamente sul Veneto, si parlò di una seconda guerra fra l'Austria e l'Italia. Sarebbe stata la rivincita per l'Italia e la riconquista di tutto il suo territorio, se [208] nella nazione l'entusiasmo guerriero avesse potuto costringere il governo a più risoluto atteggiamento: questo invece piegò un'altra volta alle ingiunzioni austriache. Si ordinò a Garibaldi, unico vincitore, di sgombrare il Tirolo; e Garibaldi, condensando tutta l'amarezza del proprio patriottismo in una sola parola, rispose: «Obbedisco». Spirato il secondo armistizio, ne venne segnato un terzo a Cormons (12 agosto) di quattro settimane, durante il quale fu sottoscritta a Praga la pace fra Austria e Prussia, e a Vienna la cessione formale della Venezia alla Francia colla condizione che il debito publico delle provincie lombarde comprese nel Veneto fosse liquidato secondo il trattato di Zurigo.
In tanto vilipendio di se stesso il governo aveva invano cercato di migliorare le condizioni del trattato col chiedere «che le discussioni per le ratifiche dei confini fossero riserbate alle trattative della pace», giacchè tale allusione al Tirolo meridionale venne subito respinta dalla Francia e dalla Prussia.
Napoleone, per la vanità di figurare arbitro nella grande contesa, non si accorgeva di offendere mortalmente l'Italia colla propria mediazione; Vittorio Emanuele, che aveva serbato dignità nell'abbandono di Villafranca, s'arrese questa volta prontamente, ma il Ricasoli resistette fino all'ultimo, e non cedette che al pericolo di una vergogna maggiore. Infatti i veneti, inerti durante tutta la guerra, chiedevano ora ad alte grida di venire accolti nel regno minacciando di costituirsi in stato indipendente sotto la protezione della Francia: sottoscrizioni coperte di molte ed illustri firme viaggiavano a Parigi per sollecitare l'imperatore alla ricostituzione dell'antico stato veneto.
Nel Tirolo invece la popolazione non solo non si era sollevata, ma aveva strenuamente combattuto contro i garibaldini con ventidue centurie di cacciatori indigeni sotto gli ordini del generale Kuhn.
La stipulazione della pace fu lunga e laboriosa. L'Austria, malgrado la dichiarazione di liquidare il debito [209] delle provincie cedute a norma del trattato di Zurigo, esigeva altri 36 milioni di fiorini come loro quota proporzionale dei debiti da essa contratti dopo tale trattato: per gli uffici di Francia e di Prussia si potè venirne a capo, ma si dovette abbandonarle nella questione delle frontiere la linea dell'Isonzo ed accettare quella dei confini amministrativi. Così l'Italia, senza frontiere verso la Francia dopo la cessione della Savoia, non ne ebbe contro l'Austria, che ad una nuova guerra avrebbe potuto riprendersi il Veneto colla massima facilità. Finalmente il 3 ottobre fu sottoscritto a Vienna il trattato di pace: per esso l'Italia si addossava un debito di 99 milioni, e l'imperatore d'Austria con tarda cortesia rimetteva al re d'Italia la corona ferrea trafugata nel 1859; i sudditi veneti addetti al servizio dell'impero ebbero facoltà di rimpatriare conservando gradi e stipendi presso il nuovo governo; furono resi gli archivi della republica veneta, ma quasi a memoria insolente della lunga conquista restituita non perduta, l'Austria si ritenne i palazzi di Roma e di Costantinopoli già appartenenti alla republica.
Eseguite tutte le ratifiche, il generale Leboeuf, commissario per l'imperatore Napoleone III a Venezia, dichiarò di consegnare a se stesso il paese, affinchè il popolo manifestasse liberamente la propria volontà di aggregarsi alla nazione italiana: dopo tale dichiarazione il generale Aleman cogli avanzi del presidio austriaco s'imbarcava per Trieste. I comizi plebiscitari tenuti il 21 e il 22 diedero 647,246 sì per la fusione col regno costituzionale di Vittorio Emanuele contro soli 69 no.
E quasi a così triste pace mancasse ancora un anacronismo, Vittorio Emanuele con serotina vanità di re savoiardo volle ricevere gli oratori veneti piuttosto a Torino che a Firenze, per affermare contro il concetto della cresciuta italianità la nuova conquista regia.
Il difficile problema veneto, che nessuna delle due politiche italiane era bastata a disciorre con forze proprie, si era risolto coll'intervento di un'altra grande [210] rivoluzione europea inspirata dal medesimo principio di nazionalità. Ma la giovane nazione vi aveva fatto una prova ben dolorosa della propria incapacità. Monarchia e rivoluzione, unite momentaneamente nell'accordo migliore, non avevano saputo trovarvi più le eroiche energie dei loro primi momenti, quando il conte di Cavour col piccolo Piemonte osava la spedizione in Crimea, o Garibaldi, contro l'opinione di questo, arrischiava l'impresa dei Mille. Il soffio epico, che aveva reso ammirabile il partito rivoluzionario nella ricostituzione della patria, era cessato coll'avvento delle masse alla nuova vita publica, mentre il governo caduto nel più tristo vassallaggio francese vi aveva smarrito col senso dell'antico orgoglio savoiardo la dignità di nuovo regno italiano. La potenza collettiva della monarchia e della rivoluzione in quell'incerta fusione di elementi ancora troppo eterogenei era riuscita minore della loro autonoma potenzialità.
Nell'esercito, altrettanto grosso di numero che fiacco d'organismo, si era rivelata specialmente l'impotenza della nazione. Il governo, costretto da una politica antipatriottica all'equivoco di Sarnico, alla tragedia di Aspromonte, alla resa della Convenzione di settembre, rispecchiava sciaguratamente nella propria insufficienza quella anche maggiore del parlamento; la nazione non migliore nè dell'uno nè dell'altro finiva colla propria passività ad imporre loro quella medesima politica, della quale ora il danno e il disonore l'offendevano.
La nuova guerra aveva abbassato l'Italia. Il piccolo Piemonte, abbandonato a Villafranca, aveva dovuto subire nel 1859 la pace coll'Austria, ma dopo aver combattuto a fianco dei francesi con pari valore; e la sua spedizione in Crimea, i suoi trionfi diplomatici, la fine alterezza della sua politica negli anni anteriori, le intrepide iniziative, tutto deponeva in suo favore. L'Italia, con un esercito maggiore di quello austriaco, con un numero di volontari che avrebbe potuto raggiungere i centomila, con una flotta doppia dell'inimica, [211] senza i pericoli interni, con un alleato capace di prostrare da solo l'impero austro-ungarico in sette giorni: l'Italia vinta a Custoza, sconfitta a Lissa, accettante la Venezia dalle mani di Napoleone, doveva fatalmente decadere nel concetto dell'Europa, che in questo secolo aveva veduto le insurrezioni di Spagna e le ribellioni di Grecia, e vedeva ora la rivoluzione della Germania organizzata nel più ammirabile capolavoro del genio di Bismarck.
Bisognava quindi all'Italia riconcentrarsi nel silenzio di un'altra migliore preparazione. Ma finchè il periodo rivoluzionario, aperto colla guerra franco-sarda, non si conchiudesse con la conquista di Roma esaurendo la propria generazione, era impossibile sperare nella immobilità dei suoi dati politici un rialzo nella coscienza nazionale.
Comunque ricomposta, l'Italia era troppo importante alla generazione del suo risorgimento perchè questa ardisse avventurarla nel pericolo di una più nobile politica.
Si era appena sottoscritto il trattato di pace a Vienna, e nella Venezia si preparavano già febbrilmente le feste plebiscitarie, che un'altra reazione brigantesca scoppiava a Palermo.
Forse il nuovo discredito del governo contribuì ad accelerarne l'esplosione.
I nuovi metodi politici di centralizzazione violavano troppe tradizioni, specialmente nelle provincie meridionali, separate dal resto del regno da lunga distanza di periodi civili, per non produrvi un vivo malcontento. La coscrizione militare, la moltiplicità grandinante delle tasse, la soppressione delle corporazioni monacali, vi irritavano tutte quelle passioni piuttosto compresse che soffocate dalla guerra spietata contro il brigantaggio. La stessa epopea garibaldina, che sugli albori della rivoluzione vi aveva infiammato la fantasia delle moltitudini, non era più per esse che un ricordo di lontane vittorie dopo la catastrofe di Aspromonte.
Una mortificazione d'indefinibili speranze inaspriva i dolori di una cronica miseria, alla quale il governo non aveva potuto sino allora che domandare sacrifici. Le vanità tradizionali dell'autonomia duravano ancora nell'isola, la lunga reazione brigantesca del Napoletano, cresciuta quasi a guerra civile, vi sostituiva lentamente [213] nelle immaginazioni la magnifica teatralità delle imprese garibaldine: tutto e tutti contribuivano a preparare una nuova ribellione, la plebe delle campagne colla brutalità, quella cittadina coll'abbiettezza, la borghesia coll'avarizia, il patriziato colla superbia e coll'ignoranza, il clero colla superstizione e colla perfidia.
Il governo, ancora sotto il peso delle ultime umiliazioni, non solo non s'accorgeva del nuovo pericolo, ma, avvisatone dai propri funzionari, temeva di raddoppiarlo mostrando di premunirsi.
La reazione brigantesca esplose naturalmente a Palermo, ove le velleità di autonomia rifermentavano ad ogni coazione dell'unità contro l'egoistica indipendenza regionale. La rivolta fu breve, ma violenta, facinorosa, incredibile di odio e di insania. Già profittando della guerra nel Veneto, per la quale tutti i presidii delle città erano stati ridotti al minimo, dalle congiure sordamente riprese all'indomani dell'annessione si era venuti alle bande armate: mancava un disegno, un uomo, una bandiera. Non si sapeva neppure chiaramente lo scopo della rivolta; non vi erano intese con altre regioni, non accordi diplomatici, non vera preparazione di guerra. Ma un odio indefinibile riuniva tutte le classi contro il governo: si sognava di autonomia senza il coraggio di precisarla nemmeno come sogno: si moltiplicavano i pretesti alle ribellioni traendoli da ogni novità. Il brigantaggio napoletano era stato una reazione legittimista: la reazione siciliana doveva essere un malandrinaggio senza aspirazione nè al passato nè all'avvenire.
Il 16 settembre (1866) le bande armate aggirantisi da molte settimane sui monti si raccozzarono improvvisamente ed entrarono a Monreale mettendo a rumore la città: quindi irruppero su Palermo, ne sollevarono la plebaglia, ne asserragliarono le vie, vi assediarono nel palazzo il prefetto Torelli colla poca truppa accorsa a difenderlo, e composero un governo provvisorio. Parve, ed era il rovescio della conquista dei Mille. [214] Tutta l'isola ne fu commossa, ma per mancanza di un disegno e di una bandiera il moto non potè espandersi. Il governo, che alle istanze reiterate del prefetto non aveva voluto accrescere il presidio della città ridotto a 3500 uomini, dovette quindi mandare su Palermo il generale Cadorna con grosso nerbo di truppa per soffocarvi la guerra civile. L'orribile tumulto durò sei giorni: la vittoria rimase naturalmente al governo, ma il combattimento fu indescrivibile di ferocia e grande la strage: si dovette riconquistare ogni via, ogni casa; dai conventi mutati in fortezze frati e monache combattevano per gli insorti; la plebaglia, che non aveva seguìto Garibaldi nel 1860, si ostinava adesso con atroce temerità contro l'esercito regolare. Di questo perirono nella mischia quasi cento soldati e trecento furono feriti; degli altri non si volle fare il conto perchè sarebbe stato troppo difficile e vergognoso.
L'ordine fu ristabilito. Gli autonomisti, che avevano mestato nella congiura e fornito le bande, spaventati essi medesimi dalla truce anarchia, riaderirono prontamente al governo. Per prudenza politica questo non volle indagare nè le vere origini, nè quali fossero i maggiori colpevoli della rivolta.
Nelle provincie napoletane più infette dal brigantaggio quel moto siciliano non ebbe ripercussione: con esso finì la reazione meridionale separatista.
Il gabinetto Ricasoli, già indebolito dai disastri della guerra, ne ricevette un colpo mortale.
Le illusioni create nei più ingenui di parte moderata dalla Convenzione di settembre dovettero dissiparsi alle nuove dichiarazioni di Napoleone III, che ritirando momentaneamente il presidio da Roma non intendeva assumere altri impegni per l'avvenire. Il sacrificio del diritto nazionale consumato dal governo per eliminare i francesi da Roma, nella speranza di potervi un giorno entrare dietro qualche imprevedibile [215] avvenimento, tornava quindi inutile dopo questa minaccia di altro intervento. Infatti non appena l'esercito regolare francese si fu ritirato da Roma, una grossa mano di finti volontari racimolati fra esso vi rientrava a costituire una legione, chiamata poi dal nome di Antibo e salutata dal generale francese Dumont, venuto da Parigi a passarla in rivista, come nuova legione tebana.
La teorica cavouriana della conquista di Roma con mezzi morali, infelicemente interpretata da' suoi successori, sembrava finire nel più doloroso ridicolo, ora che l'ottenuta soluzione del problema veneto rendeva più urgente quella della questione romana. Si comprendeva da tutti che là stava il principio della rivoluzione italiana e la sola possibile rivincita degli errori e delle umiliazioni patite dal periodo delle annessioni sino allora. Bisognava a qualunque costo forzare Roma, per dare all'Italia colla sua capitale storica una vera coscienza di nazione.
Ricasoli vi si accinse: ma come all'indomani della Convenzione di settembre il Lamarmora aveva deputato a Roma il Vegezzi, così egli vi mandò il Tonello per trattare delle sedi vescovili vacanti. Poi, lusingato dalla nomina di due prelati liberali alle chiese metropolitane di Torino e di Milano, si spinse oltre sulla via di una conciliazione. Il concetto suo e dei partigiani neo-guelfi era d'indurre il papa ad una spontanea rinuncia del potere temporale, largheggiando siffattamente con lui di concessioni nella politica ecclesiastica da assicurargli un'immensa preponderanza sulla vita civile. A scusa di questo disegno s'invocava la necessità di liberarsi dalla Francia col ridurre la questione romana ad un problema di ordine interno, giacchè ottenere Roma colle armi non si poteva. Ma un errore più profondo si nascondeva in quest'idea, ed era la soggezione del pensiero civile al pensiero religioso con questo riconoscimento della suprema autorità cattolica come fonte di tutti i diritti regii, e colla negazione del principio rivoluzionario il quale non aveva [216] altra originalità dal disconoscimento della supremazia religiosa in fuori. La libertà di pensiero, conquistata religiosamente dalla Riforma e civilmente dalla rivoluzione francese, sarebbe stata così sconfessata dalla rivoluzione italiana. Era l'ultima riapparizione dell'idea giobertiana del Primato: ma la vasta utopia del filosofo piemontese non riusciva nella politica del gabinetto di Firenze che a mascherare i pregiudizi della corte incapace di concepire la propria autorità senza sanzione religiosa, e cercante nella forte compagine del cattolicismo un baluardo contro i flutti della rivoluzione.
Intanto il ministero aveva già firmato la convenzione finanziaria derivata dalla Convenzione di settembre, e per la quale l'Italia assumeva il debito delle provincie pontificie annesse senza nemmeno chiedere la libertà di quei cittadini italiani che, come il bolognese Petroni, da quindici anni soffrivano nelle carceri romane. Nullameno il governo francese, per quel brutto vizio di aggiungere sempre al danno lo scorno, non fidandosi nè alla firma reale nè all'onore della nazione, aveva forzato il gabinetto a deporre venti milioni nella Cassa-depositi a Parigi.
L'occasione ai nuovi tentativi di accordi con Roma venne dalla legge sull'alienazione dell'asse ecclesiastico, che lo Scialoia, reggente allora il portafoglio delle finanze, doveva presentare alle Camere. In essa, poi giustamente definita una singolare mistura di santimonia neo-guelfa e di speculazione bancaria, si rimetteva nelle mani dei vescovi, se volessero accettarla, la vendita dei beni del clero nel termine di dieci anni, e la conversione del ricavato, e l'amministrazione e la distribuzione delle rendite agli usi del culto e al mantenimento delle persone, salvo il pagamento di 600 milioni di lire italiane allo Stato in rate semestrali di cinquanta milioni l'una, quasi per quota-parte delle appartenenze della società laica nella destinazione di tali beni. Era assuntore della vasta operazione [217] bancaria il banchiere belga Langrand-Dumonceau di parte ultramontana.
Contemporaneamente i nuovi diplomatici mandati a Roma offrivano al pontefice per parte del governo italiano la rinunzia alla presentazione dei candidati alle sedi vescovili e alle guarentigie tradizionali del placet, dell'exequatur e del giuramento.
L'abbandono di queste viete riserve della sovranità regia contro l'autorità ecclesiastica, logico secondo i principii della rivoluzione, pei quali ogni religione nello stato non deve essere che un'opinione perfettamente libera come tutte le altre, diventava nelle intenzioni e nel fatto di tale politica un privilegio alla chiesa romana, che col maneggio dell'alienazione e della disposizione del patrimonio ecclesiastico si sarebbe costituita centro di enorme clientela, esercitando la più sconfinata influenza specialmente coll'elettorato ristretto d'allora.
Gregorio VII, il fiero tribuno del papato, non avrebbe potuto chiedere di più. Fortunatamente la stessa legge storica della decadenza nel papato impedì alla corte romana di accettare l'improvvida offerta: la Camera, malgrado il bigottismo monarchico-religioso della propria maggioranza, respinse il progetto Scialoia, contro cui si levavano proteste specialmente dalle provincie venete: quindi Ricasoli, violento d'orgoglio, ottenne dal re lo scioglimento della Camera, ma le elezioni essendoglisi chiarite avverse dovette dimettersi.
Durante la lotta di queste, Garibaldi, dietro consiglio della sinistra parlamentare, si era recato sul continente per pubblicarvi un manifesto politico sull'urgenza di conquistare Roma all'Italia colle vie legali, ed aveva percorse tutte le provincie venete arringando i popoli inutilmente: la nuova Camera, da lui sognata tutta piena di rappresentanti decisi a sciogliere magari con una guerra nazionale alla Francia il problema di Roma, risultò invece poco diversa dalle altre, sebbene ostile al ministero.
Col ritorno del Rattazzi al potere doveva svolgersi in un ultimo equivoco della politica monarchica il supremo tentativo rivoluzionario per la conquista di Roma.
Difetti e qualità rendevano il nuovo ministro singolarmente adatto alla tragica avventura. La sua prontezza così a sedurre come a lasciarsi sedurre da grandi imprese, trovando sempre in un tradimento finale la soluzione ad un intrigo divenuto inestricabile, faceva di lui egualmente sperare e temere. Lo si sapeva infatti giacobino contro il papa e cortigiano con Vittorio Emanuele, ligio a Napoleone e avverso alla destra, compromesso colla sinistra e odiato dal popolo; ma così abile parlamentare e scaltro diplomatico da reggersi nelle più difficili situazioni non ostante lo squilibrio dell'ingegno.
La sua presenza al ministero, anzichè rinfocolare gli odii di Aspromonte, parve quindi al partito d'azione arra di più coraggiose e feconde iniziative.
Roma, ritornata colla partenza del presidio francese in signoria di se medesima, mutava apparentemente le condizioni del proprio problema politico. Se infino allora le sarebbe stato difficile ogni moto rivoluzionario, giacchè il governo pontificio denunciandolo come tumulto plateale avrebbe avuto, a schiacciarlo, irresistibile concorso dalle truppe francesi, ora non trovandosi sopra altri nemici che i pochi mercenari papalini poteva senza troppa difficoltà e con molta speranza di buon successo, levarsi a rivoluzione. La Convenzione di settembre, coll'assicurarle il reciproco non intervento della Francia e dell'Italia, le lasciava tutto il merito della iniziativa. Malgrado le compromissioni di Napoleone col clero francese, difficilmente ad una spontanea rivoluzione dei romani egli avrebbe potuto allora, nel rifermentare delle passioni republicane a Parigi, ripetere la spedizione del 1849; quindi [219] l'Italia invocata liberamente da Roma avrebbe risposto occupandola colle proprie truppe. L'impero buonapartesco, prima di scendere ad una guerra contro l'Italia, avrebbe dovuto pensare seriamente alla posizione fattagli in Europa dalla rivalità della Prussia.
Era questa l'idea di Mazzini e da lui eloquentemente sua indarno predicata ai romani.
Poco segreti e meno efficaci si adoperavano in Roma tre comitati liberali, moderato l'uno, mazziniano il secondo, garibaldino il terzo. Il primo sottoposto agli ordini del governo italiano badava piuttosto ad impedire che altri facesse che a fare, giustificando tratto tratto la propria esistenza con dimostrazioni puerili contro il papa; il secondo, impegolato nelle formule mazziniane, riusciva ad un'accademia; l'ultimo, combattuto con diverse intenzioni ma pari accanimento da entrambi, rimaneva impotente all'azione malgrado la praticità dei propri propositi.
Mancava sopratutto il denaro. Mazzini se ne arrovellava senza poter intendere questa avarizia della nazione, nella quale Garibaldi aveva trovato seguaci pronti a morire sotto le sue bandiere piuttosto che oblatori capaci di sacrificare somme anche tenui alle sue imprese. Nullameno si riordirono le file di una più vasta congiura, dacchè il ministero sembrava favorirla. Comitato moderato e garibaldino si accordarono in Roma; dal Regno si mandavano aiuti, il governo papale vegliava denunciando i complotti all'ambasciata francese, ma senza temerne davvero per troppo esatta conoscenza delle persone e dei mezzi. Il ministero Rattazzi, lusingato dalla possibilità di una nuova guerra europea, si cacciava risolutamente nel più cieco degli imbrogli politici: una guerra era discussa a corte, invocata come rivincita dall'esercito, suggerita dalle condizioni dell'impero buonapartesco. Il caso ne poteva venire dalla non osservanza dell'articolo 5º del trattato di Praga da parte della Prussia, e allora per l'impero le alleanze sarebbero state in Italia [220] e nella Germania del sud minacciata di assorbimento dalla nuova Confederazione del nord. L'Italia avrebbe potuto essere egualmente o colla Francia o colla Prussia. Ma se a questa guardava, per odio contro Napoleone, il partito rivoluzionario incline a fidarsi piuttosto del franco dispotismo del conte di Bismarck, col quale Mazzini aveva già aperte trattative, corte e governo per tradizioni e per opinione rimanevano fedeli alla Francia. Non si credeva allora ad una possibile disfatta dell'Impero francese; bisognava quindi destreggiarsi per vendere al miglior prezzo e al più solvibile offerente la propria alleanza. Così mentre il Vaticano con più sicuro senso della realtà calcolava sull'influenza del clero francese, giovandosi del bigottismo fanatico dell'Imperatrice Eugenia e della regina spagnuola Isabella, Rattazzi alle rimostranze del gabinetto francese sui raggiri rivoluzionari contro Roma rispondeva publicamente di voler rispettata la Convenzione di settembre, e segretamente tentava di sollevare la Spagna per mezzo di un pronunciamento militare col generale Prim, e dava denari per una spedizione rivoluzionaria contro Orvieto.
Nel suo disegno semplice malgrado i troppi viluppi era idea principale suscitare moti a Roma e nel regno fingendo frenarli, e magari frenandoli ove eccedessero, per costringere Napoleone a cedere Roma all'Italia come pegno d'alleanza. Senza compensi infatti l'Italia non avrebbe potuto accettare il nuovo peso di un'alleanza francese contro la Prussia per una guerra, della quale era impossibile calcolare le catastrofi.
Le trattative perplesse e subdole d'ambo le parti non chiarivano condizioni; si accennava ad una occupazione del resto dello stato pontificio facendo di Roma una specie di città anseatica, e ad un altro trasporto della capitale a Napoli.
Ad ogni modo Rattazzi sperava in una qualche mutazione; ma tenuto in freno dalla corte e dal parlamento, sospetto ai liberali e non abbastanza risoluto egli medesimo, male dominava le contraddizioni [221] del proprio disegno. La Francia colla formazione della legione d'Antibo, nella quale i soldati conservavano il giuramento di fedeltà all'imperatore e i libretti dell'esercito francese, non solo violava la Convenzione di settembre, ma subendo le pressioni del proprio clero guidato dal vescovo d'Orléans, monsignore Dupanloup, era costretta ad insultare l'Italia con affermazioni bellicose in favore del papato. Laonde il ministero Rattazzi ne perdeva credito presso il partito rivoluzionario, e la publica opinione si confondeva.
Garibaldi invece, già dimentico di Aspromonte, da Ginevra ove era accorso al congresso della pace per dichiararvi con Bakunine, Büchner, Pietro Leroux, Edgardo Quinet, Stefano Arago, ed altri maggiori democratici d'Europa la decadenza del potere temporale, parlava di guerra e la preparava. Quindi coll'impeto della propria natura di condottiero, non appena ritornato in Italia, vi aveva aperti arruolamenti, e s'aggirava fremendo sulla frontiera papalina. I suoi proclami ai romani erano così espliciti, e la sua azione così libera nel regno, che tutti necessariamente vi sentivano la complicità del ministero. Da comizi popolari a Milano, a Genova, a Firenze, a Napoli, sorgeva minaccioso il grido: a Roma!; il contagio guadagnava l'esercito regolare, la situazione si tendeva talmente che uno scoppio diventava inevitabile. Garibaldi, malgrado l'immutata fedeltà alla propria formula Italia e Vittorio Emanuele, per placare i più intransigenti fra i cospiratori del centro romano d'insurrezione, aveva questa volta ripreso il titolo di generale della republica romana.
Una grande illusione involgeva tutta la politica di quell'ora, ma in realtà Roma era impreparata. Le poche armi raccoltevi erano state sequestrate, un tentativo del comitato mazziniano di Genova per introdurvene altre aveva fallito; i varii comitati vi si combattevano tristamente, il ministero Rattazzi era costretto a frenare qualunque spedizione al di fuori, poichè dentro di quella nessuna insurrezione scoppiava [222] a giustificarla; mentre Garibaldi insofferente d'indugio anelava epicamente a morire sotto le sue mura se ogni vittoria fosse negata, e l'Italia non ostante il nuovo fermento di volontari era tutt'altro che disposta ad una guerra eventuale colla Francia.
Mazzini, reso più chiaroveggente dall'odio alla monarchia, sconsigliava invece dall'impresa scoprendovi l'agguato teso dal ministero alla rivoluzione. Infatti se la Francia avesse consentito la spedizione, ed era impossibile, la monarchia vi ripeterebbe come a Napoli il proprio intervento colla scusa di salvare il papa dalla demagogia e s'insedierebbe a Roma; se la spedizione fallisse, e la Francia scendesse con un corpo d'esercito a difendere il papato, la monarchia assisterebbe impassibile all'ecatombe dei garibaldini. In ambo i casi per Mazzini la rivoluzione era perduta. Laonde, cercando in Roma una iniziativa per l'Italia, egli dichiarava che, se quella dovesse venire aggregata come il resto al Piemonte, preferiva rimanesse del papa per altri tre anni. «O fare a danno della monarchia o non fare» era adesso il suo motto.
L'urgenza di tale iniziativa republicana lo spingeva sino a rampognare coloro che si arruolavano con Garibaldi, e a consigliare loro l'insubordinazione o la diserzione, appena entrati nello stato pontificio, per gridare la republica. La sua antica vanità di capitano, ancora sotto il peso della sciagurata spedizione in Savoia, s'irritava contro questa suprema imprudenza di Garibaldi, che avrebbe perduto l'Italia per rendere un servigio alla monarchia. Quindi sognava di sbarcare egli stesso con altri mille e con bandiera republicana sopra un punto della costa romana, ora che tutti esitavano ancora, e superando tutti resuscitare nella grande città la republica del '49.
Intanto i volontari arruolati publicamente nelle città e mandati in truppa ai confini vi si irreggimentavano.
Il governo publicava minacce e lasciava espandersi il moto. Quasi tutti i maggiori rivoluzionari dissuadevano [223] Garibaldi dall'impresa. Acerbi, Crispi, Mario, Fabrizi gliene illustravano con terribile evidenza i pericoli e gli equivoci; ma egli si ostinava sublimamente muto, vincendo la loro ragione col fascino della propria volontà. Nella infallibilità dell'istinto egli solo sentiva che la rivoluzione doveva a se medesima, dopo la inonorata conquista monarchica del Veneto, un supremo tentativo su Roma, alla quale la monarchia aveva abdicato colla Convenzione di settembre e il trasporto della capitale a Firenze. Sulle condizioni dell'impresa la sua vecchia esperienza s'ingannava ancora meno di quella degli altri rivoluzionari, quantunque la nobile speranza di trascinare con questa iniziativa Vittorio Emanuele in campo lo illudesse ancora. Ma la rivoluzione non poteva, come la monarchia, rinunziare a Roma sotto pena di rendere ridicola la tragedia di Aspromonte: la morte di Garibaldi e una ecatombe di garibaldini sotto le mura di quella per mano dei francesi avrebbe invece staccato per sempre l'Italia da Napoleone, e resa inevitabile la guerra al papato.
Garibaldi voleva morire. A mezzo settembre (1867) Giovanni Nicotera era già a capo di una colonna mirante su Velletri; Menotti Garibaldi col corpo centrale dei volontari si teneva pronto a marciare su Monterotondo; Acerbi con l'ala destra minacciava Viterbo; e Garibaldi scorreva la frontiera attendendo da Roma un segnale d'insurrezione, pronto a varcarla anche senza di questo. Ma il ministero, stretto dalle minacce francesi, decide di arrestarlo quantunque deputato e violando lo statuto: ad Arezzo l'accoglienza entusiastica del popolo lo protegge, ma nel villaggio di Sinalunga presso il lago Trasimeno è catturato con parte del suo stato maggiore (23 settembre). Soldati dell'esercito regolare che lo veggono passare prigioniero urlano: «A Roma, a Roma!»; il popolo di Firenze tumultua; però Garibaldi viene chiuso momentaneamente nella fortezza d'Alessandria. Allora i suoi luogotenenti si mordono l'uno l'altro per gelosia di comando; nella confusione [224] centuplicata dall'arresto del generale nè volontari, nè esercito, nè parlamento, nè paese comprendono più nulla. Siccome il ministero non disperde i volontari alle frontiere papaline, i più suppongono quell'arresto una lustra diplomatica per ritardare la spedizione, dar tempo a Roma d'insorgere, e al governo d'intervenire col proprio esercito.
Garibaldi, indignato del tradimento, dimentica se stesso al punto di chiedere protezione all'Inghilterra, agli Stati Uniti e all'Argentina come loro cittadino, Rattazzi impaurito dello scandalo gli manda il generale Pescetto, ministro della marina, per offrirgli di tornare libero a Caprera senza condizioni; Garibaldi accetta, ed invece rimane prigioniero nell'isola bloccata dalle navi regie.
Ma siccome dalla cittadella di Alessandria aveva già promesso ai romani di raggiungerli a qualunque costo, appena cominciate le ostilità fugge, a notte, romanzescamente, sopra uno schifo; approda in Sardegna; di là sbarca a Livorno, ricompare a Firenze (19 ottobre) che la guerra è già scoppiata alla frontiera pontificia. Infatti il 28 settembre alcune bande di garibaldini, varcato il confine, avevano già costretto i gendarmi di Acquapendente ad arrendersi; quindi, entrate in Viterbo, vi avevano costituito un comitato d'insurrezione col nome di governo provvisorio, mentre altre si erano insignorite di Bolsena e minacciavano Pontecorvo.
Rattazzi, messo al bivio dalla riapparizione di Garibaldi o di ripetere Aspromonte marciando contro i volontari, o di sorpassare la loro iniziativa invadendo lo stato pontificio, si dimette. Ma tutto era già perduto prima. Napoleone aveva annunziato il proprio intervento armato; Vittorio Emanuele per mezzo dell'ambasciatore Nigra era stato forzato a proporgli un intervento misto, poi il 19 ottobre gli aveva ripetuto l'offerta dichiarandosi pronto a riconoscere francamente in un proclama l'appoggio francese, e chiudendo il dispaccio col rimettersi all'alta saggezza dell'imperatore. [225] Il 22 Napoleone rispondeva ancora che «una occupazione mista non farebbe che complicare la questione dei due governi»; e Vittorio Emanuele proibiva a Rattazzi d'invadere lo stato pontificio.
Nullameno l'imperatore titubava ancora. Ma la monarchia, sottomessa da quasi dieci anni alla sua volontà, non poteva osare di soverchiarlo accettando il consiglio dato da Garibaldi a Rattazzi: «invadere Roma coll'esercito italiano e subito». Pio IX invece, conoscendo meglio del gabinetto di Firenze l'animo dell'imperatore, aveva esclamato con quella scettica bonarietà divenuta già celebre: «Imbecilli! aveva loro concesso otto giorni!».
Rattazzi, abbastanza abilmente sgusciato dalla oramai bieca situazione col dimettersi dopo aver compromesso impero, monarchia e rivoluzione, in mezzo al turbamento universale pareva ancora un forte ministro sagrificato dalla viltà del proprio governo. Il generale Cialdini, incaricato di racimolare un nuovo ministero, non essendo riuscito a dissuadere Garibaldi dall'impresa, declinava il troppo difficile mandato.
Gli successe quindi il generale Menabrea con un ministero reazionario; però non si ardì nè arrestare Garibaldi, nè impedire altrimenti la spedizione. Pel primo caso s'invocavano difficoltà insuperabili, e si diceva cavillando che nessuno poteva imprigionarlo, non il Rattazzi perchè ministro dimissionario, non il Cialdini siccome ricusatosi a formare il nuovo ministero, non il Menabrea che non l'aveva ancora formato del tutto; pel secondo il governo seguiva tuttavia la spinta datagli dalla politica di Rattazzi fra le contrarie correnti di Francia e della rivoluzione.
L'eclissi della coscienza publica era totale. Mentre il governo minacciava repressioni, i comitati mandavano soccorsi e diramavano proclami; il potere legislativo era sospeso, quello esecutivo diventato problematico.
Tutto l'eroismo italiano fremeva nel campo di Garibaldi, ma la nazione rimaneva inerte così agli eccitamenti del generale come alle recriminazioni del governo. Vittorio Emanuele pareva dimenticato.
Però il moto garibaldino si veniva a mano a mano agghiacciando: i volontarii erano pochi, malissimo armati con vecchi fucili delle guardie nazionali, quasi senza cannoni e senza cavalleria. Fra loro brillavano veterani e neofiti superbi d'entusiasmo, qualche vecchio principe come il duca Lante di Montefeltro, qualche giovane aristocratico come il principe di Piombino esule romano, gli ultimi della famiglia dei Cairoli, che dovevano morirvi. Ma lo spirito militare vi era scarso, un dissidio politico separava garibaldini e mazziniani, il contegno oramai apertamente ostile della monarchia disanimava i più, la certezza di un intervento francese toglieva finalmente ogni speranza all'impresa.
Non era più una guerra ma un sacrificio.
Una lugubre ed altera poesia dava allo stesso disordine di quelle rosse falangi una maggiore solennità: si sentivano nel silenzio delle marcie i presagi dell'ecatombe, e nel furore dei primi assalti la frenesia della morte imminente.
Il 22 ottobre settantacinque giovani guidati da Giovanni e da Enrico Cairoli s'avanzano, tragica avanguardia, su Roma: il loro disegno è di promuovervi una sollevazione che tolga alla Francia la ragione d'intervenire, e forzi la monarchia ad associarsi alla rivoluzione. Ma la metropoli cattolica non esce nemmeno in quest'ora suprema dalla propria ignavia; la polizia papalina vi ha già arrestato alcuni capi della cospirazione; altri gliene hanno già venduto il segreto; il governatore Zappi mura sei porte della città, raddoppia i presidii di piazza Colonna e del Campidoglio, intercettando ogni comunicazione colla campagna.
[227] I Cairoli, scesi di notte pel Tevere, si accampano sull'altura di Villa Glori aspettando invano il segnale dell'insurrezione: invece le loro vedette segnalano l'avanzarsi di alcune compagnie di antiboini. L'ecatombe incomincia, i settantacinque si votano alla morte: una mischia degna dei Maccabei glorifica per sempre quel piccolo poggio, e i due Cairoli cadono morenti sopra un mucchio di cadaveri.
— Muoio, sai. Saluta mammina. Il problema è sciolto! — mormora Enrico nell'agonia.
Poichè il loro impeto aveva fugato le due compagnie di antiboini, i rimasti poterono scampare a notte recando la triste notizia a Garibaldi.
Ma Roma non si è mossa. Solo in un lanificio di Trastevere alcuni cospiratori, sorpresi poco dopo (25 ottobre), resistono coraggiosamente animati dal coraggio di una donna, Giuditta Arquati Tavani, ultima romana nella decadenza papale che aveva precipitato Roma più basso dell'antica decadenza imperiale.
Garibaldi all'annunzio dell'eccidio dei Cairoli li immortala nel più bello dei propri proclami; quindi rassegnate le truppe (24 ottobre) a Passo Corese, ordina ai maggiori Valzania e Caldesi, romagnoli entrambi, l'assalto di Monterotondo. Il 25 ve li raggiunge con Mosto, Frigerio, Canzio ed altri capitani di battaglioni; Menotti, degno di lui, si è inoltrato sino a millecinquecento metri dal Pincio. Benchè quattrocento legionari antiboini guarniscano Monterotondo, mirabilmente asserragliati, dopo solo tredici ore di combattimento micidiale per i garibaldini la porta della piccola città è incendiata, e attraverso le fiamme i volontari irrompono vittoriosi. Dopo altre quattordici ore anche il castello dominante la città si arrende, ma il popolo conserva il più ostile mutismo verso i vincitori.
Nelle campagne l'odio ai garibaldini è anche più vivo ed assurdo: impossibile ad essi di chiedere una informazione ed ottenere una guida.
Fu l'unica, ultima vittoria garibaldina. L'indomani [228] una divisione francese agli ordini dei generale De-Failly salpava da Tolone, e a Firenze s'insediava il ministero reazionario Menabrea.
Incomincia la settimana di passione. Francia e Italia si uniscono contro Garibaldi. La squadra del Riboty, che da Rattazzi aveva avuto l'avviso di tenersi pronta a sbarrare l'approdo francese, riceve contrordini; l'esercito italiano si prepara a varcare il Confine per assistere impassibile alla carneficina dei volontari, il re emana un proclama nel quale li sconfessa minacciandoli come ribelli e chiamando i francesi alleati e fratelli. Garibaldi già in marcia su Roma, dopo la vittoria di Monterotondo, riceve a Casal de' Pazzi contemporaneamente il proclama del re e le informazioni di Adamoli e di Guerzoni, penetrati in Roma travestiti e ritornati senza più speranza d'insurrezione. Per la prima volta l'audace condottiero deve battere in ritirata, mentre all'annunzio dei francesi sbarcati a Civitavecchia l'esercito regio passa il confine per dividere con loro l'occupazione del territorio pontificio e «poter imprendere in situazione pari a quella di Francia nuovi negoziati», secondo una nota diplomatica del ministro Menabrea a tutte le potenze. Ma di questo intervento, del quale allora la parte moderata si vantò come di un atto risoluto, la storia ignora ancora la ragione. Dacchè il governo intendeva di non combattere i garibaldini e di lasciarli schiacciare dai francesi, la sua presenza sul campo di battaglia diventava un anacronismo inutile ed ingeneroso. Ma alla ritirata da Casal de' Pazzi la confusione entra nella piccola truppa dei volontari. Vanita la speranza della conquista di Roma, l'insufficienza dell'impresa scoppia in tutte le coscienze come una rivelazione: i mazziniani memori delle ammonizioni di Mazzini sull'esito doloroso, si sbandano gettando le armi; Garibaldi, esacerbato dalla diserzione, accusa Mazzini, il quale colla solita magnanimità di sacrificio, dopo aver avversato la spedizione, aveva da ultimo ordinato di aiutarla a quelli di parte propria. Senonchè [229] nell'incertezza di quell'ora i mazziniani si scusano, invocando le sue parole di altri giorni e fingendo d'ubbidire ad un suo ordine. Altri abbandonano il campo, ove erano accorsi sulla fede di un aiuto monarchico: una voce sinistra propala che l'esercito italiano appiedato alle spalle dei volontari attende che i francesi li attacchino di fronte per accerchiarli. La rotta precede la battaglia: da ottomila la piccola truppa discende a poco più di cinquemila, disperati della patria, reluttanti a morire invano e nullameno pronti a cercare in una suprema battaglia una fine a quell'impresa, nella quale di chiaro non v'era che la necessità di sacrificio.
Allora Garibaldi grandeggia. La sua ritirata da Roma non è che una sua mossa strategica; l'idea di ripassare il confine italiano, arrendendosi all'esercito regio senza aver combattuto i nuovi invasori, non gli passa nemmeno per il capo. Bisogna che l'Italia si riaffermi contro l'abbandono della monarchia e la prepotenza della Francia. Da Monterotondo, ove si era ripiegato, sfianca quindi su Tivoli, ove i colli gli offrono miglior terreno: i suoi ventisei battaglioni non avevano più che la metà dei soldati, la sua cavalleria è di sole dodici guide, le sue munizioni per l'artiglieria non superano le settanta cariche. Il 5 novembre la sua avanguardia è sorpresa al villaggio di Mentana da quella del generale papalino Kanzler: Garibaldi, costretto a mutare la linea di marcia in quella di battaglia, ritrova la migliore energia delle sue guerre d'America, ma i volontari mal destri si scompongono, gli zuavi pontifici ardenti di fanatismo assaltano con impeto: Garibaldi s'avventa egli stesso ad una carica alla baionetta, ma saettati di faccia e di fianco dai cannoni delle alture e dai nuovi fucili Chassepot a tiro rapido, i garibaldini debbono indietreggiare.
Nullameno la loro ritirata impone rispetto al nemico, che non sa occupare Mentana, terra aperta.
Garibaldi, sorpreso come Napoleone I a Waterloo dalla passione della morte, si precipita solo contro il [230] nemico, e come Napoleone trova nei propri luogotenenti chi lo ferma.
La sera alle otto si decide la ritirata da Monterotondo su Passo Corese. La mattina seguente i volontari depongono i fucili sul ponte di confine per ritornare sbandati alle proprie case, e Garibaldi arrestato a Figline viene chiuso nuovamente al Varignano. La Convenzione di settembre era lacerata, Roma nuovamente in mano ai francesi, le sue chiese echeggiavano alle preghiere della vittoria, mentre l'Italia stava muta guardando un corpo del proprio esercito appiedato entro i confini del territorio pontificio.
Ma il governo francese protestò così superbamente contro tale violazione che il re dovette ordinare al generale Cadorna di ripassare la frontiera.
Questa umiliazione non fu l'ultima.
Vittorio Emanuele con ingenua servilità scrisse ancora all'imperatore Napoleone una lettera per scongiurarlo nel nome dei medesimi interessi bonapartisti a richiamare le truppe da Roma e per offrirgli l'alleanza italiana, se rinunciasse ad ogni ulteriore protezione del papato. Questa lettera singolare diceva: «... gli ultimi avvenimenti hanno sopito ogni rimembranza di gratitudine nel cuore dell'Italia. L'alleanza della Francia non è più nelle mani del governo! Il fucile Chassepot a Mentana l'ha ferita mortalmente. Ma questa alleanza non è spregevole. Sire: essa è alleanza più sicura e più efficace, che non sia quella del partito clericale. Ora Vostra Maestà senza offendere la volontà della nazione può, se vuole ravvivarla o secondarla» (6 novembre).
Così scrive il re d'Italia al difensore del pontefice, al vincitore di Garibaldi, all'alleato, che primo colla formazione della legione d'Antibo aveva violato la Convenzione del settembre.
[231] Il ministro francese degli esteri Rouher, rispose brutalmente all'umile lettera del re dichiarando fra gli applausi della camera che gli italiani non si impadronirebbero di Roma giammai!
Questa parola suonò come uno schiaffo sulla fronte della nazione. Garibaldi, ancora prigioniero, veniva pregato dal ministro Gualterio di scegliersi un esilio spontaneo per non suscitare imbarazzi al governo.
Il paese intanto si manteneva calmo. I reduci garibaldini vi erano considerati come pazzi che avessero voluto forzare l'impossibile, si giudicava severamente l'opera di Garibaldi, si accusava Rattazzi di aver compromesso le sorti delle istituzioni, non si misurava abbastanza bene la nuova bassezza, alla quale era sceso Vittorio Emanuele; mentre per una delle solite contraddizioni spiacevano le compiacenze servili del Menabrea alla Francia, e i suoi postumi rigori contro i volontari. Naturalmente la discussione degli ultimi avvenimenti si restrinse alla camera, senza guadagnarvi nè di logica nè di nobiltà. La destra intransigente vi si accanì contro Garibaldi e più contro Rattazzi, capo della sinistra: pareva ad essa un sacrilegio l'aver tentato contro il volere della monarchia la questione di Roma: quindi colla vanteria di una praticità fatta di sommissione e di pedanteria derideva come rettorica le magnanime affermazioni del diritto nazionale su Roma, e respingeva come ingratitudine le pretese di una emancipazione dall'impero francese ancora arbitro d'Europa. Di rimpatto la sinistra, giustamente sospettata di riserve republicane, accusando la destra di partito antinazionale, ricadeva sotto il sospetto di voler abbattere le istituzioni, mentre i veri rivoluzionari si lagnavano invece che avesse tradito la rivoluzione a profitto della monarchia. La colpa, palleggiata da partito a partito, da ministero a ministero, dal re a Garibaldi, era uguale in tutti. Questi solo aveva voluto dar Roma all'Italia malgrado il papa, l'impero e la monarchia, ed era stato battuto, ma la sua sconfitta isolava Napoleone in Europa togliendogli [232] ogni possibilità di nuova alleanza coll'Italia, infamava il papato ed abbassava la monarchia.
Il motto di Enrico Cairoli morente — il problema è sciolto! — era stata una di quelle rivelazioni, che la storia talora accorda all'agonia degli eroi.
Il linguaggio insolente della Francia, cui il ministro Menabrea opponeva i più sciatti complimenti, compiva il discredito del governo: le arringhe abilissime del Rattazzi dichiarante di avere per rispetto alla Convenzione, sebbene violata dalla Francia, cercato d'impedire la spedizione di Garibaldi e voluto poi intrepidamente prevenirla colle truppe regie occupando il territorio pontificio onde evitare l'intervento francese, rendevano col paragone più supine le dichiarazioni del nuovo ministero: Quintino Sella, ammirabile di calma risoluta fra tanta incertezza di passioni e di idee, proponeva indarno, e per quanto povero era ancora il solo rimedio, un ordine del giorno puro e semplice che riconfermasse Roma capitale d'Italia come risposta al jamais del ministro francese. Finalmente il Bonfadini ne presentava un altro mostruosamente contradditorio che, riaffermando indirettamente Roma capitale e deplorando che si fosse voluto ottenerla con mezzi contrari alle leggi dello stato e ai voti del parlamento, conchiudeva coll'approvare l'opera del ministero.
La camera respinse anche questo, il ministero cadde, e il re incaricò daccapo il Menabrea di formarne un altro. Così la Corona, intervenendo nelle lotte parlamentari per troncarne colla propria autorità un dibattito pericoloso, riconfermava il vassallaggio della nazione alla Francia.
Fu questa l'ultima e non meno triste scena del tristissimo dramma.
Mentana rimaneva l'ipogeo della politica regia, come Marsala era stata l'apogeo della politica rivoluzionaria. Il moto rivoluzionario troppo vantato dai giornali radicali non aveva dato che poche migliaia di volontari e un inconcludente soccorso pecuniario: Rattazzi [233] assecondandolo senza aver preparato l'esercito alla possibilità di uno scontro colla Francia, aveva reso inevitabile il disastro: per la monarchia non vi sarebbe stata altra salute che nell'imitare la semplice e fulminea politica del conte di Bismarck, occupando Roma con tale prestezza da mettere l'impero francese nell'impaccio di rompere guerra all'Italia, e forse allora la Prussia avrebbe potuto rattenerlo con una sola minaccia di attacco sul Reno. Ma la monarchia non aveva sola la responsabilità della catastrofe. I volontari erano stati scarsi alla guerra, avevano disertato dal campo, si erano battuti malamente a Mentana malgrado l'eroismo degli ufficiali, si erano sbandati nella ritirata da Monterotondo strappando a Garibaldi parole roventi di biasimo. I mazziniani con insensata gelosia seguitavano ancora a vituperare Garibaldi di aver voluto combattere nuovamente con bandiera regia, quando egli stesso venendo meno questa volta al solito buon senso politico aveva alzato bandiera neutra, assunto il titolo equivoco di generale della republica romana e taciuto del re nei proclami da Monterotondo. Nell'esercito regolare, malgrado qualche applauso a Garibaldi prima del rompere delle ostilità, nessun vero entusiasmo: al comando di varcare i confini pontifici, quando già i francesi marciavano con forze triple contro i garibaldini, tutti avevano freddamente obbedito: non un battaglione si era sollevato per correre in soccorso ai volontari, non uno dei tanti ufficiali garibaldini, che vi coprivano alti gradi, aveva rotto la spada piuttosto che ubbidire all'ordine di assistere impassibile all'eccidio degli antichi commilitoni sotto le mura di Roma per mano dei francesi e a difesa del papa. L'esercito come la nazione aveva sentito l'onta divorandola in silenzio.
Il re, indarno paragonato da letterati cortigiani a Guglielmo d'Orange, si era eclissato nei lunghi preliminari dell'azione invece di mostrarvisi con cauta risolutezza, e aveva poi subìto, scongiurandole con inutile umiltà, tutte le prepotenze francesi; il parlamento [234] aveva difeso Francia e papato contro la rivoluzione. Il popolo, incapace di sentire l'idealità di Roma e di volere un'altra guerra nazionale, era povero, e non domandava che ristori alla propria miseria: era libero, e non si curava ancora della propria libertà: era padrone, ed ubbidiva a chiunque lo comandasse, sfuggendo ai pericoli di tutte le combinazioni politiche colla propria inerzia, e aspettando con inconscia sicurezza il compimento dei propri destini da un'altra coincidenza europea.
Nullameno il suo odio era adesso per la Francia: Mentana cancellava Solferino.
Nel dramma di Mentana si erano addensate tutte le antinomie della rivoluzione per risolversi in una impotenza finale: il papato, per sottrarsi alla libertà italiana, aveva dovuto abbandonarsi incondizionatamente all'arbitrio francese; l'impero napoleonico, per resistere alla democrazia, aveva perduto l'Italia; Mazzini, per tentare l'estrema prova della propria astratta republica, aveva dovuto sconsigliare l'ultimo assalto al papato; la monarchia per sostenersi aveva dovuto schierarsi fra i difensori di questo; la destra parlamentare per salvare il governo si era mostrata come partito antinazionale: la sinistra, mantenendosi nell'orbita legale e separandosi così dalla rivoluzione, si era mutata in partito di governo.
Però la decadenza di questo periodo, che dall'iniziativa francese del 1859 doveva andare sino all'acquisto di Roma nel 1870 nella ruina dell'impero bonapartesco, s'arrestava a Mentana dinanzi al crescere di nuove forze dal seno stesso della nazione.
Garibaldinismo e mazzinianismo erano consunti. Appena intorno ai due grandi duci si stringeva ancora qualche manipolo di veterani.
Una nuova generazione stava per sorgere, che non avendo partecipato alle lotte del risorgimento, non si [235] impigliava nelle sue contraddizioni e non comprendeva i suoi eroi. L'ultimo tentativo di Mentana aveva provato che solamente l'impero napoleonico difendeva il papato: nella Francia stessa i maggiori spiriti, da Michelet ad Hugo, applaudivano Garibaldi, mentre il congresso proposto da Napoleone per una nuova soluzione della questione romana falliva dinanzi all'influenza di tutti gli stati. Il sole dei Bonaparte declinava per sempre all'orizzonte europeo.
Roma tornerebbe indubbiamente all'Italia; questa convinzione era persino in coloro che non lo avrebbero voluto, e da Roma si inizierebbe per l'Italia il vero periodo dell'unità. Per ora, aspettando che un altro trionfo della rivoluzione in Europa rovesciasse l'impero francese, bisognava aiutare l'intima formazione nazionale con altre forze e con nuovi elementi. Alla grande poesia delle congiure e delle battaglie succedeva la passione prosaica degli interessi con iniziative inavvertite, che dovevano mutare lentamente le condizioni politiche e sociali del paese. Si cominciava ad accusare di enfasi ogni entusiasmo politico e di rettorica ogni eloquenza: i mutati modi di guerra rendevano inutile tutto l'eroismo di Garibaldi, le battaglie del quale, dopo la grande campagna di Moltke, non erano più che scaramucce: anche nella guerra la prosa della scienza succedeva alla poesia dell'ispirazione. L'apostolato di Mazzini non pareva più che una predicazione di catechismo: nella sua utopia di una terza epoca italiana in Europa spirava l'ultimo romanticismo filosofico di una scuola morta col Gioberti. Già la democrazia europea aveva sorpassato con più vaste formule socialistiche il grande tribuno, che, rivoluzionario in Italia, era costretto ad essere ora reazionario in Europa. Dalla Francia, dalla Germania, dalla Russia, grandi scrittori si levavano contro di lui, mentre le masse sorde alla sua voce rompevano già i confini loro assegnati dalla sua libertà deridendo la fede nel suo Dio.
[236] Le tendenze positiviste del secolo respingevano l'idealismo da ogni campo. Economia privata e pubblica attiravano tutte le forze; alle battaglie dei libri e delle insurrezioni succedevano quelle dell'industria e del commercio; i lavori si specializzavano, i patrioti diventavano importuni; si brontolava contro le cariche loro concesse per meriti di sacrifici, si gridava alla necessità di svecchiare il mondo dacchè una stessa pedanteria inceppava rivoluzionari e moderati, e secondo gli uni dissentire da Mazzini, secondo gli altri discutere il re era un delitto.
Solo Garibaldi, uomo d'istinto e di passioni, restava giovane.
La decadenza mazziniana precipitava. Nullameno la logica del sistema premeva Mazzini. Egli sentiva con nuova angoscia la necessità e l'impossibilità di altri conati republicani: ma ritirarsi di fronte alla monarchia dopo Mentana sarebbe stato un discendere più basso di essa senza nemmeno le attenuanti della sua situazione politica, e a combatterla le condizioni del partito repubblicano e della nazione non davano forze. La Società dell'Alleanza Republicana, da lui fondata negli ultimi anni, non si diffondeva che alla superficie del paese, quando invece il governo cresceva ogni giorno d'importanza, malgrado tutti gli errori della sua politica estera ed interna. Al mazzinianismo non restava che prendere il malcontento provocato dalle tasse per una opposizione ideale alla politica monarchica, e soffiarvi sopra con equivoco patriottismo. Ma il ministero Menabrea vigilava fieramente sostituendo nelle maggiori città generali a prefetti, sciogliendo arbitrariamente società politiche, arrestando i più sospetti patrioti, moschettando le turbe insorgenti contro la tassa del macinato e della ricchezza mobile. Un'insurrezione era impossibile: oramai Mazzini non conosceva più l'Italia. Intorno a lui vivente da oltre trent'anni nell'esilio, si stringeva un sinedrio d'incondizionati devoti e di abili sfruttatori, che gli falsavano al giudizio la realtà delle cose; gli si carpivano tristamente lodi, [237] biasimi, ordini e sopratutto i pochi denari senza che egli nemmeno lo sospettasse.
Dopo l'applicazione delle armi a tiro celere nessuna insurrezione poteva più prescindere da una specie di pronunciamento militare; si cercò quindi di sedurre l'esercito ma la propaganda rivoluzionaria, invece di cominciarvi in alto dai comandanti, fu iniziata nella bassa forza fra giovani caporali e sergenti senza capacità e senza credito. Era lavoro pericoloso, immorale ed inutile, che doveva naturalmente concludere a qualche insubordinazione di caserma punita colla fucilazione come avvenne poi nel caso del caporale Barsanti disgustando la grande maggioranza del paese, che dopo le umilianti sconfitte della guerra veneta seguiva con passione gli sforzi del governo per il riordinamento militare. Con più assurda idea si pensò ad un grosso comizio milanese per protestare contro le nuove restrizioni alla libertà di stampa e di riunione, e vi si invitarono rappresentanti di tutta l'Italia proclamando che alle provocazioni immancabili della polizia si sarebbe risposto colle armi. Naturalmente il governo proibì il comizio; quindi lo infamò per bocca del ministro Cantelli coll'assurda accusa che dovessero adunarvisi duecento accoltellatori. Nell'eccesso di questa reazione il ministero giunse persino ad esigere dalla Svizzera l'espulsione di Mazzini venuto a Lugano; e la republica, contraddicendo alle vecchie glorie della propria libertà, cedette all'ingiusta pressione.
Il partito mazziniano, galvanizzato da tali minute persecuzioni, parve allora rianimarsi. Invincibile nelle accuse alla monarchia di non sapere e di non volere compiere l'unità della patria colla conquista di Roma, esso ritorceva con logica superba contro il governo tutti gli espedienti della sua politica. Infatti il Menabrea nella prima calma succeduta al disastro di Mentana tornava daccapo a chiedere i buoni uffici della Francia per stabilire un modus vivendi fra il regno d'Italia e la Santa Sede, offrendosi di garantire al papa la più illimitata libertà e di assumersi una grossa [238] parte del debito pontificio, solo che il nuovo presidio francese si ritirasse da Roma. L'impero respinse colla solita alterigia l'impossibile accordo e mantenne il corpo d'occupazione a Roma, come se la Convenzione di settembre non fosse avvenuta. Con non migliore proposito Vittorio Emanuele tentò di propria iniziativa una alleanza fra Italia, Francia ed Austria contro la Prussia ponendovi a condizioni fondamentali per l'Italia lo sgombero di Roma delle truppe francesi, la consacrazione del principio del non intervento per le cose italiane, e nel caso di una guerra una rettificazione delle frontiere del Varo e delle alpi tirolesi. Si sarebbero così ricuperate Nizza e Trento rinunciando per sempre a Trieste, e lasciando in sospeso la questione di Roma. Dopo molto tergiversare Austria e Francia ricusarono. Ma l'Italia dopo Custoza e Mentana alleata coll'Austria e colla Francia a danno della nazionalità germanica, che stava per rovesciare l'impero napoleonico, sarebbe stato l'assurdo più ripugnante nella storia del secolo.
Nel 1868 nuove congiure intendevano ad un moto rivoluzionario, ma senza più alcuna delle potenti energie di un tempo: non sincerità di fede, non passione di odio al governo, non chiarezza nello scopo, non vera preparazione di mezzi. Si congiurava quasi all'aria aperta sorridendone; si sarebbe detta una Fronda, se il problema ne fosse stato meno solenne e lo spirito dei congiurati più elegante. Mazzini non osava risolvere: proclamava la necessità di assalire la monarchia, e indietreggiava dinanzi alla guerra civile; credeva sempre nel valore del popolo, e diffidava delle proprie bande. Quindi i primi moti nel Comasco, a Piacenza e a Pavia (marzo 1869), cominciati contro la sua volontà, furono così inani che non destarono la menoma apprensione; a Bologna e nelle Romagne finirono in una innocua scampagnata; il ridicolo ne colpiva i reduci, che ne ridevano essi stessi. Poi Mazzini da Genova, ove aveva riparato all'insaputa del governo, meditò un'insurrezione nella Sicilia.
[239] Era l'ultimo errore della sua politica rivoluzionaria. La Sicilia, calda ancora della propria rivolta brigantesca e staccata dal continente, non avrebbe potuto espandere il moto, pur riuscendo a dargli in se stessa vera forza espansiva. L'imitazione della grande iniziativa garibaldina diventava così evidente che pareva suggerita dalla rivalità; però nè egli era l'uomo, nè i tempi e il problema più i medesimi. Mentre la guerra fra la Prussia e la Francia stava per scoppiare, Mazzini senza accorgersene era vittima di un intrigo diplomatico di Bismarck, che per staccare l'Italia dalla Francia intendeva a fomentarvi disordini promettendo aiuti segreti di armi e di denari alla rivoluzione. Poco dopo l'astuto cancelliere prussiano, essendo invece riuscito ad assicurarsi la neutralità dell'Italia, troncava bruscamente ogni trattativa, e ne avvisava il gabinetto di Firenze.
Mazzini, arrestato nelle acque di Palermo prima d'aver toccato terra, venne chiuso nella fortezza di Gaeta; il capitano generale scelto da lui all'impresa, certo Wolf, era un agente segreto del governo.
Così finiva fra un tradimento diplomatico e un tradimento rivoluzionario l'opera politica del grande agitatore, che primo in Italia fra riformisti, federali, neoguelfi e carbonari vi aveva nettamente formulato il principio dell'unità politica. Nessuno aveva cooperato più validamente di lui al risorgimento d'Italia, e nessuno vi restava come lui straniero nella fatale decadenza del proprio sistema, fra l'ingrata indifferenza del popolo, nel momento che la monarchia stava per essere spinta su Roma da un'altra rivoluzione europea.
Mentre tutti i partiti si esaurivano nell'impossibilità di frangere l'orbita napoleonica, al di fuori di essa la vita ridesta dal grande trionfo dell'unità vigoreggiava. Nella stessa scettica indifferenza della nazione per le scene finali del proprio dramma politico era una superbia giovanile, che guardando più lontano, quando per l'imminente pienezza dei tempi l'Italia sarebbe in Roma sovrana assoluta di se medesima, si preparava a lottare su tutti i campi della civiltà colle nazioni più avanzate d'Europa.
Un potente moto era da tempo incominciato nella produzione nazionale. I nuovi mezzi di comunicazione, le due grandi mobilitazioni dell'esercito e della burocrazia, un maggiore contatto cogli altri popoli d'Europa, la diffusione delle idee, la libertà in ogni opera, e sopratutto una nuova coscienza avevano già mutata la fisonomia della vecchia Italia straniera a se stessa da regione a regione. Tutto era a rifare, e a tutto si poneva mano. Il governo spingeva prodigamente le opere pubbliche; comuni e provincie seguivano con maggior febbre e peggior metodo l'esempio: nelle provincie del nord più culte ed alacri tutte le industrie pigliavano nuovo slancio. Una larga e subita applicazione delle macchine a vapore raddoppiava i primi saggi di grande manifattura; il Moncenisio non era [241] ancora aperto che già si preparava il foro del Gottardo; Genova, cresciuta così a porto di tutta l'Europa centrale, moltiplicava il proprio commercio; Torino si vendicava nobilmente della decadenza da capitale sviluppandosi come città manifatturiera; Milano diventava centro di tutti gli scambi; a Firenze la vita della capitale galvanizzava il fiacco costume antico; a Napoli le strade aperte nel vecchio reame attiravano nuovi e fecondi elementi. Al calore di questa giovane vita e sotto la sferza del bisogno cresceva l'attività: tutte le carriere aperte a tutti mutavano gli individui in cittadini, le attitudini si rivelavano nell'esercizio, le capacità erano prodotte dalle stesse cariche moltiplicate in quel fervore oltre ogni misura.
Dacchè la formazione dell'unità nazionale doveva fatalmente compiersi col mezzo della monarchia piemontese e di iniziative straniere, la nuova operosità italiana, invece di svolgersi appassionatamente nella politica per forzarne i dati, doveva esplicarsi per valori individuali nella sfera più bassa dell'economia, come a preparazione di più alto periodo storico. Fra il bisbiglio accademico dei partiti il grosso della gente non sentiva e non badava che al problema finanziario: chi aveva risparmiato il sangue doveva prodigare il denaro, e di denaro non solo aveva d'uopo incessantemente il governo per allestire i nuovi servizi publici, ma tutti gli altri campi dell'attività. La grandine delle tasse doveva quindi cadere su mèssi non ancora mature, e talvolta su terreni appena aperti dal primo aratro.
Nel problema delle finanze s'aggruppavano tutti gli altri, ma senza speranza di benefiche coincidenze europee e di aiuti avventurieri. Nel governo diventava suprema difficoltà l'imposizione e l'esazione delle imposte in tanto squilibrio della nazione fra provincie e provincie: per l'imposta prediale o antiquati o monchi o mancanti i catasti; incredibilmente dispari il saggio della produzione anche per la differenza nei mezzi di scambio; per le ricchezze mobili più difficile [242] ancora saper dove e come colpire con giustizia approssimativa senza arrestare il circolo dell'operosità. Poi in molte regioni il nuovo governo tutt'altro che benviso, e quindi facile ad essere odiato al primo aumento di pesi: abitudini inveterate e privilegi da togliere a molti paesi come ultimi caratteri autonomici; nei politicanti e nei parlamentari dottrinarismo di teorie inapplicabili al momento e al luogo; più in basso rettorica a favore del popolo per sottrarlo ai sacrifici inevitabili della crisi; in nessuna classe spontaneità di offerta e conoscenza vera delle condizioni dello stato.
Finanziariamente il primo fatto della rivoluzione fu il sommarsi di tutti i debiti dei vecchi stati, e delle spese incontrate per rovesciarli, in una prima unità ottenuta non senza contrasto: poi venne quella delle tariffe e delle imposte. Guai e guaiti si moltiplicarono allora. La formazione italica essendo rimasta a mezzo, bisognava crescere armi a difesa della nazione e contemporaneamente spremerla per fecondarla con opere pubbliche. Ma il capitale indigeno si nascondeva ancora, il risparmio era male organizzato, il capitale straniero si presentava usuraio e diffidente. Impossibile quindi ogni tentativo di vera rivoluzione finanziaria. Nelle imposte anzichè alla scienza e alla giustizia bisognava badare all'incasso, poichè al loro assetto logico mancavano gli studi, e alla loro equità distributiva contrastava lo stesso egoismo della borghesia trionfante. Congegni e leggi amministrative s'incagliavano reciprocamente per difetti di struttura rendendo più difficile ogni esazione. Così ne venne una guerra fra governo e contribuenti piena di frodi e di violenza d'ambo i lati: il malcontento politico vi si mescolò per coprire di nobili pretesti le più tristi avarizie e le truffe più sfrontate.
La sinistra parlamentare, che come partito rivoluzionario avrebbe dovuto conservare maggior coraggio nei sacrifici, fu dall'opposizione sistematica trascinata nella più odiosa rettorica, approvando sempre le spese [243] e negando sempre le tasse; la destra invece, che contrastando politicamente alle piazze ne aveva perduto il favore e non sperava riacquistarlo, trovò nel proprio orgoglio di comando l'energia necessaria a sostenere il governo; ma destra e sinistra, camera e senato, non ebbero mai vero programma finanziario.
Alcune tasse sorpassarono i massimi più assurdi: v'ebbero provincie nelle quali l'imposta prediale raggiunse sino al 76% sulla rendita, quella dei fabbricati toccò il 50%, i dazi di consumazione inasprirono la miseria dei più poveri; alle dogane i trattati di commercio stretti nelle prime ore, quando bisognava impetrare dai grandi stati il riconoscimento del nuovo regno, diedero la peggiore forma d'imposta, giacchè la merce straniera vi ottenne trattamento non reso alla nostra dagli altri paesi. I primi prestiti furono contratti a frutti esorbitanti, le prime emissioni di rendita subirono disastrosi ribassi; dai prestiti volontari si dovette venire ai forzati, si ricorse col macinato all'atroce espediente di colpire tutti i più miseri, mentre alla tassa della ricchezza mobile da principio quasi tutti i redditi sfuggivano meno quelli degli impiegati. La vendita dei beni ecclesiastici parve olio sul fuoco, il corso forzoso della moneta cartacea fu la maggiore risorsa di cassa, quando tutte furono esaurite dal crescendo delle spese, alle quali le ultime conquiste della nazione davano uno spaventevole aire.
Allora da questo abisso senza fondo si affacciò lo spettro del fallimento. L'Europa, che aveva giudicato simpaticamente la fortuna politica d'Italia nel suo risorgere a nazione, credette di essersi ingannata vedendola vacillare sotto il peso dell'improvvisazione economica.
Fortunatamente la nazione trovò in Quintino Sella l'eroe della propria finanza.
Egli solo nell'entusiasmo delle prime feste patriottiche, all'indomani della proclamazione del nuovo regno, aveva osato pronunciare la stridula e minacciosa parola del fallimento. La finanza, maneggiata intrepidamente dal conte di Cavour come istrumento di guerra, doveva dopo la vittoria diventare la base del nuovo stato. Illusioni classiche e rivoluzionarie dicevano allora l'Italia ricca; non si comprendeva ancora la differenza fra la moderna vita industriale e l'antica, non si conoscevano abbastanza l'assetto e le forze delle altre nazioni; lo stesso orgoglio, che ci aveva fatto credere sino all'ultimo di essere sempre alla testa della civiltà europea, ci persuadeva di possedere risorse capaci di resistere a ben altro che alla nostra rivoluzione. Così le prime ammonizioni del Sella parvero pedantescamente brutali.
Ma l'irosa meraviglia del pubblico non arrestò l'austero finanziere. La sua gagliarda fibra montanara di mercante cresciuto da una famiglia, nella quale l'industria della lana esercitata da secoli diventava come un titolo di nobiltà, era di quelle che si temprano nelle battaglie, e vi si fanno infrangibili e squillanti. Nato nel 1827 e ministro delle finanze nel 1862 col ministero Rattazzi, era ancor giovane, di una natura media potente di equilibrio e di salute. Lo dicevano già illustre naturalista e matematico. Aveva studiato a Parigi durante la rivoluzione del '48 e ne era ritornato per offrire il proprio braccio alla patria, ma il ministro sardo Desambrois lo aveva aspramente redarguito. Le sue prime impressioni politiche erano state a Parigi una grande diffidenza delle sommosse popolari, e in Italia una entusiastica ammirazione per Garibaldi nella difesa di Roma, quando invece il conte di Cavour già infervorato di egemonia piemontese si rallegrava alla caduta di quella republica mazziniana. Ma della ultima rivoluzione federale italiana Sella non aveva ben sentito che il dolore del disastro [245] finale, consolandosene austeramente cogli studi. Quindi ingegnere presto celebre per alcune memorie sui cristalli, professore di matematiche, deputato, segretario al ministero della pubblica istruzione, il suo ingegno calmo e il suo carattere tenacemente onesto lo trassero al ministero delle finanze. Fra tutti i luogotenenti di Cavour, egli il più giovane, era quello che meno gli somigliava e doveva maggiormente giovare alla sua tradizione. Mentre il Minghetti, il Farini, il Ricasoli, il Rattazzi, tendevano a destreggiarsi nella diplomazia, in essa riponendo gloria e salute, il Sella libero da dottrine economiche e da vincoli partigiani rappresentava inconsapevolmente la parte sana di quella borghesia, che avendo trionfato colla rivoluzione doveva mutarla in governo regolare. Il suo patriottismo era quindi egualmente alieno dagli eroici fervori mazziniani e dalle subdole riserve monarchiche: amava con lealtà antica la dinastia di Savoia, ma voleva annullarne la conquista regia in una più vasta opera italiana.
Il problema delle finanze diventava perciò non solo un problema di vita economica, ma di vita morale. Tutte le fortune della rivoluzione sarebbero state indarno, se la nazione abbandonata a se medesima non avesse saputo ordinarsi internamente.
In mezzo alle preoccupazioni rivoluzionarie, che dovevano poi risolversi nell'alta tragedia di Aspromonte, egli pensò tosto ad assodare la prima unità del regno nelle finanze col richiamare gli spiriti alla serietà di un lavoro collettivo dal torneo ormai inutile delle armi popolari. Uomo politico nel senso corrivo della parola non era: nella fredda onestà dell'ingegno, cui l'arguzia dava tratto tratto un lampo cristallino, egli giudicava troppo severamente uomini e cose per acquistare nel parlamento seguito di capitano. Incrollabile nelle proprie convinzioni ed ostinato al trionfo delle proprie idee, gli mancava quella qualità del corrompere e del lasciarsi corrompere senza la quale riesce impossibile raccozzare intorno a se [246] medesimo abbastanza interessi per farli servire, spesso loro malgrado, ad un principio.
Egli stesso giudicandosi più tardi «così alieno dal comandare come da ubbidire» spiegava chiaramente le vicende della propria altalena ministeriale e di quel soccombere suo nel parlamento, mentre le sue idee finivano sempre per trionfarvi. Ma se malgrado una incontestabile abilità di parlamentare nelle discussioni gli falliva per fortunata mancanza di qualità negative quella di capo-partito, a certi momenti, quando nell'addensarsi dei pericoli la destrezza volgare non serviva più e bisognava per superare le crisi attingere nell'onestà della coscienza la forza di sfidare ingiustizie di corte, di parlamento o di piazza, forzando i partiti a frangere la propria orbita, allora Sella diventava il più forte uomo politico del proprio periodo.
Come la borghesia, che incarnava, egli aveva quindi più istinti che idee e più carattere che ingegno; era così democratico da non sentire vanità per nessuna carica, ed abbastanza aristocratico per appassionarsi a tutte le più fini bellezze dello spirito; adorava la propria famiglia come un antico; esercitava la politica come un dovere, ritornando ne' suoi intervalli alla scienza e conservando sino agli ultimi giorni la passione delle Alpi e delle miniere, senza chiedere alla nazione nè premio nè giustizia per la propria opera.
Se Mazzini e Garibaldi erano la grande originale poesia della rivoluzione, e il conte di Cavour vi aveva rappresentato la tradizione monarchica, Quintino Sella vi mostrò il carattere borghese nella sua più complessa potenza di mercantilismo e di scienza, di onestà e di lavoro, d'iniziative e d'equilibrio.
L'ingresso alla vita politica non poteva essere più difficile per un uomo della sua tempra. Non essendo nè economista, nè finanziere, egli non portava al ministero delle finanze che una rettitudine di matematico e di mercante: conosceva poco i partiti e non li amava. Nella politica, credeva con assennata lealtà [247] all'egemonia della casa di Savoia come al solo mezzo capace di unificare l'Italia; ammirava Garibaldi e Cavour, riconosceva l'altezza morale di Mazzini, calcolava sulla sodezza costituzionale di Vittorio Emanuele, senza troppo illudersi sulla capacità o sulla nobiltà del parlamento, quantunque vi stimasse molti individui. L'assordante rettorica delle discussioni non gli nascondeva la povertà dei caratteri e degli ingegni stordentisi di frasi. Il suo metodo, angustamente ma fortemente sperimentale, consisteva tutto nell'applicare allo stato i dettami dell'economia domestica; la sua eloquenza piuttosto che dall'arte prendeva vigore dalla profondità delle convinzioni; la sua libertà veniva da una specie d'isolamento politico abbastanza giustificato dalla qualità del suo ufficio. La finanza, che non può mai essere un'opinione, doveva allora imporsi a tutti i partiti come una realtà trascendente.
Al primo sguardo Sella vi scoperse il fallimento. Una lotta eroica diventava quindi inevitabile colla nazione per salvarla dall'abisso, ove avarizia e ignoranza la spingevano.
Politicamente pochi problemi in questo secolo furono più difficili.
Il paese gavazzava allora nella prima illusione della libertà: era povero e si credeva ricco, era stato fortunato e non voleva cessare di esserlo; ignorava se medesimo, non capiva gran cosa nella propria rivoluzione e si ricusava risolutamente agli ultimi sacrifici necessari per compierla. Mazzini e Garibaldi avevano trovato più volontarii che denaro alle proprie imprese. Quindi domandare sempre e dappertutto denari all'Italia era allora il più aspro problema e il più generoso ardimento. Nè partiti, nè ministeri, preoccupati della politica estera ed interna, avevano un concetto chiaro della situazione finanziaria.
[248] Nella sua prima esposizione finanziaria del 1862 Sella provò che il disavanzo previsto dal suo antecessore Bastogi in 317 milioni, era invece di 433; gli esercizi antecedenti al 1861 avevano lasciato un vuoto di 530 milioni riempito da un prestito mediante alienazione di rendita. In due soli anni il debito pubblico era aumentato di 924 milioni, precisamente il doppio della rendita annuale. A fronteggiarlo era impossibile contare su risparmi di spese militari o di opere pubbliche nelle attuali condizioni del paese o su prestiti che avrebbero subìto un ribasso del 40% deprimendo il corso della rendita; alle imposte, unico rimedio, il parlamento recalcitrava. Sella ebbe appena il tempo di preparane alcune abbastanza lievi che, travolto col ministero Rattazzi dalla catastrofe di Aspromonte, dovette rassegnare le dimissioni. Ma la situazione era così peggiorata che il disavanzo complessivo di cassa per gli anni 1862-63 saliva a circa 772 milioni; fra i mezzi straordinari, cui egli accennava allora per provvedere a tale somma, 150 milioni di una nuova emissione di buoni del tesoro, un prestito di 550 milioni su altre cartelle del debito pubblico, 150 milioni anticipati per locazione di ferrovie e 150 milioni di altre imposte, s'annunciava già l'idea del macinato. Provvedimenti però che egli stesso dichiarava insufficienti, e proponeva solo perchè maggiori sarebbero stati respinti dal parlamento.
Il Minghetti, che gli succedette alle finanze nel ministero Farini, era economista di grido nelle sfere governative, ma di tempra troppo fiacca e d'ingegno troppo leggero per sopportare tanta soma di rovina economica. Quindi come tutti gli agili girò intorno al problema invece di affrontarlo. Mentre il Sella giudicava severamente questione di vita o di morte il raggiungere tosto il pareggio fra le spese e le entrate ordinarie, egli credeva abile politica procrastinarlo sino al 1867, illudendosi su risparmi impossibili e non calcolando sulle nuove imposte che per due quinti. Così la finanza cedeva alla politica parlamentare invece [249] di signoreggiarla: ma tutte le rosee previsioni del Minghetti sfumarono e del suo passaggio al ministero non rimase altra traccia che in un prestito di 700 milioni. Il Sella, fisso nella necessità d'imporre al paese i più duri sacrifici, si ripiegava allora dalla sinistra sulla destra, come su partito più disposto a sfidare l'impopolarità delle tasse, ma appoggiò patriotticamente alla Camera il ministero Minghetti sostenendone le proposte, frutto in gran parte delle precedenti amministrazioni, pel riordinamento del lotto, per le aspettative e disponibilità degli impiegati, per la ricchezza mobile e pel dazio consumo; le quali ultime sarebbero riuscite più logiche ed efficaci, se tutte le sue idee vi avessero trionfato.
Però nell'acuirsi della crisi finanziaria il Sella fu ricondotto al ministero delle finanze dal Lamarmora, incaricato di liquidare la triste eredità della Convenzione di settembre. La sua posizione già difficile di finanziere poco disposto a transigere sulle tasse, diventava pericolosa colla nuova responsabilità di un patto rinnegante il maggiore diritto della nazione. Ma non abbastanza rivoluzionario per sentirne tutta l'intima tragedia, pur dolendosene in segreto, egli credeva anzitutto impedire peggiori conseguenze coll'eseguirlo per allora fedelmente; quindi si volse a fronteggiare la tristissima situazione di cassa. Il disavanzo era tale che in quell'ottobre (1864) mancavano circa 200 milioni per pagare le imminenti scadenze del dicembre. Nella crisi monetaria allora travagliante l'Europa, era impossibile pensare a prestiti per le gravissime condizioni che i prestatori avrebbero imposto; il servizio del debito pubblico, appena di 90 milioni nel 1860, era già salito a 220. Sella non si scoraggì: propose di procurare al tesoro 70 milioni mediante una anticipazione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni demaniali e una alienazione di altri buoni; quindi di esigere dal paese l'anticipazione dell'imposta fondiaria del 1865. Quest'ultimo provvedimento era così grave che il Ricasoli da lui interpellato non osò approvarlo. Nondimeno [250] fu insufficiente. In quella febbre del fallimento Sella, spingendo sino alla minuzia il proprio sistema di risparmio, ritagliò la lista civile del re e lo stipendio dei ministri, affermando di volere 60 milioni di economie su tutti i bilanci oltre 40 milioni di aumento nelle imposte esistenti. Al principio del 1865 mancavano sempre 625 milioni pel servizio di cassa, e che bisognava ottenere vendendo per 200 milioni di beni demaniali e contraendo un prestito di altri 425 milioni. Il problema delle finanze italiane pareva riprodurre quello del mitico Sisifo.
Malgrado tale sinistra evidenza il Minghetti, e con lui la maggior parte degli economisti parlamentari, si stordivano ancora nella speranza che con alcune riforme, economie, piccole tasse nuove e ritocchi alle vecchie si potesse arrivare al pareggio. Non si osava affrontare la verità finanziaria e si giuocava di equivoca abilità per nasconderla al paese, onde colui, che si arrischiasse di esporla per cercarvi i rimedi, ne fosse come l'inventore ed il responsabile. Invece la situazione peggiorava: nel 1865 era già più difficile ridurre il disavanzo da 265 a 165 milioni che non nel 1863 raggiungere il pareggio. Nessuna delle grandi tasse vigenti aveva ancora abbastanza elasticità per forzarne di altri 100 milioni il reddito. Dopo aver diviso le spese in tangibili ed intangibili, quelle per 485 e queste per 443 milioni, si doveva convenire che anche sulle prime diventavano impossibili serie economie, giacchè esercito e marina avevano continuamente d'uopo di aumenti, e le opere pubbliche si dovevano proseguire per sviluppare la ricchezza nazionale. A conti fatti lo stato spendeva annualmente circa 300 milioni più delle proprie entrate.
In tali condizioni, mentre la borghesia gravata precipuamente dalla fondiaria, dalla ricchezza mobile e dal bollo e registro, inalberava ad ogni nuovo accenno di tasse, non restava più che colpire la massa del popolo con un'imposta sulla macinazione dei cereali, sebbene il governo avesse già dovuto abolirla in tutte [251] le provincie annesse come per anticipazione di maggiore benessere materiale. Il Sella, abbastanza bene istrutto della miseria delle popolazioni agricole, sulle quali il nuovo balzello avrebbe più duramente pesato, esitò a proporlo, e non vi si risolse che attirato egli stesso dalla vertigine di una più profonda tragedia finanziaria. Nessun altro mezzo finanziario si presentava allora capace di produrre 100 milioni all'erario; la camera, bigottamente proclive ad accordi con Roma, riservava la vendita dei beni delle corporazioni religiose per una convenzione anche peggiore di quella di settembre, e che andò poi fortunatamente fallita: impossibile pensare ad un incameramento dei beni delle parrocchie. Solo una tassa del macinato, gravando indistintamente tutti i contribuenti, poteva supplire ai più urgenti bisogni dell'erario. Di giustizia distributiva nel sistema finanziario d'allora non era il caso di parlare; ma per una delle solite contraddizioni politiche quella stessa borghesia, che spingendo il bilancio dello stato a precipizio sulla china delle spese cercava con egoistica avvedutezza di sottrarsi alle imposte necessarie, si opponeva al macinato in nome del popolo, meno ancora per pietà della sua condizione che per un rimasuglio di classicismo economico non scevro di qualche timore. Infatti nessun balzello poteva in quel momento essere più doloroso al popolo delle campagne. Al primo parlarne fu quindi un tolle generale: l'opposizione scoppiò nel seno stesso del ministero. Il Lanza si dimise dagli interni: il Sella, travolto dall'improvvisa bufera, dovette anch'egli ritirarsi fra la disapprovazione della camera e le maledizioni del paese, che lo accusava d'insensata ferocia per aver voluto tentare una cura radicale del male fatto da tutti.
Gli succedette lo Scialoia.
Ma poichè la situazione rimaneva la stessa, questi dovette cacciarsi nel medesimo solco pur non osando sostenere il disegno del macinato e cercando indarno di sostituirlo con una imposta sulle bevande. Il pubblico [252] percosso da tanti allarmi pensò allora con infantile rettorica di rimediare ogni male per mezzo di un consorzio nazionale costituito in Torino a raccogliere offerte e capitalizzarle sino a poter saldare tutto il debito nazionale. Così, mentre la nazione rifiutava di assoggettarsi alle imposte necessarie, si credeva da alcuni che avrebbe potuto offrire volontariamente più delle imposte. Intanto l'alleanza colla Prussia e l'imminenza della nuova guerra contro l'Austria rendevano più difficile la situazione finanziaria. Si dovette ottenere dal parlamento la facoltà di provvedere alle finanze con mezzi straordinari, e si giunse al corso forzoso autorizzando con decreto reale la banca nazionale ad emettere per 250 milioni di biglietti. Quindi la guerra distrasse l'attenzione del paese a maggiori pericoli.
Sella, cui si voleva dare il ministero della marina, lo ricusò per andare commissario nel Veneto, ove rese segnalati servigi. Finita la guerra, si trovarono enormemente cresciuti il debito pubblico e le spese. Lo Scialoia soccombette dopo aver proposto qualche scarso espediente e rinnovato le illusioni del Minghetti; il Depretis, passando dal ministero della marina a quello delle finanze, non vi fece molto miglior figura. Poi venne la volta del Ferrara, il maggiore economista d'Italia, che dopo aver difeso teoreticamente la tassa del macinato aiutandovi persino il Sella negli studi, non osò imporla alla Camera. Nel 1867 il disavanzo era ancora di 260 milioni e si prevedeva nel 1868 di altri 180: al dicembre dello stesso anno occorrevano 580 milioni. Non si ardiva nè ricorrere a prestiti, nè aumentare la circolazione cartacea: i 600 milioni, che si potevano ricavare dall'asse ecclesiastico, bastavano appena a liquidare il passato.
La caduta del ministero Rattazzi per la catastrofe di Mentana salvò il Ferrara dalle finanze, e vi trasse il Cambray-Digny. Nessuno aveva arrischiato di attuare quanto il Sella aveva proposto; ma le condizioni dello stato seguitavano a peggiorare. Il nuovo ministro, [253] segnalando il disavanzo del 1869 in 240 milioni, dichiarò che negli anni seguenti sarebbe sempre aumentato sino a rendere impossibile ogni rimedio. Allora la tassa del macinato, ripresentata dal ministero con parecchie e non buone modificazioni, passò per opera specialmente di Sella. Questo tardo trionfo di finanziere segnò la sua condanna di uomo politico: tutti gli odii si scaricarono sopra di lui perchè tutti sapevano come alla sua tenacia si dovessero precipuamente i continui sacrifici di denaro imposti al paese. Ma nemmeno l'imposta del macinato bastava più a vincere il disavanzo: si dovette aumentare il corso forzoso, cedere per 180 milioni anticipati il monopolio dei tabacchi ad una regìa cointeressata, con patti così onerosi per lo stato e con sì loschi intendimenti che il Sella e il Lanza offesi nell'onestà vi si opposero accanitamente quantunque invano.
Intanto la lotta dei partiti alla camera rendeva sempre più difficile l'accettazione di un vero disegno finanziario. Il Sella per il liberalismo delle proprie idee avrebbe dovuto sedere a sinistra, ed era respinto a destra dall'opposizione rivoluzionaria di quella; la destra invece lo accusava di giacobinismo; la sua indipendenza dai partiti lo rendeva malviso a tutti; l'austerità di qualche rimprovero sfuggitogli aveva irritato contro di lui la corte, mentre nella stampa quotidiana e su dalle piazze saliva un ignobile coro d'improperi intorno al suo nome. Fra tanti nemici non un amico dei molti allora in favore del pubblico che lo difendesse. Nella fantasia popolare e nell'opinione stessa della camera egli solo rappresentava la necessità di sempre nuovi sacrifici, offendendo simultaneamente l'egoismo delle masse e la falsa abilità dei politicanti.
Quindi il Cambray-Digny potè troppo tardi applicare alcune idee del Sella, quando anche i più riottosi dovevano assoggettarvisi, senza esserne odiato e ottenendo presto il perdono dell'oblio; mentre a Sella tornato ministro alla vigilia della conquista di Roma [254] crebbero gli odii plateali e le inimicizie parlamentari.
Il suo terzo ministero delle finanze fu il più glorioso. Senza tener conto della sua influenza decisiva sulla corte per impedirle una alleanza colla Francia e per spingerla alla conquista di Roma, in esso meritò l'eterna riconoscenza della patria col trascinare finalmente tutti i partiti a seguirlo nell'opera suprema della ricostituzione finanziaria. Gli insuccessi di tutti i ministri, succedutisi dopo di lui alle finanze e costretti direttamente o indirettamente a riconfermare i suoi disegni, aveva persuaso anche i suoi più intransigenti avversari che egli solo era abbastanza onesto d'ingegno e potente di volontà per salvare la nazione dal fallimento. Se le resistenze dottrinarie della sinistra e le subdole riserve della destra lo impacciavano ancora nell'opera, quella da lui prestata alla conquista di Roma e l'eroica prova di oramai dieci anni contro la crescente rovina della nazione toglievano ai nemici l'autorità necessaria per abbatterlo.
Così, assumendo il portafoglio delle finanze, prima ancora che l'immane conflitto fra Prussia e Francia fosse scoppiato, nell'esposizione del 10 marzo 1870 egli presentò il conto generale dell'amministrazione dal 1862 al 1867 e la situazione del tesoro 1868-69. In tale quadro duramente colorito, la vita pubblica e segreta della nazione si rivelava per la prima volta alla coscienza pubblica. Naturalmente il conto risentiva della confusione rivoluzionaria, nella quale la nazione si era costituita, ma spiegava abbastanza chiaramente la lotta sostenuta dalla nazione per accrescere le entrate ordinarie e diminuire le spese di amministrazione. Dal 1862 al 1870 le prime erano salite da 471 a 880 milioni, mentre le seconde, quelle tangibili, erano discese da 681 a 441 milioni. Il miglioramento avrebbe quindi dovuto essere di 649 milioni, e dacchè il disavanzo ordinario del 1864 era di 210 milioni, l'avanzo finale non poteva non raggiungere i 200 milioni. Invece il disavanzo era di 450 milioni, perchè negli ultimi otto anni per riparare alle deficienze dei bilanci si [255] erano contratti per 4 miliardi di debiti e cresciute le spese intangibili da 239 a 670 milioni.
Si erano fatti sacrifizi enormi, ma non a tempo e con giusti criteri.
Malgrado tutti gli sforzi il disavanzo del 1871, detratti i rimborsi dei debiti redimibili, rimaneva sempre di 110 milioni: Sella ne chiedeva 25 alle economie, 10 di più al macinato, 2 alle volture catastali, 40 ai centesimi addizionali della ricchezza mobile sottratti ai comuni e alle provincie per attribuirli allo stato, altri 10 al dazio consumo e gli altri a minori provvedimenti. Pei 200 milioni mancanti alla cassa presentava una nuova convenzione colla banca nazionale, che portava a 500 milioni il debito dello stato verso di essa e la dispensava dall'obbligo della riserva metallica, pari all'ammontare dei mutui.
Per garanzia il governo le avrebbe concesso in deposito 588 milioni di obbligazioni dell'asse ecclesiastico.
Così si sarebbe raggiunto non già un pareggio assoluto nel bilancio, ma un equilibrio fra l'attivo e il passivo, mettendo fuori conto i rimborsi dei debiti estinguibili ai quali si sarebbe provveduto con operazioni di credito. La camera votò questo «omnibus» finanziario, ma il Sella, oppugnato vivamente dalla sinistra, dovette imprigionare per sempre la propria libertà nella destra.
L'Italia aveva finalmente superata l'ardua prova economica.
La conquista di Roma venne a scomporre da capo tale disegno finanziario. Nuovi debiti dallo stato pontificio passarono nel regno d'Italia; altre spese per l'impianto della capitale e per aumenti nell'esercito e nell'armata, resi necessari dalle inimicizie create alla nazione dalla sua ultima fortuna, tornarono ad ingrossare il passivo nei bilanci. Nullameno la potenza economica della nazione pigliava il sopravvento. Il debito pubblico in un decennio era salito da 2300 milioni a 8200, cosicchè la parte intangibile del bilancio [256] da 200 milioni toccava i 719; il movimento commerciale da 1400 milioni sommava ora a 1960; le esportazioni, prima inferiori di quasi 400 milioni alle importazioni, ora le superavano di più che 100; i vaglia postali da 22 milioni era ascesi a 260, triplicato il movimento telegrafico, le ferrovie da 2200 chilometri allungate a 6200 e i loro viaggiatori da 15 milioni aumentati a 25. Gli stessi buoni del tesoro in provincie, che appena li conoscevano, oltrepassavano adesso i 130 milioni.
Questa la situazione nazionale al cominciare del l'anno 1871.
Il pareggio era ancora lontano. Altri 200 milioni mancavano al servizio di cassa per l'anno 1872. Sella dovette rammendare tutto il proprio disegno finanziario per ripresentare un secondo «omnibus» di cinque anni così: passare il servizio di tesoreria alle banche con un risparmio di 100 milioni di fondo di cassa; esigere i proventi delle obbligazioni ecclesiastiche destinate a diminuire il credito della banca nazionale, assegnando a questa altrettanta rendita publica ed accrescendo così l'entrata durante il quinquennio di circa altri 100 milioni; aumentare la circolazione cartacea della banca nazionale per conto dello Stato; ottenere ancora 100 milioni da aumenti sul bollo e registro e sopra alcuni dazi; diminuire la spesa di 130 milioni mediante la conversione facoltativa del prestito nazionale in rendita consolidata.
Gli oppositori, che sino allora avevano accusato il Sella di troppo corta vista, gli contrastavano ora questo disegno di un quinquennio; la battaglia alla camera fu vivissima: solo la paura in tutti di rovesciare con lui il ministero gli lasciò anche per questa volta la vittoria. Poi nell'ultima esposizione del 1873 egli vinse ancora salvando il pareggio da altri aumenti di spese militari e soffocando la Camera con disperata energia nelle strette dell'eterno dilemma, o restare nell'orbita dell'«omnibus» già votato o perire nel mare senza riva del disavanzo. Ma la sua posizione politica [257] era diventata insostenibile. Sella potè ancora resistere qualche tempo, poi travolto da una coalizione parlamentare, quando già il pareggio finanziario, al raggiungimento del quale aveva sacrificato tutto se stesso, era in vista, cadde dal ministero per non più risalirvi.
Questo onore del pareggio doveva qualche anno dopo toccare al Minghetti, perchè dietro ogni Cristoforo Colombo vi è sempre un Amerigo Vespucci.
Ma l'eroe della finanza italiana, in questa lotta decennale senza tregua e senza conforto, fu il Sella. Aspro, agile, indomito, egli resistè a tutto, alle diserzioni di partito, agli odii di corte, alle esecrazioni di piazza: gli avvolgimenti della politica non poterono mai impaniarlo; volle onestamente, immutabilmente, salvare l'onore della nazione nel campo economico, come Garibaldi l'aveva salvato nel campo militare e Mazzini in quello morale. Ministro e deputato, egli fu l'incubo del parlamento, che non potè mai sottrarsi all'influenza del suo pensiero e della sua volontà. La sua media natura spiegò nella mutabilità di questa lotta virtù imprevedibili. Di geologo egli si mutò improvvisamente in finanziere, crebbe a uomo di stato quando alla caduta dell'impero napoleonico il governo stremato dalla lunga abitudine del vassallaggio alla Francia tremava ancora dell'andare a Roma. Sdegnò popolarità e fama: fu austero, ironico come la più parte dei moralisti che passano dall'ammonizione all'azione; ebbe attività incomparabile, che lo rese vecchio a cinquant'anni, e l'uccise anzi tempo.
Mentre la politica di tutti i partiti del risorgimento nazionale si esauriva in una fatale decadenza, l'Italia affermò con Sella la propria vitalità economica e civile. La resistenza provata dal paese in tale arringo fu delle più ammirabili in questo secolo, giacchè sotto la minaccia continua del fallimento, dal fondo dell'antica miseria e coll'incapacità secolare della vecchia educazione, si pose mano all'improvvisazione di un grande stato. Agricoltura, commercio, industria, [258] esercito, armata, scuole, banche, casse postali, associazioni operaie di mutuo soccorso, ferrovie, strade provinciali e comunali, fori alpini ed appenninici, porti, canali, arsenali, tutto fu simultaneamente improvvisato. L'emancipazione dai mercati stranieri seguì all'indipendenza politica, la concorrenza ci animò invece di prostrarci, nei rischi delle nuove imprese mescemmo il coraggio del ricco alla temerità del povero; onde l'Europa, che dopo averci rimessi in piedi si aspettava forse ad una seconda Grecia o ad un altro Belgio, si trovò dopo dieci anni davanti una terza Italia, seduta fieramente a Roma sulle rovine del potere temporale, pronta a difendere le proprie Alpi con un milione di soldati, e a gettare in mare dai propri cantieri le più grandi corazzate del mondo.
Mentre nella dissoluzione dei partiti l'Italia cresceva a forte stato costituzionale, la grande occasione politica, che doveva risolvere il suo problema di Roma, maturava.
La tradizione di Richelieu non era morta nella diplomazia francese.
L'impero napoleonico giudicava ancora indispensabile alla propria fortuna la divisione e l'abbassamento di tutti i vicini, onde questa sua teoria rafforzata da lunghi esempi storici cresceva a passione nell'orgoglio della nazione per mantenere sull'Europa un primato impossibile. La millenaria antitesi della storia francese, sempre rivoluzionaria e sempre monarchica, peggiorava il carattere geloso di tale pretesa. La Francia era pronta a tendere la mano a tutti i popoli, ma per mutarli in proprii clienti: quindi la forma quasi sempre militare delle sue iniziative la tirava a maniera di conquista, o l'antagonismo dei propri interessi coi loro la fermava a mezzo delle migliori imprese. Generosa ed insolente, prodiga e speculatrice, fanatica di libertà e di dittatura mobile, avventuriera, ricca, altrettanto imprudente nell'ira dell'attacco che incerta nel coraggio della resistenza, la Francia era però sempre il centro della politica europea, e non sospettava nemmeno che, il progresso dell'Europa essendo appunto nella [260] creazione di altri centri indipendenti, il principio di nazionalità dovesse riprenderle sul Reno due provincie.
Nulla poteva più arrestare la decadenza dell'impero napoleonico.
Succeduto con sanguinario processo alla impotente republica del 1848 promettendo al popolo ordine ed uguaglianza, gloria e prosperità, esso non era in fondo che una forma della democrazia non ancora arrivata alla capacità di governare se stessa. La sua missione era quindi di fortificare la coscienza nazionale in altri vent'anni di opposizione politica interna, e di mantenere alla Francia le iniziative di nazionalità nella politica estera; e l'impero si era sdebitato abbastanza bene di questi due compiti, fondando l'Italia e l'Internazionale, il maggior fatto politico e il maggior fatto sociale del secolo in Europa. Ma la sua base, fatalmente clericale, poichè i monarchici legittimisti e orleanisti l'osteggiavano, e la sua vita signoreggiata da irresistibili tendenze militari ed avventuriere, erano consunte. Così dopo aver difeso la Turchia contro la Russia per conservare contro di questa il proprio primato in Europa, e improvvisata l'Italia per mutarla in una quasi luogotenenza francese, l'impero era stato trascinato dal gran sogno napoleonico al Messico per creare coll'arciduca Massimiliano d'Austria un altro impero e un'altra supremazia francese nel nuovo mondo. Ma la Russia, arrestata un istante a Sebastopoli, proseguiva e prosegue tutt'ora nel proprio irresistibile moto d'espansione; l'Italia agglomeratasi a regno oltre e contro i disegni napoleonici accennava già per rigoglioso ed irrefrenabile sviluppo di modernità a porsi come rivale della Francia: nel Messico Benito Juarez, dopo aver fucilato l'imperatore Massimiliano a Queretaro e costretto l'esercito francese a rimpatriare, proclamava una repubblica poco minore di quella degli Stati Uniti.
La necessità per l'impero francese di appoggiarsi sul clericalismo contro l'irrompere della nuova democrazia, [261] vietando Roma agli italiani, aveva tolto a questi dopo la tragedia d'Aspromonte e l'eccidio di Mentana ogni gratitudine; mentre la Prussia, cacciatasi finalmente alla testa della Germania, dopo le proprie strepitose vittorie del 1866 minacciava di costituire nel centro di Europa un impero nazionale più vasto e poderoso di quello napoleonico.
In Francia l'opposizione liberale e antidinastica era sempre venuta guadagnando terreno: il socialismo imperiale sorpassato da quello operaio si mutava nelle mani di Carlo Marx nella più vasta e minacciosa associazione internazionale non solo contro l'impero ma contro tutti i governi. Le vittorie prussiane avevano annebbiato lo splendore delle ultime glorie francesi, la supremazia diplomatica dell'impero era già scossa, nessuna classe lo sosteneva più all'interno, nessuna idea all'estero. Il guasto del metodo corruttore e le contraddizioni della politica dinastica con quella nazionale affrettavano fatalmente la sua decadenza.
L'imperatore, ammalato, fra una corte di bigotti e d'impiegati, non aveva in se stesso potenza capace di trascinare la nazione. Poichè non era mai stato nè generale nè statista, cominciava ora a fallire come uomo di governo e come diplomatico: una inguaribile rilassatezza intorpidiva il suo pensiero. Così, prima di essere espulso quale sovrano, dovette decadere da imperatore, abbassandosi volontariamente a subire un ultimo esperimento di governo costituzionale.
Ma contro l'impero napoleonico sorgeva minacciando la monarchia prussiana.
Già all'indomani della vittoria di Sadowa il conte di Bismarck aveva esclamato orgogliosamente: «il giuoco non è ancor vinto, non è che raddoppiata la posta»; in Francia invece quella vittoria produceva la dolorosa impressione di una sconfitta nazionale. L'intromissione diplomatica tentata da Napoleone a favore dell'Austria piuttosto che salvare la dignità della supremazia francese l'aveva compromessa, poichè il conte di Bismarck, avendo potuto prima della guerra [262] abbindolarlo con una vaga promessa di cessione del territorio fra la Mosella e il Reno senza Coblenza e senza Magonza, era poi riuscito a tenerlo a bada per tutti i preliminari della pace di Praga: quindi, sicuro della nuova Confederazione del nord, lo aveva duramente respinto. Ma la politica imperiale francese, qualificata sdegnosamente dal grande cancelliere prussiano come una politica di mancie, doveva subire in Germania una serie di smacchi sempre più umilianti. Poichè sino dal 1863 il conte di Bismarck aveva contrapposto al disegno austriaco di riforma federale l'idea di un parlamento a suffragio universale diretto, fu sollecito di aggiungere a questo Reichstag un Bundesrath o Consiglio federale, composto dei delegati dei vari stati della Confederazione, formando così una specie di corpo legislativo bicamerale. In esso la Prussia dominava con una popolazione di 24 milioni sopra 6 milioni degli altri ventuno Stati confederati. Poco dopo un altro parlamento doganale sostituiva l'antico Zollverein cementando l'unità economica della Germania; quella politica non poteva tardare molto a trionfarvi.
Tale rudimentario ordinamento risultava da una serie di compromessi, nei quali i partiti rivoluzionari si acconciavano a subordinare le questioni astratte di libertà a quelle della costituzione nazionale. Le pretese dell'impero napoleonico sulla riva sinistra del Reno, che la Prussia avrebbe dovuto cedergli come scotto della propria egemonia, urtavano quindi nel sentimento patriottico della Germania ben più forte che non quello d'Italia nel 1859, e risoluto dopo le vittorie sull'Austria a non patire diminuzioni. Tutto il genio del conte di Bismarck, mutatosi da rappresentante del Junkerthum prussiano in atleta dell'unità germanica, si tendeva nell'opposizione contro la Francia, rispondendo col più intrattabile orgoglio di patria alle minacce di una diplomazia oramai divenuta impotente. La risolutezza del carattere e la semplicità di una politica inflessibile nel proprio scopo dovevano necessariamente assicurargli la vittoria sopra un avversario [263] come Napoleone, da lui paragonato ironicamente a Tiefenbacher, il più irresoluto dei generali di Wallenstein. E poichè Napoleone, malgrado le sollecitazioni della regina d'Olanda e del ministro Drouyn de Lhuys, non aveva osato marciare sul Reno mentre la Prussia convergendo nel 1866 ogni sforzo su Vienna aveva lasciato indifese tutte le proprie frontiere, l'insufficienza della Francia contro di quella si era già rivelata. Quindi l'ostilità svolgendosi in una lotta diplomatica permise al conte di Bismarck di prepararsi meglio alla guerra.
Il suo disegno non poteva essere più semplice. Mentre la Russia per punire Austria e Francia della guerra di Crimea fingeva di non occuparsi del centro d'Europa, e l'Austria, affranta dalle ultime sconfitte, e la Francia nuovamente imbarazzata di un serotino esperimento costituzionale non avrebbero potuto arrischiarsi così presto in campo, egli badava ad attirare la Confederazione del sud, rimasta indipendente col trattato di Praga, in una lega militare che preparasse quella politica. Le pretese e le minacce della Francia capitavano a buon punto.
Il conte di Bismarck si destreggiò in tale torneo con una abilità pari se non superiore a quella del conte di Cavour.
Quindi, dopo aver ricusato superbamente ogni cessione di territorio sulla riva sinistra del Reno, per forzare gli stati del sud a stringere colla Confederazione del nord una lega militare, rivelò loro il disegno presentato dalla Francia nei preliminari di Nikolsburg, col quale si chiedeva una striscia dei territori dell'Assia e della Baviera, e che l'ingenuità del diplomatico francese De Benedetti gli aveva lasciato nelle mani. Naturalmente gli stati del sud, spaventati dai pericoli di questa rivelazione, strinsero colla Prussia un segreto trattato militare per la garanzia reciproca dei proprii territori, mettendo a sua disposizione tutte le loro truppe in caso di guerra contro lo straniero.
[264] L'intimazione di Thiers, che a nome della pubblica opinione francese aveva gridato a Bismarck dall'alto della tribuna accennando al Meno: «fin qui e non oltre!», non era più che una frase insulsamente spavalda come il jamais minacciato da Rouher agli italiani.
Ma Bismarck, per togliere alla Francia ogni aureola di liberalismo, finse abilmente di secondarla nelle mire invaditrici sino a prometterle in un trattato, cui non appose mai la firma, il proprio aiuto per annettersi il Belgio e il Lussemburgo; poi, nel momento che Napoleone credeva di restaurare il proprio credito in Europa con tali acquisti, egli si ritrasse bruscamente eccitando la pubblica opinione in Germania a così fiere proteste contro la cessione del Lussemburgo da essere costretto a minacciare l'Olanda come di un casus belli, se mai vi consentisse. Alla diplomazia francese non restava quindi altro terreno di lotta che il trattato di Praga, accusando il nuovo parlamento doganale germanico di contrastare alla Confederazione del sud ed eccitando in questa gli elementi separatisti. Ma il sentimento patriottico della Germania, esasperato da queste intromissioni straniere, precipitava nell'unità prussiana non senza qualche sorda minaccia alla Francia. Di rimpatto questa usava ogni modo di amicarsi l'Austria: un convegno a Salisburgo (27 agosto 1867) fra i due imperatori era già sembrato il prologo di un'alleanza, che l'antagonismo degli interessi non aveva permesso; poco dopo l'eccidio di Mentana Vittorio Emanuele aveva tentato di rannodare tali pratiche. I tre sovrani trattavano segretamente con diplomatici di corte; nè ministeri, nè parlamenti da principio sapevano delle trattative, ma l'impossibilità per Napoleone di fare qualche concessione all'Italia su Roma impedì ogni alleanza.
Allora si diffuse per tutta Europa una grande illusione di pace come una di quelle abbaglianti serenità che sogliono precedere le tempeste.
Contemporaneamente in Italia il partito mazziniano dava gli ultimi tratti e il papato, quasi presago della fine del proprio regno, riuniva in San Pietro un concilio ecumenico per stabilire il dogma dell'infallibilità pontificia. Il principio dell'autorità divina, rappresentato per tanti secoli da pontefici e da re, doveva necessariamente ripiegarsi, dai campi della politica conquistati dal principio razionalista della sovranità popolare, sul cattolicismo come sulla religione più alta dell'umanità e nella quale il governo diretto di Dio era più evidente. I miti della redenzione di Cristo e della sua delegazione a San Pietro avevano fino dai primi tempi dato alla chiesa un forte carattere monarchico: l'unità da questa assorbita nell'impero romano, la sua intuizione di Roma come centro del mondo, l'importanza acquistatavi grado grado, l'alleanza cogli imperi medioevali, avevano messo il papato al disopra della chiesa stessa in una sfera di autorità che abbracciava tutta la vita umana. Naturalmente il papato vi si sviluppò a monarchia. L'antico principio democratico della chiesa cristiana perì nella sua stessa vittoria sul mondo. I primitivi modi democratici d'elezione dovettero cangiarsi, quando nel troppo vasto e molteplice impero cattolico diventò impossibile ai fedeli raccogliersi regolarmente in comizi per nominare il capo e i maggiorenti della chiesa. Il mondo era troppo immenso e scarso allora di mezzi di comunicazione perchè tale procedura fosse anche solo materialmente possibile.
Quindi più alte necessità teoretiche nelle guerre impegnate successivamente colla decadenza romana, coi barbari, colle eresie, costrinsero la chiesa a sempre maggiore unità di comando. La sovranità del papa vi derivava già dallo stesso concetto monarchico del Dio cristiano: una essendo la rivelazione, una doveva essere la sua interpretazione; la rivelazione essendo stata precisa doveva esserne preciso l'interprete; un [266] concilio di vescovi sarebbe stato fatalmente democratico, e col fluttuare delle opinioni avrebbe scosso la fede nei credenti. Il cristianesimo discendendo dal mosaismo era unitario. Il papato lentamente, irresistibilmente, assorbì tutti i poteri della chiesa: le corporazioni monastiche lo aiutarono nella lotta contro il clero regolare, Roma gli dette tradizione e prestigio di unità, le guerre incessanti della chiesa abituarono amici e nemici a riconoscere nel suo generale supremo il rappresentante assoluto dell'istituzione: quindi il papato crebbe al più ideale e vasto impero, che mai il mondo avesse conosciuto. L'organizzazione gerarchica restringendosi vieppiù, cinse il papa di un senato di cardinali, fra i quali e dai quali solamente poteva essere eletto: i vescovi furono come gli antichi prefetti romani nelle Provincie, i monaci vi rappresentarono gli accampamenti stabiliti dalle legioni, i parroci vi tennero il più minuto governo, mentre tutto si accentrava a Roma, donde il papa con un solo ordine, in una lingua morta e abilmente mantenuta come espressione della prima unità mondiale, poteva imprimere un moto a tutto l'orbe.
Durante il lungo tumulto medioevale il papato per istinto e per ragione fu quasi sempre guelfo, favorendo lo sviluppo dei principii popolari: i suoi pontefici vi esaurirono tutte le varietà dei vizi e delle virtù, delle verità e degli errori, senza che l'istituzione potesse seriamente pericolare. Ma il Rinascimento, sorpassando teoricamente il cristianesimo, diminuì il papato quantunque gli ampliasse il regno. Il mondo fu scoperto più vasto della missione di Cristo, l'universo maggiore della creazione di Dio. Allora la guerra delle eresie si mutò in guerra d'incredulità; il cristianesimo di rivoluzione si cangiò in reazione, il pensiero si sottrasse a ogni dogma, la scienza ruppe tutti i limiti ecclesiastici, la filosofia sorpassò le maggiori altezze delle religioni, il diritto politico ritemprandosi nel diritto naturale tornò democratico.
[267] In questa ultima guerra la vittoria decisiva fu guadagnata dalla grande rivoluzione francese. Il papato vi perì idealmente con tutte le monarchie.
La Santa Alleanza rappresentò la reazione del pensiero cattolico nella coalizione di tutte le monarchie; ma il papato, essendo più alto di loro nella lotta politica e toccando davvero al divino, doveva restringersi in se medesimo per spingere il proprio principio monarchico al disopra di ogni contatto umano, mentre esse cadevano nell'inevitabile ed assurda transazione del costituzionalismo. L'infallibilità pontificale, sempre latente nel cattolicismo, era l'ultima risposta del principio monarchico al principio democratico. Così l'eterno dualismo della storia ritornava alla semplicità dei propri dati. Il concilio ecumenico riunito in San Pietro (1869) compiva l'evoluzione del papato nel momento che l'impero napoleonico, ultima larva dell'impero di Carlomagno, stava per sparire, e il principio democratico di Lutero per trionfare in Germania fondandone un altro. Nelle Spagne l'impero di Carlo V aveva ceduto il luogo ad una republica effimera, arra di republica avvenire; il Sacro Romano Impero non era più a Vienna che un impero eteroclito; solo l'impero russo si dilatava potente di avvenire, e l'Italia riprendeva per un istante il proprio posto all'avanguardia della civiltà disponendosi ad inaugurare in Roma l'èra del diritto popolare.
Infatti il concilio ecumenico, sorpreso dalla rivoluzione, potè appena proclamarvi l'infallibilità del papa; quindi dovette aggiornarsi per essere riconvocato chi sa quando.
Ma se il papato saliva così a più alta sfera di idealità, il suo governo a Roma era caduto dopo Mentana nella più umiliante insignificanza. Roma non era più che un'immortale rovina cinta dal deserto del proprio agro. Le locomotive solcandolo parevano sperdute in un lembo di storia antica tra mandriani vestiti ancora come ai tempi delle Georgiche, e che le guardavano passare nere e fumiganti colla stessa indifferenza [268] dei bufali. Dell'antica università restava appena il vestigio; in essa non si trovava che un solo microscopio di vecchissimo modello; pel gabinetto o laboratorio di fisica non si spendevano che 1151 lire, per quello di zoologia e di anatomia comparata 1347, per l'altro di mineralogia 274, per la biblioteca Alessandrina, l'unica che fosse dello stato, 1453. Mancavano cattedre, professori, libri, studenti. Non più arti, nè artisti all'infuori degli stranieri che vi convenivano a studio; deserto il municipio, mentre nel Vaticano si affollavano prelati di ogni lingua, inconsapevoli dell'epoca nella quale vivevano, e superbi dei ventimila mercenari sbraveggianti per la città.
L'odio della curia romana alla democrazia era minore deò suo disprezzo per il regno d'Italia. Infatti le umiliazioni inflitte a questa dall'impero napoleonico per mantenere Roma sotto la sovranità del papa erano poco adatte a far concepire del giovane stato una idea lusinghiera. La stessa ultima lunga crisi ministeriale, dalla quale era uscito finalmente il ministero Lanza-Sella, faceva sperare ai più reazionari fra i prelati una prossima dissoluzione del regno. La fede nella solidità dell'impero napoleonico era loro cresciuta da che la reazione, guidata dall'imperatrice Eugenia, vi dominava maggiormente nella politica; la fortuna nascente della Prussia non inquietava; si sapeva che l'Austria si era risollevata da ben altri rovesci, e che la Francia era intatta. Nell'eventualità di una guerra di questa colla Prussia non solo i voti, ma tutte le convinzioni stavano per una vittoria francese.
I maggiori generali d'Italia non opinavano allora diversamente.
Intanto le probabilità di questa guerra aumentavano di giorno in giorno.
Attraverso le reiterate affermazioni di pace Austria e Francia spiavano un'occasione propizia all'attacco: non v'era fra loro alleanza, perchè ognuna avrebbe voluto [269] profittare del vantaggio di entrare seconda nella lizza; in Italia l'esercito e la dinastia per bisogno di rivincita erano favorevoli alla guerra; la borghesia per interesse e i patrioti per sentimento vi si chiarivano invece contrari. Ma poichè all'Italia come all'Austria e alla Francia mancava una vera cagione di guerra, in nessuna delle tre nazioni se ne spingevano alacremente i preparativi; solo la Prussia sentendone profondamente la necessità per compiere la propria unità nazionale, vi si accingeva con superba passione di patria.
Il caso fu pòrto dalla Spagna coll'offerta della propria corona al principe Leopoldo di Hohenzollern. La Francia, che nel secolo scorso aveva trapiantato un ramo della propria dinastia sul trono di Carlo V, inalberò alla minaccia di questa nuova espansione prussiana; tutte le diplomazie d'Europa n'andarono sossopra per impedire il conflitto; Bismarck indietreggiando abilmente provocò la iattanza della Francia; questa, non contenta della rinunzia spontanea del principe di Hohenzollern, avrebbe preteso dal re Guglielmo una categorica dichiarazione di proibire per sempre a chiunque della propria famiglia di accettare una simile candidatura.
A quest'assurda violenza il re rispose chiudendo la porta all'ambasciatore francese, e scoppiò la guerra più immane che la storia ricordi dopo migliaia di anni. La sua brevità fu vertiginosa. La Prussia avventò sulla Francia in pochi giorni un milione di soldati, ai quali l'impero non seppe opporne che la metà: tutto era in esso corruzione e sfacelo. Napoleone affidò la reggenza all'imperatrice per assumere nominalmente il comando dell'esercito: sotto l'immenso plateale tumulto francese di guerra s'intendevano chiaramente gli urli di odio all'impero così efferati da invocare la sua sconfitta anche a danno della patria.
Il 2 agosto (1870) i francesi occuparono scaramucciando Saarbrück, ma il 4 agosto il principe ereditario di Prussia piombava sovra essi a Weissenburg [270] e li batteva; il 6 prostrava così Mac-Mahon a Wörth da lasciarlo appena riparare nel massimo disordine a Châlons; contemporaneamente il generale Steinmetz, superate le alture di Spichern, annientava il corpo del generale francese Frossard. La guerra era già vinta. Mentre Mac-Mahon si era ritirato per Nancy a Châlons e le reliquie del corpo Frossard si ripiegavano su Metz, il maresciallo Bazaine postovi a presidio con 250,000 uomini tentava di uscirne per non lasciarvisi bloccare; ma l'incomparabile stratega prussiano maresciallo Moltke con mosse fulminee ed impreviste lo rinserrava in un cerchio di fuoco, lo arrestava il 16 agosto a Mars-la-Tour, lo ributtava il 18 da Gravelotte su Metz, chiudendovelo prigioniero. Quindi tutto lo sforzo di Mac-Mahon, che con lunga marcia circolare tentava di congiungersi a Bazaine, era non solo perduto, ma si risolveva nel più disastroso degli errori; giacchè Moltke, indovinando abilmente quel disegno, con un movimento di fianco a destra e una marcia di tre giorni lo raggiungeva a Beaumont, lo stringeva, lo catturava a Sedan (1º settembre) con tutto l'esercito di 70,000 uomini.
La Francia era vinta, l'impero napoleonico distrutto. L'indomani il vincitore, pubblicando l'inventario delle prede, lo cominciava con epica brutalità così: 1 imperatore!
Napoleone III vinto e prigioniero non aveva saputo nè combattere, nè vincere, nè morire: la caduta del primo Bonaparte era stata una rovina, quella del terzo fu un dilanio: quegli aveva fondato l'impero, questi lo aveva esaurito. Dopo Augusto, Augustolo.
L'Europa rimase per qualche tempo stupita: a Roma il papato, rialzato come altare votivo della vittoria dal primo impero napoleonico, si sentì trascinato dalla lavina del secondo.
[271] Malgrado la catastrofe di Mentana e le ripetute infrazioni della Convenzione di settembre, la politica governativa italiana non accennava a mutare d'indirizzo; in essa la diffidenza verso la rivoluzione era più viva che non il dispetto per le incessanti vessazioni imperiali; Mazzini restava sempre un ribelle specialmente dopo i conati delle ultime bande, e Garibaldi un avventuriero pericoloso, al quale si erano dovute sottrarre tutte le conquiste per ragioni di ordine pubblico, e del quale le imprudenze avevano più di una volta compromesso la monarchia. Dopo tanti ordini del giorno su Roma capitale d'Italia non si voleva arrischiare mossa alcuna per giungervi. Si diceva che il sentimento cattolico di tutto il mondo la difendeva, mentre invece l'Inghilterra era protestante, protestante la Prussia, eterodossa la Russia, la Spagna si era già ribellata in republica, e la Francia stava per imitarla. L'Austria sola aveva un governo cattolico, ma dopo le ultime sconfitte non era più nè capace nè vogliosa di ritentare una guerra di santa alleanza.
Nullameno ministero e maggioranza parlamentare avrebbero voluto allearsi coll'impero caduto per cansare la responsabilità di sopprimere il papato temporale.
Vittorio Emanuele, così freddamente ingrato con Garibaldi, affettava la più cavalleresca riconoscenza per Napoleone III. Orgoglio ed egoismo di piccolo re gli persuadevano questa differenza verso i due alleati, che gli avevano composto il regno. Malgrado l'abbandono di Villafranca, l'oltraggiosa cessione della Venezia, Aspromonte e Mentana, egli avrebbe voluto marciare con tutto l'esercito in aiuto dell'impero, lasciando Roma in mano del papa ed ingannando la nazione colla speranza che l'imperatore concederebbe poi un giorno spontaneamente all'Italia la propria capitale.
Infatti alla proclamazione di guerra nella Camera francese, Vittorio Emanuele telegrafò subito al presidente del consiglio da Valsavaranche, ove cacciava, avvisandolo del proprio ritorno alla capitale per deliberare [272] sul da farsi: «si ricordasse però che egli (il re) aveva degli impegni». A corte e negli alti circoli governativi si era così fermamente convinti del trionfo dei francesi da non ammettere nemmeno l'ipotesi contraria: quindi da un'alleanza colla Francia vincitrice si sperava qualche rettificazione delle frontiere verso Nizza o verso il Tirolo. Quanto a Roma si evitava di pensarci, ripetendo la formula cavouriana della conquista per mezzi morali. Solo il Sella, convinto di un'altra vittoria prussiana, sosteneva pertinacemente l'idea della neutralità, nascondendo le proprie idee sullo scioglimento della questione romana, del quale sentiva giunta l'ora. Il ministro degli esteri Visconti-Venosta si destreggiava intorno all'idea della neutralità senza osare di risolvere; il Lanza presidente del consiglio vi si mostrava da principio favorevole per abitudine di circospezione.
In tutti prevaleva una deferenza spassionata per Napoleone III, come al primo fattore e al miglior patrono d'Italia. Vittorio Emanuele sempre più accalorato in questo sentimento discese alle più grossolane ingiurie contro il Sella.
— Si vede bene che ella viene da mercanti di panni, gli urlò una volta sul viso, dopo avergli detto sprezzantemente che per fare la guerra ci voleva del coraggio.
— Sì, maestà, rispose con altera ironia il ministro; ma da mercanti di panno che hanno sempre fatto onore alla propria firma, mentre questa volta vostra maestà firmerebbe una cambiale che non sarebbe sicura di poter pagare.
E ogni giorno la lotta fra Sella e Vittorio Emanuele si faceva più aspra.
Napoleone stringeva il re d'istanze per deciderlo alla guerra; l'Austria egualmente sollecitata si diceva pronta ad una alleanza, qualora l'Italia v'entrasse prima, e consigliava di modificare la Convenzione di settembre in favore di questa. Ma Napoleone non osava romperla col partito clericale; tutt'al più avrebbe condisceso [273] ad eseguire puntualmente la Convenzione ritirando una seconda volta le truppe da Roma. Allora il Sella, che aveva già dovuto consentire alla chiamata di due classi sotto le armi, fu pronto a giovarsi di questa pervicacia imperiale per spingere il ministero sull'esempio dell'Inghilterra e dell'Austria a pubbliche dichiarazioni di neutralità, mentre il conte di Bismarck in accordi segreti col partito mazziniano intendeva a provocare ribellioni in Italia per impedirle di allearsi colla Francia. Ma poco dopo, persuaso dell'influenza di Sella sul ministero, il gran cancelliere troncava le trattative con Mazzini denunciandolo. Intanto le dichiarazioni (25 luglio) del Visconti-Venosta alla camera, che il pessimo dei partiti per l'Italia sarebbe quello di approfittare dei momentanei imbarazzi della Francia per sciogliere colle armi la questione romana, scoprivano tutta la debolezza della politica governativa: la destra altrettanto favorevole alla Francia quanto ritrosa a marciare su Roma avrebbe voluto rovesciare il ministero, e non l'osò; la sinistra invece lo sostenne per timore di un ministero militare di corte col Cialdini. Il re, bloccato abilmente da Sella, seguitava a trattare coll'ambasciatore francese Malaret, assicurando l'imperatore che presto avrebbe vinto la resistenza del ministero. Questo, per secondare il ritiro del presidio francese da Roma, riaderì alla Convenzione di settembre «confidando in una giusta reciprocità della Francia a conformarsi ai propri impegni»: si credette allora in Europa a segreti accordi fra i due governi. Infatti il partito della guerra a corte aumentava d'importanza: il 30 luglio, sotto l'impressione della scaramuccia di Saarbrück vinta dai francesi, fu proposta nel consiglio dei ministri la mediazione armata, che Sella potè impedire solamente colla minaccia delle proprie dimissioni.
Quindi nell'impossibilità di stringere colla Francia e coll'Austria una triplice alleanza, si ricorse all'idea di un accordo con quest'ultima da trasformarsi in alleanza offensiva, se le circostanze lo avessero richiesto, [274] V'ebbero trattative segrete di corte: il re mandò a Vienna, poi a Metz, il conte Vimercati, suo aiutante di campo; il ministro austriaco De Beust spedì a Firenze il conte De Vitzthum con un disegno di otto articoli, pel quale l'Italia, impegnandosi ad una mediazione magari armata nella guerra franco-prussiana, sarebbe rimasta a rimorchio dell'Austria con alcune vaghe promesse di buoni uffici nella questione romana. Ma Sella rese abilmente tale disegno impossibile coll'aggiunta di un articolo pel quale l'Austria assumeva l'impegno del «non intervento nel territorio romano e di favorire l'applicazione dei provvedimenti più atti a soddisfare i voti dei romani e gl'interessi d'Italia» e con alcune clausole segrete nel caso di guerra guerreggiata in comune per una rettificazione di frontiere nel Tirolo e sull'Isonzo.
Naturalmente l'Austria ricusò.
Non meglio approdò la missione segreta affidata da Vittorio Emanuele al Vimercati. Il disegno era di una triplice alleanza: ai 15 di settembre Italia e Austria avrebbero dovuto imporre alla Prussia con un Ultimatum di rispettare lo statu quo, definito dal trattato di Praga: poi, non appena le truppe francesi fossero penetrate nella Confederazione del sud, l'esercito italiano attraverso il Tirolo sarebbe andato a raggiungerle nei pressi di Monaco appoggiandosi sulle truppe austriache; a Napoleone non si chiedeva che d'impegnarsi in un articolo segreto a fare accettare dal papa un modus vivendi coll'Italia.
Napoleone a guerra già cominciata non cedette; poco dopo il cannone di Wörth rompeva tutti questi inani accordi, e la logica fatale della storia trionfava di tutte le trattative diplomatiche.
Il partito della guerra, pel quale il Cialdini spalleggiato dalla corte aveva osato persino di minacciare il ministero in senato con un discorso che parve un pronunciamento, e cui il Sella rispose con terribile severità, era vinto: vi fu ancora una lettera di Napoleone al re, scritta nell'amarezza delle prime sconfitte; [275] se ne discusse nel consiglio dei ministri, s'interrogò il generale Lamarmora perchè indicasse un modo qualunque di soccorrere l'imperatore; ma quegli confessò piangendo di non vederne alcuno.
Quintino Sella aveva salvato l'Italia contro la corte dal partecipare alla guerra franco-prussiana; poco dopo doveva salvare la corte contro l'Italia persuadendo al re la necessità di conquistare Roma.
Il ritorno puro e semplice alla Convenzione di settembre aveva giustamente esasperato la pubblica opinione scoprendole sotto quelle eccessive simpatie verso il pericolante impero di Francia il proposito di cansare a ogni modo il problema di Roma.
La partenza dei francesi da questa cominciò il 29 luglio; il 19 agosto la città n'era sgombra. Naturalmente clero vaticano e francese ne levarono alte grida, quantunque persuasi che il governo italiano non oserebbe mai scendere a violenze. Ma il fermento cresceva nella nazione: il partito mazziniano agitava vivamente le piazze; da un momento all'altro si aspettava che nuove bande di volontari varcassero il confine pontificio; il governo incerto del risolvere sembrava incantato nella rovina dell'impero francese; mentre il Sella giovandosi del suo turbamento lo spingeva a nuovi armamenti col pretesto di poter così fronteggiare la rivoluzione.
Il 31 luglio i ministri della guerra e della marina chiedevano un prestito di 16 milioni: si cominciavano accolte di cavalli, di viveri e di attrezzi militari. Il 2 agosto le prime truppe italiane si dirigevano verso la frontiera pontificia; il 10 il consiglio dei ministri decideva la chiamata di altre due classi sotto le armi e la convocazione della camera, allora in licenza, per farle votare un prestito di 40 milioni; il 14 le truppe mobilizzate e già concentrate in alcuni punti del confine erano poste sotto gli ordini del generale Cadorna.
Il 16 agosto la camera concedeva al governo i mezzi necessari per mettersi in misura «di proteggere in qualsiasi evento la sicurezza dello stato, l'indipendenza [276] della nostra politica e gli interessi d'Italia». L'opposizione parlamentare fu aspra: si sapeva che gli uomini più influenti della così detta consorteria ricusavano assolutamente di occupare Roma: il Visconti-Venosta, sempre ligio alla Convenzione di settembre, affettava di fare per l'Italia un punto d'onore di non venir meno alle proprie promesse; il Lanza dichiarava anche dieci giorni dopo che il governo non poteva accettare dalla camera nessun ordine del giorno che lo invitasse ad occupare colle armi gli stati della chiesa, perchè se v'era nel parlamento chi voleva andare a Roma colla forza, v'era però anche una grande maggioranza che credeva non si dovessero adoperare se non mezzi morali.
Quindi non era lecito sperare che in una rivolta dei romani riconosciuta da tutti impossibile.
Tutto pur d'evitare la violenza, era il pensiero di Visconti-Venosta e di Lanza d'accordo col re; tutto pur di andare a Roma, era il programma di Sella.
Il 20 agosto la camera votava con 214 voti contro 152 il seguente ordine: «La camera, approvando l'indirizzo politico del ministero, confida che esso si adoprerà a risolvere la questione romana secondo le aspirazioni nazionali»: formula equivoca nella quale s'indovinava l'intenzione del governo di non assumere alcuna iniziativa contro Roma. Laonde la sinistra si radunò in comitato per deliberare sul contegno da tenersi di fronte al governo: un pericoloso dualismo minacciava di scoppiare. Malgrado la propria inerzia il paese cominciava ad irritarsi di queste calcolate lentezze; gli esuli romani impazienti d'indugio si preparavano a qualche impresa arrischiata, il popolo si addensava in comizi per tutte le città acclamando Roma capitale. La lunga e dolorosa contraddizione della monarchia colla rivoluzione si rivelava improvvisamente alla coscienza pubblica; le memorie sanguinose d'Aspromonte e di Mentana accusavano il re che avrebbe voluto abbandonare Roma per soccorrere Napoleone III; l'arresto di Mazzini e il silenzio di Garibaldi, [277] già in moto per soccorrere la imminente republica francese, commentavano sinistramente tale contegno. Quindi dall'assemblea della sinistra uscì una commissione composta dei deputati Rattazzi, Cairoli, Crispi, Bertani e Fabrizi coll'incarico di presentare «un progetto di risoluzione conforme alle intenzioni prevalenti nella sinistra e alle necessità della situazione». Il pericolo pel governo era grave, giacchè la sinistra era decisa ad un appello al paese. Sarebbe stata la guerra civile con Garibaldi, Mazzini e tutti i monarchici più liberali da un canto, e la corte co' suoi più reazionari adepti dall'altro. Ma poichè la republica stava per essere proclamata in Francia, e la Spagna era già republicana, la monarchia di Savoia insino allora più fortunata che meritevole, non avrebbe avuto troppe probabilità di vittoria.
Quindi Sella persuase la commissione di sinistra a sospendere ogni precipitosa risoluzione assicurandole che, ove non riuscisse a vincere la resistenza del ministero, se ne sarebbe dimesso per unirsi alla rivoluzione.
Roma si mantenne inerte.
Intanto al ministero degli esteri si preparava una circolare agli agenti diplomatici per rigettare sul contegno ostile sino allora tenuto dalla curia romana la responsabilità delle misure, che il governo fosse costretto a prendere. Nel mattino del 3 settembre giunse la notizia della resa di Sédan. Ogni ulteriore indugio diventava impossibile. Sella dichiarò nel consiglio dei ministri che, qualora non si occupasse immediatamente il territorio pontificio, si sarebbe dimesso seduta stante: il Visconti-Venosta ricalcitrava, Lanza si opponeva, il re si mostrava irremovibile. Il falso argomento adoperato dal Sella di un pericolo, che l'imminente republica francese facendo di Roma un centro d'insurrezione mirasse a rovesciare la monarchia per ottenere mediante la republica una alleanza offensiva coll'Italia, non bastava a persuaderli. Nullameno bisognava risolvere: o marciare tosto su Roma, o disporsi [278] alla guerra civile contro la rivoluzione. Come sempre accade nei casi dubbi fra persone dubbie, si venne a reciproche concessioni stabilendo che le nostre truppe si sarebbero fermate alle mura della città, e non avrebbero cercato di entrarvi se non colla cooperazione dei romani. Il re inoltre avrebbe mandato al papa un legato straordinario con una lettera per avvertirlo delle intenzioni del governo, ed esortarlo ad accettare da questo la protezione necessaria al proprio ministero.
La lettera fu redatta da Celestino Bianchi e portata dal conte Ponza di San Martino. In essa Vittorio Emanuele confessava ingenuamente attraverso molte frasi equivoche di essere rimorchiato dalla rivoluzione, e rigettava sovra di essa la responsabilità di una impresa disapprovata dalla sua coscienza di re e di cattolico. Tale umile ed umiliante confessione dinanzi al papato nel momento stesso di sostituirlo nella sovranità di Roma tradiva il segreto della monarchia. I riguardi dovuti al pontefice cattolico per l'esercizio della sua altissima funzione non avrebbero dovuto impedire a Vittorio Emanuele di affermare con solennità regale il diritto dell'Italia su Roma. Mai si era presentato momento più propizio e glorioso per la sua casa dopo le umiliazioni di Villafranca, delle annessioni centrali, d'Aspromonte, della Convenzione di settembre, della cessione del Veneto, e di Mentana. Vittorio Emanuele cavalcante sotto le mura di Roma e spronante il cavallo su per la prima breccia aperta dalle artiglierie, col coraggio mostrato alla battaglia di Palestro quando si slanciò cogli zuavi francesi nella Sesietta, sarebbe stata la più epica figura del secolo, degna di appaiarsi con Garibaldi; invece la sua lettera di scusa al pontefice e dal pontefice sdegnosamente respinta, le sue tergiversazioni diplomatiche, la sua inutile opposizione a Quintino Sella, scopersero in lui il piccolo re di Piemonte, cui la rivoluzione aveva potuto dare l'Italia, ma non la grande coscienza della sua nuova èra.
[279] La seconda circolare mandata agli agenti diplomatici all'estero colla data del 7 settembre spiegava come l'occupazione del territorio pontificio fosse piuttosto una necessità di ordine pubblico per garantire l'inviolabilità del pontefice e il suo libero ministero che una rivendicazione del diritto nazionale. Le garanzie, cui allora si accennava, si riassumevano in un privilegio di extra-territorialità, conservando al papa la condizione di sovrano, ai cardinali il grado di principi, ed offrendo persino una lista civile garantita da un trattato.
Tale extra-territorialità doveva consistere nel possesso della città Leonina: così il potere temporale sarebbe stato diminuito sino oltre il ridicolo, ma rispettato nell'idea. Il nuovo minimo regno avrebbe quindi fatto il paio colla republica di San Marino.
E in questa idea nè giusta nè pratica, giacchè avrebbe mantenuto in Roma il dualismo di due re, era dovuto convenire anche il Sella per decidere il ministero ad invadere lo stato pontificio. La sua politica di quei giorni era tutta in un solo argomento: spaventare il governo colla minaccia di una rivoluzione. Infatti per opera segreta sua i comizi crescevano di numero e di violenza, la stampa unanime spingeva il governo ad una pronta iniziativa, il vecchio filosofo Mamiani andava di ministero in ministero pregando e rimproverando. Marco Minghetti scriveva da Vienna: andate a Roma. Il generale Lamarmora formulava il problema monarchico così: poichè abbiamo l'abisso dinanzi e di dietro, dunque avanti! Il nuovo governo republicano francese, interrogato dal Nigra, rispondeva che ci vedrebbe fare con simpatia. Solo il conte d'Arnim, ambasciatore prussiano presso la Santa Sede, parlava vagamente di difficoltà; ma si sapeva troppo bene che questa era una sua iattanza personale.
Finalmente la campagna fu aperta l'11 settembre. La marcia su Roma si compì senza battaglie, poichè il papa aveva deciso di resistere solamente nella città per costringere i nemici ad aprirvi una breccia. Il conte d'Arnim ottenne indarno una dilazione di ventiquattro ore per un supremo tentativo di conciliazione presso la corte vaticana: il 20 settembre la città fu investita dalle artiglierie fra porta Pia e porta Salara, porta San Giovanni e porta San Pancrazio; appena aperta una breccia a porta Pia, cessò la resistenza troppo debole per una battaglia e troppo sanguinosa per una dimostrazione.
Fra le due parti i morti e i feriti non sommarono a duecento.
Il regno dei papi era caduto per sempre senza trovare nell'ultima ora nessuno di quei grandi atti, che immortalano i vinti.
Nella capitolazione firmata fra il generale Cadorna e il generale Kanzler si accordarono alle milizie papaline gli onori di guerra, e non si parlava della città Leonina. Questa intenzione di lasciar sussistere il papato temporale in tale specie di ghetto cattolico, permise ad un gruppo di falsi rivoluzionari capitanato da certo Luciani, finito poi nelle galere, di agitare la plebe in quel primo fermento e d'insediare una giunta provvisoria in Campidoglio per decretarvi la decadenza del potere temporale. Si convocava già il popolo a un comizio nel Colosseo, sebbene la città si conservasse nella solita inerzia. Quindi il generale Cadorna, giustamente impensierito, s'affrettava a nominare una giunta provvisoria di diciotto fra i più noti moderati della città con alla testa Michelangelo Caetani, duca di Sermoneta, noto favorevolmente per innocui sentimenti liberali e per studi pedanteschi sulla Divina Commedia. Il 2 ottobre venne fissato il plebiscito, che riuscì naturalmente in favore del regno italiano: sopra [281] 167,548 inscritti della provincia di Roma risposero all'appello 135,291; gli squittinii diedero 133,681 sì e 1507 no: nella sola città i sì furono 40,805 e i no 46. Ma i trasteverini, còlti da subito entusiasmo politico, vergognando di rimanere come un gregge nell'appannaggio del pontefice, diedero anch'essi contro il malvolere del governo il proprio voto. Il 9 ottobre la deputazione romana recava il risultato del plebiscito a palazzo Pitti; a reggere provvisoriamente Roma era deputato il generale Lamarmora.
Benchè Roma fosse materialmente conquistata e il potere temporale abbattuto, la monarchia non osava ancora affermare solennemente il proprio trionfo. Una profonda e complessa superstizione occupava tutti gli spiriti: l'immensa importanza del papato, signore di duecento milioni di cattolici, sgomentava la corte. Già la prima formula del plebiscito trasmessa a Roma dal ministero dell'interno lo avrebbe reso condizionato, ed era del seguente tenore: «colla certezza che il governo italiano assicurerà l'indipendenza dell'autorità spirituale del papa, dichiariamo la nostra unione al regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale del re Vittorio Emanuele e dei suoi successori». Così pei romani l'idea del papato avrebbe dovuto prevalere su quella di Roma. Fortunatamente l'istinto rivoluzionario delle masse vi si oppose: la Giunta provvisoria rispose nobilmente che Roma non aveva nessun diritto d'imporre condizioni alla patria per la propria annessione: se il governo intendeva garantire l'autorità spirituale del pontefice farebbe opera savia, ma non spettava al popolo romano tale iniziativa.
Si era dovuto discendere ad accordi: da Firenze venivano proposte altre dizioni dello stesso tenore: allora la Giunta provvisoria aveva minacciato di dimettersi se non si fosse adottata una formula di plebiscito incondizionato. Poi la sera del 26 settembre erano stati inviati a Firenze don Emanuele dei principi Ruspoli e Vincenzo Tittoni per trattare col governo: il ministero aveva fatto pompa d'asprezza rimproverando [282] loro che gente liberata appena appena dalla servitù per opera del governo italiano non facesse che creare imbarazzi e dar segni di malcontento. Ma Quintino Sella intervenne risolutamente nel dibattito, imponendo una formula plebiscitaria semplice e categorica: «vogliamo la nostra unione al regno d'Italia sotto il governo monarchico costituzionale di Vittorio Emanuele e dei suoi successori». Non per tanto la Giunta dovette consentire nel proclama, col quale invitava il popolo al plebiscito, questa frase: «sotto l'egida di libere istituzioni lasciamo al senno del governo italiano di assicurare l'indipendenza dell'autorità spirituale del pontefice».
Durante tali trattative era giunta la protesta della città Leonina risoluta a non voler restare sotto il dominio del papa. Il ministero, che aveva fermamente deciso di sbarazzarsi del papa, lasciandolo sovrano in quella specie di borgo sacro, ne fu sossopra; avventuratamente il Vaticano stesso soccorse al suo imbarazzo. Il 25 settembre il cardinale Antonelli dichiarava spontaneamente al barone Blanc, segretario generale al ministero degli esteri e venuto a Roma col Cadorna, che «il progetto di lasciare al papa la città Leonina offriva difficoltà insormontabili. Quella parte della città priva di qualsiasi autorità regolare stava per divenire un centro di facinorosi: essere urgente che il generale Cadorna vi stabilisse, come nelle altre parti di Roma, dei posti di pubblica sicurezza, esser urgente sopratutto che gli italiani avessero occupato Castel Sant'Angelo, ove quantità considerevoli di polvere erano mal custodite da qualche veterano pontificio contro possibili attentati. Pregare in pari tempo che le autorità militari italiane togliessero dai giardini del Vaticano alcune casse di polvere, la cui presenza allarmava il pontefice».
La senile paura della curia vaticana, associandosi al confuso sentimento rivoluzionario del popolo, trionfò di ogni riserva del gabinetto di Firenze, e diede tutta Roma all'Italia.
In mezzo all'effervescenza destata nella nazione dalla conquista di Roma il contegno della monarchia appariva anche più dimesso; non si capiva come Vittorio Emanuele, affrettatosi nel 1859 ad entrare trionfante in Milano, e nel 1860 a cacciare Garibaldi da Napoli, non osasse ora, vincitore per sola virtù del proprio governo, fare il proprio ingresso solenne nella città eterna. Gli immaginari pericoli inventati dalla stampa ministeriale per giustificare l'inazione del re a Firenze svanivano al primo esame. Anzitutto nel primo sbigottimento della caduta la curia vaticana si mostrava così arrendevole, che dopo aver sollecitato essa medesima l'occupazione della città Leonina, si prestava di buon garbo a risolvere le mille questioni pullulanti dal mutamento sopravvenuto nella città. Il cardinale Antonelli, già così sdegnoso coi ministri italiani in ogni tentativo d'accordo, riceveva adesso più volte al giorno il barone Blanc: meglio ancora il Giacomelli, mandato in Roma ad organizzarvi il sistema finanziario, era riuscito, mediante la cortese cessione di cinque milioni dell'obolo di San Pietro trovati nella tesoreria pontificia, a fargli accettare una prima rata dei cinquanta mila scudi mensili inscritti nel bilancio dello stato pontificio sotto il titolo: «Mantenimento del papa, del Sacro Collegio, dei Palazzi Apostolici, delle guardie, ecc., ecc.». Era quindi naturale che, vanito quel primo spavento, alla nuova pace fattasi in Europa la curia alzasse la voce a protestare: si poteva temere che la Prussia, costretta da necessità interne a qualche concessione verso il partito clericale, fosse per appoggiare quei reclami; era quasi sicuro che la Francia, sdegnata dei nostri rifiuti a soccorrerla durante la guerra, ci tenesse il broncio e minacciasse, se la reazione che doveva succedere all'impero giungesse al potere; era certo che l'Austria, estrema potenza cattolica, per la sua rivalità contro la Prussia protestante moltiplicherebbe difficoltà e rimostranze.
[284] Il Sella, prevedendo con molto senno pratico tutto questo, sino dalla prima ora voleva che il trasporto della capitale avesse luogo «subito, anche prima di subito», giacchè il potere temporale non poteva considerarsi abolito finché Roma non fosse davvero capitale d'Italia; e quantunque il re e il ministero unanimi vi si ricusassero, non cessò dall'insistere. A questo lo spronava lo stesso ambasciatore inglese sir Paget. Non bastò l'osservare, che ritardando l'ingresso del re a Roma si dava tempo alla curia vaticana di rimettersi sulla difensiva, che si sarebbe poi dovuto invitarvi tutto il corpo diplomatico senza essere sicuri che l'invito fosse tenuto, che finalmente non lo si potrebbe più fare se non dopo avere con legge apposita assicurato al papa guarentigie sovrane. E allora Roma, invece di essere una conquista d'Italia, ne diverrebbe un acquisto mediante un mercato diplomatico.
Tutto fu inutile. Il Lamarmora, governatore a Roma, si unì al partito della corte: Sella, che aveva ancora una volta forzato il ministero colla minaccia delle proprie dimissioni a deliberare che il re si recherebbe a Roma il 30 novembre, dovette recedere davanti alle dimissioni del Lanza, il quale giovandosi di una sua assenza aveva condotto il ministero a disdirsi.
Ma come tutto cospirasse ad aiutare la monarchia, che si aiutava così poco, in sul finire dell'anno una piena del Tevere, sommergendo mezza la città, offerse al re un pretesto caritatevole per entrarvi. La piena cresceva e pioveva a dirotto, quando un tardo manifesto, al quale pochi avevano badato, vi annunziò la venuta del re d'Italia. Mai più grande avvenimento ottenne minore attenzione. Il re giunse nel pomeriggio; pochissima gente era ad attenderlo sul piazzale della stazione, ed era piuttosto plebe che popolo, giacchè le miserie e i pericoli dell'inondazione preoccupavano tutti. Quando il re scese di carrozza nell'atrio del Quirinale, volgendosi al Lamarmora con atto di [285] viaggiatore seccato del viaggio mormorò in piemontese: finalment i suma[1].
Questa esclamazione fu poi corretta con avveduto spirito cortigiano nel famoso motto: Finalmente ci siamo, e ci resteremo.
Mentre Vittorio Emanuele procrastinava così il proprio ingresso a Roma e il papato atterrito dai pericoli immaginari di un rivoluzione cittadina ricusava l'offerta della città Leonina per meglio essere protetto dal governo italiano, il mazzinianismo vaniva come partito d'opposizione. Il suo programma republicano, smentito dai continui successi della monarchia, perdeva colla risoluzione del problema romano ogni forza di attualità. Quindi il ministero si affrettò ad amnistiare Mazzini, che dal carcere di Gaeta traversò inconsolabile tutta l'Italia per riprendere più solo di prima la via dell'esilio. Il grande rivoluzionario era vinto per l'ultima volta: come Napoleone I dopo Waterloo, egli doveva abbandonare la terra delle proprie glorie, troppo piccola ancora per poterlo contenere vivo fra i piccoli vincitori di Roma.
Ma poichè la rivoluzione italiana, malgrado la contraddizione deprimente del proprio processo monarchico, doveva anche questa volta avere nella storia un significato universale, Giuseppe Garibaldi da Caprera, ove s'era ridotto infermo dopo Mentana, al primo grido di republica scoppiato a Parigi scriveva alla Francia offrendole con sublime ingenuità «ciò che [286] ancora restava» di lui. L'impero francese era caduto, l'impero germanico stava per essere proclamato nella grande sala del Trianon dedicata a tutte le glorie della Francia: nell'irresistibile tempesta delle vittorie prussiane pareva perduta ogni idea democratica, dacchè alla guerra contro il cesarismo napoleonico ne succedeva un'altra contro la Francia republicana. L'Italia che avrebbe dovuto soccorrerla, e non lo poteva per la propria antinomia monarchica, entrava trepida a Roma quasi sentendosi minore del papato; la Spagna republicana stava riparata dietro l'alta muraglia dei Pirenei; Russia ed Austria quantunque gelose del vincitore assistevano con gioia segreta alla rovina di quella Francia che circa un secolo prima aveva scardinato e per sempre le loro divine monarchie; la liberale Inghilterra calcolava già i vantaggi che la diminuzione dell'antica rivale potrebbe arrecare al proprio commercio.
Nè la Francia iniziatrice in Europa della moderna democrazia era senza colpe. Il suo primo impero aveva violentato l'indipendenza di tutti i popoli, la sua seconda republica aveva proditoriamente rovesciato la prima republica romana, il suo secondo impero aveva imposto all'Italia il sacrificio d'Aspromonte e l'ecatombe di Mentana per negarle Roma e con Roma l'unità. Mentre il papato rovinava come una tarlata impalcatura sotto il palco improvvisato della monarchia italiana, Garibaldi, il ferito d'Aspromonte, il vinto di Mentana, offriva alla Francia in nome dell'Italia la propria spada di cavaliere dell'umanità. Il suo appello ai volontari di tutto il mondo affermava nel silenzio di tutte le monarchie la solidarietà delle nazioni nell'idea republicana. Francia e Italia erano sempre unite, malgrado le colpe dei propri governi. Mentana non aveva cancellato Solferino, giacchè là contro l'Italia aveva vinto l'impero napoleonico, qua per l'Italia aveva vinto la Francia.
Quindi Garibaldi, lasciando alla monarchia italiana raccogliere per le vie di Roma i cenci del papato, [287] accorreva in aiuto della republica francese. Se la sua spada di condottiero non poteva pesare molto sulle bilancie della guerra, la sua presenza nel campo francese era di un immenso valore ideale.
Non tutti però anche fra i migliori intelletti lo compresero. Poiché la guerra era per la Francia irremissibilmente perduta, pareva alla prudenza sottile dei pratici che l'offerta di Garibaldi, vecchio ed oramai impotente capitano di poche migliaia di volontari, non fosse che una senile bravata: il suo proclama al popolo tedesco contro la guerra fu giudicato un vaniloquio; persino Mazzini si dolse di questa andata in Francia, mentre la monarchia italiana occupava così umilmente Roma. L'inflessibile e mistico republicano non poteva perdonare alla Francia republicana del 1848 il tradimento usato alla republica romana; e siccome la nuova republica francese, nell'immensa anarchia di quel momento, non si atteggiava secondo il suo ideale democratico, egli giudicava non solo inutile ma nocivo ogni sacrificio fatto per essa. Il popolo non se ne sarebbe giovato. Ma l'istinto di Garibaldi, anche questa volta più sicuro del genio di Mazzini, non si curava nemmeno delle intenzioni o degli atti dei nuovi governanti republicani: egli sentiva solamente che l'Italia doveva pagare Solferino e vendicare Mentana con una vittoria in Francia contro i prussiani. La republica anche meglio delle monarchie è superiore ai propri governi.
Ma quella improvvisata dal Gambetta a Tours non usò verso Garibaldi molto meglio dei governi italiani del 1848-59. Si tardò più d'un mese a rispondergli; si sarebbe voluto ricusarlo e non si osò; malgrado l'ovazione entusiastica fattagli dal popolo di Marsiglia si tentò di stancarlo moltiplicando contraddizioni ed indecisioni. Pareva che la sua generosità umiliasse l'orgoglio nazionale francese.
Nullameno il favore popolare costrinse i governanti a permettergli di comporre un esercito, che ebbe nome dai Vosgi, e sul principio non superava gli ottomila [288] uomini. Il suo nucleo più compatto, formato da volontarii italiani che avevano seguìto per l'ultima volta il loro vecchio capitano, n'era come il battaglione sacro, nel quale si confondevano veterani sfregiati da cento battaglie e adolescenti come Giorgio Imbriani votati alla morte del campo, venturieri di buona lega, miscredenti iconoclasti che dal lungo odio al papato avendo sorbito un disprezzo aggressivo per tutte le religioni, dovevano attirarsi l'odio delle campagne francesi ligie alla chiesa romana. Intorno a questo nucleo s'aggruppavano battaglioni di franchi tiratori, reggimenti di marcia disordinati come sciami e composti cogli avanzi degli immensi eserciti distrutti, truppe di nuove leve poco vogliose di combattere, marinai, doganieri, studenti, villani e plebei. Lo stato maggiore era anche più eterogeneo: comandanti italiani e francesi di provenienze diverse vi si astiavano; i nuovi ufficiali republicani nominati da Gambetta accusavano di ogni disastro gli ufficiali dell'impero capitati nel nuovo esercito dei Vosgi; gli uni e gli altri soffrivano della generosità degli italiani venuti a vendicare Mentana sui prussiani. Reggeva lo stato maggiore il generale Bordone, forte d'ingegno quanto debole di moralità. Ma l'organizzazione dell'esercito non potè riuscire che fiacca: Gambetta pretendeva dirigere egli medesimo la guerra, dislocando colonne a colpi di telegrafo e limitando con ogni mezzo l'azione di Garibaldi. Infatti, malgrado l'opinione del prefetto Ordinaire e della popolazione di Besançon, la quale avendo accolto Garibaldi con entusiasmo intendeva affidargli il comando di tutti i corpi del dipartimento, egli li volle sottoposti al generale Cambriels invocante indarno di essere messo a riposo per curarsi di una pericolosa ferita al capo.
L'esercito garibaldino cresciuto di parecchie migliaia, secondo il solito malissimo armato, non poteva fare che una campagna difensiva. Le forze, la scienza e l'incomparabile organamento rendevano i prussiani più esperti sul terreno invaso che non gli stessi difensori, [289] ed assicuravano loro anticipatamente il trionfo finale. Nullameno Garibaldi, infondendo parte della propria grande anima in quelle informi cerne raccogliticce, riuscì a riprendere l'offensiva con una celerità di mosse che meravigliò gli stessi nemici.
Da Autun, suo quartiere generale, il 28 dicembre mosse alla difesa di Dijon, battè le avanguardie tedesche a Prenois e a Darois; senonchè Dijon arrendendosi ai prussiani lo costrinse ad indietreggiare dopo un inutile assalto notturno sino ad Autun e a difendervisi strenuamente da ogni attacco nemico. Ma troppo scarso di forze per poter arrischiare un vero disegno di campagna, dovette quindi regolarsi piuttosto su quello del grande esercito di Bourbaki, estrema speranza della Francia: così non appena il generale prussiano Werder si ripiega abilmente sulle proprie linee di Gray-Vesoul, Garibaldi con marcia rapida e ardita rioccupa Dijon, ne guarnisce la fronte di colonne staccate, ne compie le fortificazioni attendendo di congiungersi all'esercito di Bourbaki e con esso minacciare il fianco dei prussiani. Intanto la guerra precipita alla fine; i generali francesi Faidherbe e Chanzy sono già stati schiacciati in Piccardia e nell'Orleanese, Parigi affamata sta per discutere la propria resa, il generale prussiano Manteuffel con un movimento parallelo a quello di Bourbaki e molto meglio eseguito malgrado il verno rigidissimo raddoppia le linee di Werder per accerchiare Bourbaki e Garibaldi. Ma se quegli finisce miseramente gettandosi sulla Svizzera, questi assalito lotta invece tre giorni respingendo ogni assalto, assalendo alla propria volta, togliendo al 61º reggimento prussiano la bandiera, finchè sorpreso dall'armistizio, nel quale per proditoria dimenticanza del Favre e per felina sottigliezza del Bismarck non è tampoco nominato, sfugge a 150,000 nemici con una delle più ammirabili ritirate che vanti la storia della guerra.
Allora l'ingratitudine della Francia ufficiale lo persegue; lo si accusa d'incapacità e di ladreria; si negano [290] le sue battaglie; generali e fuggiaschi come Dudrot si levano contro di lui publici insultatori; il suo esercito, sospetto di essere troppo republicano, è disciolto come una banda di briganti; i giornali moderati d'Italia tengono bordone al turpe vilipendio, mentre il popolo francese con uno slancio irresistibile del cuore lo manda, benchè straniero, deputato all'assemblea di Bordeaux, e i prussiani s'inchinano con guerresca nobiltà al suo valore. All'assemblea di Bordeaux, ove la reazione monarchica rumoreggia già prepotentemente, le calunnie e gli sfregi diventano così ignobili che Victor Hugo, alzatosi a protestare in nome della Francia coll'autorità del proprio genio, è costretto a dimettersi da deputato.
Ma Garibaldi, che dall'Italia aveva già sopportato quanto di più crudele potesse inventare l'ingratitudine patria, non ebbe una parola di lamento: ricusò la deputazione offertagli dal popolo francese; poco dopo acclamato generalissimo dalla Comune scoppiata a Parigi, pur riconoscendo l'intima giustizia di quella improvvida rivoluzione, vi si rifiuta come generale e come soldato, per chiudersi fra gli scogli di Caprera più povero dei propri commilitoni, e più incompreso di prima alla volgare coscienza dei governi.
Se Vittorio Emanuele si era sentito troppo piccolo per guidare contro Roma il proprio esercito, Garibaldi era stato abbastanza grande per comprendere che alla caduta del papato bisognava contrapporre l'affermazione di una più vasta idea; e in nome della storia latina, universale da tremila anni, era corso in Francia a frenare l'ultima invasione germanica, opponendo agli eccessi di un popolo, fatto esercito ed impero per diventare nazione, la democrazia republicana di tutte le nazioni d'Europa.
Malgrado il diffondersi del pensiero democratico, la magnifica storia del cattolicismo e l'ammirabile unità del suo potere esecutivo, inspiravano non solo [291] alle masse ma agli stessi avversari un superstizioso rispetto. A ciò contribuiva forse per massima parte la coscienza del vuoto teoretico della irreligione, che spremendo convulsamente scienze e filosofia, non aveva ancora trovato nulla da sostituire alle soluzioni offerte dal cattolicismo.
Quindi il papato, glorioso per una guerra di quasi duemila anni contro tutta l'umana varietà di nemici, soverchiava ancora la coscienza pubblica con una specie di fatalità resa più terribile da una interpretazione di provvidenza divina.
Le repugnanze della monarchia alla conquista di Roma, e la deferenza al papato delle maggiori potenze mondiali anche non cristiane, dovevano rendere più difficile lo stabilire con una legge i nuovi rapporti della chiesa collo stato. Fra i dogmi più orgogliosi del pensiero italiano primeggiava quello dell'universalità di Roma. Nella storia antica, almeno quale era ancora insegnata nelle scuole e sentita nelle masse, Roma era stata l'unità del mondo: il cristianesimo, abbandonando Gerusalemme per Roma, aveva raddoppiato questa unità dilatandola sino agli ultimi confini della geografia; nella lunga preparazione medioevale Roma era stata la città santa e la capitale del diritto popolare; al rinascimento Roma aveva egualmente contenuto i viaggi di Colombo sul mare e di Galileo nel cielo; lo schianto del protestantesimo non era bastato a dimezzarla; la rivoluzione francese era caduta sotto la Santa Alleanza, mentre il papato risaliva radiosamente al disopra di questa.
A Roma tutto il mondo cattolico stava ancora sottomesso. Nel periodo semi-secolare della rivoluzione italiana. Roma aveva sempre sovrastato al dibattito fra popolo e monarchia: l'unità politica d'Italia non era mai stata assolutamente creduta per la difficoltà di mutare la capitale del papato in capitale della nazione. Coloro medesimi, che per irreligiosità di pensiero sfuggivano alla sua influenza, non osavano concepire la conquista di Roma pari a quella di Palermo [292] o di Napoli. Cesare Correnti sconsigliava dall'andare a Roma per non impegnare il governo in un dibattito contro i terribili teologi della curia vaticana; D'Azeglio, mascherando la timidezza di prudenza, aveva già voluto fare di Roma una città anseatica; Cavour non aveva ardito proclamarla capitale d'Italia che sperandone la cessione spontanea dal papato e dalla Francia; i suoi successori nel ministero si erano affrettati a rinunziarvi trasportando la capitale a Firenze; Giuseppe Mazzini stesso, affermando per la conquista di Roma la necessità di una rivoluzione intimamente democratica, veniva a riconfermare la sua inviolabilità, giacchè l'Italia non era ancora capace di tale progresso. Persino Giuseppe Ferrari, fuorviato dalla propria interpretazione delle rivoluzioni italiche, dissuadeva dall'andare a Roma ridotta come Benares e Gerusalemme a città sacra di una morta religione, per non mettere la nuova culla d'Italia nel più antico dei suoi sepolcri. L'acuto filosofo non s'accorgeva che tale rinuncia a Roma avrebbe mantenuto la superiorità del pensiero religioso sul pensiero civile. Teodoro Mommsen, protestante di religione e razionalista di pensiero, domandava febbrilmente a Quintino Sella: «Che cosa farete a Roma? A Roma non si sta senza un'idea universale».
Nessuno fra i più intrepidi miscredenti della politica pensava allora che andando a Roma si potesse non tener conto del papato. Fra il volgo dei liberi pensatori, che avrebbero voluto distruggervi tutti gli altari, e la monarchia che sostituendovi il papato nel governo temporale tendeva a diminuire con quello il numero degli scontri, non vi era ancora un partito democratico abbastanza forte per comprendere che la rivoluzione italiana non avrebbe avuto significato mondiale se non col risottomettere il cattolicismo alla legge comune pareggiandolo con tutte le altre religioni. Allora il cattolicismo avrebbe dovuto provare contro tutte queste la propria superiorità senza alcun aiuto di privilegi nella lotta, sotto pena di perdere il [293] proprio primato storico. Un'immensa rivoluzione sarebbe avvenuta nei costumi e nelle idee: il cattolicismo, costretto a vivere delle oblazioni dei fedeli nella nuova miseria procuratagli dall'incameramento di tutti i beni, sarebbe disceso alla più ignobile idolatria, o salito nelle proprie migliori idealità. L'Italia avrebbe dato in Europa un esempio di libertà religiosa, quale la giovane America non ha ancora saputo: solamente così la caduta del potere temporale dei papi avrebbe segnato un'epoca nella storia civile dei popoli.
Ma da molti secoli, non ostante la sede del papato, Roma non era più universale.
Il progresso umano stava appunto in questa decadenza di Roma, mentre in Europa e in America fiorivano a centinaia i centri del pensiero e dell'azione civile. Oramai era facile comprendere che il papato non dava più a Roma altro vantaggio sulle grandi città moderne che quello abbastanza equivoco di una Mecca, e che nel secolo decimonono sognare ancora una città universale, e quindi un popolo eletto, era un indietreggiare al di là dello stesso cristianesimo, il quale aveva annullato l'elezione del popolo ebreo.
L'Italia, terra classica di un diritto divenuto universale prima ancora che il cristianesimo vi si annidasse, avrebbe dovuto alla propria gloria millenaria di spersonalizzare la chiesa cattolica. Ma la monarchia, conservando nella ricevuta delegazione dal popolo l'antica pretesa della delegazione divina, alla quale il papato era tramite necessario, si affrettò a riconoscergli non solo un primato su tutte le religioni, ma ad investirlo di una indefinibile sovranità poco conveniente alla religione ed incompatibile collo stato.
Le rivoluzioni sopprimono, le monarchie transigono.
Vittorio Emanuele dinanzi a Pio IX era ancora nell'attitudine di Carlomagno davanti a Leone III; l'ultimo re ritirava la donazione fatta dal primo imperatore, ma chiesa ed impero, pontefice e sovrano, trattavano [294] sempre entro la stessa orbita, mentre la rivoluzione civile, vincitrice da tempo di tutti i miti religiosi e politici, non era peranco giunta a conquistare un governo pari a se stessa.
Le condizioni della politica europea erano favorevoli all'esperimento della coesistenza in Roma dei due sovrani e dei due poteri. La Francia si affaticava contro la Comune di Parigi, la Spagna avendo eletto re il secondogenito di Vittorio Emanuele era frenata nelle proprie escandescenze cattoliche dalla politica di corte, l'Inghilterra protestante applaudiva alla caduta del papato, Prussia ed Austria si sorvegliavano reciprocamente.
D'altronde il governo italiano era disposto a concedere più di quanto le diplomazie estere potessero chiedere. La procrastinazione dell'ingresso solenne del re a Roma era arra sufficiente delle sue e delle intenzioni della nazione.
La nuova legge, che si disse delle Guarentigie, votata dalle camere il 5 aprile 1871, dichiarò la persona del papa sacra ed inviolabile; a lui si mantennero tutti gli onori reali: si permise che nello stato tenesse armati a propria difesa; la sua dotazione di cinquantamila scudi mensili fu conservata esente da ogni onere governativo, provinciale o comunale; gli si attribuirono i palazzi vaticani e lateranensi colla villa di Castel Gandolfo e in essi nessun ufficiale italiano di pubblica autorità potrebbe mai introdursi; si riconobbero inviolabili i cardinali nella vacanza della sede pontificia, gli ecclesiastici partecipanti all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non soggetti a molestia o sindacato delle autorità italiane; si mantennero agli ambasciatori presso la Santa Sede le solite prerogative; poste e telegrafi furono gratuiti pel pontefice nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie; ogni istituto per l'educazione degli ecclesiastici venne preservato dall'ingerenza delle autorità italiane. Quindi abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione pei membri [295] del clero cattolico, dispensati i vescovi dal giuramento regio, eccettuate Roma e le sedi suburbicarie dall'obbligo di conferire i benefizi maggiori e minori a cittadini del regno, aboliti gli exequatur e i placet per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica non riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici; in materia spirituale e disciplinare nè riconosciuto appello, nè concessa esecuzione coatta; riserbato a legge ulteriore il riordinamento delle proprietà ecclesiastiche nel regno.
Così papato e monarchia, costretti a guerra mortale dalla rivoluzione, patteggiavano ancora barattandosi immunità e privilegi: il cattolicismo cresceva come religione di stato fino ad equiparare il proprio papato alla monarchia.
Quindi al trattarsi dell'abolizione dei monasteri vennero preservate a Roma tutte le case generalizie, riconoscendo loro la personalità negata agli ordini: un'altra legge dichiarò proprietà nazionale i musei apostolici senza sottrarli all'arbitrio del papa.
Ma anche questa volta la monarchia aveva interpretato abilmente il pensiero nazionale che voleva Roma capitale senza la distruzione del papato. Il trasporto della capitale e l'ingresso solenne del re a Roma riuscirono a fredde feste officiali: governo, parlamento e corte s'accamparono ove poterono; questa al Quirinale, ma Vittorio Emanuele non osò mai dormire negli appartamenti del papa, e vi morì per caso in una cameretta sopra una altana; quello alzò nel cortile di Montecitorio la propria aula in legno, quasi dubitando di fidare il proprio danaro a più duraturo monumento; l'altro ridusse molti conventi ad uffici.
Solo Quintino Sella ebbe allora un concetto chiaro della trasformazione necessaria a Roma per diventare davvero capitale d'Italia, ma nè il governo nè il municipio seppero secondarlo. La iscrizione liviana da lui scolpita sotto la statua del legionario romano nel nuovo palazzo delle finanze — Signifer, statue signum, [296] hic manebimus optime — fu il suo ultimo grido di battaglia contro il partito, cui aveva imposto la gloria di condurre la monarchia in Campidoglio.
Una grande nazione s'era aggiunta all'Europa; la più gloriosa delle città mondiali tornava ad essere una delle sue capitali civili. Se l'Italia non aveva nella propria rivoluzione potuto diventare republica e proclamare a Roma la superiorità del pensiero civile sul pensiero religioso, mettendosi all'avanguardia delle razze latine, nullameno il fatto della sua ricostituzione unitaria e la caduta del potere temporale le davano un significato maggiore che non quello stesso del nuovo impero germanico. Il principio della nazionalità e della sovranità popolare avevano trionfato in Italia meglio che in Germania, ove gli antichi ordini feudali e il nuovo ordinamento militare viziavano ancora dolorosamente la vita moderna.
Il trionfo del principio democratico era meraviglioso. Dopo la caduta dell'impero napoleonico, fra la selvaggia rivolta dei comunisti e l'insensata reazione degli elementi monarchici, la Francia restava republica; l'Italia aveva chiamato con un plebiscito Vittorio Emanuele a Roma, la Spagna con un altro plebiscito aveva nominato a proprio re il duca d'Aosta, la Germania con un terzo plebiscito militare aveva promosso il re di Prussia ad imperatore, e queste tre monarchiche elezioni esprimevano il principio della sovranità popolare. L'Europa era profondamente mutata; ogni possibilità di nuova Santa Alleanza vi diveniva inconcepibile. La Francia sempre all'avanguardia, con un milione di prussiani bivaccanti su tutte le sue campagne, aveva osato proclamare in una rivoluzione comunista, degenerata necessariamente nella più bestiale delle guerre civili, un principio di libertà economica superiore ad ogni ordine di classi e a ogni idea di nazione.
L'Austria, ultima potenza del diritto cattolico, respinta dal centro d'Europa, doveva inorientarsi, contrapponendo [297] l'eterogeneità del proprio federalismo alla unità russa nel problema della ricostituzione nazionale dei Principati Danubiani.
La profezia di Napoleone I, morente a Sant'Elena, che fra mezzo secolo l'Europa sarebbe o republicana o cosacca, quasi che la Russia potesse davvero svolgersi nella storia come negazione della democrazia, attraverso l'errore del proprio dilemma si era dunque puntualmente avverata.
L'Europa ancora divisa da monarchie era già concorde nel più irresistibile sentimento democratico.
In questo periodo di unificazione monarchica l'opposizione politica dalle sfere governative, ove soccombeva ogni giorno in nuove transazioni, non potè salire più alto traendo seco tanto pensiero da atteggiarne la letteratura nazionale. Molte cause storiche vi si opponevano.
Anzitutto il mazzinianismo, come la più vecchia ed importante delle opposizioni, era pressochè la sola, cui il popolo prestasse qualche attenzione; ma se Mazzini per la grandezza dell'ingegno letterario e per l'eroismo del carattere vi aveva meritamente acquistato una gloria immortale, i suoi scolari, chiudendosi nella più servile imitazione di lui, si vietavano spontaneamente ogni valore. Accadeva ai mazziniani nella politica come ai manzoniani nella letteratura: in ambo le scuole una stessa pedanteria morale vi aveva isterilita la produzione: gli uni di Manzoni non avevano voluto ammirare che l'onestà religiosa del sistema, e dimenticavano gli istinti scetticamente naturalistici, allora meravigliosi in tanta voga di romanticismo; gli altri in Mazzini veneravano la dogmatica deistica e il classicismo republicano, mentre filosofia e scienza sgretolavano questo e quello, e un'altra democrazia, più impetuosa di passioni e larga di metodo, chiamava le plebi a nuove conquiste economiche.
[299] Al difuori del mazzinianismo non v'era altra opposizione. La grande fioritura letteraria era caduta: Manzoni, Leopardi, Niccolini, Guerrazzi, Giusti, tacevano o morti o esauriti: nella filosofia cresceva in Napoli un hegelianismo, dal quale Francesco Fiorentino tentava di staccarsi con scettiche intenzioni e con studi storici, mentre Terenzio Mamiani chiudeva il proprio dilettantismo nelle Confessioni di un metafisico, insufficiente ripresa di vecchie verità diminuite da una incertezza anche più insufficiente di metodo, e Camillo de Meis in un libro sui tipi vegetali ed animali dava la più originale e profonda critica del sistema darwiniano. Le scuole di Gioberti e di Rosmini erano cessate: solo quest'ultima durava nei seminari entro una lotta teologica inavvertita dal grosso publico. La poesia languiva nel romanzo, nel teatro e nella lirica; nessuno fra i giovani aveva saputo prendere il posto dei grandi morti. Prati, travolto dall'abbondanza della propria vena, cadeva di poema in poema, avendo smarrito ogni senso politico nell'ammirazione incondizionata del re e della corte: Aleardi si disfaceva in un sentimentalismo serotino, nel quale la volgarità delle idee traeva alla sciatteria della forma: l'Uberti, integro ed aspro, aveva dovuto miserevolmente suicidarsi senza speranza di immortalità nell'arte e senza conforto di vera azione esercitata sul pubblico: il Praga con senso schietto di modernità ma scarso valore artistico tentava le prime rappresentazioni della nuova vita: il Zanella, ultimo prete liberale, cantava con minore estro e forma più eletta un ultimo accordo fra scienza e religione. Nievo e Tarchetti, dopo aver solcato il romanzo, come stelle filanti, dileguavano quasi senza traccia, sebbene il primo, più vasto d'ingegno e di indole più sana, meritasse più lungo tempo nella vita e maggiore importanza dopo la morte: Giacometti, Ferrari e Cicconi tentavano indarno di galvanizzare il teatro accumulandovi residui classici e romantici, nazionali e stranieri, senza intuizione della società moderna e senza originalità di fattura.
[300] Se davanti all'informe sembianza di Vittorio Emanuele, trionfante come primo re d'Italia, i vecchi grandi poeti avevano serbato un silenzio solenne, come sentendo l'assurda sproporzione dell'uomo cogli avvenimenti, mentre i cantori di corte tentavano invano di rappresentarlo alla nazione come il suo redentore, nemmeno le due maggiori figure di Mazzini e di Garibaldi, sintetizzanti nella propria originalità tutta la rivoluzione italiana, avevano potuto accendere l'estro poetico della nazione. Vittorio Emanuele era troppo più piccolo dei fatti, cui apponeva spesso nolente la propria firma: Mazzini e Garibaldi li trascendevano troppo perchè l'Italia potesse comprendere giustamente l'opera loro.
Infatti l'unificazione nazionale aveva dovuto compiersi tragicamente contro di essi.
Mentre dal 1821 al 1870 congiure e battaglie, piazze e campi, esigli e patiboli, vittorie e sconfitte, offrivano la più ricca messe artistica di questo secolo, la letteratura italiana pretestando mancanza d'argomenti si trascinava ancora alla retroguardia di quella francese; e poichè il grande avvento della letteratura europea era già cominciato, inducendo in ogni altra nazionale la maggior dose di umanesimo con una più libera varietà di forme, l'Italia letteraria correva pericolo di perdere ogni caratteristica dietro troppe imitazioni. D'altronde la rivoluzione non era abbastanza derivata dalla massa del popolo per avergli così toccato il cuore da rinnovare tutti i suoi artisti. L'opera monarchica, ristretta in un partito di corte e di parlamento, con esclusione del popolo da qualunque ufficio politico, malgrado la fortuna dei propri risultati era stata troppo umiliante nel processo per suscitare veri entusiasmi.
La nazione rimaneva quindi inconsapevole: si adattava con mirabile destrezza ai nuovi modi di vita senza indagare quanto sangue o genio costassero; si buttava alacremente a lavori d'ogni genere sotto lo stimolo della concorrenza europea e nell'oblìo più ingiusto [301] dell'epopea, dalla quale era uscita la sua libertà. Tutto concorreva a togliere lo spirito nazionale dalla concentrazione necessaria allo sbocciare di una vera letteratura.
Una goffa ed inevitabile rettorica dominava ambo i partiti. Il monarchico, affettando la superbia del senno nel trionfo del proprio governo, cercava di rianimare i vecchi sentimenti di sudditanza a favore dell'unica vincitrice dinastia col prodigare scherni e calunnie ai pochi eroi della rivoluzione; il partito rivoluzionario, non volendo confessare la propria impotenza d'organizzazione, rinfacciava alteramente alla monarchia le bassezze del suo governo, e spingeva inutilmente a rivolte che avrebbero tolto alla nazione di quetarsi in quel primo assetto. In fondo non si ammirava Vittorio Emanuele; Cavour era quasi dimenticato nel rapido avvicendarsi de' suoi successori; si lasciava indifferentemente Mazzini nell'esilio, e si sorrideva argutamente quando Garibaldi da Caprera mandava ancora qualche monito con stile reso donchisciottesco dalla contraddizione di un'effervescenza sempre giovanile con una senilità oramai esausta.
Mentre dietro l'orme di Napoleone I era sorta la più splendida di tutte le letterature nella storia francese, dai campi di Garibaldi e di Vittorio Emanuele non crescevano fiori, e non salivano voci. Quella fiacchezza di coscienza nazionale, che dopo Dante aveva impedito all'Italia di trarre dalle innumerevoli tragedie delle proprie cronache un teatro come quello di Shakespeare, e aveva ristretto a mano a mano tutta la letteratura nelle scuole, durava ancora.
Manzoni, Niccolini e Guerrazzi erano stati la passione di una speranza vanita nella volgarità del trionfo.
Garibaldi, il più alto degli eroi, e Mazzini, il più forte degli scrittori, vi rimanevano egualmente incompresi: la letteratura usava verso di loro come la politica: siccome non si era saputo seguirli, non si seppe poi rappresentarli: il popolo li amava istintivamente. [302] mentre la ragione degli studiosi, volendo interpretarli, li falsificava.
Dal 1859 al 1870, come dal 1848 al 1859, non v'ebbe quindi vera produzione letteraria: in questo periodo la minuta preparazione all'ultima lotta soffocò le grandi passioni e distolse dai supremi ideali; in quello la febbre e la fatica dell'organizzazione governativa distrassero dalla meditazione dei fatti e dallo studio del loro significato.
Cavour dominò il primo, Sella riassunse il secondo; destrezza diplomatica e destrezza finanziaria condussero al trionfo d'entrambi.
Ma se l'opposizione politica non potè disciplinarsi a vero partito contro la monarchia per organizzare in se medesima come in un campo trincerato tutta la nuova vita moderna, l'Italia che per lungo e misterioso affinamento di razze e di spirito aveva potuto produrre non solo Mazzini e Garibaldi, ma individualizzare intorno ad essi le più nobili virtù in un ciclo meraviglioso di cavalieri, trovò in Giosuè Carducci un altro grande poeta. Con lui l'opposizione si mutò di politica in ideale.
Egli non era però e non poteva essere un combattente come Mameli, nel quale la passione dei fatti sopraffacesse la loro meditazione.
Se cresciuto fanciullo fra la rivoluzione del '48, ne aveva rimasto negli orecchi e negli occhi il tumulto, nella Toscana ove era nato e nella modesta famiglia che intendeva allevarlo quietamente, queste prime impressioni non bastarono a turbare lo sviluppo del suo temperamento. La sua gioventù si svolse ostinatamente studiosa, quasi imbalsamata di classicismo, trovando in esso una nuova fonte di orgoglio patriottico. I suoi primi odii di toscano furono quindi per la scuola lombarda, nella quale Manzoni aveva fatto una rivoluzione romantica così grande da sorpassare lo stesso romanticismo: [303] ma poichè in essa si era annidata la scuola neo-guelfa, mentre Niccolini e Guerrazzi, classici e ribelli, si mantenevano ghibellini, il giovane poeta fondeva già nella propria ira di classico contro i degeneri romantici cattolici lo sdegno patriottico e superbamente irreligioso, che aveva ispirato l'Arnaldo da Brescia e l'Assedio di Firenze. Tutta Toscana era classica per necessità forse di natura e per superbia di tradizione.
Mentre in Giusti e in Guerrazzi, trovatisi nel tafferuglio dell'azione, la molle fibra toscana aveva ceduto lasciandoli troppo minori nell'opera che nel pensiero, nel Carducci una natura più concentrata e tempi relativamente più ordinati dovevano accumulare maggiore dottrina e più salda coscienza. Nulla da principio tradiva in lui il rivoluzionario. La sua gioventù, come quella del Leopardi, era cresciuta nell'Ellade fra i grandi poeti e i grandi eroi dell'antica libertà: la sua virtù era un riflesso della loro, la sua arte non insuperbiva che nell'imitarli. Se l'immensa storia di Roma slargava poi il suo pensiero apprendendo al suo cuore una più nobile alterezza di patria, la letteratura latina restava fatalmente secondaria per il suo gusto, e di Roma egli non sentiva veramente che la gloria pagana. Il cristianesimo gli pareva una forma della decadenza e una mortificazione del pensiero romano. Nella splendente serenità della propria fantasia il giovane poeta fuggiva istintivamente le tenebre cristiane e tutta quella religione, che, nata di peccato e di martirio, proscriveva il mondo in nome di un'ideale senza figura e di una virtù senza bellezza. Il medioevo come epoca classica del papato gli restava chiuso; solo ai primi albori del rinascimento, nella primavera dell'arte novella, egli tornava a sentire nell'Italia la propria patria; ma allora la passione di Dante rifomentando la sua antipatia al cristianesimo, aizzava il suo odio moderno al papato.
Nel fervore dei primi studi la recente interpretazione medioevale della scuola neo-guelfa gli pareva [304] una tarda ipocrisia politica per giustificare il bigottismo delle corti e dell'aristocrazia italiana, mentre tutti i magni spiriti, da Dante a Machiavelli, da Bruno ad Alfieri, da Foscolo a Mazzini, avevano sempre combattuto la tradizione papale per proclamare una libera unità di patria. Intorno a lui, nella Toscana, fra lo scadimento del carattere e degli ingegni, la grande scuola ghibellina durava tuttavia. Le liriche tragedie di Niccolini e i tempestosi romanzi di Guerrazzi erano ancora le due più efficaci originalità della letteratura nazionale, le sole due forme di romanticismo che non gli repugnassero assolutamente.
Ma questo letterato, che aveva cominciato coll'appassionarsi alle più fini e recondite bellezze della forma, non era un arcade da smarrire nella plastica della bellezza il senso della sua verità interiore. Se la sua squisita natura artistica gli permetteva di riprodurre le molli ed indefinibili venustà del Petrarca e del Poliziano, i suoi poeti prediletti restavano quelli che a Roma, in Grecia e nell'Italia classica avevano espresso la maggiore verità e nobiltà della natura umana. L'eleganza della sua stessa severità di aristocratico cresceva valore alla modernità del suo sentimento republicano, mentre irrequieti istinti di novità, sommovendo la simmetria della sua classica cultura, lo traevano pei campi delle letterature europee.
Così egli era la natura artistica più composita di questo secolo in Italia: intimamente gran signore come Alfieri e gran cittadino come Parini, senza la stramba albagia dell'uno e la soverchia remissività borghese dell'altro; la passione moderna di Foscolo in preda a tutti i delirii del cuore e a tutte le tempeste di una vita politica, alla quale era conteso ogni equilibrio, agitava la sua anima fra quel dissolversi dell'Italia antica federale e l'organizzarsi della nuova Italia unitaria; l'odio popolano di Guerrazzi contro tutte le autorità dava al suo classico sdegno la precisione e la vivezza dell'accento, mentre dalle grandi tragedie di Niccolini gli veniva l'abitudine dei più alti voli lirici, [305] e dal Bini e dal Giusti qualche amarezza scettica e satirica ad impedire che l'ira gli si guastasse nella declamazione.
La sua varia e potente cultura, ben diversa da quella dei vecchi letterati, trascendeva la sua stessa potenza poetica, e doveva poi permettergli di rinnovare pressochè tutta la critica letteraria toccando i temi più svariati con sicura originalità.
E poichè la rivoluzione italiana, della quale resterà il massimo poeta, era una conseguenza della rivoluzione francese, questa diventò per il suo pensiero adulto una stazione come l'Ellade e Roma. Tutte le libertà spesso disgiunte, talora contradditorie, mai identiche, che aveva appreso nel vecchio mondo greco e italiano si armonizzavano allora nel suo pensiero; la sua coscienza vi trovò la propria unità, le sue passioni di poeta e di uomo si esaltarono in quell'immenso dramma, al quale l'impero napoleonico non aveva aggiunto che un atto, e nel quale tutta l'Europa era entrata gettandovi, attori inconsapevoli, popoli e re fra un uragano di battaglie meno terribili ancora delle stragi cittadine. Il suo classicismo ne andò quindi rotto. Gli istinti rivoluzionari della sua arte, inconsapevolmente prigioniera nelle forme del passato, aiutandosi delle nuove convinzioni montagnarde, gli fransero la cerchia della nazionale tradizione letteraria per suggerirgli altri motivi e ritmi poetici. Ghibellino con Dante, egli divenne giacobino con Victor Hugo e con Michelet; Barbier gli insegnò a condensare l'ira patriottica nei giambi; Heine, un francese d'elezione, gli apprese ad avvelenare l'invettiva; la sua prosa ancora agghindata si snodò come quella di Manzoni e di Mazzini al contatto della francese, la storia della grande rivoluzione dell'89 gli fornì argomenti a chiarire quella che si compiva in Italia; l'opposizione al secondo impero gli prestò forme e concetti ad oppugnare la monarchia di Savoia.
Il suo forte ingegno fece il resto.
[306] Così, mentre l'Italia ascoltava distratta le fantasie di Prati e le elegie di Aleardi, egli, ancora sconosciuto malgrado una classica ode, nella quale aveva acclamato a Vittorio Emanuele come tribuno armato del popolo, le gittò i Decennali e i Levia Gravia, primi saggi di una poesia politica, cui la severità del classicismo giovava quanto la modernità del pensiero.
L'opposizione ideale al processo di unificazione monarchica era finalmente sorta. La coscienza italiana, incerta fra le critiche sistematiche di Mazzini, le invettive intermittenti di Garibaldi, le accuse contradditorie della sinistra e le subdole difese della destra, trovava in un poeta la sincerità del proprio ideale superiore a tutte le antitesi partigiane.
Ma questo poeta era troppo classico per poter diventare mai popolare, e non abbastanza originale per essere il poeta del popolo. Se la sua opposizione era sincera, i modi della sua arte erano ancora troppo antichi, e i suoi modelli di guerra quasi tutti stranieri. Dante, assalendo i propri nemici politici nell'Inferno, aveva fuso insuperabilmente linguaggio e pensiero popolare, non rifuggendo da alcuna immagine, accettando tutte le parole, non rattenendo mai l'impeto della collera per cesellare una terzina. Victor Hugo nei Châtiments investendo il secondo impero era stato brutale e sublime come Dante e come la Bibbia: la sua ira aveva superato l'enormità di quella del mare trovando tutte le voci, tutti i ritmi, tutte le forme, tutte le forze; nessun confronto gli era parso troppo alto o troppo basso per umiliare imperatore e impero; nessun particolare per quanto ignobile, nessun motto per quanto osceno, nessuna rivelazione per quanto ribalda, avevano arrestato la foga o irritato il gusto della sua poesia. E i Châtiments erano e saranno la più grande poesia politica di tutte le letterature. Ma Victor Hugo odiava per amore di due grandi republiche, quella dell'89 e del '48, aveva intorno il popolo più democratico del mondo, e rovesciava un impero che era l'ultimo inevitabile e miserabile esperimento di un sistema [307] consunto; il poeta italiano non poteva odiare la monarchia di Savoia come quegli Napoleone III. Tutta Italia aveva accettato dinastia e governo piemontese per organizzarsi meno dispendiosamente e più facilmente in nazione: le insufficienze e le brutture di tale forma politica erano adunque per lo meno pari, se non maggiori, nel popolo che nel governo. Il contegno del re verso Mazzini e Garibaldi, malgrado molti atti villani, era ancora meno ingrato di quello della nazione. Quindi il poeta che non poteva colpire la dinastia nella monarchia trovando sempre in questa la nazione, che avrebbe indarno mentito coll'accusare di decadenza la rivoluzione, che non si sentiva intorno le proprie collere a certe umiliazioni nazionali, che malgrado una troppo lunga serie di errori politici vedeva sempre paese e governo avvantaggiarsi verso l'unità, era costretto a ruminare nella solitudine il proprio sdegno per immortalarlo nella più squisita forma classica, e sbatterlo a un dato momento sul viso alla patria come un guanto. La sua alterezza signorile di cittadino, la sua preziosa severità di artista republicano, l'isolamento della sua vita di professore ancora incompreso concordavano a crescergli l'energia poetica; il contatto stesso colle Romagne, ove da Bologna si mescolava spesso coi più ardenti rivoluzionari, doveva forse giovargli più che tutto il resto.
Ma se la natura troppo composita gli toglieva di essere popolare come Victor Hugo in Francia e Heine in Germania, le sue mirabili attitudini artistiche, perfezionandosi nello sforzo continuo di tradurre nel verso i fatti politici del momento, dovevano fare di lui il miglior poeta lirico e il più efficace poeta civile di questo secolo in Italia. La borghesia, più attiva del popolo nella rivoluzione, e perciò più capace di intenderne le antinomie, dimenticò finalmente nei suoi canti il proprio soverchio culto pel Manzoni. Allora non v'ebbe più avvenimento lieto o giocondo per la patria, al quale Carducci non prestasse la propria voce. La sua lirica si atteggiò in tutte le forme, rinnovò tutti [308] i ritmi, ebbe lamentazioni superbe di dolore, singulti di satira, ruggiti d'imprecazione, grandinò sui fiacchi e sugli ipocriti che indietreggiavano davanti a Roma, vi percosse d'anatema il pontefice, tuonò sui palazzi del re, gettò urli d'entusiasmo per Garibaldi; poi, divagando apparentemente in Francia, ne rappresentò i fasti rivoluzionari e le infamie borboniche a rimprovero per l'Italia; parve discendere nel medio evo ad evocarvi le grandezze republicane dei comuni; s'allontanò a Roma e in Grecia; e sempre fervida di entusiasmo patriottico e di passione democratica fu appello ed ammaestramento, monito e preghiera, per la libertà della patria e per la sua gloria.
La donna, questo eterno tema della poesia, non vi ottenne che pochi canti e non i migliori.
Una febbre di grandezza animava il poeta. Si sarebbe detto che tutta la sua collera e il suo rimpianto derivassero dal non essersi egli pure battuto per l'Italia, dal non avere cospirato con Mazzini, dal non avere marciato con Garibaldi: ed anche in questo amaro sentimento egli era il poeta della borghesia, che sentiva di non aver fatto abbastanza per la rivoluzione. Quindi la sua onestà di uomo povero e di gran signore soffriva alla gazzarra dei primi affari, di cui il governo si serviva come di una corruzione: la sua generosità popolana si mutava in rabbia ad ogni ingiustizia usata verso Garibaldi o Mazzini.
Nullameno il suo temperamento artistico dominava sempre la tempesta del suo pensiero politico, permettendogli d'immergersi in studi filologici e critici sino a mutarlo in uno fra i massimi professori d'Europa, e a fargli rinnovare la prosodia italiana colla latina in una assimilazione sempre più organica di idee nuove con forme antiche, e di forme estere con modi nazionali.
Ma la sua opera poetica non potè avere in Europa un potente significato di originalità.
Mancava ad essa la schiettezza moderna dell'ispirazione colla caratteristica di una vera passione nazionale. [309] Il poeta soffriva ma non odiava; non comprendeva il popolo e restava al popolo incompreso; peggio ancora il popolo odiava meno di lui. La borghesia poteva intenderlo, ma non seguirlo, dacchè la monarchia era la forma da essa imposta alla rivoluzione. Mentre Hugo e Heine, guidati dall'istinto infallibile dell'odio, trapassavano ad ogni colpo il proprio avversario, egli, costretto ad una critica ideale, riusciva spesso meno terribile di Mazzini malgrado il vantaggio della forma poetica, e meno franco di Garibaldi che poteva dare ad una ingiuria plebea il valore di una rivelazione.
Come la rivoluzione italiana, egli fu dunque troppo composito e non abbastanza democratico per essere originale; le passioni gli bruciarono più la testa che il cuore; la dottrina perfezionandogli l'ingegno glielo restrinse; fu classico, aristocratico e borghese, mai veramente nè popolano nè popolare. Laonde, classico, mantenne nell'arte la tradizione regia, che la monarchia di Savoia sovrapponeva alla rivoluzione; aristocratico, ebbe le superstiti delicatezze della propria classe con tutte le sue impotenze; borghese, fu al tempo stesso mazziniano e garibaldino contrastando alla monarchia ed accettandola come Mazzini e Garibaldi.
La sua ultima poesia politica Ça ira, mirabile epopea di pochi sonetti, invece di essere garibaldina fu francese.
Nell'immenso campo poetico del risorgimento nazionale egli non colse che pochi fiori e non ripercosse che alcune voci. Garibaldi ebbe da lui qualche ode; Mazzini una iscrizione, un sonetto, e da morto. La sua poesia politica, incomparabile nella nostra letteratura, non bastò al confronto di quella francese: malgrado la magnanimità dei propositi e l'elevatezza dei sentimenti, non osò tutti i confronti fra rivoluzione e monarchia, mancò di amore e di odio, ebbe più riflessione che istinto per finire in una critica, che compostezza [310] e ricercatezza di forma rendevano spesso poco accessibile.
La rivoluzione italiana, trovando in Carducci il poeta del proprio periodo di unificazione, non potè quindi tradursi intera nella sua opera, come intera non aveva potuto svolgersi nella forma monarchica: letteratura e politica la dimezzarono. Le sue imprese più miracolose, le sue più tragiche catastrofi, le sue più cupe umiliazioni, fraintese o poco intese, non trassero dalla coscienza nazionale la passione necessaria a rinnovare la vita e l'arte italiana.
Mazzini e Garibaldi come eroi universali, trascendenti la stessa rivoluzione, vi rimasero incompresi.
L'Italia aspetta ancora il poeta, che come Hugo ed Heine le riveli l'epopea rivoluzionaria e la decadenza del papato nell'effimero e contradditorio trionfo della monarchia di Savoia. Le avventure americane di Garibaldi, la sua difesa di Roma, la ritirata sino alla pineta di Ravenna, l'impresa dei Mille, la tragedia d'Aspromonte, l'ecatombe di Mentana, la vittoria di Digione, la solitudine di Caprera, saranno un giorno le massime glorie della lirica nazionale: le cospirazioni, l'esilio, l'apostolato fra congiure e patiboli, la fede superiore a tutte le smentite, la generosità più tenace di tutte le ingratitudini, la democrazia italiana e mondiale di Mazzini, inspireranno una drammatica più profonda e nobile di quella di Shakespeare; le rappresaglie ignobili ed assassine del papato alla sua ultima ora, le senili ribalderie di tutte le corti italiane, la fortuna troppo spesso fraudolenta della monarchia di Savoia costretta alla gloria dell'unificazione italica, le incertezze bigotte dell'aristocrazia, l'avara prudenza della borghesia, la bruta incoscienza del popolo, l'abbietta reazione del clero produrranno una satira ben più tetra e vivace che non quella del Giusti e del Carducci.
Ora l'illustre poeta, respinto come Mazzini dalla nuova passione rivoluzionaria, si è ritirato con alterezza signorile nel castello incantato della propria [311] arte, e come Tennyson vi si oblia nell'ingannevole riproduzione di ogni forma di poesia. La nazione lo venera come pochi anni or sono venerava il Manzoni, ma origlia già per cogliere qualche nuova voce fra la cantilena delle proprie scuole.
Però anche in questa ritirata il Carducci ha potuto significare il trapasso borghese dalla monarchia di Vittorio Emanuele a quella di Umberto I, mentre nel dissolversi di tutti i partiti storici, che avevano cooperato al trionfo dell'unità nazionale, la borghesia, come sorpresa dalla lassitudine dell'opera compita e nell'assenza di ogni alto preciso ideale, si è abbandonata con giocondità teatrale ad un vano entusiasmo per la propria dinastia. Una ebbrezza di pace ha quindi colto il poeta della rivoluzione, mutandogli la cetra di Alceo nella lira di Metastasio: qualche ombra delle antiche malinconie gli è rimasta in fondo al cuore, qualche gemito e qualche urlo gli sfuggono ancora come rimbombi dai crepacci che i fiori del recente prato non hanno potuto chiudere, ma l'artista squisito se ne serve abilmente come di una dissonanza, e, dimentico del popolo e della rivoluzione, modula soavi canzoni alla regina d'Italia[2].
La presa di Roma chiudeva il periodo dell'unificazione.
Se Trento e Trieste restavano ancora in mano all'Austria, e Nizza era stata ceduta alla Francia che già da oltre mezzo secolo possedeva la Corsica, nullameno l'Italia col sostituirsi in Roma al potere temporale compiva la propria unità. Una dissoluzione dei partiti politici era quindi inevitabile. L'impero francese, rovesciato a Sedan dalle armi vittoriose del nuovo impero germanico, non trascinava più l'Italia come un satellite nella propria orbita; l'opposizione mazziniana vaniva nello stesso risultato dell'unità; Garibaldi aveva scritto l'ultimo canto della propria epopea sulle mura di Digione.
L'Italia era monarchica.
Ma la monarchia, che aveva imposto alla rivoluzione la propria forma, doveva a Roma mutare d'indirizzo e di metodo. Alla fortuna delle armi e delle diplomazie, ora, nel dissolversi di ogni opposizione e nella conquistata libertà di se medesima, stava per succedere una più calma e feconda applicazione dei principii rivoluzionari. L'esclusione del popolo dagli uffici politici diventava impossibile: lo statuto strappato a Carlo Alberto dal Piemonte non bastava più all'Italia. Colla risoluzione dei massimi problemi pregiudiziali, [316] onde monarchia e rivoluzione si erano reciprocamente mortificate, cresceva la necessità di meglio riordinare il primo assetto, sottoponendo tutte le leggi improvvisate nel trambusto della formazione nazionale a nuova critica.
In Roma l'Italia doveva a se stessa e all'Europa la medesima opera civile delle maggiori nazioni.
Nullameno un profondo squilibrio turbava ancora la sua vita. Il suo governo reazionario contro la rivoluzione mazziniana era stato, malgrado molte inevitabili contraddizioni, anche troppo rivoluzionario rispetto alla massa delle popolazioni, specialmente in alcune provincie. Gran parte delle leggi liberali, anzichè domandate, erano state imposte al paese: l'antagonismo regionale non era al tutto scomparso, la differenza di cultura e di costume fra il sud e il nord aveva reso impossibile il beneficio di molte riforme. L'insufficienza rivoluzionaria della nazione proseguiva tuttavia nella vita politica: fra parlamento e paese il rapporto di rappresentanza si era alterato anche troppo e troppo spesso, mentre fra l'Italia legale e l'Italia reale l'abisso, invece di restringersi, in molti punti si allargava.
Dell'antica scuola dei riformisti, mutati in costituzionali dall'influenza dell'opera cavouriana, non rimanevano più che pochi manipoli apparentemente dominanti ancora nella camera e nel ministero, ma Quintino Sella, imponendo loro la conquista di Roma, li aveva esautorati. Quindi il loro odio più segreto e più forte era per l'illustre finanziere, che dopo dieci anni di lotta stava per raggiungere finalmente in Roma il pareggio del bilancio. La destra più monarchica che democratica non poteva iniziare il nuovo periodo parlamentare per dare alla monarchia l'elasticità e la facilità di una republica.
La legge delle Guarentigie aveva dichiarato per l'ultima volta tutto il suo pensiero politico.
Nella rapida e profonda dissoluzione di tutti i partiti, programmi e capi andavano sperduti.
[317] Al di fuori del parlamento il disordine sopravvenuto colla rivoluzione nell'assetto secolare delle classi non si era ancora calmato in un altro ordinamento, la destra non era mai stata vero partito conservatore giacchè i conservatori, che avrebbero dovuto sostenerla, l'oppugnavano invece o per antipatia a' suoi metodi violenti e alle idee succhiate dalla rivoluzione, o per devozione alle monarchie cadute. Il clero si manteneva antipatriottico ed antinazionale, l'aristocrazia non possedeva influenza politica, la corte si componeva di uomini nuovi come quella del primo e del secondo impero napoleonico. Troppi pregiudizi sociali, politici e religiosi inceppavano ancora il pensiero della destra, e falsavano il suo carattere: però nell'urgenza di una nuova più vasta riforma politica dovette darne qualche accenno nell'istruzione pubblica e nell'esercito e cominciare inconsapevolmente una conquista nell'Africa.
La sinistra, rinchiusa nell'orbita legale dalla conquista di Roma, si liberava finalmente dalle troppe equivoche aderenze al partito republicano, rendendosi non solo possibile ma necessaria al potere. Il suo addestramento, cominciato nel parlamento piemontese, aveva durato abbastanza per attenderne ora qualche frutto; ma, costretta a precisare il proprio programma, essa non sapeva ancora estrarlo dalla tumultuante congerie di tutte le proposte accumulate in tanti anni di opposizione. Rancori e sottintesi dividevano i suoi capitani; molte diffidenze li colpivano a corte e nel paese per il loro passato rivoluzionario. D'altronde nemmeno la sinistra aveva al di fuori del parlamento un partito numeroso e compatto che la sostenesse. Tutti sentivano la necessità di un altro indirizzo politico, ma pochi ne vedevano la direzione, e ne avrebbero saputo calcolare la velocità.
I dati politici del nuovo periodo dovevano essere tutti di ordine interno, giacchè Trento e Trieste rimaste in mano dello straniero non avevano più tale importanza [318] da dominare la vita della nazione; nè l'Italia, nè la monarchia correvano pericoli. Bisognava riorganizzare tutti i servizi pubblici, ricostituire esercito e armata, raddoppiare le ferrovie, triplicare o quadruplicare l'elettorato politico ed amministrativo, riordinare le opere pie sottraendole al clero e preparandole ai bisogni della vita moderna, correggere i riparti comunali, provinciali, amministrativi e giudiziari, sintetizzare la magistratura migliorandone l'ordinamento colla diminuzione delle preture, raddoppiare la vita all'istruzione elementare, costituire quella tecnica, portare l'altra superiore al livello delle odierne condizioni europee, raggiungere il pareggio nel bilancio e, appena raggiunto, abolire i più ingiusti balzelli come il macinato e il corso forzoso, decentrare l'amministrazione emancipando comuni e provincie, diminuire la tutela del governo sul paese per abituarlo a reggersi da sè e a contare sulle proprie forze, disciplinare parlamento e partiti entro la regolarità delle funzioni costituzionali, arrestare il diffondersi della burocrazia, sottrarre nei trattati il commercio nazionale al vassallaggio estero, aiutare lo sviluppo della vita e della coscienza italiana.
A questo programma era votata la sinistra.
Doveva quindi accadere che essa, arrivando al potere ancora nel disordine delle proprie abitudini di opposizione, vi si trovasse così a disagio da non sapervisi reggere solidamente da principio.
L'antica destra si era formata di tutti quei riformisti, che nella rivoluzione del quarantotto credevano ancora al federalismo e al costituzionalismo dei principi; la sinistra si componeva per massima di transfugi dal campo rivoluzionario. La monarchia assorbendo l'una e l'altra, fondeva nella propria unità le due più vivaci differenze della nazione, ma la rivoluzione trionfava così della monarchia imponendole le proprie idee per mezzo degli stessi disertori. Così nella nuova gamma dei ministeri di sinistra si sarebbe [319] indubbiamente cominciato da quelli, che più si avvicinavano alla destra sino a toccare cogli ultimi la Montagna; la monarchia di Vittorio Emanuele non potè avere alcun vero ministero di sinistra, quella di Umberto I non ne avrà forse alcuno di vera destra.
In questa seconda fase la monarchia sembrerà perciò trionfare di tutto e di tutti. La sua forza di assorbimento si eserciterà sulle cose e sulle idee, sui partiti e sugli individui, con tale potenza che solamente coloro sempre ad essa nemici, anche nel periodo dell'unificazione, potranno sottrarlesi. Il segreto della sua forza sarà nella sincerità de' suoi voleri democratici, che le permetteranno di concedere al paese riforme politiche più larghe delle sue stesse pretensioni, e nella impossibilità logica per l'Italia di mutare governo prima di averlo esaurito. Una improvvisa fortuna portando il duca d'Aosta al trono di Spagna per un effimero ed inglorioso esperimento regio sembrerà dare alla dinastia avventurosa dei Savoia qualche barbaglio della gloria napoleonica: Austria e Germania, accogliendola nella propria alleanza, la renderanno compartecipe al dominio sulla politica europea, mentre la Francia dovrà raccogliersi in se medesima per superare la prime difficoltà della propria republica, e la Russia rimetterà momentaneamente della propria preponderanza. Nella calma succeduta alla lunga crisi dell'unificazione, il governo della sinistra soddisferà tutte le passioni dei vecchi oppositori senza irritare quelle della gioventù, per la quale le maggiori colpe della monarchia verso la rivoluzione saranno già un passato incredibilmente lontano. E tutti si sottometteranno al nuovo re Umberto I, ammirabile figura di gentiluomo e di borghese, che intuendo con fino senso di attore il carattere del re moderno, sarà come il sindaco d'Italia, bonario e signorile, sottomesso al parlamento e ai ministeri, ma soverchiando l'uno e gli altri con una popolarità conquistata da incessanti dimostrazioni di affetto per tutte le sventure della nazione.
Come nella rivoluzione federale del quarantotto tutti gli uomini politici avevano dovuto egualmente fallire travolti dalla liquidazione del passato, così nel secondo periodo monarchico della unificazione tutti i partiti dovevano essere assorbiti dal governo. Solo coloro, che come Alberto Mario, discepolo di Cattaneo, risognavano un federalismo republicano, o come Maurizio Quadrio e Federico Campanella rimpiccolivano nell'intrattabile onestà del carattere e nell'angustia dell'ingegno il già angusto classicismo republicano di Mazzini, potevano, isolandosi in una critica melanconica ed inascoltata, sottrarsi al fascino monarchico, e morire ravvolti nella propria bandiera. Tutti gli altri, abbandonati al grande corso della storia, dovevano finire col cooperare nella monarchia all'organizzazione del governo. Quindi la loro dedizione, precoce o tarda, si drammatizzò per tutta la varietà dei loro caratteri e dei loro ingegni, non senza aumentare lo scetticismo delle masse, alle quali le solitarie e tragiche grandezze della rivoluzione non avevano potuto infondere una forte fede politica.
Conversioni e voltafaccia si moltiplicarono opportuni ed inopportuni, ingiustificabili e nullameno giustificati. I bisogni della vita privata e le necessità di quella pubblica trionfarono di tutte le resistenze; i rancori reciproci si calmarono nell'oblio onde il popolo copriva tutte le opere individuali; i dibattiti parlamentari abituarono alla prevalenza delle idee sui sentimenti e dei fatti sui sistemi. D'altronde il governo, seguendo l'abile indirizzo cavouriano di sedurre tutti gli avversari e di restare implacabile a tutti i nemici, si giovava di qualunque espediente. Coloro fra i rivoluzionari, che non cedettero alle multiple lusinghe del denaro, soccombettero alla bramosia del potere o alla invidia della fortuna guadagnata dai primi ad arrendersi. I più alti e nobili caratteri compirono il proprio passaggio dalla rivoluzione alla monarchia, dalla Montagna [321] al ministero, sacrificando le loro inattuabili idealità alla pratica del governo, come nella vigilia della guerra avevano immolato la republica all'unità; altri, che nella rivoluzione avevano portato solamente il tumulto delle passioni e l'energia del temperamento, si stancarono presto del mestiere di tribuno, e si umiliarono alla monarchia non potendo umiliarla; molti le chiesero il prezzo di servigi resi più alla nazione che ad essa; troppi vi si rifugiarono dal disprezzo del popolo. Le dedizioni assunsero spesso forma di tradimenti anche per la violenza della critica, onde i pochi incrollabili republicani le perseguitarono: i neo-convertiti, costretti dalla necessità di persuadere il governo e di ribattere gli antichi compagni ad esagerare la nuova fede, discesero sovente a ribalderie senza scusa. Si videro quindi uniti in una inqualificabile amicizia ex-ministri delle cadute dinastie con ribelli da essi già condannati alla morte e alla galera, e gli uni e gli altri sottomessi alla monarchia di Savoia, e daccapo ostili al popolo.
In questo inevitabile crescendo di conversioni la monarchia venne diventando come il capo saldo della nazione: la sua importanza aumentò in Europa giorno per giorno; il suo liberalismo e la sua popolarità le diedero una sembianza simpatica di originalità, che seduceva egualmente popoli e re. Se la sua corte era tutta di transfugi dalle altre corti rovinate, il suo governo si componeva quasi interamente di prigionieri fatti alla rivoluzione.
Tale drammatico fenomeno di un governo servito fedelmente da tutti i recenti avversari sarebbe però stato impossibile, qualora nel paese non vi avesse corrisposto una così larga evoluzione costituzionale da avviluppare quasi tutta la vecchia e la nuova generazione.
Fra questi prigionieri della monarchia, e che essa gettava nel trambusto del parlamento, o deponeva nel senato come in un museo di figure di cera, o allontanava nelle ambasciate, o disseminava nelle prefetture, [322] o isolava nell'esercito, o comprometteva in posti subalterni, brillavano ancora nel vigore della forza figure di soldati e di cospiratori, di artisti e di scienziati, capaci d'imporre rispetto al popolo e alla corte. L'imprudenza di qualche frase tradiva ogni tanto in essi l'uomo antico; il ritorno di qualche motivo eroico nella politica li univa improvvisamente in una affermazione non solo superiore ma contraria alla monarchia; poi la fatalità costituzionale li gravava nuovamente, e piegavano il capo pensosi forse di un tempo migliore.
Alla rivoluzione non restava più nè il maestro, nè il capitano, nè programma, nè bandiera.
Mazzini, rifuggitosi nell'esilio dopo l'amnistia di Gaeta quasi a punire l'Italia morendo in terra straniera, si era confessato vinto coll'affermare che la monarchia una volta entrata a Roma vi dominerebbe «chi sa per quante generazioni», e tornava inconsolabile di amore italiano a morire in Pisa accettando dal governo l'apoteosi dei funerali, e riconoscendo così la sua libertà costituzionale; Garibaldi, dopo aver tutto ricusato dalla monarchia fuorché la condanna a morte, la fucilazione d'Aspromonte e la prigionia del Varignano, soffocato dalle angustie e dai disordini della propria casa accettava finalmente due milioni, e veniva paralitico a Roma per salutare in Umberto I e nel principino ereditario i re d'Italia. Dopo la resa dei due grandi capitani le capitolazioni dei minori rivoluzionari precipitarono: Alberto Mario, pur combattendo la monarchia sino all'ultima ora, non le augurò più che un placido tramonto; Aurelio Saffi, modesto Aronne del nuovo Mosè che aveva potuto morire nella terra promessa, succedendo nella direzione del partito republicano non fu più che un pontefice riverito ed inefficace: e recentemente, quando re Umberto visitò le Romagne (1888) rimaste sempre ostili alla monarchia, persuase al popolo ogni più onesta e lieta accoglienza al sovrano. Giovanni Nicotera, già violento di odio contro tutti i re, salì al ministero, e vi si [323] mostrò violento contro i republicani immutati; Benedetto Cairoli, ultimo della propria eroica famiglia, fu presidente dei ministri, e fece scudo a re Umberto della propria popolarità nel primo viaggio reale di riconoscimento; Agostino Depretis, cospirante nel 1853 per rapire in Lombardia l'imperatore d'Austria, e Francesco Crispi cacciato da Torino per ordine di Cavour, saliti colla sinistra al potere, vi divennero i più abili e fieri difensori della monarchia alleata coll'Austria; Giuseppe Ferrari tramontò nel senato accettando dal re, egli filosofo della legislazione, un mandato legislativo; Emilio Visconti-Venosta e Giacomo Medici ottennero di essere marchesi; le decorazioni fioccarono sugli altri, la Camera accolse coloro che si credevano ancora un avvenire, il senato ospitò gli invalidi, e un'aura di pace rasserenò tutte le fisonomie, mentre il partito republicano dileguava come un ricordo, e quello socialista mandava per le piazze i primi vagiti.
La monarchia aveva vinto. Allora Giosuè Carducci, che aveva cantato contro di essa le glorie più giacobine della rivoluzione, e serbato il più sdegnoso silenzio dinanzi a Vittorio Emanuele, si arrese anch'egli prigioniero deponendo, simbolo di pace, una corona di fiori poetici sulla fronte della regina d'Italia.
Malgrado l'entrata a Roma e il pareggio oramai in vista, la posizione del ministero Lanza-Sella era perduta. La destra non poteva perdonare al Sella di averla violentata nella questione romana; la sinistra prossima ad afferrare il potere raddoppiava di ostilità: entrambe si unirono contro il ministero col gruppo toscano, che accennava a riprendere il triste ufficio della Permanente piemontese per la medesima pessima ragione del trasloco della capitale da Firenze a Roma. Costoro chiedevano una somma enorme di compensi, [324] quasi la nazione dovesse pagare all'abbandonata metropoli tutte le pazzie del suo lusso improvvisato per le vie.
Una prima crisi scoppiò per la costruzione di un arsenale militare a Taranto, cui il ministero assegnava 6 milioni, mentre una commissione parlamentare glie ne attribuiva prima 70, poi 23. Il ministero si dimise, ma la battaglia essendosi accesa come inconsapevolmente, il re lo riconfermò. Ne venne così una tregua brevissima, della quale la destra profittò per prepararsi a più vigoroso assalto contro i provvedimenti finanziari presentati dal ministero per fronteggiare le nuove spese introdotte nel bilancio. Agostino Depretis, nominato capo della sinistra alla morte di Urbano Rattazzi, si associò al Minghetti, ultimo capitano della destra, e il ministero cadde.
La destra si suicidava uccidendolo.
Infatti il nuovo ministero Minghetti non potè, malgrado l'abilità parlamentare di molti suoi membri, avere alcuna vitalità politica. Di tutta la destra l'unico uomo di stato moderno per intendimenti e principii era il Sella. Se il suo carattere fosse stato più malleabile e la sua coscienza meno delicata, come nel conte di Cavour, avrebbe dovuto associarsi a Depretis nel comando della sinistra, recandole la sincerità del proprio metodo finanziario col nobile disdegno di ogni falsa popolarità.
Il nuovo ministero fu quindi fatalmente di reazione: Minghetti, il più tardo dei riformisti a credere nel processo cavouriano di unificazione, assunse colla presidenza il portafoglio delle finanze; Visconti-Venosta vi rimase agli esteri; Silvio Spaventa, mal viso per gli eccessivi rigori polizieschi di un tempo, ebbe benchè non pratico, i lavori pubblici, Cantelli, inetto legittimista cresciuto alla corte della duchessa di Parma, governò l'interno.
Poichè la Francia nella rovina dell'impero napoleonico e della rivoluzione comunarda era caduta alle [325] mani di una reazione monarchica doppiamente irritata coll'Italia per la conquista di Roma, ne venne che le relazioni politiche fra le due nazioni si guastarono. La Francia accusava l'Italia d'ingratitudine rinfacciandole la campagna del 1859; questa rimbeccava aspramente ricordandole Nizza e Savoia, Villafranca e Mentana. Da Versailles, nuova capitale politica, questa reazione rinfrancata di tutti gli elementi più conservatori del legittimismo, dell'orleanismo e del bonapartismo, affettò quindi di voler riaprire in certo modo la questione di Roma: il conte di Choiseul ministro francese a Firenze partì in congedo per non accompagnare Vittorio Emanuele nell'ingresso solenne a Roma; petizioni dalle campagne fioccavano all'assemblea di Versailles per un intervento in favore del potere temporale.
Naturalmente la politica italiana, impressionata di queste ostilità, si torse verso la Germania. Vittorio Emanuele, così deferente a tutti i voleri di Napoleone III, s'irrigidì altezzosamente dinanzi a Thiers, diventato presidente della republica francese; e quando Sella, nell'occasione delle feste per il traforo del Cenisio, tentò combinare fra loro un abboccamento, il vecchio re piemontese si rifiutò all'etichetta, che gli avrebbe imposto di muovere incontro al presidente della republica francese. «Il re d'Italia, egli rispose al Sella, sta di casa a Torino e il signor Thiers sa dove trovarlo, se ha bisogno di conferire con lui». Ma poichè la Francia accennava a contrastarci il pacifico possesso di Roma, il re d'Italia avrebbe dovuto almeno rispondere che avrebbe atteso il signor Thiers al Quirinale.
Il primo atto del nuovo ministero Minghetti fu di condurre in visita il Re a Vienna e a Berlino come per risposta alle ingiuste recriminazioni francesi. Il governo di Versailles ritirò da Roma il proprio ministro Fournier, e mandò nelle acque di Civitavecchia la fregata Orénoque; la stampa delle due nazioni si accapigliò; gli animi si invelenirono così che quando [326] l'imperatore d'Austria venne a Venezia e quello di Germania a Milano per rendere la visita a Vittorio Emanuele, l'Italia non s'accorse dell'ingiuria fatta a Roma.
Parve invece trionfo insperabile che due imperatori visitassero l'Italia, pur disconoscendone la capitale col rifiuto di entrarvi.
Il secondo atto del ministero fu la cattura di Aurelio Saffi e di altri ventinove republicani mazziniani, convenuti in una villa Ruffi della campagna riminese per discutere sull'attitudine del loro partito davanti alla monarchia. Quest'assurda violenza poliziesca, cui tennero dietro altre molte, finì di screditare il governo della destra, reso già odioso dall'ostinata opposizione ai più necessari sviluppi democratici della rivoluzione e da una durata di quasi quindici anni.
La lotta parlamentare riarse più viva alla riapertura del parlamento (novembre 1875): Agostino Depretis aveva da Stradella promulgato in un magistrale discorso il verbo della nuova sinistra. Fra le riforme promesse vi si annunciavano come più urgenti: l'affidare ai laici l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, l'obbligo dell'exequatur eseguito con rigore, l'istruzione laica resa obbligatoria e gratuita, l'allargamento del voto politico ed amministrativo, la determinazione per legge delle incompatibilità parlamentari e la diminuzione del numero dei deputati impiegati, un pronto inizio di decentramento abbandonando ai comuni e alle provincie la nomina dei propri sindaci e dei propri presidenti, l'abolizione delle sottoprefetture e dei consigli di prefettura, la correzione delle leggi tributarie e delle norme per la compilazione dei bilanci, la revisione dei trattati di commercio secondo il principio del libero scambio, una correzione della legge di pubblica sicurezza, il miglioramento delle circoscrizioni giudiziarie, e finalmente una legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari.
A questo largo programma di riforme il ministero non seppe contrapporre che la propria apologia e l'annunzio del pareggio, dovuto all'opera sagace e coraggiosa [327] del Sella. Quindi cadde per tradimento del gruppo toscano, che passò a sinistra, donde gli venivano molte promesse di aiuti a Firenze.
Così si chiudeva la prima fase parlamentare del regno d'Italia.
In mezzo alle accuse che la colpivano caduta, la destra poteva nullameno vantare la gloria di avere stabilito il primo assetto. Le sue colpe maggiori verso la rivoluzione derivavano piuttosto dalla monarchia impotente a seguire una politica più nobile e più democratica: gli altri suoi difetti politici erano una conseguenza delle scuole e delle classi, nelle quali si era reclutata. La contraddizione di dovere simultaneamente essere rivoluzionaria e conservatrice viziò il processo della sua legislazione e della sua politica estera sino a compromettere più volte l'onore d'Italia. Come partito essa non credette mai sinceramente alla possibilità di unire l'Italia in una sola nazione, contrastò a tutte le imprese di Garibaldi, rinnegò tutto l'apostolato di Mazzini, si sottomise all'impero Napoleonico, arretrò dinanzi al pontefice, mancò d'audacia anche quando era prudenza l'averne, e stimò sempre lo sviluppo della democrazia un errore ed un pericolo: nullameno il suo patriottismo e la sua pratica abilità furono mirabili in tanta inesperienza della nazione. Nelle sue file agirono colti ingegni e severi caratteri, che la corruttela e le troppe conversioni politiche dei primi giorni non poterono guastare; l'aristocrazia vi rifulse coi propri migliori individui, la borghesia ne fu lo spirito e il numero, la corte l'avvolse nella propria decorazione.
La necessità della sua caduta era la prima conseguenza del regime costituzionale da essa organizzato, giacchè l'indirizzo del governo verso la nuova generazione non poteva essere dato che dai più liberali fra gli uomini che avevano ricostituito l'Italia. I riformisti del quarantotto avevano troppo creduto ai principi per credere abbastanza al popolo e chiamarlo con più largo voto a parte della vita politica; i costituzionali, [328] ostinati nel giudizio che la nazione sussistesse nella monarchia e per la monarchia, non potevano fidarsi alla democrazia ed ammettere che solo coll'accettarne francamente i principii e col favorirne coraggiosamente lo sviluppo la monarchia durerebbe utile e gloriosa all'Italia.
Fra gli uomini della prima destra italiana il conte di Cavour resterà nella storia l'unico grande statista, Ricasoli il più nobile, Rattazzi il più equivoco, Sella il più efficace, Minghetti il più eloquente de' suoi successori: gli altri saranno e sono già dimenticati. Ma della loro opera minuta, incerta ed oscura, proseguiranno lungo tempo i benefizii; mentre il loro manipolo stretto intorno a Vittorio Emanuele appare tuttora bello nella varietà delle fisonomie e nel vigore degli atteggiamenti, quantunque la coorte dei cavalieri garibaldini lo veli passando oltre col barbaglio delle proprie armi, e Mazzini solitario lo copra dall'alto colla propria ombra grande.
L'avvento della sinistra capitanata da Agostino Depretis si compiè fra le più liete speranze: pareva a tutti che lo svolgimento dei principii democratici da essa invano propugnati per sedici anni avverrebbe senza scosse e con feconda prontezza. Questa doveva essere la necessità del nuovo periodo parlamentare, ma il brusco passaggio dell'opposizione al governo vi traeva inesperienze ed abitudini troppo tribunizie, perchè l'opera legislativa non avesse a soffrirne. Anzitutto il partito della sinistra, lungi dall'essere ben organizzato nel parlamento, mancava pure di vera base nel paese: i radicali ne speravano troppo, i moderati ne temevano ancora più; il bisogno di conservare nel pubblico la popolarità acquistata colla critica sistematica a tutti i passati ministeri costringeva la sinistra a considerare le imminenti riforme piuttosto come illazioni di principii, che quali adattamenti alle [329] condizioni reali del paese. Nella politica estera, mentre la destra si era sempre mantenuta servile alla Francia imperiale per influsso del principio dinastico, la sinistra aveva negli ultimi anni guardato alla Prussia; e poichè le vittorie di questa ci avevano permesso la conquista di Roma contro i divieti dell'impero napoleonico, e ora la Francia republicana e reazionaria sembrava voler contrastarci il conseguito trionfo dell'unità, il nuovo ministero liberale doveva esagerare le simpatie verso l'una e le diffidenze verso l'altra anche per mostrarsi dinastico quanto la destra. Non valeva osservare che la reazione nell'assemblea francese sarebbe effimera, che la republica non vi era ancora assettata, che la Francia isolata in Europa dall'ostilità diplomatica della Prussia non potrebbe seriamente pensare a contenderci Roma, che solo i reazionari orleanisti e legittimisti impadronitisi del ministero lo risognavano indarno: si volle credere al pericolo di una guerra imminente, e nell'ammirazione destata dalle meravigliose vittorie prussiane si cercò di essere clienti a Berlino dopo essere stati vassalli a Parigi.
Naturalmente la corte spingeva il governo in tale direzione. Si temeva dall'amicizia della Francia il contagio republicano: nella Spagna il ripristinamento della dinastia borbonica con Alfonso XII figlio di Isabella la cattolica non dava abbastanza garanzie di stabilità monarchica: un secondo scoppio republicano a Madrid avrebbe potuto destare qualche eco a Roma.
Dinastia e governo, temendo ingannevolmente di un moto republicano nel paese, si rifugiavano fra le più forti monarchie di Europa.
D'altronde la Francia, offesa dalle intenzioni anche troppo manifeste del nostro governo, offendeva: la nostra aderenza al suo nemico vittorioso le sembrava una inutile mostruosità d'ingratitudine dopo tanta nostra devozione a Napoleone III; non intendeva la nostra presente inimicizia se non come odio istintivo di monarchia alla republica.
[330] Nel nostro popolo invece duravano ancora i rancori per le offese a cagione di Roma, mentre una crescente ammirazione per la Prussia gli faceva parere una gran cosa l'essere accolto nella sua alleanza.
Non sarebbe stato difficile comprendere piuttosto che all'indomani della grande guerra del 1870, colla Francia esausta, colla Prussia affranta e preoccupata gravissimamente del proprio problema interno, coll'Austria scaduta, colla Russia tutta intesa ad un imminente attacco contro la Turchia, coll'Inghilterra oramai inefficace in tutte le questioni continentali, l'Italia avrebbe potuto con una politica forte d'indipendenza e d'iniziative conquistare un grande posto in Europa. La sua posizione oramai assicurata contro tutti i nemici la rendevano necessaria in Europa: tutti i popoli l'avrebbero guardata con irresistibile simpatia, tutti i governi avrebbero subìto i suoi impulsi. Ma perchè l'Italia si ponesse alla testa dei popoli faticanti per la costituzione della propria nazionalità le occorreva una coscienza di se medesima e della propria missione, quale Mazzini aveva indarno cercato d'infonderle.
Le sue condizioni interne non erano abbastanza floride. Il pareggio raggiunto era piuttosto di cassa che di rendita; e le teorie economiche del nuovo governo costringendo all'abolizione del macinato e del corso forzoso, l'avrebbero certamente compromesso. Dopo l'esperienza delle armi prussiane l'esercito andava riordinato, riarmato, portato ad un milione; la flotta era sempre allo studio; le maggiori reti ferroviarie incompiute; l'esperimento di un voto più largo nel popolo ancora da tentarsi.
Nella Camera il nuovo partito di governo si componeva in gran parte di transfugi di destra, perchè i radicali, pur aspettando con simpatica deferenza, non avevano dimenticato tutti i sottintesi republicani. Bisognava non gettare il paese in una doppia prova di politica estera ed interna, ma largheggiando con esso di riforme liberali, mantenerlo con opportune pressioni [331] sotto la tutela del governo. La sinistra doveva proseguire il giuoco della destra con poste maggiori: il principio monarchico rimaneva a pernio della vita nazionale. Ma poichè la destra odiava ciecamente il nuovo governo, questo era forzato a compromettersi coi radicali e ad appoggiarsi sopra una mobile maggioranza ottenuta con ogni sorta d'espedienti. La sua azione si esercitava naturalmente per corruzioni: la sincerità sperata dal paese in questo secondo partito si perdeva in un più tristo scetticismo, l'orgoglio nazionale veniva nuovamente umiliato dalla Germania, il programma delle nazionalità era abbandonato per una alleanza coll'Austria posseditrice di Trento e di Trieste, l'ostilità alla Francia ci traeva al disconoscimento di ogni moto nazionale nei Principati Danubiani e nella Grecia.
Da principio i ministeri di sinistra, anzichè succedersi in una gamma razionale di liberalismo, si alternarono tristamente per inescusabili gare fra i capi: la vanità del potere vi guastò i migliori caratteri, la necessità degli espedienti vi falsò più d'un principio. Si vide allora la destra allearsi con assurda partigianeria ai radicali, reclamando il suffragio universale per non accettare l'equo allargamento proposto dal ministro Depretis; questi trascinare re Umberto a Vienna, perchè il Minghetti vi aveva condotto Vittorio Emanuele, e subire uno smacco anche più oltraggioso, giacchè a Vittorio Emanuele la visita fu resa a Venezia e ad Umberto promessa a Roma e non restituita. Una rettorica finanziaria, nel crescendo delle spese, che doveva raddoppiare il numero dei chilometri ferroviari e portare il bilancio della guerra a oltre settecento milioni, volle abolito con grave squilibrio del bilancio il macinato ed il corso forzoso; una rettorica politica non seppe considerare il voto concesso al popolo nè come diritto nè come funzione, e negò il suffragio universale per riconoscerlo poi abbassando fin sotto l'assurdo il livello e le prove della capacità elettorale.
[332] Nel nuovo grande disegno ferroviario i criteri regionali prevalsero ancora agli scientifici.
Molte delle riforme promesse andarono perdute; quelle attuate lo furono non bene.
Non si osò giustamente toccare lo statuto per non rimettere in questione la monarchia, ma lo si violò in più di un articolo, dichiarandolo intangibile. Il senato, assurdo come istituzione storica in Italia, rimase immutato, ultimo baluardo della regalità e superstite forma del diritto divino, giacchè il potere legislativo gli viene delegato dal re e non dal popolo. Le opere pie, di cui solamente ora (1889) il ministero Crispi studia una riforma, seguitarono nell'antico andazzo piuttosto a beneficio della borghesia e del clero che dei poveri, con anacronismi di fondazioni religiose e con falsità di intendimenti economici condannati egualmente dalla scienza e dalla vita moderna. Non si osò ancora condensare le troppe università nei loro centri storici, differenziando chiaramente la cultura classica dalla tecnica e riassumendo nelle mani del governo l'istruzione elementare abbandonata ai comuni e da questi trascurata per insufficienza di denaro o di coscienza civile.
Nullameno in questa seconda fase d'organizzazione le idee si slargarono, e l'orgoglio nazionale si ridestò. Si comprese la necessità di atteggiarsi a grande nazione: l'esercito, cresciuto pari a quello delle maggiori potenze, ci diede il senso di un'altra forza politica; nella flotta il vecchio genio italiano improvvisò la più moderna e miracolosa architettura navale sorpassando Inghilterra ed America; il foro del Gottardo, chiamato da Carlo Cattaneo la via delle genti, decise all'ampliamento del porto di Genova, che potè rivaleggiare con quello di Marsiglia e diventerà l'emporio di tutta l'Europa centrale. Industria e commercio prosperarono attraverso pericoli di crisi incessanti; l'emancipazione manifatturiera fu conquistata più che a mezzo; l'agricoltura, della quale una mirabile inchiesta parlamentare svelò tutte le piaghe, si guarì di alcune, [333] e passò dallo stadio empirico a migliori e più diffuse intenzioni scientifiche. Le ferrovie, cresciute in breve a 14,000 chilometri, aiutarono l'uniformità dello sviluppo nazionale; s'iniziò la perequazione fondiaria, lunga e costosa impresa, senza la quale nessun vero miglioramento tributario era possibile; nell'esercito si abolì l'ignobile privilegio della surrogazione per denaro, e la coscrizione fu estesa a tutti gli individui validi; non si osò ancora il sistema più economico dell'irreggimentazione regionale per dubbi di pericolosi antagonismi, ma si tende ora a provarla; si popolarizzò l'istituzione dei tiri a segno, primo addestramento della futura nazione armata; le associazioni operaie moltiplicarono di numero e di valore; l'avvento dei nuovi elettori politici ed amministrativi togliendo al governo l'odioso carattere di clientela, lo ritemprò nella realtà della vita popolare; si unificarono le Cassazioni, ma solamente in materia penale per rispetto ingiusto al regionalismo: si ricorressero pressochè tutti i codici guadagnando all'Italia il nome di prima fra le nazioni liberali; si accennò ad una legislazione sociale del lavoro, la quale arenò fra i pregiudizi politici della borghesia e gli apriorismi della scuola liberista.
Colla sinistra al potere cessò la minore età della nazione.
L'opposizione clericale stessa parve diminuire di intensità. Si parlò di transazioni e di conciliazioni; il papato, fermo nelle viete dichiarazioni, ne raddolcì la forma e in molti atti le contraddisse; la libertà del suo esercizio spirituale fu riconosciuta anche dai cattolici ultramontani, ma papato e monarchia non poterono ancora conciliarsi. Il papato non abbandonerà tutte le proprie pretese se non perdendo tutti i privilegi: bisognerà quindi che una rivoluzione riduca prima il cattolicismo a non essere più che una opinione e un rito sostenuto dai credenti ma destituito di ogni personalità civile: finchè il cattolicismo avrà beni e [334] gradi consacrati dalla legge pretenderà di riacquistare quanto ha perduto.
L'Italia è ora una delle grandi nazioni d'Europa: la sua monarchia, sorta da una insufficienza rivoluzionaria e democratica, è la più popolare e liberale del mondo.
La coscienza nazionale, sonnolenta nel periodo epico dell'unificazione, riconquista oggi nel culto degli eroi il proprio passato. Mazzini e Garibaldi giganteggiano sulle piazze di tutte le città; le commemorazioni dei grandi morti popolarizzano la storia dell'unità gettando i semi di una futura poesia in racconti di eroismi e di magnificenze morali prima non sospettate; Vittorio Emanuele si trasfigura nella luce dell'epopea perdendovi ogni volgarità; Cavour, obliato un momento nel trambusto dei suoi successori, riappare astro di prima grandezza nel cielo d'Europa. L'Italia è fatta: la sua storia si riapre per una terza epoca di operosità politica internazionale. Infatti l'Italia, trent'anni or sono conquista di stranieri e schiava di tiranni, è entrata ieri conquistatrice nell'Africa.
L'unità della storia mondiale, che scoperte scientifiche e geografiche hanno da gran tempo assicurato, attira con mirabile rapidità tutti i continenti nell'orbita di una stessa politica.
Nessuna nazione potrebbe o vorrebbe più circoscriversi in se stessa: religione, commercio, scienza, hanno aperto alla civiltà tutte le terre; ogni mercato subisce le oscillazioni dello scambio internazionale; oramai non vi sono più segreti per la geografia, nè sconosciuti per la storia. La nave svedese di Nordenskjöld girando il polo artico ha rivelato la presenza degli ultimi abitatori dei ghiacci; viaggiatori di tutti i paesi hanno traversato i deserti centri dell'Africa e dell'Australia; l'Asia si apre davanti alle marcie concordi e rivali della Russia e dell'Inghilterra, mentre l'America scoperta appena da quattro secoli non ha più selvaggi.
L'Europa, rimasta ancora, malgrado il miracoloso sviluppo di questa ultima, il centro ideale del mondo, organizza in se medesima i propri popoli nell'orbita della nazionalità e coi principii di una democrazia più universale di tutte le religioni, per attirare gli altri continenti nei periodi della propria civiltà. L'America, instancabile ed incomparabile traduttrice di idee, non ne ha ancora prodotto alcuna veramente originale, giacchè la sproporzione fra la grandezza del suo suolo [336] e il numero della sua popolazione la costringe a convergere in se medesima quasi tutte le proprie forze. L'Europa, sola, piccola, affollata, sempre gestante, deve bastare a tutto, ritrovare il significato dell'antichità, e rinnovare continuamente se stessa per potere del proprio futuro fare un'epoca mondiale. Quindi il suo sforzo sempre crescente nei secoli, dacchè il cristianesimo le diede a Roma la sicurezza di una seconda unità, si è moltiplicato dopo il Rinascimento e la scoperta d'America, così da imprimere alla storia universale un acceleramento inapprezzabile.
Quando la scienza storica, imitando i progressi dell'astronomia, potrà calcolare entro l'orbita di periodi universali la velocità delle idee per tradurre in cifra la vita e il valore di ogni popolo, quello dell'Europa dall'epoca greca al Rinascimento italiano varrà non solo più che tutti gli altri, ma la sua potenza d'irradiazione dovrà esprimere nella velocità dei propri raggi la differenza della durata cronologica della sua civiltà colle altre. E mentre quella asiatica in cinquanta secoli non avrà potuto sorpassare i confini del proprio continente, la civiltà europea in meno di venti avrà già dato al mondo due unità ideali: quindi dal Rinascimento ad oggi i suoi ultimi quattro secoli, attuandovi l'unità reale in una conscia cooperazione di tutti i popoli, supereranno di velocità gli altri venti forse di quanto nel sistema solare i periodi di Venere vincono quelli di Urano.
Mentre nel secolo decimosesto, settimo ed ottavo, spingendosi in tutte le direzioni ad incontrare le incognite dei popoli inerti fuori del raggio della sua storia, l'Europa faceva ogni maggiore sforzo sull'America quasi ad affrettare in essa una rivalità che le potesse più presto giovare in questa missione d'incivilimento universale, dal principio di questo secolo la sua passione e la sua opera si sono rivolte più specialmente all'Africa. L'America, divenuta già moderna, piuttosto che aver bisogno dell'Europa per svilupparsi, ne segue la vita ampliandola in se medesima per tutta [337] l'immensità del proprio teatro coll'ebbrezza superba di sentirsi già all'avanguardia del progresso mondiale.
La costituzione delle nazionalità, provocata dalla rivoluzione francese, sembra accennare che l'Europa in questo fatale acceleramento dell'opera propria sul mondo, invece di procedere come nel passato per costante irradiazione d'individui, tardi e non sempre susseguita dalla cooperazione dei loro stati, voglia più presto, individualizzando tutti i propri popoli, costringerli ad agire come individui collettivi. Infatti l'opera storica di un popolo non costituito in nazione è non solo male apprezzabile, ma scarsa ed intermittente oltre le sue frontiere, mentre quella delle nazioni, più intensa e costante, determina coll'incontro della propria in altre originalità la formazione di nuovi caratteri.
Quindi il principio dell'uguaglianza civile e della sovranità popolare, ricostituendo in nazioni i popoli ancora frantumati dalle conquiste medioevali, impone loro per una fatale contraddizione di affrontare fuori d'Europa le genti barbare, o conglomerate in imperi eterogenei, o riunite a gruppi nazionali, o disperse in tribù, per sottoporle alla prova della civiltà europea.
Storia e preistoria, storia moderna e storia antica, debbono in questo secolo sviluppare la loro guerra immortale. Finchè la preistoria vivente era ignorata dalla storia, e la storia antica lungi dal contatto della storia moderna, il mondo abbastanza grande per ambedue poteva mantenerle contemporanee nella propria cronologia; ma scontrandosi per il continuo dilatarsi dell'orbita europea, dovevano urtarsi in una guerra di distruzione. Preistoria e storia antica o si rimuterebbero entro la storia moderna assimilandosi le sue idee, o indietreggerebbero lentamente cedendo il terreno ai popoli superiori.
La storia, lungi dal consacrare l'intangibilità di alcun popolo, ha sempre distrutto quelli che non potevano adattarsi al suo disegno.
[338] Nel diffondersi della civiltà rappresentata dalla razza bianca una medesima conquista strappò sempre ai popoli selvaggi o esauriti i terreni atti a ricevere il quadro di una più alta vita. Invasioni e colonie furono sino dalla più tarda antichità i mezzi più efficaci d'espansione: nelle prime il progresso avveniva per la sovrapposizione di un popolo ad un altro; nelle seconde per focolari d'irradiazione ideale, che dovevano aiutare la natura dei popoli circostanti a più intellettuale sviluppo. Tutto quindi servì in questa caccia dell'uomo civile all'uomo barbaro, del popolo giovane al popolo decrepito; irresistibili attrazioni dell'ignoto geografico, passioni religiose, curiosità scientifiche, avarizie commerciali, fantasie guerriere. Naturalmente la civiltà, svolgendosi col processo inevitabile di una guerra, trattava le colonie come avanguardia di scoperte o sentinelle morte, mentre le invasioni giungevano sui campi di battaglia all'ora assegnata, vincendo, struggendo, fecondando.
Nella lunga incubazione della civiltà mediterranea, alla quale l'Asia già immobile nel trionfo di un'epoca poco più perfettibile coi propri dati restava lontana ed estranea, l'Africa non aveva concorso che colle proprie sponde. Una cintura di città marittime le aveva abbellite e fecondate senza poter allargarsi all'interno. La loro vita creata dal mare tendeva quindi al mare verso altri lidi, ove altre città rispondevano loro con una vita più satura di elementi terrestri. Solo il Nilo aveva potuto, accumulando sulle proprie rive molti germi africani, crescervi una civiltà più che marittima; ma questa pure non aveva saputo risalire nemmeno tutto il corso del gran fiume, prigioniera ad occidente ed al sud di paurosi deserti.
L'immensa Africa ignorava la gloria del proprio Egitto.
[339] E quando questo tramontò dopo Cartagine entro lo splendore della civiltà romana, e il cristianesimo prima e il maomettanesimo poi, tentarono di penetrare nel centro del continente nero, questo rimase nullameno un mistero: ambo le religioni vi si depravarono in una sconcia interpretazione quasi confessando l'impotenza del proprio Dio innanzi ai feticci di selvaggi, cui un clima inesorabile sembrava negare per sempre ogni speranza di ideale.
Ma l'azione della storia sull'Africa non cessò.
Quattro secoli or sono, quando Cristoforo Colombo discendeva dalla vecchia caravella all'America, Cadamosto veneto penetrava nel Senegal e nella Gambia, e la republica veneta offriva ad un sultano di tagliare l'istmo di Suez, miracolo di audacia allora, miracolo di scienza oggi, e che senza forse si sarebbe avverato anche allora.
L'Italia, dopo aver attirato con Roma tutta la civiltà africana nella propria orbita, e mediante le republiche del medioevo mantenuto con essa commerci quasi inosservati dall'Europa barbarica, parve allora arrestarsi: Africa ed America sfuggirono simultaneamente alla sua influenza.
Nonpertanto Roma e la Mecca, come centri religiosi, rattenevano sempre l'Africa nella storia universale; gl'imperi litoranei improvvisati dalla conquista saracena sulle sue coste avevano potuto dilatarvisi alquanto verso l'interno, e ubbidivano ancora alla voce di Costantinopoli: Spagna, Francia, Portogallo, Inghilterra, girando il capo di Buona Speranza, avevano finalmente circoscritto il continente nero, fermandosi su tutte le sue sponde e risalendo tutti i suoi fiumi.
Se la grande speculazione mercantile europea si riversava sull'America attratta dall'incanto delle sue terre e dalla facilità di sfruttarle, un'acuta curiosità spingeva sempre nuovi esploratori nell'Africa, sulle rive della quale il moltiplicato commercio colle Indie creava stazioni navali e stabilimenti coloniali. La supremazia mondiale dell'Europa, chiamando all'azione [340] tutti i popoli germanici per controbilanciare la fatale decadenza delle nazioni latine, aveva già colle ultime vittorie su Costantinopoli tolto ogni pericolo alla barbarica espansione del maomettanesimo, che un giorno dall'Africa invadeva le Spagne e, superati i Pirenei, si spingeva fino a Poitiers contro Carlo Martello.
Oramai imperi e reggenze barbaresche non erano più che una forma consunta della feudalità saracena, ridotta a vivere di brigantaggio terrestre e marittimo.
Quindi la grande rivoluzione francese, prima ancora di condensarsi nell'impero militare di Napoleone I per meglio rovesciare tutte le monarchie di diritto divino, discese in Africa e vi sottomise l'Egitto. L'impresa parve un'avventura di condottiero antico, ma era invece una conquista moderna. Napoleone tagliava così l'ultimo nodo, che stringendo l'Africa a Costantinopoli la manteneva ancora più soggetta all'influenza orientale del maomettanesimo che all'azione europea: la Sublime Porta dopo la perdita dell'Egitto non conserverebbe più che una sovranità nominale sulle altre terre limitrofe. La conquista fu momentaneamente perduta, ma la Turchia non potè più ristabilire il proprio potere sull'Egitto. Una dinastia macedonica v'improvvisò un trono con barbariche imitazioni della monarchia napoleonica, e vi si sarebbe proclamata al tutto indipendente se rivalità d'interessi europei non l'avessero impedito per mantenere ancora alla Turchia una specie di diritto imperiale.
Nonpertanto l'Egitto divenne europeo.
L'archeologia ricostituì tutta la sua antichità, la geografia ritrovò le sorgenti misteriose del suo Nilo, la matematica tagliò il suo istmo di Suez. La dinastia di Mehemet Alì, che ebbe in lui l'uomo di stato e nel figlio Ibrahim il generale, durò appena il tempo necessario alla prima fase dell'incivilimento moderno in Egitto, per cadere all'indomani dell'apertura del canale sotto il protettorato dell'Inghilterra (1882), la quale aveva già conquistata pochi anni prima l'Abissinia. La Francia sino dagli ultimi giorni della restaurazione [341] (luglio 1830) si era impossessata d'Algeri, e dominava col Portogallo nella Senegambia, conquistava più che mezza l'immensa isola del Madagascar, s'impadroniva (1878) della Tunisia. La Spagna preponderava al Marocco; l'Olanda spesseggiava di colonie come l'Inghilterra sulle coste del doppio oceano africano; persino la Russia e la Germania tentano ora di stabilirvene.
La storia africana di questo secolo è tutta europea: l'Asia non vi agisce più che col maomettanesimo provocandovi guerre feroci di religione, come l'ultima del Mahdy; i napoleonidi vi hanno iniziato e compito il loro breve ciclo solare, l'americano Stanley vi ha scoperto il Congo, vasto quanto l'Europa, e che il piccolo re del Belgio vi ha acquistato come un podere; i Boeri, di origine olandese, vi hanno già una republica; viaggiatori di tutte le nazioni si sono inoltrati per tutti i suoi deserti superando tutte le montagne, affrontando tutte le tribù, rivelando tutta la preistoria. Il loro eroismo è stato sublime quanto benefico, il risultato delle loro scoperte immenso quanto imprevedibile.
Un'Africa orribilmente nera e selvaggia si è rivelata alla storia, ma il suo clima che in molti luoghi è una vampa, i suoi deserti che hanno l'ampiezza dei mari, la loro aridità che fa pensare ad una maledizione e che una volta si supponevano uniformi in tutto il suo centro, non sono che una varietà della sua natura. Ora si sa che fra le sue montagne si trovano territori incantevoli, regioni prodigiose di bellezza e di feracità, sulle quali vive ancora la più feroce razza, che il sole abbia mai annerito. Una feudalità primitiva vi sminuzza l'impero in minime tirannie di tribù, una sanguinaria incoscienza vi fa della guerra l'unica industria e della strage il supremo divertimento; vi si incontrano ancora monumenti di teschi, e vie segnate da ossa. L'antica favola delle amazzoni vi è tuttora una realtà nell'impero del Dahomey, che ha il [342] proprio esercito composto di donne; i sacrifici di Moloch, nausea e terrore del mondo antico, vi si celebrano sempre ai funerali dei re trucidando migliaia di mogli e di servi. La servitù vi è istituzione millenaria, più feroce che in Asia non sia mai stata; il commercio degli schiavi, vietato sul mare, vi prospera all'interno così che si calcolano a molti milioni i venduti di ogni anno. Per quest'Africa tutto quanto avvenne nella storia del mondo è come se non sia avvenuto: la sua vita è ancora nel sole che brucia il sangue e dissecca nell'animo ogni sentimento; il popolo, che vi cresce nudo come i deserti e con una coscienza egualmente arida, vi è la fiera più crudele della sua fauna.
Quanti miliardi di vittime in quante migliaia di anni ha consumato questa preistoria africana, che, immobile nelle proprie idee rudimentarie, si ripete, colla disperata monotonia di un vagito e di un rantolo, di un bambino che nasce e di un uomo che muore?
Ma l'Europa dopo molti secoli di assedio ha potuto penetrare tutte le contrade dell'Africa e sta per sostituirvi la propria storia: tutte le grandi nazioni europee si sono gettate a questa conquista sfogando magari in essa le loro antiche rivalità: denaro, sangue, genio, tutto vi è profuso. Le ferrovie cingono fin d'ora tutte le sue coste con un monile di ferro, entro il quale l'Africa prigioniera della civiltà non può più ricusarne i benefizi: dopo il grande taglio del canale di Suez un disegno anche più grande allaga già il deserto di Sahara, e vi crea sulle sponde fecondate una cintura di città pari a quella del Mediterraneo; un altro congiunge i corsi dello Zambese e del Congo, spezzando il continente in due grandi isole per meglio irradiarle da tutto il litorale e dal centro. L'Italia risorta nazione non poteva ricusarsi a questo problema africano, che domina la politica estera dell'Europa: il suo concorso doveva anzi rappresentarvi il primo risultato della sua nuova vita internazionale.
Quindi, prima ancora di aver ripreso agli stranieri tutta la propria terra, l'Italia si torse verso l'Africa.
Già il conte di Cavour nel periodo della grande preparazione piemontese, sentendo l'attrazione di questo nuovo mondo, aveva cercato di avviare un servizio postale fra Cagliari e Tunisi; Garibaldi, esiliato dal governo sardo dopo la difesa di Roma, aveva scelto per residenza Tangeri; un illustre cappuccino, il padre Massaia, testè morto cardinale, era penetrato da molti anni nell'Abissinia, recandovi nel fervore dell'apostolato religioso parecchi intendimenti civili. Altri viaggiatori, còlti improvvisamente dalla nostalgia del deserto, approdarono in Africa, e la percorsero superando indicibili difficoltà: Beccari, Piaggia, Antinori, Gessi, senza aiuti di governo, vi compierono miracoli d'eroismo; quest'ultimo, ammirabile fibra di romagnolo antico, vi si mutò in generale, e vinse nelle guerre del Sudan più d'una battaglia. Allora nel fermento lasciato dalle imprese garibaldine, crebbe istantaneamente una passione misteriosa per il terribile continente nero: si fondarono società geografiche, si organizzarono come in tutto il resto d'Europa spedizioni di nuovi esploratori, i giornali si appassionarono di racconti africani, come quattro secoli prima tutte le conversazioni favoleggiavano dell'America e delle Indie. Un'indefinibile poesia trasfigurava agli occhi della moltitudine i giovani viaggiatori che partivano per l'Africa; una pietà inconsolabile si destava alla novella della loro morte.
Pareva a tutti che questo fervore di scoperte e di iniziative fosse una prova di nuova gioventù nella nazione, che stava ricostruendo con temerità pari all'ingegno nella propria flotta la prima armata del mondo. La marina mercantile cresceva, e cresceva pure l'emigrazione. Chè se a questa, salita ora all'altissima cifra annuale di 200,000 emigranti, era in molte provincie sprone la miseria agricola, in molte altre tale coraggiosa facilità ad abbandonare la patria per un mondo [344] ignoto e lontano, era ancora un sintomo della nuova vita italiana. Pochi anni addietro, nella stessa miseria, al popolo sarebbe sembrato un suicidio l'emigrare. Ma l'emigrazione si dirigeva di preferenza sull'America del sud dominata da colonie latine.
Nell'Africa, tanto più vicina, Cairo ed Alessandria erano le stazioni predilette dagli italiani.
Ma la nazione sentiva oscuramente la necessità di uscire di se stessa per affermarsi politicamente nell'opera internazionale delle maggiori potenze. L'Italia aveva scritto in Africa troppi capitoli della propria storia antica, per non ritornarvi nella guerra di conquista ripresa così vivacemente dall'Europa al principio del secolo. La via aperta alle Indie per il canale di Suez, l'ampliamento del porto di Genova, il doppio traforo delle Alpi le suggerivano le prime ragioni: la storia spingeva colla propria fatalità.
Però le coste africane non presentavano in alcun punto facilità e ricchezza di conquista: l'Italia, ultima cooperatrice, vi troverebbe forse le maggiori difficoltà nelle gelosie delle nazioni che ve l'avevano preceduta. D'altronde nè il suo popolo, nè il suo governo erano ancora abbastanza consapevoli per gettarsi con molta fortezza d'animo e larghezza d'intendimenti ad imprese coloniali.
Quindi i principii dell'impresa furono meno che modesti.
Prima ancora che le camere di commercio, riunite in congresso a Genova nell'ottobre del 1869, proponessero al governo di stabilire in un porto del Mar Rosso una fattoria di commercio e di transito, il professore Giuseppe Sapeto, che aveva lungamente soggiornato nelle regioni dei Danakil e dei Somali, insisteva in una relazione al generale Menabrea, allora presidente dei ministri, per un acquisto di tal genere. Vittorio Emanuele protesse l'idea spingendo ad un contratto col sultano Berehan, indipendente dalla Porta e dall'Egitto, per la compra della baia d'Assab e dell'isola Darmakieh. Il pagamento della somma abbastanza esigua [345] di L. 47,000, fornite dal governo, venne eseguito dal genovese Rubattino, il più ricco e patriottico fra gli armatori d'Italia. Quindi l'11 marzo 1870 due pali solidamente conficcati ai capi nord e sud del terreno acquistato e portanti su due tasselli di legno l'epigrafe — Proprietà Rubattino — segnavano dopo tanti secoli il nuovo ingresso dell'Italia nella storia coloniale.
Questo grosso e quasi deserto podere era a 64 chilometri da Perim e a 240 da Aden.
Il fatto rimase inavvertito: appena Nino Bixio, sempre fervido di avventure marinaresche e militari, se ne congratulò vivamente col governo, augurando bene per l'Italia e chiedendo subito che si occupasse soldatescamente Assab per guarantire le persone e le merci, che vi avrebbero affluito.
Ma il khedivè d'Egitto aveva già protestato contro l'occupazione di Assab: il Visconti-Venosta, allora ministro degli esteri, oppose l'indipendenza di questo piccolo territorio da ogni alta giurisdizione, poichè le caimacanie di Suakin e di Massaua, delle quali il khedivè era stato investito dalla Sublime Porta, non giungevano sino ad Assab; questi replicò nominando governatore di Massaua lo svizzero Munzinger ed estendendo i limiti di quella provincia sino a Berbera. Allora il governo italiano, troppo presto impacciato da così piccole difficoltà, rinunciò ad ogni assetto pratico e definito dello stabilimento di Assab, per consigliare alla compagnia Rubattino di ampliare i propri servizi marittimi verso Oriente.
Così durò per parecchi anni sino agli ultimi mesi del 1879.
All'indomani del trattato di Berlino (marzo 1878) una più grossa questione minacciò di rompere le relazioni fra l'Italia e la Francia. Poichè il congresso aveva scartata la proposta russa di una grande Bulgaria accampata fra l'Egeo e il Danubio, mentre all'Austria [346] si sarebbero date la Bosnia e l'Erzegovina con grave offesa dell'Italia, che avrebbe così veduto crescere senza aver partecipato alla guerra turco-russa la sua secolare nemica ancora padrona di Trento e di Trieste, si credette che fra le quinte del congresso fosse stato offerto all'Italia Tunisi per compenso. La Francia, che già vi mirava, stimò invece favorevole ad una propria iniziativa su questa reggenza posta ai confini dell'Algeria il disinteressarvisi unanime di tutte le potenze. Vero è che a Tunisi la colonia italiana, molto più numerosa ed importante delle altre, e cresciuta di speranze col crescere della madre patria, chiedeva a questa una più efficace protezione.
Una convenzione marittima stretta nel 1877 col governo beylicale aveva riconfermato l'antica linea Genova-Cagliari-Tunisi; un'altra linea era stata instituita in partenza da Palermo: la vicinanza della costa africana, visibile nei giorni limpidi dagli estremi monti siculi, consigliava a proteggervi i nostri interessi mediterranei. L'Inghilterra, insignorendosi di Cipro, aveva ferito le suscettibilità francesi, e ne temeva per il suo canale di Suez qualche rappresaglia collo stabilimento di nuove stazioni militari sulle coste vicine per parte della Francia; quindi consigliava all'Italia di occupare Tunisi e Tripoli. Naturalmente, vicino per vicino, essa preferiva l'Italia perché meno temibile. Ma il ministero Cairoli, repugnante per convinzioni democratiche a qualsivoglia forma di conquista estera, non osava assumerne la doppia responsabilità della spesa e del rischio. La Francia, sino allora in relazioni poco amichevoli coll'Italia, mutava improvvisamente di maniere, affermando replicatamente con documenti e colloquii officiali di non mirare ad occupazione di sorta sulla costa africana, o, mirandovi un giorno, di non vi si disporre se non d'accordo coll'Italia.
Queste assicurazioni sorpresero l'ingenua lealtà del Cairoli: egli credette che la republica francese, fatta accorta dell'errore commesso coll'inimicarsi l'Italia, [347] intendesse a riconquistarne l'amicizia: infatti tutto sembrava consigliarle tale condotta.
Ma si dimenticavano l'indomabile vivacità e le inesauribili risorse del popolo francese. Vinto dai prussiani in una delle più grandi guerre della storia, travolto nella rovina dell'impero napoleonico, riarso e lacerato dallo scoppio della Comune, combattuto da tutte le frazioni monarchiche, esso aveva nullameno in pochi anni pagato l'enorme debito di cinque miliardi, assicurata la propria republica, rinnovato l'esercito, rinsanguate le finanze. Una febbre di orgoglio e di lavoro lo spingeva a nuove conquiste per interrompere con qualche fatto glorioso l'ignominiosa tradizione di Sedan.
Il gabinetto Cairoli credette la Francia, come l'Italia, occupata solamente a rimarginare le proprie ferite. Ma il suo disinganno avrebbe potuto essere sollecito, quando ai primi accordi col bey per allacciare con un filo telegrafico la rete sicula alla tunisina, la Francia si oppose bruscamente col pretesto che la sua amministrazione algerina godeva già nella Tunisia il monopolio dei servizi telegrafici. Tale pretesto, fiacco politicamente, non era neppure sicuro in diritto. Nullameno il gabinetto Cairoli cedette e i telegrammi fra Roma e Tunisi seguitarono a passare per Parigi, Marsiglia, Algeri e Bona.
Poco dopo l'armatore Rubattino offriva al ministero di comprare il tronco ferroviario Goletta-Tunisi della società concessionaria inglese ridotta al fallimento, se il governo gli concedesse il medesimo trattamento di guarentigia in uso per le linee italiane. Cotesto breve tronco era il prolungamento naturale della linea italiana di navigazione sussidiata dal governo, poiché le nostre navi per le tristi condizioni del porto di Tunisi dovevano arrestarsi alla Goletta. II contratto era facile e tenue la somma. Il ministero annuì. Ma il contratto era appena firmato che già la società francese des Batignolles, proprietaria della grande arteria algerina di Bona-Guelma, prolungata [348] in quel momento coi soccorsi della republica sino a Tunisi, ne stringeva un secondo ricomprando per maggior somma la linea già venduta. Evidentemente una intenzione politica aveva provocato questa truffa: la questione, recata prima ai tribunali ordinari, fu quindi riassunta dalla corte di cancelleria a Londra. Il magistrato inglese sentenziò imponendo una nuova licitazione fra i due contendenti. Il gabinetto Cairoli, tardi accorto del pericolo e impaurito della doppia responsabilità, chiamò a consiglio i migliori uomini parlamentari, che furono unanimi nel mantenere ogni appoggio al Rubattino. Laonde un disegno di legge (12 luglio 1880) fu presentato al parlamento per una rete complementare di linee di navigazione e per garanzia alla società Rubattino di un interesse chilometrico per la ferrovia Goletta-Tunisi. La camera con un silenzio più espressivo di ogni parola votò la legge.
L'onore nazionale era impegnato.
Ma la Francia passò oltre: avventurieri e speculatori parigini piombarono su Tunisi; i giornali francesi alzarono la voce. Non per tanto il gabinetto Cairoli, saldo nel convincimento che la Francia rifuggisse da pericolose avventure, e troppo credulo alle assicurazioni diplomatiche dell'ambasciatore marchese di Noailles, non badò a premunirsi. La sua politica del momento, chiamata poi ironicamente della mano libera, consisteva nel voler essere a qualunque costo in amichevoli rapporti con tutti: in fondo si voleva la pace non sentendosi pronti alla guerra. Ma siccome le voci di occupazione francese aumentavano, si dovettero chiedere spiegazioni a Parigi; il generale Cialdini, allora ambasciatore colà, diede nella pania; il ministero francese protestò sino all'ultimo contro ogni diceria; però pochi mesi dopo, inventando una tribù barbara di Krumiri, che dal territorio tunisino avrebbero fatto scorribande in Algeria, spedì contro di essi un corpo di truppe. Il gabinetto Cairoli, credendo ancora questo cattivo pretesto una buona ragione, non si mosse: la diplomazia francese affermava sempre di non [349] pretendere tutto al più che una rettificazione di frontiere nel paese dei Krumiri, e mentre il suo ambasciatore lo ripeteva per l'ultima volta al Cairoli nel palazzo della Consulta, il generale Bréard s'impadroniva di Tunisi costringendo il bey a firmare un trattato, che lo riduceva a funzionario francese.
Si disse allora, e non senza fondamento, che il principe di Bismarck spingesse la Francia a questa violenza per impedirle ogni possibile alleanza coll'Italia e mantenerla nell'isolamento.
Per l'Italia questo avrebbe dovuto essere caso di guerra, ma Cairoli, altrettanto eroico patriota che insufficiente diplomatico, non sapendovela preparata, preferì dimettersi in mezzo ad una tempesta d'ingiurie, e tacere. La pubblica opinione giudicò che tutta la colpa fosse sua, ma non seppe di essere corsa sino alla guerra se non quando il pericolo ne fu passato. L'ultimo dei Cairoli aveva fatto alla patria l'ultimo dei sacrifici, immolando al suo interesse l'onore del proprio nome: Garibaldi, rimasto solo a comprenderlo fra l'equivoco di tutti, si dolse della sua opera e plaudì al suo silenzio.
Questo doveva essere il nostro primo insuccesso africano.
I partiti strepitarono, l'Africa divenne popolare. Dacchè tutte le nazioni europee vi davano l'esempio di continue imprese, si cominciò ad ammettere la possibilità di una conquista, che riaprisse la nostra gloriosa storia coloniale: il crescere della marina militare e mercantile secondava le speranze; i recenti rancori contro la Francia, eccitati dal governo per odio alla sua republica, spronavano ad una rivincita. Altri viaggiatori seguitavano a partire pel continente nero: Pellegrino Matteucci, che doveva poi disputare a Stanley la gloria di traversarlo da oriente ad occidente spirando a Londra vittorioso dell'incredibile viaggio, si avventurava in una prima spedizione ai paesi dei Gallas; il capitano Antonio Cecchi rimaneva per quattro anni prigioniero della regina di Ghera, che esigeva [350] sultanescamente l'omaggio dell'amore da tutti i bianchi pellegrinanti pel suo regno; Giulietti e Bisleri ritentavano una nuova via per l'Abissinia; Chiarini, Bianchi, Diana, Monari, punti d'eroica invidia, si disponevano a partire e nessuno di essi doveva più ritornare.
Il governo si sentiva spinto.
Malgrado la politica di pace ad ogni costo, che lo attirava nell'alleanza degl'imperi tedeschi per odio alla Francia, facendogli scordare le supreme rivendicazioni del diritto nazionale, dal Mediterraneo gli venivano continui richiami all'azione: la Francia stessa dopo l'occupazione di Tunisi sembrava offrirgli in compenso quella della Tripolitania.
Intanto la necessità di assettare Assab di qualche maniera per non subirvi un secondo smacco tunisino urgeva.
L'Inghilterra, gelosa del proprio predominio indiviso sul mar Rosso, sosteneva le pretese del governo khediviale e moltiplicava a studio le difficoltà diplomatiche contro il gabinetto Cairoli, che, senza mutare il tono remissivo delle proprie risposte, tentava di passare di straforo. Infatti, dopo aver mandato nelle acque di Assab la fregata Varese col capitano De Amezaga per compiervi gli studi necessari all'assetto del nuovo stabilimento, la sostituì con un semplice avviso, l'Esploratore, perchè Gordon, governatore inglese del Sudan, aveva protestato da Massaua. Questa ostilità inglese energicamente accentuata dal ministro Salisbury bastò a rattenere nuovamente il gabinetto Cairoli. Intanto alla camera qualche interpellanza veniva ad incoraggiarlo: la Francia minacciava di attivare uno stabilimento commerciale nel proprio possesso di Obok; poi la caduta quasi simultanea dei ministri Salisbury e Cairoli permise ai successori di ritentare un accordo. Infatti i gabinetti Gladstone e Depretis parvero più vicini ad intendersi: l'eccidio della spedizione Giulietti nel territorio egiziano di Beilul, e di cui il governo khediviale non diede alcuna soddisfazione [351] per quanto costretto ad accettare nell'inchiesta un commissario italiano, aumentò gli addentellati nella questione: un tentativo dell'Egitto per ristabilire la propria sovranità a Rabeita sopra il sultano Berehan, che aveva venduto all'Italia la baia di Assab, fu sventato mercè l'intervento del nuovo gabinetto inglese: finalmente si firmò una convenzione fra l'Italia e l'Inghilterra pel riconoscimento della nostra sovranità ad Assab, e la camera con apposito disegno di legge potè gettare le basi politiche di un primo stabilimento commerciale.
In tutto questo lungo dibattito la nostra diplomazia non aveva avuto di meritevole che la tenacia del proposito.
La rivoluzione militare provocata al Cairo da Araby-bey sollevò in Europa la questione di un intervento egiziano: Leone Gambetta, il maggiore dei republicani francesi moderni, allora al potere, propose subito a lord Granville un accordo per intervenire a favore del khedive e crescere così la già vasta preponderanza della Francia e dell'Inghilterra sull'Egitto; ma il gabinetto inglese, temendo che la Francia meglio fornita di forze militari terrestri potesse guadagnare troppo in tale impresa, declinò l'offerta. Il signor De Freycinet, succeduto poco dopo al Gambetta, si mostrò alieno da ogni intervento armato: quindi venne fuori la proposta di una conferenza a Costantinopoli per riordinare la situazione egiziana. Il ministero Depretis-Mancini l'accolse con trasporto siccome l'unico mezzo per evitare le complicazioni di una guerra, ma naturalmente la conferenza abortì. Allora l'Inghilterra, pigliando ardimentosamente l'iniziativa, ripropose un intervento armato prima alla Francia, poi all'Italia: entrambe ricusarono.
Era questo il secondo rifiuto opposto dall'Italia all'Inghilterra sempre per la stessa timidezza politica: col primo aveva ricusato al tempo della guerra russo-turca (1877) d'intervenire nel mare e negli stretti per preservarvi gli interessi commerciali e politici, coll'altro [352] rifiutava di conquistare sull'Egitto una preponderanza che avrebbe incredibilmente migliorata la sua posizione nel Mediterraneo.
L'errore questa volta era così grave che la Germania stessa e l'Austria, per rispetto delle quali siccome alleate il ministero Depretis-Mancini non aveva ardito concorrere nell'iniziativa inglese, lo disapprovarono. Mentre la diplomazia italiana aspettava quindi che la Sublime Porta, vincendo la oramai proverbiale inerzia, intervenisse colle armi a difendere il proprio potere imperiale minacciato dalla rivoluzione, l'Inghilterra sconfiggeva il 13 settembre l'esercito di Araby-bey a Tel-el-kebir, bombardava Alessandria, e s'insignoriva alteramente dell'Egitto.
Tale facile trionfo rese più evidente la ingiustificabile timidezza del ministero che aveva ricusato parteciparvi. Quindi il problema africano si acuì ancora nella coscienza del paese: alla camera voci autorevoli si levarono per accusare il troppo riguardoso ministro, si citarono l'impresa di Crimea e le più temerarie e feconde iniziative garibaldine. Dopo tanti anni di inazione, malgrado i guasti mal riparati della finanza, si sentiva da tutti la necessità di far concorrere l'Italia ad una qualche opera internazionale.
La guerra accesa dal Mahdy nel Sudan, e vampeggiante per tutti i territorii dell'alto Egitto, parve riaprire all'Italia le porte dell'Africa, giacché l'Inghilterra regnante sull'Egitto per mezzo del khedive vi si dovette mescolare. Già l'esercito egiziano forte di circa 30,000 uomini aveva dovuto ripiegarsi sulle fortezze: un indomabile fanatismo dava alle orde del Mahdy l'entusiasmo delle prime invasioni mussulmane in climi e luoghi che sembravano dover vincere ogni resistenza di soldati e qualunque abilità di generali europei. La guerra d'Abissinia contro l'imperatore Teodoros, costata da 300 milioni senza produrre alcun risultato politico, persuadeva l'Inghilterra ad essere più circospetta in questa del Sudan ben più lunga e difficile per la vastità del territorio e l'indole dei combattenti. [353] Essa si limitò quindi a dissuadere il vicerè, ridotto a poco più di un personaggio decorativo, da ogni conato per riconquistare le posizioni perdute e a mantenersi sulla difensiva nella valle del Nilo e sulle coste del mar Rosso. Nullameno, cedendo alla generosa iniziativa di Gordon, illustre generale e viaggiatore che per aver soggiornato lungamente nel Sudan vi aveva acquistato pratica di guerra e molta influenza politica, gli consentì una spedizione armata per tentare una rivolta d'indigeni contro il Mahdy. Intanto mandava un'altra ambasceria in Abissinia presso l'imperatore Giovanni, rimesso da lord Napier sul trono usurpato da Teodoros, per trascinarlo alla guerra contro i mahdisti coll'offerta cessione di qualche territorio disputato sull'alto confine dell'Egitto. L'ammiraglio Hewett, abbastanza fortunato in questa missione, potè persuadere l'imperatore ad aiutare la ritirata attraverso l'Etiopia e a Massaua delle truppe khediviali in guarnigione a Kassala-Amedib-Senahit, abbandonandogli queste piazze con tutto il paese dei Bogos, e garantendogli colla protezione britannica il libero transito d'ogni merce per e dall'Abissinia. Un trattato, al quale restò poi il nome dell'ammiraglio Hewett, fu quindi firmato fra l'Egitto, l'Abissinia e la Gran Brettagna il 3 giugno 1884.
Ma la guerra del Sudan anzichè arrestarsi dilagò. Il generale Gordon fu presto assediato a Khartum dalle orde soverchianti del Mahdy; la sua posizione, militarmente insostenibile, era già politicamente perduta malgrado tutti gli sforzi del suo ingegno e del suo carattere di eroe. La pubblica opinione inglese se ne commosse vivacemente; ma il governo, riconoscendo per l'Inghilterra, troppo scarsa di truppe terrestri, insuperabili le difficoltà di una guerra nel Sudan contro popolazioni fanatiche e fierissime, disconobbe ogni carattere ufficiale all'impresa di Gordon, e resistette parecchi mesi freddamente alle istanze della pietà popolare. Però questa insistè talmente che il governo dovette rassegnarsi a mandare in Africa il generale [354] Wolseley (20 settembre 1884) con diecimila uomini per tentare di aprirgli una ritirata. Contemporaneamente la Francia, dimentica sino allora del proprio stabilimento di Obok, improvvisamente volle farne un posto militare e commerciale assegnandovi la somma di 800,000 lire nel bilancio del 1885, e cercando d'impadronirsi di tutta la costa dei Somali per meglio penetrare nell'Harrar. A ciò le bastava ribellare quei selvaggi contro le deboli guarnigioni egiziane, e prendere immediatamente il posto di queste nei porti di Berbera, Zeila e Tagiura. Naturalmente l'Inghilterra tentò d'impedire e di prevenire: provvide rapidamente all'occupazione di Berbera e di Zeila, ma i francesi con non minore rapidità s'impossessarono di Ras-Alì, Angar, Sagallo, Gubet Harab e di Tagiura. Da Massaua il governatore civile Mason bey telegrafava che la tribù degli Habab aveva raggiunto il Mahdy, e chiedeva rinforzi. Era impossibile anche all'Inghilterra fronteggiare tante difficoltà, mantenersi nell'Egitto, combattere nel Sudan, occupare tutti i porti africani nel mar Rosso senza attirarsi altre controversie in Europa.
Quindi tornò a sollecitare l'intervento dell'Italia spingendola ad ingrandirsi intorno ad Assab per impedire alla Francia, più temibile rivale, di crescere sul mar Rosso, e per giovarsi dei nostri soldati nella guerra contro il Mahdy. Il ministero Depretis-Mancini, sempre troppo riguardoso in tale materia anche dopo gli esempi francesi ed inglesi, non osava risolvere; quando il nuovo eccidio della spedizione Bianchi nel territorio di Aussa venne ad eccitarlo. Si decise di occupare Beilul. Poi nuove titubanze: l'Inghilterra ci proponeva segretamente anche Zula e Massaua; la Turchia, sola in diritto di opporsi, non avrebbe potuto protestare che inefficacemente.
Come accade quasi sempre agli incerti, dalle troppe riserve si passò a disegni temerari: non si era osato di cooperare all'impresa d'Egitto contro Araby-bey e si pensò di affrontare nel Sudan il Mahdy. L'intrepido viaggiatore Antonio Cecchi, già sulle mosse per un [355] viaggio di esplorazione al Congo, fu mandato sollecitamente a Massaua per studiarvi un itinerario per le truppe italiane, che in numero di 20,000 avrebbero dovuto marciare da questo porto su Kassala.
Tutta Europa non s'occupava allora che dell'Africa. A Berlino si teneva una conferenza (dicembre 1884) per distribuire l'azione di ogni stato nel continente nero, e più specialmente costituire lo stato del Congo conteso fra i viaggiatori Brazza e Stanley: la Germania entrava anch'essa nell'arringo, piantando la propria bandiera nell'Africa occidentale ovunque esistevano fattorie di commercianti tedeschi sopra un territorio più vasto dell'Italia. Questa non poteva più a lungo mancare agli appelli della storia. La compromissione di un primo possesso in Assab, le sollecitazioni dell'Inghilterra, l'irritante rivalità della Francia, le ultime carneficine dei nostri viaggiatori, gli accordi diplomatici, prima evitati, poi cercati, finalmente assunti, spingevano irresistibilmente il suo governo sulla via del mar Rosso.
All'annunzio che si sarebbe occupata Massaua, nei giornali e alla camera scoppiò una veemente discussione: la maggioranza delle voci vi era favorevole, quantunque si sentisse da tutti che la diplomazia del ministero, come non aveva salvaguardato bene sino allora la dignità della nazione, così non le prometterebbe in questa oscura impresa africana abbastanza risolutezza e sapienza di modi. Francia e Turchia tentarono presso l'Inghilterra di sbarrarci ancora una volta il cammino: finalmente il ministero spedì nel mar Rosso il contrammiraglio Caimi con due navi cariche di mille soldati da sbarco. L'Inghilterra mandò nelle acque di Massaua il Condor col mandato di osservare e riferire, e in sostanza di proteggerci.
Il colonnello inglese Chermside, governatore generale degli egiziani nel mar Rosso, ci accolse favorevolmente a Massaua (5 febbraio 1885): la bandiera egiziana vi fu momentaneamente conservata.
La prima fase della nostra politica coloniale era conchiusa. La fatalità storica aveva trionfato di tutte le inesperienze del paese e di tutte le esitazioni del governo. Bisognava ora prepararsi ad un'impresa di conquista, dalla quale ci verrebbero guerre cogli indigeni e dissidi cogli altri grossi stati coloniali.
Però l'Italia era in Africa: nessun popolo in nessuna storia aveva in trent'anni compito più mirabile progresso passando dalla schiavitù alla conquista.
Nel medesimo giorno che le truppe italiane occupavano Massaua, il Mahdy trucidava a Khartum il generale Gordon con tutta la guarnigione. Il disegno di una cooperazione italiana nel Sudan, sulla quale il ministero aveva contato per ottenere più vasti possedimenti, vaniva dunque dinanzi al fermo proposito del gabinetto inglese di rinunciare a questa guerra sudanese. Allora la pubblica opinione italiana mutò: all'orgoglio di conquista successe un improvviso scoramento; si temette di essere abbandonati dall'Inghilterra in un agguato; le forze vittoriose del Mahdy crebbero nelle fantasie della gente; si seppe che nel primo proclama affisso a Massaua dal contrammiraglio Caimi, essendoci vantati imprudentemente amici dei turchi, avevamo riunito contro di noi le ostilità reciproche di tutte le tribù limitrofe, e che l'Abissinia ci spiava con minacciosa diffidenza. L'opposizione parlamentare rinfacciava al governo di cercare conquiste in Africa, mentre alleandosi coll'Austria abbandonava Trento e Trieste; i lagni rettorici per lo sciupio del poco danaro della nazione in imprese illiberali crescevano. Il ministero, sbigottito dall'abbandono della Inghilterra, la sollecitò a ritentare l'impresa di Khartum col generale Wolseley, e spedì a Massaua il generale Agostino Ricci per studiare una marcia su Kassala con un corpo d'esercito, se mai gli inglesi ripigliassero l'offensiva: quindi, smentendo alla camera ogni arditezza d'iniziativa, il ministro Mancini ripetè [357] sino all'umiliazione la necessità per l'Italia di fare in Africa la più modesta di tutte le politiche coloniali.
Una incertezza fastidiosa agitava paese e governo. Era impossibile e ridicolo restare a Massaua senza acquistarvi un vasto territorio con sbocchi sicuri per il commercio interno. La bandiera egiziana sventolante ancora daccanto alla nostra toglieva credito al nostro indefinibile diritto di occupazione; ogni altro acquisto ci susciterebbe contro l'Abissinia; la Russia, aspirante a coprire quest'ultima del proprio protettorato, teneva già verso di noi una riserva di mal augurio; la Francia aizzava la Turchia alle proteste e alle armi; l'Inghilterra, minacciata bruscamente dalla Russia verso l'Afganistan, sospendeva in Africa ogni lotta.
Il ministero pensò quindi di premunirsi contro il maggior pericolo, seducendo con larghe promesse di pace e di commerci il negus d'Abissinia, presso il quale legati di Francia e di Grecia s'argomentavano a crearci diffidenze e difficoltà. Gli si deputò in missione con molti regali il capitano Ferrari, ma se le assicurazioni di questo parvero calmarlo un istante, non poterono togliergli il sospetto della conquista da noi iniziata sul confine del suo impero. Infatti all'annunzio del nostro continuo dilatarci ad Arafali ed Arkiko, e dell'intenzione di occupare Saati e Amba, il negus s'irritò nuovamente: razzie di abissini nei pressi di Massaua parvero prodromi di guerra. Nel parlamento e nel paese le apprensioni divennero più vive; il ministero, incapace di dare all'impresa africana un rapido ed imponente sviluppo militare, si sentiva trascinato alla guerra, e volendo nasconderne la fatalità si imbrogliava ad ogni interpellanza. Nei partiti l'idea africana era non meno torbida che nel governo, le discussioni tiravano all'accademico. A complicare la situazione venne il ritiro di Gladstone dal ministero inglese, nel quale successe il marchese di Salisbury pertinacemente ostile sino dalla prim'ora ad ogni nostro intervento in Africa.
[358] Il ministero Depretis ne fu scosso, il ministro Mancini dovette dimettersi.
L'occupazione di Saati da noi compita con basci-buzuck assoldati dal comando superiore di Massaua produsse nuovi scoppi di ira alla corte d'Abissinia. Tale villaggio preso dagli egiziani nel 1866, quando posero piede a Massaua, da essi abbandonato nei disastri del 1875-76, rioccupato al tempo della missione Hewett, ritolto loro alla firma del trattato che ne derivò e nullameno rimasto loro, era ancora difeso da alcuni buluck di basci-buzuck, quando il colonnello Saletta decise d'impadronirsene contro ogni possibile sorpresa degli abissini su Monkullo, che è la chiave di Massaua. Per quanto il danno immediato di questa occupazione fosse degli egiziani, e gli abissini considerassero questi come i loro più antichi nemici, era impossibile al negus non sospettare gravi pericoli da questa nuova espansione degli italiani sui confini del proprio regno. Il nostro contegno verso le tribù degli Habab, dei Belad-el-sek e dei Mensa, sui quali l'Abissinia pretendeva esercitare una assoluta supremazia e alle quali noi concedemmo il nostro protettorato, punse oltre l'orgoglio del negus anche le gelosie di ras Alula, il suo miglior generale. L'imperatore Giovanni scrisse a Menelik re dello Scioa, suo tributario, per lagnarsi degl'italiani e denunziargli la loro imminente cacciata dall'Africa; agenti egiziani e greci soffiavano su queste ire.
Intanto a reggere il ministero degli esteri il Depretis chiamava il conte di Robilant, generale ed ambasciatore a Vienna, di credito superiore al valore poichè aveva consigliato la visita di re Umberto a Francesco Giuseppe e da questo non restituita con grave sfregio di Roma. I primi atti del nuovo ministro furono nullameno abbastanza risoluti: unificò il comando militare di Massaua sino allora diviso fra le forze di terra e di mare, vi mise a capo il generale Genè imponendogli di profittare del primo conflitto colle autorità egiziane per impadronirsi del governo e dell'amministrazione [359] diretta sui territori da noi occupati, ma vietandogli categoricamente di allargarne i confini. Tale minimo colpo di stato avvenne senza difficoltà da parte degli egiziani: la Sublime Porta cessò da ogni protesta alla prima minaccia di guerra.
Il governo negava sempre ogni intenzione di conquista territoriale affermando che solo le colonie commerciali sono veramente utili e che il porto di Massaua, come emporio necessario dell'Abissinia, ce ne offrirebbe una delle più utili. Intanto si era dovuto allargare sensibilmente il raggio del suo territorio; si temeva già una guerra e non si ardiva prevenirla con spedizioni di nuovi soldati e coll'occupazione dei luoghi più strategici.
Un futile orgoglio aristocratico rendeva il conte di Robilant sprezzante verso le barbare potenze africane. Tuttavia, uomo piuttosto di diplomazia che di politica, pensò di spedire presso il negus in più vistosa missione il deputato generale Pozzolini perchè coll'aiuto del capitano Harrison Smith, mandato per accordo segreto dall'Inghilterra, potesse ammansirlo. Ma ras Alula moltiplicando le razzie intorno ai nostri territori, ed essendo scoppiata una insurrezione all'estrema parte meridionale dell'Abissinia, il ministro temette che un altro massacro di una missione capitanata da un generale deputato potesse impegnarci in una guerra col negus, e telegrafò a Massaua ordini di soprassedere. Ne venne che il negus, avvisato della missione e non vedendola arrivare, si stimasse sbertato, e che il capitano Harrison, presentandoglisi solo dopo venti giorni di marcie, gli facesse involontariamente giudicare molto timide le ambascerie italiane.
Alla camera questo nuovo smacco provocò critiche a destra e scherni a sinistra. La democrazia rettorica, impigliandosi nelle contraddizioni del diritto politico col diritto storico, non avrebbe voluto nessuna guerra coll'Africa: si paragonava la nostra occupazione di Massaua a quella austriaca di Trento e di Trieste, si dimenticava che se i più civili non avessero sempre [360] conquistato i più barbari la civiltà non sarebbe mai cresciuta. La scoperta di Colombo non giovò all'America già scoperta dai groenlandesi, dai giapponesi e dagli indiani, se non perchè fu susseguita dalla conquista europea. I brevi calcoli dell'interesse nazionale e la minuta scienza d'analisi economica sui vantaggi e sui danni delle colonie non bastavano a giudicare di questa impresa africana, giacchè ogni colonia deve trovare la propria giustificazione non nel presente ma nel futuro, non nell'utile della nazione che la fonda, ma in quello della nazione che da essa deve sorgere.
Senonchè il governo, quasi sperando di rendere inavvertita la propria azione in Africa col diminuirla, vi aveva sospeso i lavori di una piccola ferrovia di congiunzione fra i pochi posti militari, e malgrado l'esempio del cavo telegrafico sottomarino gettato dall'Inghilterra fra Suakin e Perim all'indomani della sua occupazione nell'Egitto, lasciava per ingiustificabile gretteria Massaua senza mezzi di comunicazione diretta telegrafica, dopo avervi diminuito il già scarso presidio.
Una stessa politica di riserbi e di iattanze faceva credere che con due battaglioni si sarebbe resistito a tutto l'esercito abissino, mentre non si voleva guerra con esso a nessun costo; si dichiarava di voler attirare un grande commercio a Massaua assicurando le vie di terra dai predoni, e si lasciava ras Alula fare stragi e razzie sulle popolazioni sottomesse al nostro protettorato; si sconfessava con crudele indifferenza ogni rapporto colla spedizione Porro, massacrata nell'Harrar al mese di aprile del 1886, e se ne permetteva un'altra al conte Salimbeni, al maggiore Piano e al tenente Savoiroux presso il re del Goggiam con carattere quasi officiale.
E anche questa fu catturata da ras Alula per sospetto di spionaggio. La nuova occupazione di Uà sempre per tutela delle carovane commerciali attirò a Massaua nuove minaccie da ras Alula: il pericolo incalzava. La scarsezza delle guarnigioni obbligò il generale [361] Genè a munire Uà e Saati con soldati regolari e con pochi cannoni, poichè da parecchi mesi aveva chiesto indarno al ministero, sebbene senza sollecitarlo troppo, un rinforzo di duemila uomini. Finalmente un telegramma di sconfitta già pubblicato dai giornali inglesi giunse a Roma.
Il 24 gennaio (1887) ras Alula, movendo da Ghinda, aveva tentato invano l'assalto di Saati; quindi il 26 tre compagnie e cinquanta irregolari sotto il comando del colonnello De Cristoforis, accorse da Monkullo per vettovagliare Saati, erano state sorprese e trucidate sulle alture di Dogali. Il capitano Tanturi non aveva potuto giungere colla propria compagnia sul campo di battaglia se non quando il massacro era già consumato: «Tutti i nostri soldati giacevano in ordine come fossero allineati!» egli scrisse poi nel proprio rapporto.
Questo incredibile eroismo di coscritti morti senza indietreggiare, allineati come ad una rivista, gonfiò di tragico orgoglio il cuore della nazione. Qualcuno dei superstiti, lasciati per morti dal nemico, raccontò che il colonnello rimasto degli ultimi a cadere, nell'ebbrezza di una morte resa dall'eroismo dei suoi soldati più bella di tutte le vittorie, avrebbe ordinato al manipolo, che ancora lo difendeva, di salutare i caduti:
— Presentate le armi! —
La commozione nel parlamento e nel paese fu maggiore del fatto. Il ministero si scompose, parecchi ministri dovettero uscirne, si dichiarò la guerra all'Abissinia, e non si chiesero alla camera più di cinque milioni; si ordinò al generale Genè di mercanteggiare con ras Alula, minacciante di trucidare la spedizione Salimbeni se tutta l'Africa non fosse immediatamente sgombra dagli italiani: si dovettero consegnare al barbaro un migliaio di fucili a lui diretti, dianzi sequestrati, e cinque capi di tribù assaortine, a lui nemici, riparati nel nostro campo sotto la protezione dell'onore italiano.
[362] E nemmeno così si ottenne subito il riscatto dei tre prigionieri.
Ma questo tragico episodio di Dogali troncava finalmente tutte le ambagi della nostra politica coloniale: guerra e conquista diventavano inevitabili.
L'Italia risorta nazione aveva ripreso il proprio posto d'avanguardia nella guerra immortale della civiltà contro la barbarie: Dogali era stata la prima conseguenza di Solferino.
Così l'Italia in quindici secoli di una storia, la più complessa fra tutte, aveva potuto raggiungere la propria individualità politica costituendosi in nazione.
Splendidi e squallidi i suoi avvenimenti si erano succeduti con foga precipite attraverso le scene di un dramma, nel quale tutte le leggi della vita per lungo tempo erano sembrate capovolgersi. Nessuna unità apparente fra tante avventure, nessun carattere dominante nel suo popolo composto dalla sintesi di tutte le razze. Già prima ancora che Roma, dilatandosi a città universale, desse al mondo la prima unità politica, quando nell'Europa la barbarie era più antica e più fitta, il popolo misterioso degli Etruschi aveva improvvisato fra il Tevere e il Po una civiltà meravigliosa d'arte e di scienza, di politica e di religione. Roma, costituita in una immensa città militare, che imporrebbe poi a tutto il mondo la propria giurisprudenza, non aveva potuto fondere in un solo getto le troppe genti d'Italia: la sua azione politica restava loro fatalmente esterna, mentre il suo orgoglio quiritario considerandole come materia di conquista, le respingeva dall'eguaglianza civile dei suoi cittadini, che era tutto il resultato della sua vita storica. Ma quando Roma, cresciuta ad impero universale, dovette diventare come il centro neutro del mondo, e le sue legioni composte di sudditi ribellandosi al governo dei Cesari nominarono [364] i propri imperatori e s'impadronirono dell'orbe, una nuova eguaglianza avvenne fra cittadini e concittadini, fra capitale e provincie.
Naturalmente queste, conservando contro quella un residuo di originalità etnografica, si giovarono dei suoi elementi civili per rinnovellarsi in nazioni indipendenti. La grande religione del cristianesimo aiutò singolarmente col principio della propria eguaglianza morale e della libertà di coscienza questo processo d'individuazione già affrettato dalla decadenza imperiale cogli orrori di una corruzione, nella quale con Roma sembrava perire la coscienza umana. E quando per l'inevitabile spostamento di governo determinato dalla necessità di resistere alle frontiere orientali più vivamente minacciate dai barbari, la capitale da Roma emigrò a Bisanzio, l'Italia, pur conservandosi nominalmente centro dell'impero occidentale, non fu più che una provincia come tutte le altre. Roma passava per lungo ed incerto tramite dall'impero al papato, dal paganesimo al cristianesimo, mentre Ravenna, antico villaggio lacustre e mediocre stazione navale, s'ingigantiva con improvvisa ed effimera fortuna a capitale d'occidente. Allora irruppero le invasioni che rinnovarono il mondo antico preparando il moderno. Popoli barbari cresciuti in una selvaggia verginità dilagarono sulle terre romane, e ne assorbirono la civiltà, disparendo per dar luogo ad una razza più mista, nella quale un sangue giovane beveva tutti gli aromi vaporanti dalla rovina di una antica civiltà. Il mondo fu quindi e dovunque federale.
Bisanzio, perduta sul confine dell'Asia, cessò quasi di appartenere alla storia europea per attendere fra gli orrori e gli splendori della più spirituale decadenza quella rinnovazione mussulmana, che doveva poi imporre al cristianesimo d'occidente l'ultima e più difficile prova.
Ma se nell'Europa il mareggiare delle invasioni sembra ubbidire piuttosto alle leggi fisiche della gravitazione che a quelle ideali della storia, nell'Italia, [365] ove a Roma dura ancora l'idealità dell'impero e splende più pura ed universale l'altra della chiesa, le invasioni s'illuminano d'incandescenti chiarori, e si sottopongono quasi con umiltà di olocausto a questi due supremi poteri. Senonchè il loro tumulto è così sanguinario, le loro battaglie così spaventevolmente effimere, le loro stratificazioni storiche sul suolo italiano così confuse, la loro inconsapevolezza così ingenua, le loro catastrofi così ritmiche, mentre i due concetti della chiesa e dell'impero s'alzano sempre nelle tenebre medioevali sino a parere due stelle di una medesima costellazione, che nè cronisti, nè storici, nè vincitori, nè vinti, nè barbari, nè latini, nè politici, nè sacerdoti, nè poeti, nè filosofi possono comprenderne l'idea o apprezzarne almeno approssimativamente il risultato.
Al momento, in cui s'attendono le conseguenze più previste nel dramma dei personaggi e nella tragedia dei popoli, altre invasioni irrompono, nuovi prologhi scompongono gli epiloghi, la narrazione s'interrompe nello sbigottimento di un nuovo racconto, altre geste disperdono le immagini delle quali la leggenda stava rivestendo le imprese degli ultimi trionfatori. Goti, Longobardi, Franchi, Alemanni si succedono scacciandosi, schiacciandosi, sovrapponendosi gli uni agli altri: Normanni, Angioini, Aragonesi, Francesi perpetuano queste invasioni, che interventi pontifici e discese imperiali trasformano in disastri periodici. Ogni mattina i popoli sembrano ricominciare la trama della propria storia: le loro città si trasformano in teatro di glorie straniere, i loro campi servono a battaglie di una guerra scoppiata nella Scandinavia o nella Germania, nella Francia o nella Spagna.
Quindi una confusione inestricabile di forme e di periodi politici rende inintelligibile la storia di questi primi tempi. Guerre ed invasioni sono così continue che non si discernono più nè vincitori nè vinti, nè invasi nè invasori: chiesa ed impero sovrastano, municipii romani e città militari si osteggiano, il moto indigeno [366] è come una corrente di fiume nel mare, che vi diventi inavvertibile a pochi passi dalla foce. I governi, che s'improvvisano sul suolo ancora tutto pregno di elementi romani e solcato da tutti gl'istrumenti della nuova religione cristiana, sono qua comunali, là feudali, normanno in Sicilia, bizantino a Venezia, teocratico a Roma, regio a Pavia: o s'irrigidiscono in fragili regni, si stemperano in labili republiche, si distaccano in villaggi indipendenti, si sminuzzano in gruppi abbaziali, urtandosi coi più imprevedibili contrasti nella più abbacinante fantasmagoria.
Un dualismo riprodotto dappertutto dalla più eterogenea multiplicità rovescia l'alta Italia sulla bassa, municipii contro municipii, città contro città, castelli contro castelli: gli odii s'invertono per rianimarsi, le guerre stancano i secoli senza una tregua, gli eserciti compaiono talora come indipendenti dai popoli, questi vigoreggiano sballottati da convulsioni troppo lunghe per essere un morbo, l'anarchia rinnova tutti i governi senza soccombere ad alcuno di essi, l'impero è impotente come la chiesa e non per tanto chiesa ed impero sono le due sole idee e i due unici poteri invincibili.
L'Italia ha dimenticato il mondo sul quale regnava con Roma, e ridotta Roma sede del pontefice e capitale di una piccola regione turbolenta quanto Genova, meno colta di Firenze, più povera di Milano, quasi nulla politicamente di fronte a Venezia.
Ma dopo quattro o cinque secoli la lava delle invasioni si è già solidificata amalgamandosi col terreno, dal quale germoglia una nuova flora. Una razza mista di sangue e di colore, di tendenze, d'abitudini, di tradizioni, d'ideali è disseminata per l'Italia in tanti piccoli stati con governi di tutti i modi, con dimensioni che sfuggono a tutti i calcoli. Un particolarismo angusto e fratricida costituisce la loro forza e la loro originalità: il comune è una idea, che vale quella dell'antica urbe e la supera potendosi riprodurre da per tutto, mentre Roma era condannata ad essere unica nel mondo e contro il mondo. Il comune nega inconsciamente [367] la tradizione pagana, le invasioni barbariche, le trasformazioni dell'impero romano, la feudalità, il papa, la nazione, il mondo. La sua vita, circoscritta al suo territorio, si fortifica nell'oblio di ogni universalità: i suoi nuovi cittadini imbevuti di tutte le superstizioni medioevali, oppongono una indipendenza capace di qualunque bassezza e di qualunque eroismo a tutte le autorità religiose e politiche; la loro tenacia stanca tutte le inimicizie, la loro passione li mette a paro con tutte le idee, la loro originalità li sovrappone a tutti i poteri. Quindi il nuovo federalismo si organizza nei comuni attraverso rivoluzioni, nelle quali i partiti pullulano e le sètte si suddividono; dittatori, tiranni, signori, si moltiplicano; le epopee si specializzano, le politiche si frantumano, e ogni comune diventa un governo, uno stato, una nazione, un mondo separato ed antagonista, che solo la legge arcana della federazione avvince a tutti gli altri, e che nell'orgoglio della propria individualità pretenderebbe ad una storia speciale come Roma ed Atene. La guerra, che come una bufera sbatte gli uni sugli altri i comuni, sprigiona dalla loro idea scintille che rischiarano ed incendiano: la loro prima vittoria è contro i castelli, la seconda contro le città militari, la terza dei comuni più grandi e spirituali sui più piccoli e meno intelligenti. Laonde la loro storia riproduce a distanza di secoli quella dell'antica Grecia; la Toscana supera l'Attica nella molteplicità del genio, e basta da sola ad iniziare una terza epoca di incivilimento mondiale. Tutti i borghi hanno grandezze che illustrerebbero una grande nazione: la loro vita resiste a tutte le sventure, prospera fra tutti i delitti, si decora di tutte le virtù, si scinde in tutte le varietà per riunirsi in unico risultato. Nè la chiesa nè l'impero possono prevalere contro i comuni, che sono il nocciolo infrangibile della patria e della nazione futura.
La guerra, invece di distruggerli, li amalgama in corpi sempre maggiori, che vittorie e sconfitte consolidano: alleanze ed esigli stringono le prime fratellanze [368] politiche; le stesse rivalità inconciliabili, incatenandoli l'uno all'altro, li preparano a sempre maggiore unità.
Mentre i loro cronisti sembrano chiudersi ognuno nella cerchia angusta delle proprie mura, la storia invisibile li appaia e li coordina: il loro racconto inintelligibile diventa chiaro proseguendo oltre i confini dei loro territori e della loro epoca nel racconto degli altri: malgrado l'intrattabilità degli odii, che lo esagerano, nell'assenza di ogni preconcetto e di ogni giudizio morale riesce quasi sempre vero.
Coll'impero, col papato e coi comuni l'Italia è ancora il centro della nuova civiltà. Ogni moto viene all'Europa dall'Italia: Cesari e pontefici debbono incoronarsi a Roma; da Roma si diffondono il diritto e la religione, la tradizione e l'avvenire. Tutti gli altri popoli, usciti appena dalla preistoria e oscillanti ancora nella marea delle invasioni, aspettano da Roma e dall'Italia le idee: il loro istinto non può diventare coscienza che per mezzo di una rivelazione italiana, la loro bravura mutarsi in virtù che al contatto del sentimento italiano, la loro forza essere creatrice che sotto la direzione del genio italiano. L'Italia sola è classica: impero, papato, religione, scienza, arte, politica, tutto prosegue in essa e la trascende senza stremarla. L'Italia basta al mondo, e si serve indifferentemente dei Cesari e dei papi, doma la propria religione coll'incredulità, respinge l'ateismo coll'arte, sgretola tutti i dispotismi con una libertà, alla quale concede l'efferatezza di tutte le tirannidi; è dotta, marinara, tribunizia, bancaria, agricola, democratica, mentre l'Europa non ha ancora che barbari alle prese colla propria gerarchia militare e colla nuova religione cristiana.
Il numero delle rivoluzioni italiane è così enorme che oggi stesso la scienza storica stenta ad accettarlo, la gamma delle sue forme politiche così ricca che nessun progresso vi può essere impedito, la folla de' suoi grandi uomini così densa che la fortuna e non il merito [369] deve assegnare loro l'immortalità. Appena i suoi comuni, respingendo come un cuneo la doppia barriera del papato e dell'impero, arrivano alla grande libertà di potere decorare se stessi, una primavera di bellezza comincia per tutta l'Europa: l'epoca della barbarie è conchiusa, l'Italia ha trionfato del mondo.
Le altre nazioni riunite dalla guerra a grandi unità con pochi ma potenti e contrari caratteri potranno dietro l'impulso italiano proseguire nell'opera dell'incivilimento. L'Italia, come stanca della propria immensa elaborazione, si riposa in un'orgia di bellezza, moltiplicando i propri artisti ed imponendo loro come a soldati la conquista quotidiana di un capolavoro. I suoi comuni divenuti signorie stanno per sparire nei principati, la sua religione romana per essere spezzata da uno scisma, del quale la coscienza umana si coprirà come di uno scudo; il suo Cesare non è più che un simbolo, il suo papa un vescovo, le sue republiche non sono più una libertà, i suoi regni non hanno ancora unità, perchè il federalismo necessario alla sua vita per la produzione di tante idee e di tante forme non può sparire che sotto l'azione di un'idea maggiore della chiesa e dell'impero.
Ma l'Italia, indietreggiando dall'avanguardia della civiltà, copre la propria ritirata col lanciare Colombo alla scoperta dell'America e Galileo a quella del cielo: così, dopo aver dato al mondo l'unità romana e cristiana, vi aggiunge quella geografica e l'universalità planetaria sorpassando lo stesso cristianesimo, col quale l'aveva salvato dalla barbarie medioevale.
La sua immensa storia di venti secoli s'impicciolisce quindi in quella del Piemonte e della Sicilia; Firenze non è più che una stazione ove le belle arti essendosi troppo a lungo fermate, hanno perduto ogni energia di progresso; Venezia s'irrigidisce in una inutile difesa contro i turchi, dando al proprio governo l'immutabilità dei marmi, coi quali ha costrutto i propri incantevoli palazzi; Milano decade a provincia francese o spagnola; Roma è appena la capitale di uno [370] stato pontificio senza potere, senza nazionalità e senza governo.
La storia italiana, mutata in eco della storia europea, deve ripetere le voci di Francia, di Germania, d'Austria, di tutti. Il suo federalismo si è arrestato all'ultimo termine, e s'inizia segretamente il periodo dell'unità. L'Italia, che colle proprie idee universali ha dato all'istinto individualistico degli altri stati la profondità di una coscienza nazionale, attende dai contraccolpi della propria opera l'energia di organizzarsi in nazione. Per ora la diffrazione delle sue tendenze e l'esaurimento delle sue forze lo contendono. Come nel medio evo, la sua grande valle del Po seguita quindi ad esser il teatro ove si decidono le massime contese europee, ma nelle quali solo il Piemonte si mescola per educarsi all'abilità necessaria di una futura egemonia italiana. Mentre la Germania s'insanguina nella rivoluzione della Riforma per togliere a Roma il primato religioso e l'estrema fattizia unità mondiale all'Italia, questa dalla festa della bellezza durata tutto il cinquecento è già tornata all'azione, dando ai propri scienziati l'impeto degli antichi legionari romani.
Il seicento è l'epoca eroica delle scienze, l'ultimo trionfo del genio italiano. Dopo questo sforzo supremo l'Italia pare cancellata dalla storia: Inghilterra, Francia, Spagna, Olanda, Portogallo, Austria, Russia, si dividono il mondo: l'America è già misurata, girata l'Africa, contornata l'Asia, scoperta l'Australia: il mondo, libero da ogni antica unità religiosa o politica, è aperto a tutte le carriere, ma solo quei popoli, che vi raggiunsero l'indipendenza e la libertà di nazione, possono agirvi efficacemente. L'Europa in preda ad una febbre di operosità urge tutte le proprie genti. La Spagna, succeduta nel posto dell'Italia all'avanguardia della storia, non ha potuto durarvi più di un secolo; la Francia, rimasta sola a difendere il primato delle razze latine, sembra perdere terreno dinanzi agli sforzi giganteschi della razza teutonica rappresentata dall'Inghilterra e dalla Germania; ma poichè il genio [371] romano è inesauribile, la Francia contrappone presto alla Riforma, che aveva emancipato la coscienza religiosa, una rivoluzione, che crea la coscienza civile.
E l'Italia ritorna nella storia con Napoleone I, ultimo Cesare e ultimo condottiero, che dilata la rivoluzione francese con due antichi concetti romani, l'universalità imperiale e la democrazia militare.
La nazionalità italiana riappare quindi fugacemente entro l'impero napoleonico nei limiti di un regno, nel quale persino il papa è scomparso, e sul quale comanda un fanciullo col titolo di re di Roma. Ogni traccia di federalismo vi è cancellata: l'Italia, presa nell'orbita della rivoluzione francese, ha ricevuto dal suo urto la forza di conglomerarsi politicamente in nazione; l'impero napoleonico si scomporrà come un immenso bolide; ma l'Italia, aggirandosi sempre in quell'orbita, potrà in solo mezzo secolo consolidarsi in nazione.
Tale è oggi in Europa.
Ma quale è in questo glorioso continente il suo posto e la sua missione?
La moderna Europa civile non somiglia all'antica: questa guardava il Mediterraneo, quella fronteggia tutto il mondo. Dopo il Rinascimento l'Europa si creò nel mare Baltico un secondo centro, ove Olanda, Germania, Inghilterra, Scandinavia, Russia si fusero come le antiche nazioni mediterranee; ora tutte le coste dei suoi mari brillano di fari civili, all'interno tutte le sue grandi città sono centri di scienza e di vita. Le sue vittorie sull'Islamismo, col quale l'Asia aveva tentato più volte di sopraffarla, le hanno da quasi due secoli assicurata la primazia su tutti i continenti; i suoi popoli organizzati in nazione offrono lo spettacolo di una forza, alla quale l'antichità non saprebbe trovare in se stessa alcun paragone. L'Inghilterra possiede un impero maggiore del romano, la Russia ha un territorio quasi pari a quello della Cina, piccoli paesi come il Portogallo e l'Olanda posseggono colonie decuple di loro stessi.
[372] L'Europa libera non ubbidisce a nessuno dei propri popoli, non soccombe più ad alcuna loro preponderanza fattizia, ma conquista, illumina, rinnova tutti gli altri continenti. L'America è già tutta europea di spirito, figlia primogenita e rivale dell'Europa: questa vi possiede ancora qualche colonia, che può sfruttare come una fattoria, ma che perderà presto come tutte le altre. L'America è democratica: l'altro ieri fucilava al Messico l'ultimo imperatore avventuriero, ieri distruggeva nel Brasile l'ultimo impero e rinviava in Europa Pietro I di Braganza, come un servitore pensionato.
I due grandi problemi esteri per l'Europa sono l'Africa e l'Asia, che essa deve attirare l'una dalla preistoria nella storia, l'altra dalla storia antica nella storia moderna. Tutte le nazioni europee si sono date in questo secolo la posta sul continente nero; Russia ed Inghilterra si contendono la gloria e l'utile di trasformare l'Asia; il secolare problema della Turchia sul Bosforo non è che un dato del problema orientale. Ma la Russia, già distesa nell'Asia sovra immensi territori, cinge colla Siberia la Cina a nord-ovest, e dal Caucaso discendendo per la Persia e l'Afganistan minaccia di asserragliarla al sud per sopraffarvi l'Inghilterra; una ferrovia russa, miracolo d'improvvisazione, in pochi anni, tocca già al Tibet; Annenkoff, il generale che l'ha costrutta, ne sta disegnando un'altra sino all'estrema frontiera chinese verso il Giappone. L'America ha offerto i miliardi dei propri banchieri al Celeste Impero per aprirvi le prime grandi arterie ferroviarie; gli inglesi solcano di ferrovie l'India; il commercio ha dischiusi tutti i porti asiatici; la Francia, sempre liricamente avventuriera, è penetrata vittoriosa fino a Pechino e si è ritirata fermandosi conquistatrice nell'Annam, nella Cocincina e nel Tonkino.
Mentre l'Europa penetra con sì irresistibile espansione nei due vastissimi continenti, che quasi l'imprigionano, raddoppia in sè medesima con rapido processo le proprie forze. Tutti i suoi popoli in questo [373] secolo si sono rinnovati al contatto della rivoluzione francese. Teocrazie, monarchie, aristocrazie, hanno dovuto soccombere ad una democrazia multiforme: appena costituite le nazioni, si pensa a confederazioni per razze. Nel Baltico un disegno di federazione presentato dal re di Svezia (1864) congiunge Svezia, Norvegia e Danimarca; l'avanguardia della democrazia latina ne propone un altro per stringere in un solo fascio Spagna, Francia e Italia; la Germania, riunitasi intorno alla Prussia in un impero di 45 milioni di cittadini, aspetta l'occasione di assorbire gli altri 12 milioni di tedeschi predominanti ancora nell'impero austriaco. Questo, scacciato dal centro d'Europa, tende ad inorientarsi, e per resistere al moto delle nazionalità comincia a concedere qualche autonomia ai maggiori popoli, onde è composto: l'Ungheria è già in possesso di un proprio parlamento, gli czechi di Boemia lo reclamano ad alte grida e propongono Praga a loro capitale, nei Principati Danubiani guerre e rivoluzioni vi educano le forti popolazioni a libertà. Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, vi sono già indipendenti e con dinastie proprie; la Bosnia e l'Erzegovina, cedute in amministrazione all'Austria dal trattato di Berlino (1878), non intendono acconciarsi al nuovo padrone, che tutti gli slavi di Polonia, di Transilvania, di Gallizia, di Slavonia, di Dalmazia, guardano con occhio nemico. La Grecia ostinata nell'eroismo delle proprie rivendicazioni, tiene sempre la mano sull'elsa per slanciarsi contro il turco, del quale l'impero europeo, caduto nel fondo della più orribile rovina economica, si sfascia politicamente sotto l'azione combinata dell'idea greco-slava e dei propri principii barbarici. Ora le rivalità dell'Austria, della Russia e dell'Inghilterra lo proteggono ancora, ma l'irresistibile moto nazionale delle sue popolazioni cristiane non può essere arrestato da alcuna combinazione diplomatica. Qualunque sia dunque per essere il carattere che dominerà la formazione di questi nuovi stati divisi ancora da odii di sètte religiose e da gelosie storiche [374] di razza; vi preponderi la influenza greca o slava, l'unità panslavistica di Pietroburgo, o una federazione più democratica che vi rispetti le originalità regionali; l'Austria si dissolva in questo moto o vi si rinnovi entrando coi proprii popoli in questa lega che potrebbe avere altrettante capitali che gli Stati Uniti d'America, Praga, Buda-Pest, Belgrado, Bucarest, Sofia, Atene, Costantinopoli, mentre Vienna sarebbe la seconda città della Germania: è impossibile che il processo d'individuazione si fermi in questi stati, cui l'islamismo non potè fondere, e che la moderna democrazia deve integrare.
Se nei primi passi all'indipendenza essi tutti, come il Belgio, la Grecia e l'Italia, accettarono o accattarono dinastie indigene o straniere, le quali naturalmente si destreggiarono diplomaticamente fra loro medesime e più forti vicini per timore di essere fuse in un grosso getto monarchico; questo tirocinio politico era necessario per addestrarli ai governi rappresentativi e per convergere in una fattizia unità di comando i loro sforzi sempre infranti da troppo minuti antagonismi.
Quindi il grande problema europeo, una volta dibattuto sul Reno, sul Po e sull'alto Danubio, ribolle ora alla foce di questo ultimo e sulle sponde del mare Nero, che dopo essere stato uno stagno turco sta per diventare un lago russo, se il panslavismo, nell'incalcolabile sua forza di espansione trionfando delle opposizioni riunite dell'Austria e dell'Inghilterra, offra alle popolazioni slave del sud più pronta indipendenza della Porta e maggiore fortuna politica coll'annessione all'impero degli czar.
L'avvenire della politica e della storia europea è dunque slavo.
Un immenso popolo, disseminato sulla metà del nostro continente, sta per aprirvi un periodo di civiltà pari al latino e al germanico. Il suo numero enorme è tuttavia piccolo per il suo territorio: la sua orbita abbraccia già una gran parte dell'Asia, e si piega dal [375] mare di Behring al mar Glaciale sino al Baltico, penetra nella Scandinavia e nella Prussia, dal mar Nero tende al Mediterraneo e da questo all'Adriatico e all'Oceano Indiano. Le avanguardie slave vigilano già nella Dalmazia, sono accampate nel cuore dell'Austria, gli eserciti russi hanno già corso vittoriosi tutta l'Europa da Parigi a Costantinopoli. L'impero degli czar ha l'estensione e la varietà di un mondo. Nella sua spaventevole unità governativa presenta la più salda compattezza attraverso le antitesi di tutte le forme della vita primitiva colla vita moderna; religione e politica vi sono fuse da secoli nello czar, pontefice ed imperatore, che regna, governa, giudica, rivela a nome di Dio. La forza dell'impero è incalcolabile come l'autorità del suo governo: nessuna guerra può vincerlo, nessuna rivoluzione rovesciarlo. Entrato da poco più di un secolo nella storia europea, esso ne domina già le vicende: ha indigato la rivoluzione francese, cancellato il primo impero napoleonico, organizzato nella Santa Alleanza la reazione monarchica, liberata la Grecia, sottratti colla propria influenza i Principati Danubiani alla Turchia; colla voracità dei barbari divora tutti i prodotti della nostra civiltà per meglio assimilarsene la sostanza; ha già una scienza, una letteratura, una musica, una politica, della quale i disegni sorpassano tutte le combinazioni diplomatiche degli altri governi. Il suo raccoglimento è sublime di promesse, la sua attività miracolosa d'ardimenti. Coll'istinto infallibile dell'avvenire minaccia simultaneamente Asia ed Europa: il suo sogno è di espandersi dall'India all'Illiria, la sua marcia attraversa regioni di tutti i climi e di tutte le storie, lenta, calcolatrice, senza mai indietreggiare, assodando la conquista prima di aumentarla, aiutandosi egualmente colla barbarie ubbidiente della propria moltitudine e colla raffinata cultura del proprio governo. Nessuna tirannia è più terribile e meno capricciosa della sua, che ubbidisce ancora più fanaticamente del popolo all'idea di un mondo russo. Roma non era che una città di soldati, Londra [376] non è che una città di mercanti, Pietroburgo è una città di padroni, che invece di soggiogare il mondo o di sfruttarlo, vogliono riempirlo di se medesimi. La loro devozione allo czar è fatta di fede in se stessi. Di fronte all'impero russo l'impero austriaco pare una piccola confusione burocratica, e quello germanico un accampamento militare: entrambi debbono destreggiarsi nella politica per difendere la propria importanza, mentre la Russia sa di essere inattaccabile.
La terribilità della sua forza si rivela ad intervalli nelle esplosioni de' suoi rivoluzionari, che col nome inesplicabile di nihilisti vorrebbero trarla dalla sua base per farne una improvvisata democrazia moderna. Solo il cristianesimo alla prima guerra contro Roma potè mostrare nei propri neofiti una pompa di volontà e una gloria di passione pari a quella dei moderni nihilisti.
Il moto delle nazionalità raddoppia la potenza della Russia, facendola centro di tutti gli slavi dispersi nel mezzo o nel sud dell'Europa: il panslavismo è la più vasta, profonda idea nazionale della storia europea. Grecia, Belgio, Italia, Germania, non vi prelusero che come saggi.
All'immensa iniziativa della rivoluzione francese solo il moto panslavista è degno risultato.
Quindi l'Europa non ha che due fuochi, Parigi e Pietroburgo: due originalità, la republica e lo czarismo: tutti gli altri governi costituzionali sono transizioni di epoche e transazioni di principii. Nessuna guerra se non russa può mutare sensibilmente la carta europea; nessun problema è più vitale per tutti i governi del come gli slavi del sud si riuniranno in nazione. I popoli occidentali d'Europa possono perfezionarsi piuttosto che crescere; il popolo russo può emigrare all'interno per una varietà sconfinata di terre, ove tutti i climi gli promettono tutte le ricchezze, prima che le collisioni del lavoro col capitale vi producano la tormenta politica delle nostre anguste democrazie.
[377] Ora per quasi tutti i governi d'Europa la questione pregiudiziale è quella della loro forma monarchica, alla quale mancando la consacrazione religiosa e la giustificazione teoretica crescono ogni giorno le ostilità. Negli stati, ove le monarchie furono necessario strumento alla rivoluzione, la lotta è meno violenta per l'elasticità delle une e dell'altra; ma in quelli, ove le monarchie preesistevano alla rivoluzione, la lotta si accanisce nelle antinomie dei principii, che le costituzioni irritano cogli stessi espedienti di conciliazione.
Fra cittadino e re la guerra è anche più fiera che non fra operaio e capitalista, giacchè alle rivoluzioni sociali debbono sempre aprire il passo le rivoluzioni politiche.
Dopo la proclamazione della sovranità popolare tutte le monarchie sono idealmente reazionarie. Il loro ufficio in questo secolo fu di prestare alla rivoluzione il proprio ambiente per attuarvi l'originalità dell'idea democratica nella sproporzione pericolosa fra la coscienza culta delle classi dirigenti e la coscienza bruta delle classi dirette. Le monarchie diventarono come il punto neutro, ove s'accordarono le ragioni del passato e le istanze dell'avvenire, i pregiudizi e i privilegi storici colle uguaglianze e colle giustizie sociali. Nella garanzia di ordine offerta dalle monarchie si acquetarono le diffidenze delle plebi e gli odii delle aristocrazie contro il pareggiamento democratico; ma le contraddizioni della sovranità popolare col diritto divino dovevano mutare la pace costituzionale fra monarchi e popoli in una guerra parlamentare con interventi di piazza, appena le battaglie rompessero i confini statutari.
Le monarchie più gloriose furono in Piemonte e in Prussia, e dureranno più lungamente, finchè un egoismo dinastico o un errore di metodo inimicandole colla patria le rompa come il bozzolo, dal quale deve involarsi la farfalla.
[378] In fondo a tutte le monarchie costituzionali sta la stessa republica.
Quale è dunque il posto e la missione dell'Italia monarchica in questa Europa, nella quale la popolazione aumenta da un secolo con nuova proporzione, e il militarismo prodotto dalle guerre di nazionalità mantiene armati nella pace tre o quattro milioni di soldati, e può raddoppiarli al primo scoppio di ostilità? L'Italia, che va liquidando la sovranità temporale del papato, e ha raggiunta fra tutti gli stati risorti a nazione la più intensa unità politica, con oltre duemila anni di storia la più gloriosa, e in breve territorio la più spiccata varietà di attitudini nel proprio popolo, quali idee e quale forza può recare nella politica europea? In questo secolo non è più possibile parlare di primati come quelli antichi di Roma; la civiltà futura d'Europa potrà colorarsi vivamente ai riflessi del mondo slavo, ma non sparirà più nel carattere di un solo popolo.
Ora all'avanguardia del progresso democratico sta ancora la Francia colla propria republica, mentre la Russia, attardata nella più arcaica forma di governo, addensa promesse su promesse di civili originalità: unità republicana e unità ieratica chiudono l'Europa come in una parentesi. Nella Germania il federalismo imperiale non ha altra vera unità che l'esercito; il lavoro dell'assimilazione politica, cui non basterà una sola generazione, converge all'interno tutte le forze nazionali; la Spagna non entra più nel concerto europeo che per risolvervi qualche difficoltà coloniale; l'Inghilterra non vi è spinta che da contraccolpi della questione orientale; l'Austria cerca una nuova base federalista per non uscirne. L'Italia, costretta dal proprio diritto nazionale alla conquista di Trento e di Trieste, e dalle proprie origini rivoluzionarie ad una politica democratica, dovrà attraverso le oscillazioni delle correnti parlamentari seguire una politica che secondi il liberalismo francese e le nazionalità slave. La [379] sua opera nel Mediterraneo può essere prevalente: i suoi addentellati storici col mondo greco-slavo le permettono un'ingerenza altrettanto fortunata che gloriosa, le sue affinità colla Francia e colla Spagna le assicurano con una alleanza l'invincibilità.
Il suo nemico immutato è l'Austria; il mare, che può e deve essere suo, è l'Adriatico, mentre la Germania avrà il Baltico.
La sua monarchia dei Savoia potrà accompagnare la rivoluzione nazionale dell'unità sino alla conquista di Trento e di Trieste?
La scienza della storia non può rispondere a questo problema.
Ora l'Italia elabora in se stessa la propria coscienza di grande nazione. Se la forma monarchica del suo governo è naturalmente reazionaria, il suo spirito rivoluzionario ha potuto produrre in questo secolo le due maggiori originalità politiche con Napoleone I e con Garibaldi: il suo governo è ancora all'avanguardia della nazione, ma questa si affretta per raggiungerlo, e non può tardare molto a sorpassarlo.
L'alleanza attuale dell'Italia colla Germania e coll'Austria contro la Francia e la Russia non esprime più che l'ultimo stadio della sua inferiorità politica, nella contraddizione della sua posizione diplomatica colle sue tendenze storiche.
L'avvenire d'Italia sarà di assoluta libertà, e quindi fecondo di grandi iniziative.
La Germania all'indomani del proprio trionfo sul secondo impero napoleonico, nell'ebbrezza superba di sentirsi finalmente libera ed una, alzava a se medesima una statua colossale sulle rive del Reno fisa minacciosamente verso Francia; nè paga a questo monumento di un'ultima gloria militare, esorbitando dalla propria idea, ne levava un'altra ad Arminio che tagliava a pezzi le due legioni di Varo, quasi con quella vittoria aneddotica di un condottiero selvaggio volesse opporre se medesima all'immensa storia ideale di Roma. Quindi, bandendo per l'iscrizione latina, che doveva spiegare [380] quel monumento, un concorso mondiale, con spavalda ironia dava il premio al romagnolo Ferrucci, retore latinista e abbastanza vacuo italiano per non sentire la vergogna di vantare una sconfitta romana così:
Hic, ubi romano rubuerunt sanguine valles,
Duxque datus saevae cum legione neci
Hostibus hic terror post saecula multa resurgo
Vindex Germani nominis Arminius.
L'Italia tacque.
Quando l'Italia avrà conquistata intera la coscienza della sua nuova grandezza in Europa, sentendo meglio quella antica nella quale fu centro a tutto il mondo, risponderà alla Germania col mettere in Campidoglio, al posto di Marco Aurelio, l'incomparabile statua di Giulio Cesare confusa ora nel museo capitolino fra troppi capolavori, e vi scriverà sotto con romana brevità:
DIVO
Caio Julio Caesari
URBS ET ORBIS
E ora esaminiamo le condizioni della lotta politica attuale.
Casola Valsenio, 2 giugno 1888-29 settembre 1890.
1. Io stesso, allora giovinetto, che avevo seguito trottando fra la poca gente la carrozza del re dalla stazione sino dentro all'atrio del Quirinale, potei udire questa esclamazione e notare il suo gesto: nell'una e nell'altro nessun accento o significato di grandezza. Vittorio Emanuele aveva l'aria oltremodo annoiata, il vecchio Lamarmora era imbronciato. Infatti pioveva e, malgrado la pioggia, per mostrarsi al popolo eran venuti dalla stazione col mantice della carrozza abbassato.
2. Ora (1890) è diventato senatore come Berchet: Dio lo salvi dal rimpiangere, come l'illustre suo predecessore, le strofe rivoluzionarie, che fecero già la sua potenza di cittadino republicano e resteranno la sua gloria di poeta civile.
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, così come le grafie alternative (neo-guelfi/neoguelfi, khedive/khedivè, oblio/oblìo e simili), correggendo senza annotazione minimi errori tipografici.